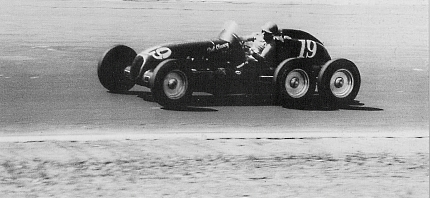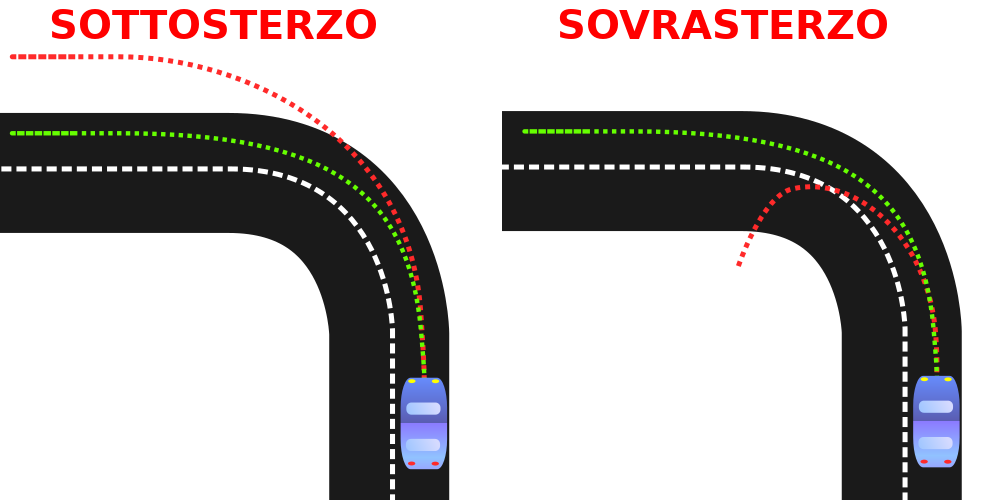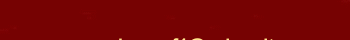|
|
 |

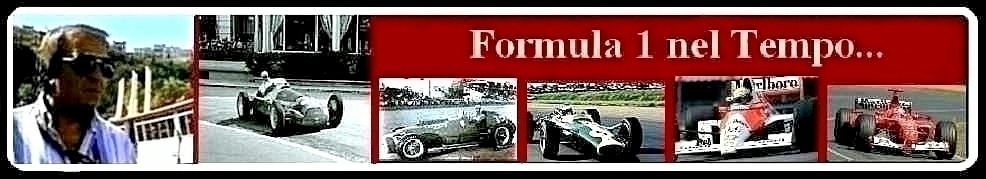
 |
Per poter capire il ruolo importantissimo che hanno
avuto e tuttora hanno le monoposto da competizione nell'ambito delle
migliorie tecniche applicate poi alle vetture di serie, devono essere
analizzati alcuni dati realtivi all'incremento di potenza dei motori, e
alla storia delle competizioni pre e post belliche.
Le monoposto pre belliche
Le monoposto pre belliche altro non erano che delle versioni modificate
delle vetture di produzione, e tali modifiche consistevano
più che altro nella sovralimentazione (quella sviluppata dal
1923 al 1951 era basata su compressori azionati meccanicamente dal
motore) del motore e nel rafforzamento di sospensioni e freni,
più eventualmente un alleggerimento della massa. Nessun
passo avanti nella storia dell'automobile fu fatto a causa della
Seconda Guerra Mondiale, in quanto le industrie automobilistiche
vennero impiegate nella produzione di armi e artiglierie leggere e
pesanti....
Auto Union Type D
|
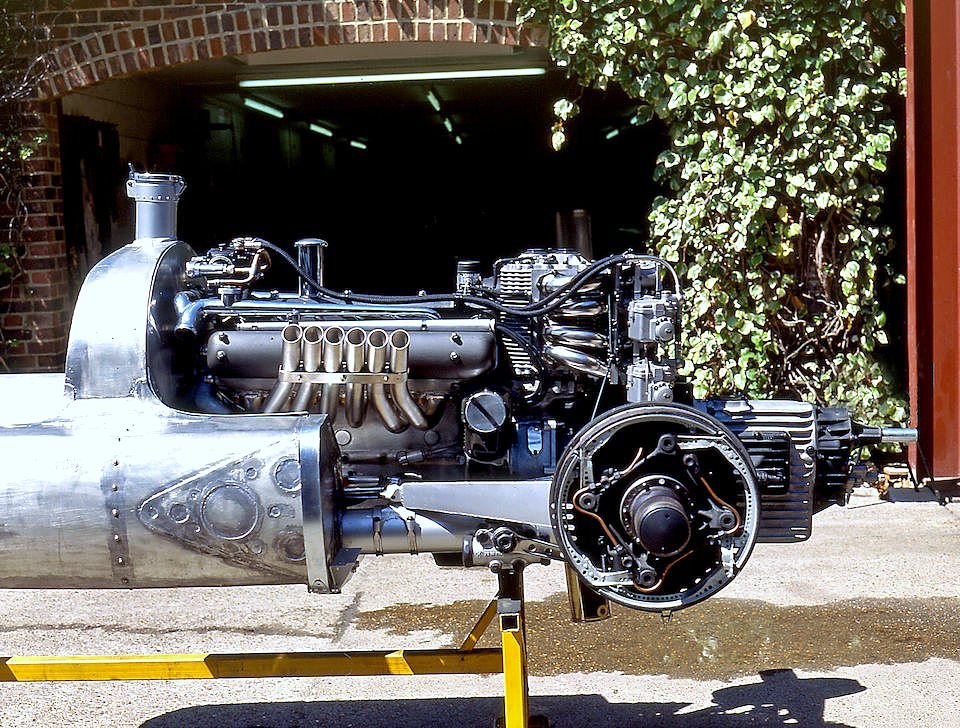
|
La Type D nacque in un periodo molto difficile per le Auto Union da
Gran Premio: il 28 gennaio 1938 la squadra corse aveva perso il suo
asso Bernd Rosemeyer, tragicamente scomparso in un incidente durante un
tentativo di record sull'autostrada Darmstadt-Francoforte. Inoltre,
c'era in quel periodo parecchio lavoro da fare: la Formula 750 kg era
scaduta il 31 dicembre del 1937 e per l'anno seguente era stata imposta
una nuova formula denominata 3 litri, che prevedeva una cilindrata
massima di 3 litri per le auto sovralimentate e di 4,5 litri per quelle
aspirate. Ma già da mesi era in fase di sviluppo una nuova
vettura che avrebbe preso il posto della plurivittoriosa Type C, ormai
non più idonea a soddisfare i nuovi regolamenti.
La
nuova vettura non fu più progettata da Ferdinand Porsche, come
invece era avvenuto per i precedenti tre modelli da Gran Premio
marchiati con i "quattro anelli". Il geniale progettista boemo fu
infatti totalmente preso dalla progettazione di quello che in futuro
sarebbe divenuto noto al mondo intero come Maggiolino. La
responsabilità del progetto della futura Type D fu invece
affidata a Robert Eberan von Eberhorst,
responsabile tecnico del reparto corse Auto Union. Il progetto
ripercorse solo in parte le linee guida tracciate a suo tempo
dall'ingegner Porsche, mentre per un'altra parte fu invece del tutto
inedito. In particolare, furono apportate modifiche consistenti alle
sospensioni: all'avantreno vennero montati ammortizzatori idraulici,
mentre al retrotreno venne montato un ponte a doppio snodo simile ad un
De Dion, soluzione già messa in pratica dalla rivale
Mercedes-Benz e che anche la Horch, tanto per rimanere in casa Auto
Union, aveva già montato già dalla fine del 1935 in una
variante ideata da Oskar Siebler.
Ma
la vera novità fu ovviamente il propulsore, progettato e
realizzato in modo da soddisfare i nuovi regolamenti imposti per la
stagione 1938: il tetto massimo di cilindrata fissato a 3 litri per le
vetture sovralimentate suggerì a von Eberhorst di ridurre anche
il numero di cilindri da 16 a 12, mantenendo sempre l'architettura a V,
ma con un differente angolo fra le due bancate, 60 gradi anziché
45. La cilindrata fu di 2985 cm³, la metà di quella della
Type C, ma in questo caso il rapporto di compressione fu aumentato da
9.2 a 10:1, ottenendo così un motore più spinto del
precedente, il che permise di ottenere, grazie anche alla
sovralimentazione mediante due compressori volumetrici
configurati a doppio stadio, una potenza massima di 485 CV. Questo
nuovo V12 era inoltre caratterizzato dalla distribuzione a due valvole
per cilindro azionate da tre assi a camme, uno centrale per l'aspirazione e i due laterali per lo scarico. Tagliando via quattro cilindri si ottenne un motore dal minor ingombro longitudinale, il che permise di ridurre l'interasse,
in maniera tale da ottenere un triplice vantaggio: riduzione di peso,
maggior maneggevolezza ed agilità della vettura e telaio più
"comunicativo" con il pilota.
Essendo questo nuovo motore molto più spinto del precedente, i
consumi salirono del 20% rispetto alla vettura da Gran Premio dell'anno
prima: la Type D riusciva a percorrere appena un chilometro con un litro
di carburante,
carburante che consisteva in una miscela di alcool, acetone,
nitrobenzolo ed etere solforico, ed era stipato in tre serbatoi della
capacità totale di 280 litri.
|

Tazio Nuvolari su Auto Union D-type, nel 1938, a Donington Park
|
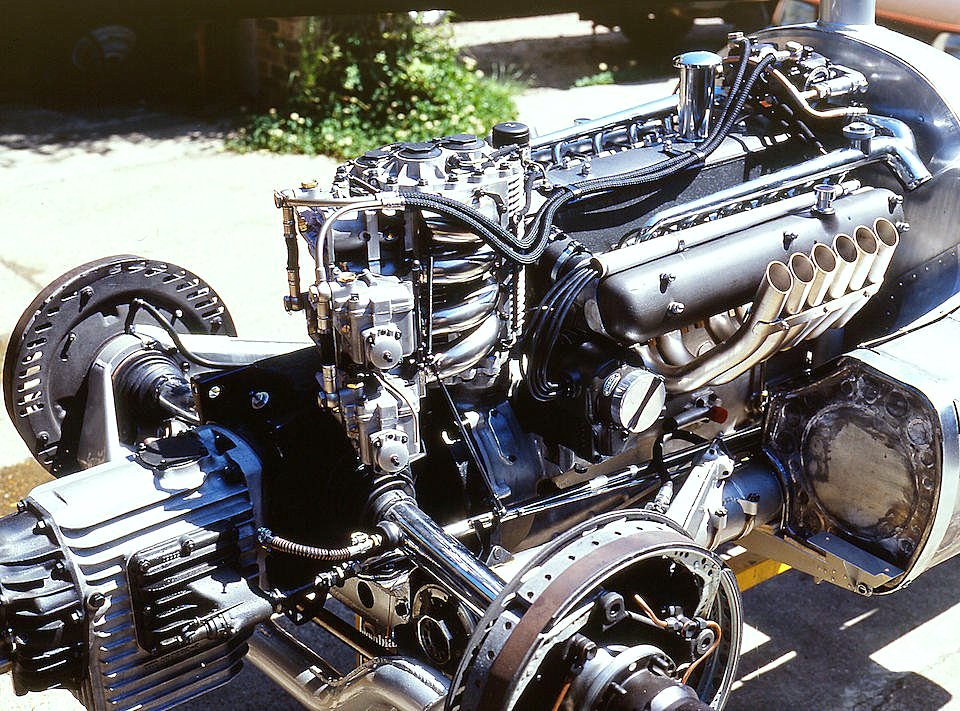 |
|
Il
debutto sportivo della Type D fu enormemente ritardato dalle
difficoltà di messa a punto della vettura, che continuava a
manifestare qua e là dei problemi. Le prime gare della stagione
1938 videro la Type D assente dai tracciati. Il debutto avvenne solo il
3 luglio sul circuito di Reims per il Gran Premio di Francia. Purtroppo
l'esito fu a dir poco catastrofico, poiché i tre piloti
disponibili in quello scorcio di stagione (Hasse, Kautz e Müller)
abbandonarono tutti la gara in seguito ad incidenti. Il guaio fu che
questi tre piloti non erano all'altezza dei grandi Stuck e Rosemeyer,
ma quest'ultimo, come si è detto all'inizio era scomparso
tragicamente all'inizio di quell'anno, mentre più o meno nello
stesso periodo Stuck e l'Auto Union giunsero al divorzio per motivi in
realtà mai chiariti completamente. L'unica speranza visibile
all'orizzonte per l'Auto Union pareva giungere dall'Italia: all'inizio
della stagione, infatti, Tazio Nuvolari entrò in una fase di
contrasto con l'Alfa Romeo, da cui sarebbe nata un'altra separazione
eccellente. Presa la palla al balzo, i dirigenti dell'Auto Union e il
"mantovano volante" presero contatti e giunsero ad un accordo,
formalizzato il 15 luglio grazie al nullaosta della Federazione
Automobilistica Sportiva Italiana: Nuvolari divenne il nuovo pilota
della squadra corse dell'Auto Union. Il debutto dell'asso mantovano
avvenne il 24 luglio al Nürburgring per il Gran Premio di
Germania, dove giunse quarto a causa di alcune noie al motore, che tra
l'altro ebbe una perdita d'olio che schizzò sul parabrezza
rendendo difficoltosa la visuale al pilota italiano. Alla Coppa Acerbo
sul Circuito di Pescara, Nuvolari giunge in pole position, ma durante
la gara è costretto al ritiro assieme a Müller ed Hasse. Il
migliore piazzamento per una Type D fu il quarto posto conquistato da
Hans Stuck, che nel frattempo fu riammesso nella squadra corse dopo le
enormi pressioni cui fu sottoposta in tal senso la Auto Union dal
regime tedesco. La riscossa avvenne l'11 settembre al Gran Premio
d'Italia disputatosi a Monza:
Nuvolari conquistò la vittoria davanti a Hermann Lang e la stampa
dedicò fiumi di inchiostro a tale evento. Il 22 ottobre a Donington,
Nuvolari investe un cervo durante le prove, ma all'avvio della gara
parte in quarta e si trova a condurre già dopo la prima curva, e dopo
alcune peripezie termina al primo posto regalando un'altra vittoria
all'Auto Union con una Type D ormai messa completamente a punto. Alle
vittorie di Nuvolari nella stagione 1938 vanno inoltre aggiunte le
cinque cronoscalate vinte da Stuck sempre su Type D.
tenutosi il 25 giugno, Lang trionfa ancora, ma la gara fu funestata da
un incidente mortale in cui Seaman perse la vita. Questa volta è Hasse a
guadagnare il secondo posto, mentre Nuvolari e Müller furono costretti
al ritiro. Il 9 luglio a Reims arrivò la prima vittoria della stagione
per la Type D e per l'Auto Union. A portare la monoposto al trionfo fu
questa volta Müller, seguito da un'altra Type D, quella di Meier. Ed
ancora Müller giunse secondo al Gran Premio di Germania, mentre la
vittoria andò di nuovo alla Casa di Per la stagione 1939 Nuvolari e Stuck furono riconfermati, così
come anche Müller e Hasse. Inoltre, vennero ingaggiate due giovani
promesse, Georg Meier e Ulli Bigalke. Anche nel 1939, la stagione
sportiva cominciò in ritardo per la Type D, che non partecipò alle gare
di Pau e di Tripoli.
Ma il debutto al Nürburgring vide comunque la vittoria della
Mercedes-Benz di Lang davanti a Nuvolari, giunto secondo. AlGran Premio del BelgioStoccarda.
Quell'anno, la stagione sportiva fu particolarmente breve a causa della
situazione politica che stava rapidamente degenerando proprio in
Germania. Al Gran Premio di Belgrado fu Nuvolari a concludere
vittoriosamente l'ultima gara disputata da una monoposto Auto Union e
l'ultima valida per un Gran Premio. Ma il titolo andò comunque alle
Mercedes-Benz. Era il 3 settem bre 1939: il giorno prima Adolf Hitler aveva invaso la Polonia, dando il via alla catastrofica Seconda Guerra Mondiale.
|
Le monoposto post belliche
.....Finita la guerra, con l'istituzione del Campionato del Mondo e
l'introduzione di regolamenti circa la costruzione delle vetture da
competizione, si ricominciò dai vecchi progetti, invece di
agire verso nuove direzioni. Sul finire degli anni Sessanta la
sovralimentazione dei motori (la concezione di aerodinamica e quindi di
lavoro su scocche arriverà più tardi, negli anni
Settanta) è ottenuta dall'azione di turbo-compressori
comandati dai gas di scarico. Il ciclo di grandi evoluzioni per il
motore aspirato ha preso l'avvio necessariamente da cilindrate
ragguardevoli, data l'esiguità delle potenze specifiche
realizzabili: appena 60-80 cavalli/litro, contro i 200-230 cavalli per
litro di cilindrata dei sovralimentati. Appena avviato il processo,
tuttavia, la corsa alle più alte potenze specifiche
è stata notevole, con il traguardo dei 100 cavalli per 1000
cc raggiunto per la prima volta dai motori della formula di due litri e
mezzo e con incrementi spettacolari per la F.1 1500, fino alla soglia
dei 150 CV/litro, e per la F.1 3000, ormai prossima ai 180 CV/litro.
L'aumento delle potenze è legato a molti fattori, quali il
numero dei cilindri, il rapporto corsa-alesaggio, il regime di
rotazione, il sistema di alimentazione, eccetera, il criterio stesso
della cilindrata non è che parzialmente vincolante, ai fini
dell'equità della competizione, tanto da essere sostenuto
attualmente da altre limitazioni; ma la sua validità permane
pressochè indiscussa per l'unità di tempo entro i
cui limiti avvengono i progressi. Il punto di partenza per la grande
avventura del motore aspirato in questo dopoguerra è stato
di potenze specifiche comprese fra i 60 e i 70 cavalli/litro; un
livello relativamente basso, che aveva, nondimeno, prospettive di
rapido incremento con gli insegnamenti dell'esperienza parallela in
campo motociclistico, dove la sovralimentazione era stata abolita con
grande anticipo e la quota dei 100 cavalli/litro poteva già
considerarsi una norma, pur con il vantaggio delle cilindrate unitarie
esigue. Quindi, al momento del confronto cruciale fra il sovralimentato
e l'aspirato, la bilancia proponeva su un piatto l'otto cilindri in
linea delle celebri Alfa Romeo 158/159 con punte massime di 425
cavalli, ma con 400 cavalli effettivi nella media delle applicazioni, e
sull'altro piatto i 12 cilindri Ferrari a V di 60°, di quattro
litri e mezzo, con disponibilità di 360-380 cavalli e con
vantaggi già sensibili nelle utilizzazioni e nei consumi.
Dal 1953 iniziò una preziosa concentrazione dei tecnici su
motori a quattro e a sei cilindri in linea, con molti studi rivolti
alle camere di combustione, all'evacuazione dei gas di scarico, con
particolare riferimento alle lunghezze critiche dei condotti, e con
grandi sforzi concentrati sull'alimentazione, monocarburatore e perfino
a iniezione. E' il momento dello studio intenso anche sulle
proprietà dei carburanti e dell'affacciarsi delle prime
camere di scoppio adatte a far risaltare i fenomeni di "swirl" e di
"squish". Il quattro cilindri in linea rappresenta veramente l'ideale
per gettare solide basi, utili ad un serio sviluppo del moderno motore
aspirato. Il sei cilindri in linea viene introdotto da Gordini, mentre
da parte inglese (Era-Bristol e HWM-Alta) un gradino più
sotto, si fa leva su valori specifici già confortanti.
Così, con l'avvento del sei cilindri in linea della Maserati
del 1953, con il conseguimento dei 190 cavalli a 7500 giri, si
arrotonda a 95 CV/litro la potenza specifica, con la bellezza di 12,7
CV/litro a mille giri. Le basi per la successiva Formula 1 di due litri
e mezzo (1954-1960) sono gettate e l'avvento delle tecnologie della
Mercedes, con distribuzione desmodromica e iniezione diretta, danno
nuovi stimoli alla ricerca. Con i 280 cavalli effettivi dell'otto
cilindri in linea della marca tedesca, con 112 CV/litro e ben 13,2
CV/litro a mille giri, saliti nel 1955 a 118 CV/litro e a 13,9 CV/litro
a mille giri, il tetto è stato raggiunto per quell'epoca di
sviluppo e i primati tecnici di questo motore sono tali da restare
insuperati per tutto il corso della formula. y-Climax, dimostra
l'importanza di accelerare l'evoluzione di propulsori con grosse
cilindrate unitarie, superiori ai 620 cc, con valori addirittura di 15
CV/litro per mille giri e pressioni medie effettive fino a 13,5
Kg/cm#2. Come soluzione intermedia, il motore V 6 della Ferrari si
trascina le stesse ragioni di validità, con applicazioni
preziose. Il finire degli anni Cinquanta non è favorevole a
troppi investimenti nell'evoluzione dei motori: i progressi favoriti
dalle rivoluzioni d'autotelaio appaiono ben più ingenti di
quel che la tecnica motoristica potrebbe offrire, determinando una
certa stasi. Il passaggio dall'architettura convenzionale del motore
anteriore e trazione posteriore al motore posteriore-centrale con
trazione sulle ruote posteriori, ha prodotto effetti preponderanti,
tanto da garantire le maggiori affermazioni alle Cooper e alle Lotus
con un quattro cilindri Climax di appena 240-243 cavalli, pari a
96,5-97,5 CV/litro, con buone concentrazioni di potenza in un regime di
6800 giri, che fa calcolare 14,2-14,3 CV/litro a mille giri. Negli anni
Sessanta, parallelamente, fanno la loro comparsa le prime appendici
alari, la cui efficenza è limitata, ma che garantivano un
buon carico aerodinamico per i telai (alluminio) e i pesi delle
vetture, che comunque mantenevano freni a dischi in acciaio e
pneumatici convenzionali. Gli anni Settanta portano nuove evoluzioni.
Oltre al perfezionamento del telaio autoportante, all'evoluzione dei
motori boxer, comincia la nuova concezione di aerodinamica. I telai
cominciano ad assumere una forma a freccia, per poter fendere meglio
l'aria. per quanto concerne i motori, si esplorano i 10000 giri, 450
cavalli nella media della produzione. Scarichi di diametro maggiore e
altri perfezionamenti al circuito di lubrificazione.470 cavalli nel
1975 e con punte di 480-490 nelle ultime espressioni. Gli stimoli sono
venuti dalla crescente avanzata dei motori a 12 cilindri - Ferrari in
particolare - pur con altre componenti della Matra e dell'Alfa Romeo.
La Matra, con un 12 cilindri a V di 60° raggiunse un'apice di
520 cavalli. Per l'Alfa Romeo, il passo dalla Sport alla Formula 1, con
il 12 cilindri "boxer" (l'ultimo ridisegno a V di 60° risponde
ad esigenze extra-motoristiche, ovvero di installazione in vettura e di
flussi aerodinamici interni), è stato breve, seppure
scontata la stagione iniziale del '76, per raggiungere i migliori
compromessi fra tenuta, distribuzione della potenza lungo la curva e
prontezza d'accelerazione. Ufficialmente, questo motore ha dato le
potenze specifiche più alte, con 177 CV/litro e qualcosa
come 14,75 CV/litro a mille giri. Le valutazioni, nondimeno, si fanno
difficili per il più vittorioso dei 12 cilindri, il "boxer"
Ferrari, che ha puntato tutto sulla buona stabilità di
funzionamento, indipendentemente dai valori massimi. Anche l'ascesa di
questo motore, esemplare per la concezione del manovellismo e del
comando della distribuzione, è stata spettacolare, partendo
dai 430 cavalli a 11600 giri del 1970, per salire subito dopo a 465
cavalli a 12000 giri, pari a 13 CV/litro a mille giri, e per toccare i
490 cavalli effettivi nel 1974. l'evoluzione conobbe poi una stasi fino
al 1979.
|
|

BREVE STORIA DELL'EVOLUZIONE TECNICA DELLA FORMULA 1

|
Il concetto di deportanza rivoluzionò la concezione delle corse. Fino a quel
momento le vetture da corsa dovevano essere fondamentalmente veloci, il più
veloci possibile, per raggiungere la massima velocità nei rettilinei, che erano
la parte predominante di ogni circuito. Velocità dell’ordine di 340 km/h erano
state raggiunte sui circuiti più veloci già negli anni ’30, e si dovrà aspettare
il 1982 perché vengano raggiunte di nuovo.
Le monoposto però, fino all’avvento
dell’aerodinamica, dovevano rallentare in maniera radicale per affrontare le
curve. In questo modo la differenza fra velocità massima e velocità di
percorrenza delle curve era enorme. Si pensi che le Auto Union del 1936
disponevano di 520 HP e di velocità di punta dell’ordine dei 345 km/h. Su di un
circuito velocissimo come Monza, un giro era percorso alla media di circa 180
km/h. Trent’anni dopo le monoposto, con circa 330-350 cavalli, e velocità
massime non superiori ai 280 km/h, giravano su quel circuito ad una media di
circa 200 km/h.
|
|
|
Con l’avvento dei dispositivi aerodinamici, nel 1969 le
monoposto migliori, con circa 420 HP ed una velocità massima non superiore ai 270 km/h, girarono a
Monza a 236 km/h di media. Questi dati devono essere valutati in termini di
efficienza globale. Un motore potentissimo poteva essere usato per andare forte
in rettilineo, ma la velocità in curva restava subordinata all’aderenza al
suolo. Questa, a sua volta, era legata alla sezione dei pneumatici, al loro
coefficiente di attrito, alla capacità delle sospensioni di tenere il pneumatico
aderente al suolo. Questi fattori erano, fino all’avvento delle appendici
aerodinamiche, evidentemente bassi, perché la velocità di percorrenza della
curva rimaneva molto distante dalla velocità massima che la vettura poteva
sviluppare in rettilineo. Il
ricorso ai dispositivi aerodinamici ha quindi permesso di ridurre in modo
drastico la differenza fra velocità massima e velocità di percorrenza delle
curve. Si era quindi verificato un paradosso: il tempo guadagnato in rettilineo
da una vettura velocissima, ma lenta nelle curve, era inferiore al tempo
guadagnato da una vettura lenta in rettilineo ma veloce nelle curve.
A
questa nuova concezione delle corse automobilistiche verrà subordinata tutta
l’evoluzione dello sport motoristico, fino ai nostri giorni. |
|
|
|
|
 |
È del 1977 l’ultima vittoria di Niki Lauda in Formula 1 con la Ferrari
|

|
|
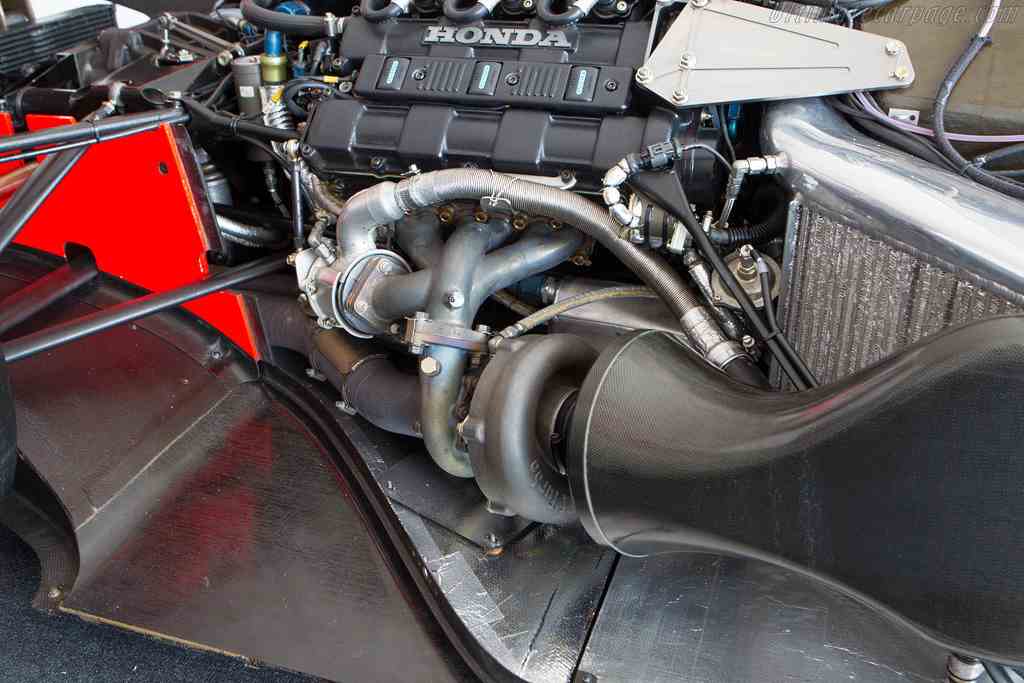
La McLaren MP4/4
fu la vettura del team McLaren che prese parte al campionato di Formula
1 1988. Fu progettata da Gordon Murray e Steve Nichols, e rappresenta
tuttora una delle auto di Formula 1 più efficaci della storia,
avendo vinto 15 dei 16 Gran Premi cui prese parte. I piloti Ayrton
Senna e Alain Prost lottarono tra di loro per il titolo mondiale, senza
che alcun avversario potesse inserirsi nel duello.
|
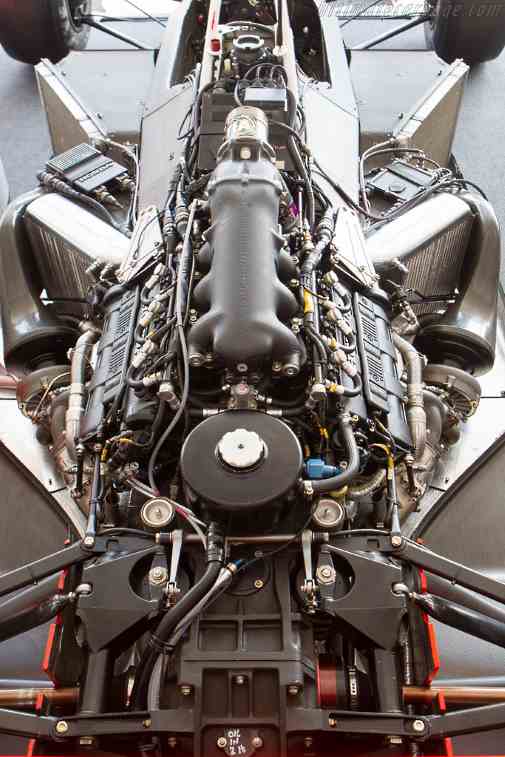 |
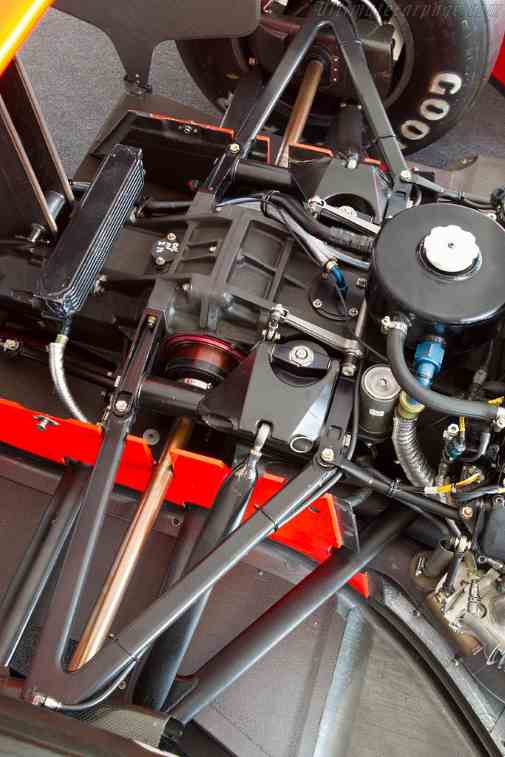 |
| Nel 1987 la Williams
aveva nettamente sconfitto la McLaren sia nella classifica piloti che
in quella costruttori. I motori Honda erano però passati alla
scuderia di Woking e la capacità del fornitore giapponese di
creare un motore più basso dei precedenti permise a Murray e
Nichols di riprendere ed affinare i concetti introdotti nel 1986 con la
Brabham BT55, senza l'handicap delle scarse affidabilità e
potenza che avevano caratterizzato il motore BMW inclinato.
Nel 1988 il regolamento tecnico prevedeva la possibilità di
utilizzare motori aspirati di 3500 cc di cilindrata senza limiti di
consumo, oppure motori turbocompressi da 1500 cc di cilindrata, con
pressione di sovralimentazione limitata a 2,5 bar e 150 litri di
carburante per percorrere la distanza della gara. La Honda scelse questa
seconda possibilità, in quanto le evoluzioni previste per il proprio
motore le permisero di mantenere un vantaggio sulla concorrenza.
L'MP4/4 si ispira alla Brabham BT55 di Gordon Murray, che nell'87
aveva disegnato la MP4/3, approfondendone i concetti.
L'idea di Murray era quella di una macchina estrema sotto il profilo
fluidodinamico, ma nel caso della Brabham non si ottennero vantaggi: il
motore era un progetto molto complesso e soprattutto fine a sé stesso.
Secondo Gordon Murray disegnare una macchina con le linee della BT55
permetteva di ridurre di circa il 30% la sezione frontale rispetto ad
una monoposto convenzionale: la linea di cintura estremamente bassa
riduceva moltissimo la resistenza all'avanzamento con vantaggi notevoli
in velocità e consumi. Infatti la BT55 nel 1986 era stata l'auto con la
velocità di punta più alta.
Questa soluzione consentiva anche di investire con una maggior portata
d'aria la superficie alare posteriore, incrementando il carico
aerodinamico sulle ruote motrici, con conseguente incremento di trazione
e velocità di percorrenza in curva. Sotto questo aspetto la BT55 era stata un fallimento perché il suo
motore BMW era un 4 cilindri in linea, molto alto, e per poter
migliorare il progetto aerodinamico era stato inclinato di 72°,
soluzione che creava problemi di lubrificazione e combustione; inoltre
con un motore alto il centro di gravità dinamico risultava sempre molto
sbilanciato, anche a causa di un cambio a 7 marce ingombrante e
complicato.
|
Come consulente, nell'87 Murray cercò di sviluppare questi
concetti sulla MP4/3 disegnata da Steve Nichols, il quale cercò di
riprendere in parte il progetto MP4/2 di John Barnard, che ormai era
superata. Perciò, a parte il muso, tutto il resto della vettura fu
ridisegnato cercando di abbassare la linea di cintura e il centro di
gravità.
Murray poté intervenire con questa filosofia progettuale grazie al fatto
che la MP4/3 utilizzava un motore V6 con angolo di bancata di 90°.
Inoltre riprogettò le pance laterali, spostando le prese d'aria di sfogo
dei radiatori ai lati della vettura anziché sulla parte superiore; con
questo intervento ridusse l'altezza e rese più slanciato il roll-bar,
sfruttando il fatto che la capacità massima dei serbatoi nell'87 era
stata ridotta da 220 a 195 litri. Tuttavia il motore non si dimostrò
abbastanza solido e potente contro l'Honda della Williams.
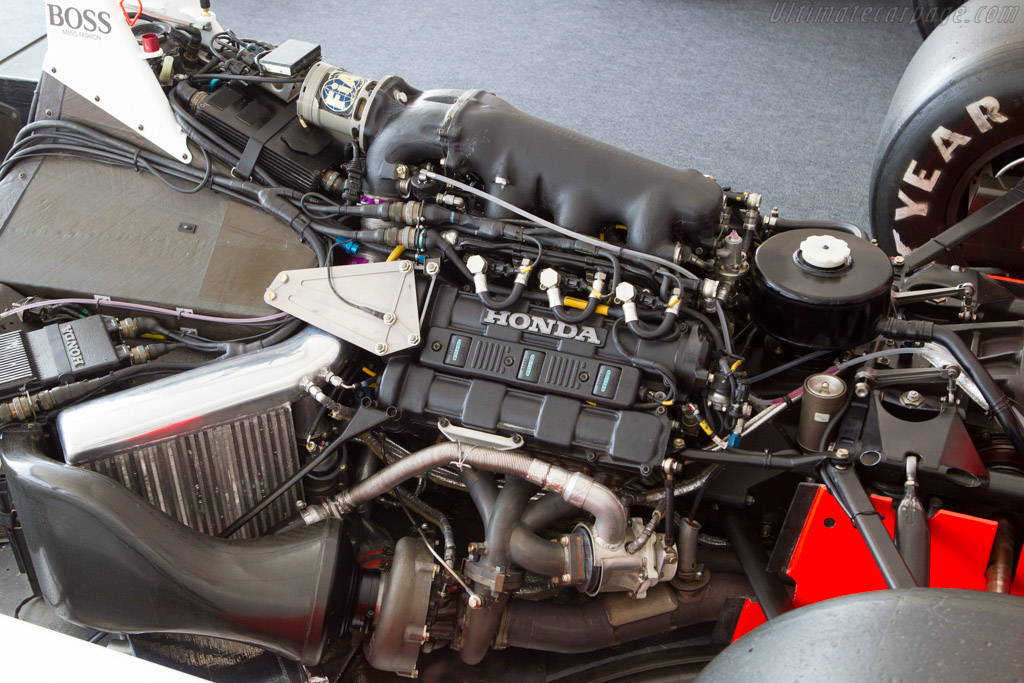
Nell'88 la McLaren per la MP4/4 ottenne la fornitura di questi
motori, che erano sempre dei V6 ma con un angolo di bancata di 80°,
quindi Murray poté estremizzare ulteriormente quanto visto sulla MP4/3,
abbassando ulteriormente l'altezza complessiva della scocca.
Sostanzialmente lavorò come sulla MP4/3 anche perché pure nell'88 fu
ridotta la capacità dei serbatoi (da 195 a 150 litri).
Una delle modifiche più evidenti fu il muso, molto più rastremato e
slanciato, con grande riduzione della sezione frontale e conseguente
maggiorazione della superficie alare anteriore. Queste varianti
all'avantreno si erano rese necessarie anche per rispettare la nuova
norma che obbligava a collocare la pedaliera delle scocche di nuova
costruzione dietro l'asse delle ruote anteriori, una soluzione che il
regolamento impone ancora oggi e che ha reso la posizione di guida quasi
sdraiata anziché seduta.
Per via di questi interventi l'MP4/4 risultò notevolmente competitiva:
oltre ad essere una macchina molto curata, fu l'unica progettata
espressamente per gareggiare col motore turbo, a differenza dagli
avversari che avevano puntato su ex vetture turbo adattate agli
aspirati, o su progetti di scocche con motore turbo dell'anno prima.
Questa scocca utilizzava sospensioni a ruote indipendenti con
trapezi sovrapposti e sistema a puntone di tipo pull-rod all'avantreno e
push-rod al retrotreno. Quest'ultima soluzione, insolita per l'epoca,
nasceva dall'esigenza di sollevare la posizione dei semialberi, in modo
da non alterare gli angoli di esercizio dei giunti, dato che la scocca
era molto bassa.
|
 |
 |
Durante la fase pre stagione fu testato anche un sistema di
sospensioni attive, che per questioni di affidabilità non fu però mai
utilizzato nei Gran Premi.
La vettura fu talmente dominante che non venne evoluta in troppi
pacchetti aerodinamici, salvo profili alari specifici per circuiti da
basso o alto carico aerodinamico come Monaco, Monza o Hockenheim.
Una delle modifiche che più saltarono all'occhio fu l'eliminazione delle
prese d'aria delle turbine, perché si riteneva che creassero dei
vortici d'estremità che disturbavano i flussi d'aria sul profilo alare
posteriore.
Il motore adoperato era l'Honda RA168-E, un V6 biturbo da circa
650 cavalli, ultima evoluzione del 6 cilindri giapponese che aveva
debuttato nell'83. L'unità fu rivista per ridurre drasticamente il
consumo di carburante dato che il regolamento imponeva una minor
capacità dei serbatoi, e per sfruttare meglio la potenza ai medi regimi
per via dell'altra restrizione sulla pressione di sovralimentazione,
passata da 4.0 a 2.5 bar.
Il cambio, abbastanza convenzionale, era un Weissmann a sei marce
più retromarcia, prodotto in collaborazione con la stessa McLaren e
montato longitudinalmente.


Ayrton Senna
Gran Premio del Canada 1988
|
Già nel corso della stagione 1987,
la McLaren aveva annunciato l'ingaggio di Ayrton Senna, proveniente
dalla Lotus, insieme alla fornitura dei motori Honda. In McLaren il
brasiliano avrebbe fatto coppia con il due volte campione del mondo
Alain Prost. Nella fase di sviluppo, grande attenzione venne posta
all'elettronica di gestione del motore, per l'ottimizzazione dei
consumi, e la vettura si presentò subito vincente, con un notevole
margine sulla concorrenza.
La stagione si sviluppò quindi sulla traccia di un dominio
incontrastato della McLaren. Dopo una prima fase favorevole a Prost,
Senna recuperò progressivamente, per poi passare in vantaggio alla fine
delle gare estive. L'unica corsa che la MP4/4 non vinse fu il Gran Premio d'Italia,
in cui Prost si ritirò a causa dell'unico problema meccanico incontrato
nella stagione, mentre Senna, al comando, si toccò con la Williams di Schlesser
alla prima variante, nel corso di un doppiaggio a pochi giri dal
termine. Dopo Monza Prost vinse due gare, riportandosi vicino, ma
vincendo in Giappone Senna guadagnò il titolo.
Al termine della stagione Prost aveva accumulato più punti totali, ma
Senna vinse grazie ai punti scartati dal pilota francese. Invece tutti i
punti erano validi per il mondiale costruttori, che la McLaren si
aggiudicò con un record di 199 punti.
|
Il Flybrid Systems KERS introdotto in F1 dalla stagione 2009
Il KERS, acronimo di Kinetic Energy Recovery System (in italiano “sistema di recupero dell'energia cinetica”)
è un dispositivo elettromeccanico atto a recuperare parte
dell'energia cinetica di un veicolo durante la fase di frenata e a
trasformarla in energia meccanica o elettrica, nuovamente spendibile
per la trazione del veicolo o per l'alimentazione dei suoi dispositivi
elettrici.
|
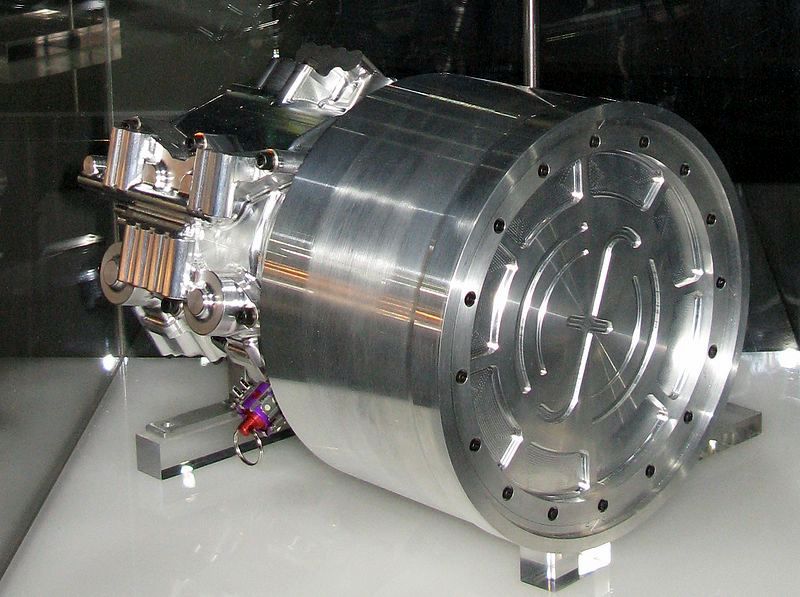 |
Durante
la frenata di un veicolo, l'energia cinetica che deriva da tale
decelerazione è dispersa in calore per attrito del sistema
frenante. Tale energia può essere intercettata da un meccanismo
ad alto momento di inerzia come un volano oppure immagazzinata in un
accumulatore o una batteria e venire impiegata in un secondo momento,
per esempio in fase di accelerazione del veicolo o comunque quando si
abbia bisogno di una riserva di energia per aumentare le prestazioni
del mezzo.
Il sistema KERS è costituito da:
- un motore/dinamo (in corrente continua);
- un accumulatore di carica elettrica, in genere composto o da pile al litio, oppure supercondensatori o ancora batterie a volano;
- un sistema di controllo che permette di gestire il funzionamento del
dispositivo come motore oppure come dinamo a seconda delle necessità.
|
|
F1: come e perchè la Power Unit Mercedes è stata più performante
della concorrenza.
Italian Wheels poco tempo fa vi ha raccontato i motori turbo della F1:
i nuovi V6 ibridi hanno infatti rappresentato la più grande
novità regolamentare del 2014. Oggi vogliamo andare oltre, cercando di spiegare perchè alcuni motori (i Mercedes) hanno funzionato meglio di altri (i Ferrari ed i Renault).
Ricordiamo, in maniera rapida, cosa dice il regolamento: i motori di tutte le F1 a partire dal 2014 dovranno essere dei V6 turbo di 1600 cc, affiancati da due motori elettrici, l’MGU – K e l’MGU – H. Quello che però il regolamento non dice, lasciando quindi carta bianca ai progettisti, è come disporre i vari elementi del motore turbo e come mettere in relazione la componente termica con quella ibrida. Ed è qui che i motoristi della casa di Stoccarda hanno fatto il colpaccio. A Brixworth, un piccolissimo centro del Northamptonshire, in Inghilterra, i motoristi Mercedes, sotto la guida di Andy Cowell, hanno dato vita ad uno dei propulsori più efficienti e vincenti della storia della F1: il Mercedes PU106A. Questo motore (o meglio, questa Power Unit) ha fatto scuola per molti aspetti.
 |
Il più importante in assoluto è stato la disposizione degli organi interni del motore: la PU Mercedes, infatti, ha la turbina separata dal compressore. La
turbina è posizionata nella parte posteriore del motore, dove
confluiscono gli scarichi, mentre il compressore è posto all’interno di uno scasso nel serbatoio dell’olio,
sito nella parte anteriore del V6. Questa distanza tra le due
componenti fondamentali del motore turbocompresso, ha fatto sì che la
PU106A riuscisse a gestire in maniera migliore le temperature: secondo
le leggi termodinamiche, più
è fresca l’aria in entrata, più calda è
l’aria di uscita, maggiore è il rendimento. In più, tale “anomalo” posizionamento ha permesso ai tecnici Mercedes di montare una turbina più grande della concorrenza,
e proprio da tale turbina venivano fuori i circa 80 cv in più che le
W05 Hybrid (e le altre vetture motorizzate con la PU106A) avevano
rispetto alle vetture equipaggiate con propulsori differenti.
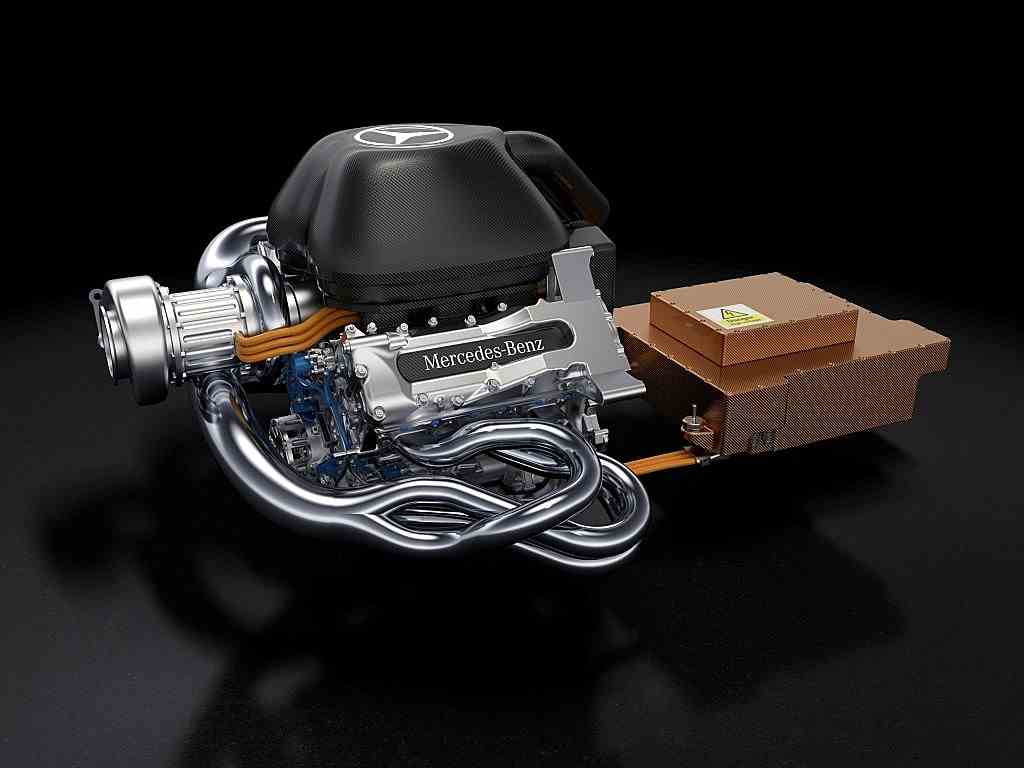
Qualcuno potrebbe a questo punto chiedersi: ma una
turbina più grande non ha anche più inerzia, diventando
più difficile da muovere ai bassi regimi? Giustissimo,
rispondiamo noi. Ed è qui che entra in gioco la perfetta
efficienza dell’ MGU – H montato sulla PU106A.
Ricordate? Questo
motore elettrico si alimenta grazie al calore prodotto dai gas di
scarico, per poi sfruttare la potenza prodotta (circa 90 cv) per muovere
l’alberino di trasmissione che collega turbina e compressore, ovviando
così al turbolag. Ebbene, tale propulsore elettrico sul motore Mercedes funziona meglio che sugli altri: il trucco risiede negli scarichi. Gli scarichi della PU106A hanno infatti i
collettori molto corti, raggruppati in un involucro termicamente
schermato che permette una minore dispersione del calore, a tutto
vantaggio dell’efficienza del suddetto MGU – H.

Il risultato, oltre ad una maggiore potenza massima, è stato l’avere una incredibile disponibilità della coppia motrice, a qualsiasi regime, che
permetteva alle W05 Hybrid di trarre vantaggio anche in uscita dalle
curve lente, quelle in cui teoricamente la turbina più grande avrebbe
dovuto essere un handicap; oltretutto, grazie a questa quantità di
coppia, parti meccaniche importanti (come il cambio) venivano utilizzate e sollecitate di meno. L’unico
problema che i tecnici Mercedes hanno dovuto affrontare – e che poi
hanno risolto in maniera più che brillante – è stato la maggiore fragilità dell’albero di trasmissione tra turbina e compressore:
essendo infatti le due componenti più distanti, le vibrazioni prodotte
dal V6 avrebbero potuto portare al danneggiamento o alla rottura
dell’albero, compromettendo il motore. Ecco quindi che a Brixworth hanno
deciso di inserire dei tiranti di irrigidimento all’interno del V6, rendendolo più stabile.
|
|
Ferrari F14 T
La Ferrari F14 T è la sessantesima monoposto costruita dalla casa automobilistica Ferrari per partecipare
al campionato mondiale di Formula 1 2014.
Identificata, durante lo sviluppo, con il codice interno 665 sostituisce la F138, che aveva disputato la stagione 2013
del campionato mondiale di Formula 1.
|
|

Fernando Alonso - Ferrari - 2014 Monaco Grand Prix
|
 |
|
La PU Ferrari (la 059/3),
a dispetto dei magrissimi risultati ottenuti, era anch’essa innovativa.
Sono state 3 le scelte inedite compiute dai motoristi Ferrari: l’avanzamento
del motore termico; la collocazione dello scambiatore di calore
all’interno della V dei cilindri; la disposizione del serbatoio
dell’olio. Tutte queste scelte sono state fatte per cercare di ottenere un’aerodinamica estrema al retrotreno, che
infatti risultava essere particolarmente allungato: ciò avrebbe dovuto
permettere al diffusore e alla zona della Coca – Cola di essere più
efficienti. |
Questa sistemazione ardita dei suddetti componenti ha però
irrimediabilmente compromesso l’efficienza della Power Unit: la politica
del “risparmiare spazio al retrotreno” ha infatti portato all’adozione
di una turbina di dimensioni minori rispetto a quella della PU Mercedes, a tutto discapito della potenza generata dal motore termico.

Kimi
Räikkönen alla guida della monoposto sul circuito di
Shanghai; si nota l'ampia sezione nera che contraddistingue la
livrea della F14 T.
Presentata
il 25 gennaio 2014 sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari, il nome
F14 T è stato scelto dai tifosi, attraverso un sondaggio effettuato online sul sito web della casa.
Rispetto ai canoni stilistici delle monoposto di Maranello, la livrea
della F14 T mostra, abbinato allo storico rosso corsa, un più ampio uso
del nero, che in questa stagione, oltre a lambire la parte inferiore
della vettura come già accadeva sulla F138, copre adesso anche tutta la
zona del retrotreno;
l'uso di tale colore ha un duplice funzione, ovvero sia migliorare la
leggibilità dei marchi degli sponsor tecnici, sia celare alla vista le
soluzioni tecniche adottate dalla Ferrari in questo ambito della
macchina.
Le due sezioni rossonere della carrozzeria sono inoltre separate da una
sottile striscia tricolore. Inserti bianchi sono infine appannaggio
dell'alettone anteriore nonché dei deviatori di flusso posti davanti
alle pance laterali.
Per la prima volta nella storia della Formula 1, vengono utilizzati
numeri personalizzati per ciascun pilota. Fernando Alonso optò per il
14, numero con cui gareggiò nei kart, mentre Kimi Räikkönen scelse il 7. |
|
Lotus 81

Elio De Angelis, Lotus 81, 1980 Gran Premio di Monaco
La Lotus 81 è una vettura di Formula 1 costruita dal team Lotus per la stagione 1980.
|
 |
Progettata da Colin Chapman e Martin Ogilvie,
questa vettura aveva un disegno abbastanza tradizionale (a differenza
di altre Lotus); spinta dal tradizionale Ford Cosworth DFV 3.0 V8, era
una tipica vettura ad effetto-suolo. Pur garantendo parecchia deportanza, subiva troppo le sconnessioni in pista. Per tale ragione Chapman decise di sviluppare l'innovativa Lotus 88 a doppio telaio.
|
 |
1980
- La Lotus 81 debuttò con alla guida il confermato Mario Andretti e il
neo-arrivato Elio De Angelis. Dal Gran Premio d'Austria venne schierata
la versione B, affidando una terza vettura all'esordiente Nigel Mansell.
Il miglior risultato in gara fu il secondo posto colto da Elio De
Angelis nel Gran Premio del Brasile,
seconda gara della stagione. I ritiri furono frequenti. In totale, il
team conquistò 14 punti iridati ed il quinto posto nel campionato
costruttori.
|
 |
1981 - La
Lotus 81 venne impiegata anche nella prima parte della stagione 1981
nella versione B, affidata alla coppia formata da Elio De Angelis e
Nigel Mansell. I risultati furono due quinti ed un sesto posto con De
Angelis più un terzo posto con Mansell nel Gran Premio del Belgio.
Nell'intento della scuderia avrebbe dovuto essere sostituita dalla
Lotus 88, che però non fu considerata conforme ai regolamenti e venne
infine rimpiazzata dalla Lotus 87.
|
Tecnica :
I segreti del motore a scoppio
|
Come è fatto e come
funziona
|
Un motore a scoppio (ma più
correttamente andrebbe chiamato "motore a combustione interna"
o "motore alternativo endotermico") è essenzialmente
composto da 3 organi meccanici in movimento :
Il pistone
E' un oggetto di forma
generalmente cilindrica, che
scorre dentro un'altro (il Cilindro), ed il suo movimento è quello
di andare su e giù.
L'albero a gomiti
Ha la duplice funzione di trasformare il moto alternativo (in su e
giù) del pistone in quello rotatorio e di portare il moto verso il
cambio e poi alle ruote .
La biella
E' un'organo di collegamento che permette di unire il
pistone con l'albero a gomiti e di trasmettere le forze.
In pratica questi tre organi
meccanici hanno lo scopo di trasformare un moto rettilineo
alternato (quello del pistone) in un moto rotatorio (quello
dell'albero) per sfruttare l'energia dovuta allo scoppio della
benzina e per fare un'altra serie di funzioni che vedremo in
seguito.
|
|
|
Esistono poi altri importanti
componenti :
Cilindro :
La parte in cui scorre il
pistone. Praticamente un grosso Foro.
Testa :
E' la parte superiore che chiude il cilindro.
Camera di scoppio
o di combustione :
E' la parte superiore del cilindro cioè lo spazio che rimane tra
la testa ed il pistone quando questo è nella posizione più
elevata. E' la zona in cui avviene
la combustione della benzina e dell'aria.
Carter o
Basamento :
E' generalmente la struttura che
circonda e sostiene tutti gli altri organi meccanici e che
comprende i cilindri.
Cielo del pistone :
E' la parte superiore del pistone, quella a arriva a sfiorare la
testa e sulla cui superficie avviene la combustione.
Fasce
: Sono delle guarnizioni che garantiscono la tenuta dei
gas, e limitano l'usura tra pistone e cilindro.
Bilanciere :
E' una massa che fa parte dell'albero che ha lo scopo di
equilibrare il motore, cioè di ridurre le vibrazioni.
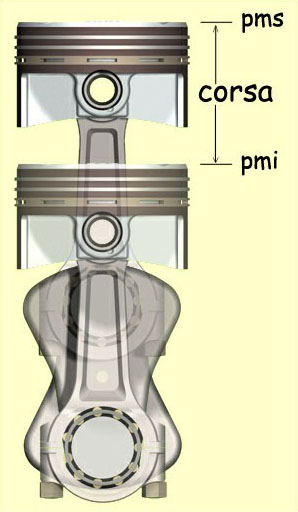 E'
necessario dare qualche nome alle dimensioni caratteristiche di un
motore. E'
necessario dare qualche nome alle dimensioni caratteristiche di un
motore.
(D) Alesaggio:
Il diametro del pistone
(C) Corsa :
Lo spostamento verticale che compie il pistone nel suo movimento.
E' anche il doppio della distanza tra dove è collegata la biella
all'albero e l'asse di rotazione dell'albero stesso.
(S) Sezione del cilindro :
é l'area della sezione del cilindro, cioè l'area del cerchio che
ha per diametro l'alesaggio. Infatti si ha che S =
p
D2
(V) Cilindrata :
Il volume spazzato dal pistone nel suo movimento. E' semplicemente
la sezione del cilindro per la corsa
[
 ]. ].
(Pms) Punto morto superiore :
E' la poszione più alto che raggiunge il pistone nel suo moto (la
biella è perfettamente verticale e il pistone è fermo e sfiora la
testa)
(Pmi) Punto morto
inferiore : E' il punto più
basso che raggiunge il pistone nel suo moto (la biella è
perfettamente verticale e il pistone è fermo)
(r) Rappoto di
compressione : E' il rapporto
tra il volume della camara di scoppio e quello della cilindrata ,
diviso per la cilindrata. r = ( Vc + V ) / V
(RPM) Numero di giri al
minuto : E' la velocità di
rotazione dell'albero motore.
(Z) Numero di cilindri
: Va da 1 (monocilindrico) a
più di 12 (pluricilindrici)
Un paio di definizioni :
Quadri [ C=D ] :
Si chiamano così quei motori che hanno la corsa e l'alesaggio
uguali.
Super quadri [ D>C ] :
Quei motori in cui l'alesaggio è più lungo della corsa .
A corsa lunga [ C>D ] :
Quei motori con la corsa maggiore dell'alesaggio .
Rapporto corsa alesaggio [
C/D ] : Se è minore di 1
significa che il motore è super quadro, se uguale a 1 che è quadro
e se maggiore di 1 che è a corsa lunga.
|
|
I
motori di cui parleremo sono i
4Tempi, che oltre agli organi meccanici precedentemente
descritti, hanno un'ulteriore serie di organi meccanici che
svolgono compiti ausiliari, ma indispensabili al
funzionamento del
motore stesso.
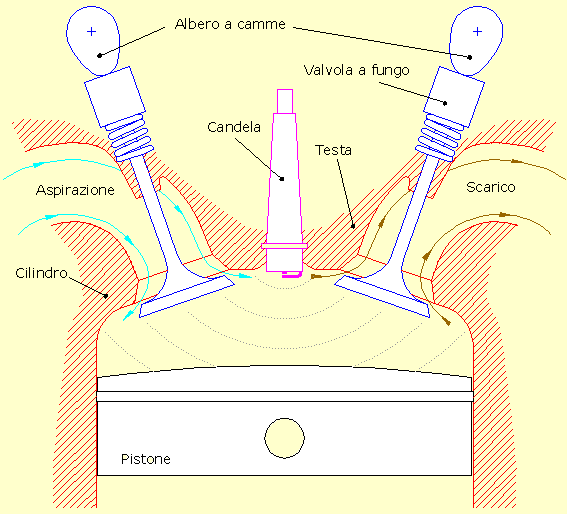
|
In
estrema sintesi, il motore a scoppio funziona perché la benzina,
si mischia con l'aria ambiente che fornisce l'ossigeno necessario alla
combustione, entra nel cilindro, scoppia, cioè brucia
violentemente e fornisce la pressione necessaria a
spingere il pistone, il quale porta in rotazione l'albero a
gomiti, e da questo, per mezzo di vari organi meccanici, come
cambio e trasmissione, la
potenza arriva alle gomme e il veicolo avanza. Ovviamente queste
fasi avvengono grazie a precisi
organi meccanici che svolgono precisi compiti. Nella camera di
scoppio, avvengono, le seguenti operazioni : aspirazione,
compressione scoppio e scarico.
|
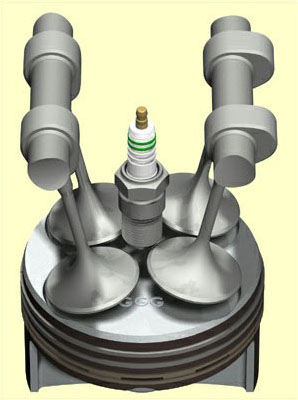 |
|
|
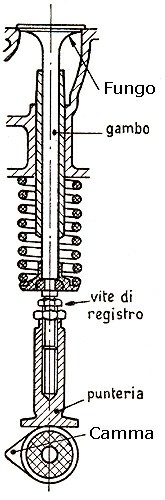
|
Condotto d'Aspirazione
E' il condotto da cui entra
la carica fresca, cioè la miscela di aria e benzina ancora
non bruciata. Infatti a monte della camera di scoppio esiste
un dispositivo che succhia la benzina dal serbatoio e l'aria
dall'ambiente esterno e li miscela in parti ben definite.
Questo dispositivo può essere un carburatore o un sistema di
iniezione.
Valvola d'Aspirazione :
La miscela d'aria e benzina
deve entrare nella camera di combustione solo nel momento
giusto e per un periodo di tempo prestabilito. Per questo
esiste una valvola, che apre e chiude, il condotto
d'aspirazione regolando, quindi, come un rubinetto il flusso
della miscela. Nei motori a 4Tempi, vengono usate usualmente
valvole a fungo, chiamate così per via della sua
caratteristica forma. Le valvole sono comandate dall'albero
a camme.
Albero a camme di aspirazione :
E' un' albero parallelo a quello a gomiti, normalmente posto
sopra la camera di scoppio (come in schema), che prende la
rotazione dall'albero motore stesso, e gira solidale con
esso. Su questo albero sono ricavate le camme, cioè dei
profili eccentrici che girando spingono il piattello della
valvola su e giù , secondo una precisa regola che dipende
dalla forma stessa della camma . Poiché le camme sono legate
all'albero motore è ovvio che se il motore sale di giri
anche l'albero a camme sale di giri e così anche la valvola
d'aspirazione apre e chiude il condotto più velocemente. In
questo modo tutto funziona a qualsiasi regime di rotazione ,
perché ogni operazione accelera o decelera con il motore
stesso.
Condotto di scarico :
E' equivalente a quello di
aspirazione , ma a differenza di questo serve ad espellere i fumi
di scarico , cioè quello che rimane dalla combustione della miscela bruciata, e conduce fino alla
marmitta.
|
 |
Valvola di scarico :
E' equivalente a quella di
aspirazione, solo che regola l'apertura e la chiusura del condotto
di scarico.
Albero a camme di
scarico :
E' equivalente a quello di aspirazione, solo che imprime alla
valvola di scarico, dei tempi di apertura diversi da quelli di
aspirazione.
Candela :
I motori a scoppio , che vanno a benzina si chiamano anche ad
accensione comandata perchè l'esplosione del carburante è
dovuto ad una scintilla, che si innesca perchè della corrente
passa nello spazio tra due elettrodi. L'organo che regola lo scoppio e che genera la
scintilla è la candela, che normalmente è unica e posta verticale
al centro della camera di scoppio. La quantità di corrente e il momento della
scintilla è regolato da organi meccanici o elettronici che
prendono il movimento dallo stesso motore , garantendo anche in
questo caso, il sincronismo tra la velocità di rotazione del
motore e l'accensione.
|
|
La testa e la camera di
combustione :
La testa è uno delle parti
più importante
per un propulsore, sulla quale più si lavora in fase di
progetto. Infatti, la
maggior parte delle azioni che avvengono in un motore e
dalle
quali dipendono le prestazioni, si sviluppano proprio
nella
camera di combustione. Quindi la sua geometria può
migliorare
sensibilmente le prestazioni e dare
caratteristiche specifiche al propulsore. Infatti sulla
testa,
da una parte ci sono tutti gli organi atti alla
distribuzione, cioè tutti quegli organi che servono a far
entrare ed
uscire il carburante, i gas freschi e quelli combusti,
mentre dall'altra la zona che rimane libera quando il pistone è al pms,
cioè la camera
di combustione, la quale condiziona in modo molto
significativo la
combustione e quindi la capacità di generare la potenza
che serve
a spingere il veicolo. In particolare il disegno della
camera di
combustione deve porsi come obbiettivo quello di ottenere
un veloce
processo di combustione, un elevato riempimento di
carburante e
minimizzare le perdite di calore attraverso le pareti.
Ovviamente nella storia dei motori a scoppio, i progettisti si
sono sbizzarriti, producendo teste delle forme e delle geometrie
estremamente varie, anche se oggi per vari motivi, i tipi di testa
più diffusi, per i motori a benzina, sono sostanzialmente quattro.
E' riportato di seguito lo schema delle quattro teste più
diffuse e di un'altra serie di teste delle forme molto curiose.
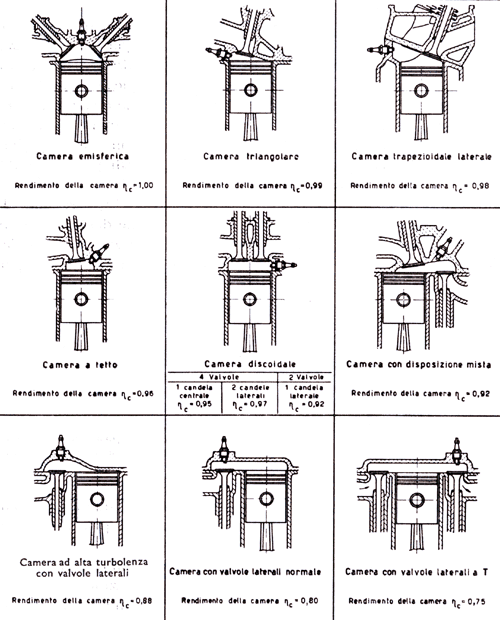
|
|
|
|
|
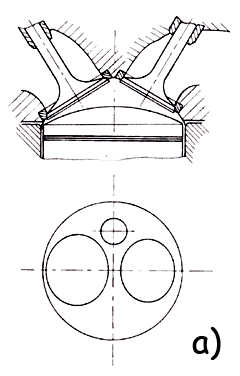
|
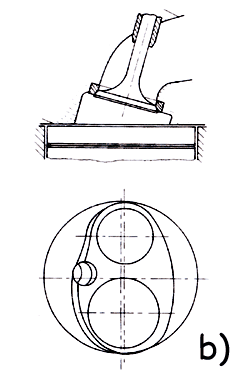
|
|
|
|
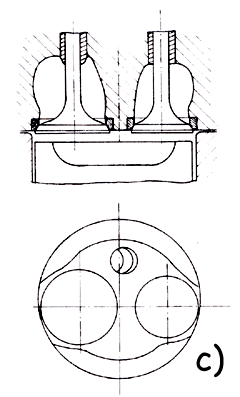
|
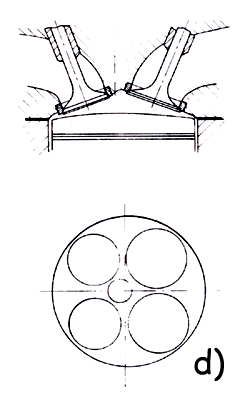
|
|
|
|
a) EMISFERICA
: Offre buoni riempimenti ed elevate
prestazioni;
b) A CUNEO o TRIANGOLARE
: Limita l'effetto della detonazione e produce molta
turbolenza, cosa che favorisce la velocità di combustione;
c) A TAZZA
: Camera molto compatta, bassi consumi
e basse emissioni inquinanti;
d) A TETTO
: Con quattro valvole, permette di ottenere alte
potenze specifiche e resistenza alla detonazione.
|
|
|
 |
|
I pluricilindri:
I motori reali sono nella
maggior parte dei casi composti da un numero di cilindri
superiori a uno. Le piccole utilitarie di solito hanno 4
cilindri in linea, mentre le vetture più raffinate hanno 8,
10 o 12 cilindri. Non esiste un limite teorico al numero
massimo di cilindri che si possono accoppiare per fare un
motore, ma la storia testimonia che è difficile e inutile
superare i 16.
|
Le
configurazioni con cui accoppiare i vari cilindri sono le
più varie. La più semplice è quella dei motori "in
linea" (a), in cui l'albero a gomiti è comune a tutti i
cilindri, e i vari pistoni, bielle, teste sono disposti l'uno
accanto all'altro. Già più complessi ma ugualmente diffusi
sono i motori a "V" (c), in cui c'è sempre un solo albero ma i
pistoni oltre ad essere accanto all'altro sono su due file
distinte ed inclinate di un certo angolo (spesso 90 o
60). Esistono poi altri tipi di motori, molto meno diffusi,
i cui schemi si vedono in figura. Tra questi ricordo in
particolare il Boxter (f) e i motori stellari (m) impiegati
specialmente agli albori dell'aviazione (ad esempio il barone
rosso nella seconda guerra mondiale)
|
Funzionamento del motore
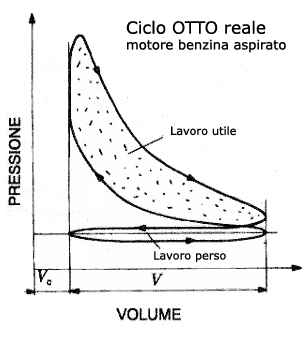 |
|
Aspirazione , compressione , scoppio ,
espansione e scarico ...
queste sono le parole della formula magica che fa funzionare un
motore! Infatti un 4Tempi, come quello di cui mi accingo a
spiegarvi, compie queste quattro fasi ogni due giri dell'albero a
gomiti e ripete queste quattro fasi di continuo molte decine di
volte al secondo. Cioè ogni volta che il motore compie queste
quattro fasi torna nelle condizioni di partenza e può
ricominciare. Tutto quello che succede tra l'inizio e il momento
in cui il motore torna nelle stesso condizioni di partenza si
chiama, nel complesso, CICLO. E' ovvio che le fasi principali del
ciclo siano proprio aspirazione, compressione, scoppio, espansine
e scarico.E' importante accennare al fatto che il motore a scoppio
è una macchina che serve a realizzare proprio questo ciclo. Per i
motori a benzina esiste un ciclo di riferimento teorico noto col
nome di OTTO, mentre nei motori a gasolio il ciclo di riferimento
è quello DIESEL. I cicli OTTO e DIESEL sono due tipi particolari
di cicli termodinamici , che prendono il nome dagli studiosi che
li idearono. Ovviamente un motore è tanto migliore quanto più
riesce ad avvicinarsi alla teoria, cioè quanto più riesce ad
avvicinarsi ad un ciclo OTTO o DIESEL. |
|
 |
Per cominciare si può pensare di
partire nel momento in cui il pistone è nel punto morto
superiore e le valvole sono chiuse. In pratica, siamo
nell'istante in cui il pistone è salito fino al suo massimo e
sta per scendere. Se le valvole rimanessero ferme, è ovvio che
il pistone scenderebbe facendo solo espandere quel poco gas
che rimane nella parte superiore del cilindro e continuando in
questo modo,
l'unico effetto sarebbe quello di frullare il gas senza
generare nemmeno un Cv, anzi si fermerebbe subito. Con
riferimento alle immagini, possiamo per semplicità immaginare che l'albero a
gomiti e quelli a camme, girino in senso antiorario. La loro
velocità è differente, in particolare ogni due giri dell'albero a
gomiti le camme ne compiono uno solo. |
 |
ASPIRAZIONE
La prima cosa che deve succedere
nel motore è quella di far entrare l'aria e la benzina, cioè
la fonte dell'energia del motore. Quindi è necessario che si
apra la valvola di aspirazione e che il pistone scendendo
richiami dal condotto di aspirazione la miscela. Così accade e
il pistone percorre tutto il tragitto dal Pms al Pmi, con la
valvola del condotto di aspirazione completamente aperto,
riempiendo completamente di miscela fresca.
|
 |
COMPRESSIONE
Appena il pistone raggiunge il
punto morto inferiore, il pistone si ferma di nuovo, e
ricomincia a salire e comprime i gas. Per evitare che la
miscela appena entrata riesca dal condotto di aspirazione, è
necessario che la valvola di aspirazione si chiuda. Il pistone
quindi comprime tutto il volume di gas che era presente nel
cilidro, schicciandolo in quella piccola parte di spazio
rimasta libera tra il cielo del pistone e la testa del
cilindro. In genere , il rapporto di compressione, cioè il
rapporto tra il volume iniziale e quello finale della
compressione, è intorno a 1:10 , con valori che arrivano
vicini a 1:20 per i motori più prestazionali. |
 |
SCOPPIO
Una volta raggiunto il punto
morto superiore, la benzina e l'aria sono al massimo della
compressione e sono tutte contenute in un piccolo spazio
intorno alla candela. E' facile immaginare che se si fa
passare corrente sulla candela, si genera una scintilla che fa
prendere fuoco al gas. Precisamente si dovrebbe dire che
esplode, cioè il volume dei gas incrementano di migliaia di
volte generando una pressione incredibile che va a spingere il
pistone verso il basso, ed è questa pressione che tramite la
biella e l'albero a gomiti si trasforma nella potenza utile
che fa avanzare il veicolo. |
 |
ESPANSIONE
Immediatamente dopo lo scoppio,
la pressione dei gas spingono il pistone verso il basso fino a
che il pistone è nel Pmi in cui tutta l'energia dei gas si è
convertita in potenza utile. E' importante far notare
come di tutto il motore l'unica fase utile sia questa. Tutto
il resto è al traino cioè tutte le altri fasi usano parte di
questa energia per funzionare e non la rendono disponibile per
spostare il veicolo.
|
 |
SCARICO
A questo punto il pistone ha
raggiunto il Pmi, l'energia rilasciata dall'esplosione ha
quasi esaurito la sua energia e il pistone è pronto a
risalire. Inizia così la fase di scarico. Lo scopo di questa
fase è quella di espellere i gas combusti per poter riportare
il motore nelle condizioni iniziali, cioè di chiudere il
ciclo, per poi ricominciare da capo. Per far questo si apre la
valvola di scarico, e il pistone nella sua risalita spinge
fuori il gas combusto, che così si dirigono verso la marmitta.
Quando il pistone arriva al Pms, tutti i gas sono stati
espulsi, si chiude la valvola di scarico, si apre quella di
aspirazione e siamo pronti a ricominciare a immettere nuova
miscela fresca.
|
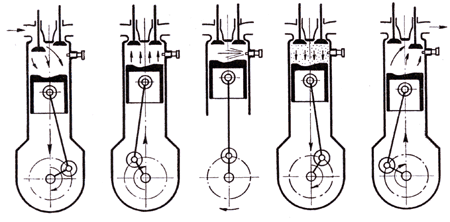
Ecco un'altro modo per
visualizzare tutte insieme le fasi che compie il motore
ogni due giri dell'albero motore.
|
|
Approfondimento :
L'avviamento
Da come vi ho messo le cose, sembra
che sia l'albero, spinto da una forza immaginaria, a trascinare il
motore nel suo movimento, invece è il motore che fornisce
l'energia. In realtà, come noto, che il motore a scoppio ha
bisogno di essere messo in moto dall'esterno e che solo quando è
partito riesce ad auto sostentarsi. Le macchine di inizio secolo
avevano la manovella che usciva dal cofano e dovevano essere
azionate a mano, oggi tutte le vetture di serie hanno un motorino
elettrico, quelle da corsa per risparmiare sul peso sono messe in
moto dall'esterno con un altro motore o spinte (come le moto da Gp).
Quando poi i motori sono stati avviati è l'inerzia del motore
stesso che fa andare avanti le cose ... in pratica nella fase di
scoppio parte dell'energia sviluppata fa accelerare gli organi
meccanici, che poi rallentano nelle altre fasi e permettono che
tutto funzioni . In più per aumentare l'inerzia del motore e per
rendere le fasi più regolari (meno vibrazioni) si aggiunge un
volano cioè un pesante disco che ruota insieme all'albero a
gomiti.
Approfondimento : Gli
anticipi delle valvole
Vorrei introdurre un aspetto
importante sul reale funzionamento dell'aspirazione e scarico, che
è presente in ogni motore. Voglio parlare degli anticipi delle
valvole.
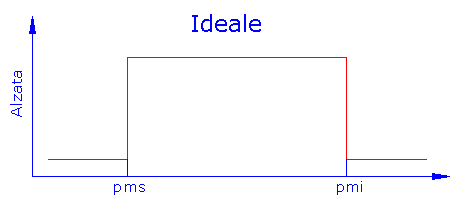
E'
facile immaginare come qualsiasi azione non avvenga perfettamente
istantaneamente, cioè richieda un certo tempo magari breve ma non
nullo. Anche aprire e chiudere le valvole richiede un tempo non
nullo. Dalla spiegazione che vi ho scritto sopra, sembra che le
valvole rimangano chiuse, poi improvvisamente nel momento in cui
il pistone passa dal Pms o Pmi le valvole istantaneamente
percorrono tutto il loro spostamento posizionandosi nella
posizione di apertura e rimangano in tale condizione fino alla
fine della fase nella quale tornano in posizione di chiusura.
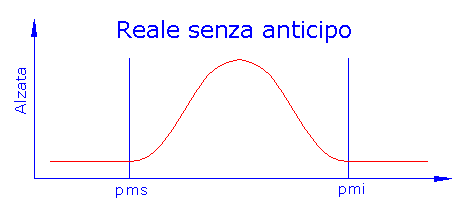
Questo
nella realtà non può avvenire e quello che si riesce a fare è di
far muovere la valvola in un tempo che è paragonabile con il tempo
di una fase, cioè significa che in un quarto del ciclo. Quindi se
si fa cominciare l'alzata della valvola nel Pms e si impone la
chiusura nel Pmi si ha che la valvola non è perfettamente aperta
durante la fase ma all'inizio sarà socchiusa, sarà completamente
spalancata solo intorno alla metà della fase e sarà socchiusa alla
fine della fase. Questo complica molto il flusso dei gas nei
condotti di aspirazione e scarico perchè come detto durante la
fase la valvola sta più tempo nella posizione di quasi chiusa che
in quella di aperta.
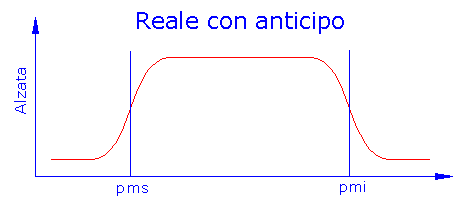
Per
compensare questo problema è necessario anticipare il momento in
cui le valvole si aprono e ritardare il momento in cui si
chiudono, rispetto al momento ideale, in modo che al
raggiungimento di questo, la valvola sia sufficientemente aperta o
chiusa per far bene il suo compito. Questo però significa anche
che ad esempio nella prima parte della compressione, la valvola di
aspirazione sia ancora aperta, col rischio che parte della miscela
sia respinta fuori invece di essere compressa, oppure che
nell'ultima fase di espansione dopo lo scoppio parte della spinta
vada persa perchè i gas combusti escono dalla valvola di scarico
che si sta aprendo.
Curioso, e fondamentale è il momento
dell'incrocio, quello in cui finisce la fase di scarico ed inizia
la fase di aspirazione in cui entrambe le valvole sono
parzialmente aperte, con ovvie conseguenze.
Questo che sembra un problema, in
realtà non è così drammatico. Anzi nei motori moderni e ancor
più in quelli più prestazionali gli anticipi e l'incrocio sono
veramente notevoli, perché si riesce grazie agli effetti
dinamici, non solo a far funzionare tutto come se fossimo nel caso
ideale in cui le valvole si aprono e chiudono nei Punti morti, ma
addirittura si migliora, riuscendo ad esempio ad incamerare più
miscela di quella teorica. Questo fatto è ancora più spinto nei
motori 2t ad alte prestazioni, dove pur funzionando tutto in modo
diverso, l'incrocio dura quasi metà ciclo.
Ovviamente ci sono degli aspetti negativi come l'incremento di
emissioni inquinanti e il peggioramento nel consumo di carburante,
aspetti essenziali in un motore stradale, ed assolutamente inutili
in un motore da corsa.
Di seguito vi riporto il grafico
degli andamenti reali delle aree di passaggio delle valvole di
aspirazione e scarico di un generico motore a 4T. Su questo
grafico è riportata l'area geometrica o efficace (dipende da come
si calcola) rispetto a quella totale, che dipendono dalla
posizione della valvola a fungo. Quindi l'andamento dell'area è
analoga a quella dell'alzata, ed infatti è analogo a quelli che vi
ho disegnato sopra. Spero siano evidenti gli anticipi
dell'apertura e il ritardo di chiusura, e come intorno al Pms si
abbia un ampio incrocio di ben 120 gradi di manovella (180 è una
fase intera).
Diagramma di un motore reale
AAS = Anticipo Alsata Scarico |
AAA = Anticipo Alsata
Aspirazione |
|
RCS = Ritardo Chiusura Scarico |
RCA = Ritardo Chiusura
Aspirazione |
|
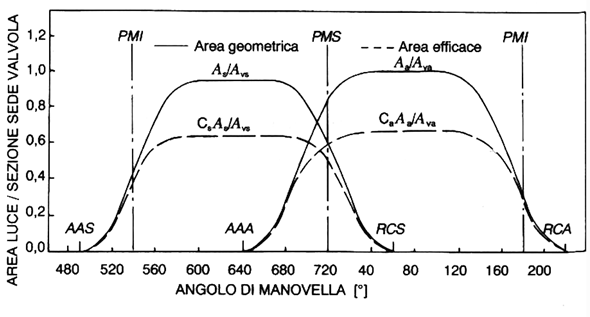
|
|
|
Un'altro modo per
visualizzare le fasi, e gli anticipi è
rappresentato dai diagrammi polari, o circolari. Nel
primo, un cerchio rappresenta lo scarico e un'altro
l'aspirazione. Nel secondo invece è tutto
rappresentato tramite una spirale. Cmq siano fatti sono
evidenti gli anticipi e l'incrocio che si estendono
molto al dilà dei punti morti
|
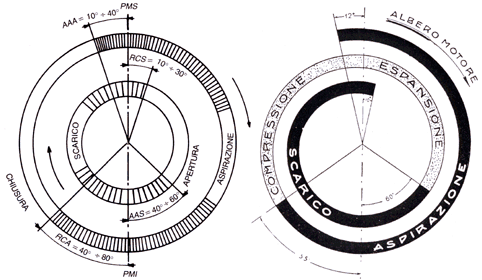 |
|
|
| |
Approfondimento :
L'anticipo della candela
Anche la scintilla della candela che
innesca la combustione ha un certo anticipo rispetto al Pms.
Perchè anche in questo caso il fronte di fiamma ci mette alcuni
istanti per propagarsi. Se si calcola l'anticipo con esattezza si
riesce a far arrivare l'onda di pressione sul cielo del pistone
esattamente quando questo ha raggiunto il pms. Se si facesse
innescare la miscela quando il pistone è al pms, avremo lo strano
effetto che il fronte di fiamma deve inseguire il pistone nella
sua discesa, con il non desiderato effetto di perdere la spinta
per tutto quel tempo che il fronte di fiamma non ha raggiunto il
pistone.
Approfondimento :
Regolazione degli anticipi
Questi anticipi dipendono dalla forma delle camme e sono calcolati
in fase di progetto ad un preciso regime di rotazione, che
normalmente è quello di potenza o coppia massima. E' ovvio che man
mano che ci si allontana da questo regime di rotazione preso di
riferimento le cose vanno via via peggiorando , fino ad essere
persino controproducenti. E' per questo che i motori più moderni
hanno sistemi di fasatura variabile in modo da variare gli
anticipi ad ogni regime di rotazione, ottimizzando le prestazioni
del motore su tutto l'arco di funzionamento.
|
Forza, Coppia, potenza, e
curve caratteristiche
3D animation of a injected V8
La Forza
La forza è un concetto abbastanza
intuitivo e per questo è difficile darne una definizione
esatta. Facendo degli esempi si può pensare che se spingiamo
un oggetto lo facciamo applicando una forza, allo stesso modo
applichiamo una forza se solleviamo un peso, così come due
corpi in contatto si scambiano forze, ecc ecc. Il secondo principio
della dinamica concepito da newton alla fine del 1600, chiarisce in
modo semplice la reale natura della forza. Questo principio afferma che
se si applica una forza ad un corpo questo accelera, cioè
cambia la sua velocità. Ad esempio quando in un'automobile
si azionano i freni, le gomme trasmettono al veicolo una forza
contraria al moto, che fa rallentare il veicolo. Stessa cosa fa il
motore che permette di far incrementare la velocità del
veicolo. La formula che riassume il secondo principio della dinamica
è [ F = m * a ] dove "F" è la forza, "m"
è la massa e "a" è l'accelerazione.
La Coppia
E' importante introdurre almeno a livello intuitivo
è il concetto di coppia, che detto in modo molto
approssimativo, è la forza nelle rotazioni. Infatti se
applicando una forza ad un oggetto, questo si sposta nella direzione in
cui ho spinto, se applico una coppia ad un oggetto questo inizia a
ruotare nel senso in cui applico la coppia. Infatti per imprimere una
rotazione, come dice il nome (coppia), sono necessarie 2 forze uguali
ma contrapposte e che agiscono su assi distinti (rette d'azione).
Quello che conta nella coppia è sia l'entità
delle forze che la distanza tra i loro assi, chiamata braccio. E'
esattamente come per una leva, si può dare molta forza
vicino al fulcro (centro di rotazione della leva) o si può
dare poca forza a grande distanza dal fulcro. Quindi quello che viene
trasmesso dagli organi ruotanti come quelli presenti in un motore
è la coppia e non la potenza. La coppia nel motore si genera
(come vedremo) dalla esplosione della benzina che imprime una pressione
sul pistone che si trasforma in una coppia , attraverso la biella e
l'albero motore che agiscono da leva. Poi la coppia raggiunge le ruote
tramite la trasmissione, composta per lo più da organi
rotanti. La coppia mette in movimento le ruote le quali aderendo al
terreno trasformano la coppia in una forza che fa avanzare il veicolo.
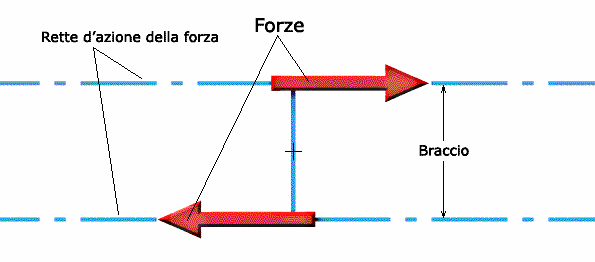 |
La Potenza
L'energia è la capacità di
fare un certo lavoro, come ad esempio la capacità di
spostare un oggetto, la potenza invece è l'energia nel
tempo, cioè tiene conto della capacità di fornire
energia, quindi di fare qualcosa, ma riferita alla velocità
con cui questa energia viene fornita, cioè alla
velocità con cui viene fatta quella certa operazione. Per
capirmi meglio faccio un esempio: poniamo che si abbia una catasta di
legna e questa vada spostata portandola da un posto all'altro. Una
persona può fare questo semplice operazione prendendo un
pezzo di legno alla volta e facendo molti viaggi avanti e indietro fino
a che tutta la catasta è stata spostata. Una ruspa invece
può prendere tutta la catasta in una volta e portarla a
destinazione. L'energia che l'uomo e la ruspa hanno fatto per spostare
la catasta è la stessa infatti l'energia è in
qualche modo legata all'operazione fatta e entrambi hanno portato a
termine con successo l'operazione. Quello che invece cambia
è il modo di farlo, infatti la ruspa ci ha messo molto meno
tempo ... è ovvio che una ruspa è molto
più potente di una persona. La potenza tiene quindi conto
della velocità con cui si fa un'azione. Tornando alle
automobili potrei fare un'altro paragone dicendo che sia una Panda che
una Ferrari sono in grado di raggiungere i 100 Km/h , però
una Ferrari che è più potente ci arriva molto
prima della Panda.
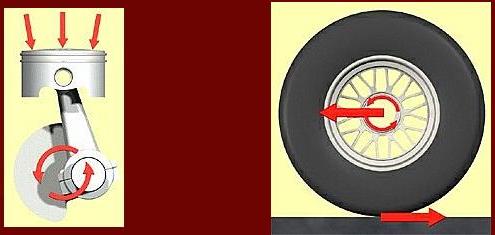 |
La Catena di forza e coppie
Combustione:
Trasforma, tramite una reazione chimica, l'energia del combustibile in
calore e pressione.
Motore:
Trasforma la pressione generata nella combustione, prima in forza
tramite la superficie del cielo del pistone e in coppia tramite la
biella e l'albero a gomiti .
Cambio:
Modifica la coppia in arrivo dall'albero a gomiti del motore, in altra
coppia però ad un numero di giri sfruttabile da un veicolo.
Trasmissione:
Trasporta, per mezzo di organi rotanti , la coppia in uscita dal cambio
verso le ruote, e la ripartisce tra le varie gomme.
La ruota:
Trasforma la coppia che viene dalla trasmissione in forza che spinge il
veicolo, e lo fa avanzare.
Legame tra coppia e potenza
La relazione che lega queste grandezze
caratteristiche è molto semplice:
La Potenza è la Coppia moltiplicata per il numero di giri,
purché espresse nelle unità di misura corrette
(Kw,Nm,1/s), che in formula si esprime :
P = C * n
Ad esempio se un motore a 3000 giri/min eroga 50 Nm di coppia , eroga a
quel numero di giri circa 21 Cv. Infatti 3000 giri/min equivalgono a
314 1/s per cui P=C*n = 15700 kW = 15.7 Kw, che in Cavalli equivalgono
a 21.4. Se lo stesso motore a 5000 giri/min eroga 40 Nm di coppia,
eroga a quel numero di giri circa 28 Cv. Infatti 5000 giri/min
equivalgono a 524 1/s per cui P=C*n = 20900 kW = 20.9 Kw, che in
Cavalli equivalgono a 28.4.
Curve caratteristiche
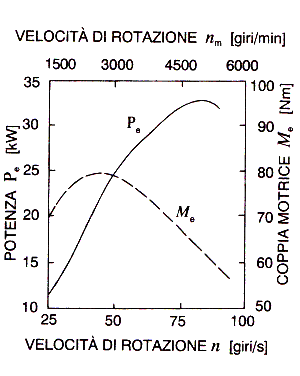 |
Come abbiamo visto la coppia e la potenza sono le
grandezze più significative delle prestazioni di un motore.
Per rappresentare queste due grandezze si usa un grafico come quello a
lato in cui si riporta con due curve l'andamento della coppia e della
potenza al variare del numero di giri. Queste curve si ottengono da
test fatti al motore su opportune apparecchiature dette "banchi prova",
in condizioni si gas completamente spalancato, e massimo carico. Ogni
motore ha delle curve diverse dagli altri, in ogni caso tutte le curve
hanno un andamento simile cioè crescono all'inizio poi
raggiungono un massimo e dopo discendono. Per la coppia questo avviene
perché quando il motore gira piano, è difficile
far entrare la miscela fresca nel cilindro mentre quando il motore ed
ad alto numero di giri è difficile far riempire in modo
ottimale il cilindro di miscela fresca, perché i gas trovano
molta resistenza a fluire velocemente nei condotti, e gli attriti del
motore si fanno dominanti. La curva di potenza invece sale quasi
sempre, tranne nell'ultimo tratto dove tutti gli organi meccanici del
motore vanno così veloci che gli attriti disperdono la
maggior parte dell'energia prodotta. E' poi da notare come la curva
della potenza cresce con maggior rapidità fino al massimo
della coppia in quando in questo tratto crescono sia la coppia che il
numero di giri. Successivamente il numero di giri continua ad aumentare
mentre la coppia diminuisce e curva di potenza (che è il
loro prodotto) tende a spianare fino al massimo. E' intuitivo capire,
che la curva di potenza sale praticamente sempre, se si pensa al fatto
che all'aumentare del regime di rotazione, aumenta il numero di volte
in cui scoppia la miscela fresca in un certo tempo. |
|
|
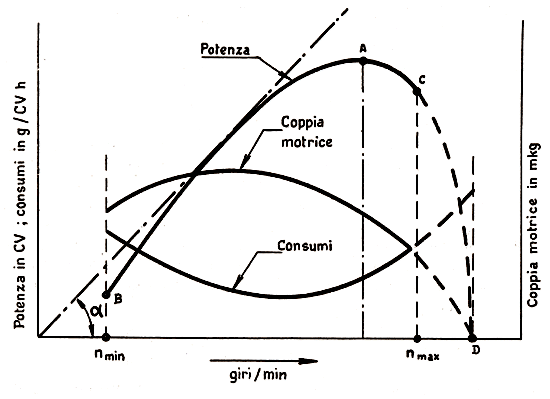 |
| In questa figura oltre alle curve di coppia e
potenza di un motore reale è riportata anche quella del
consumo. E' interessante notare come di solito il consumo minimo si
abbia col la farfalla del gas completamente spalancata e ad un numero
di giri intorno al punto di coppia massima. Un'altra cosa che si nota
è che il punto di coppia massima si ha in corrispondenza del
numero di giri in cui la retta che passa per l'origine degli assi tange
la curva di potenza. |
Coppia, potenza e prestazioni del
veicolo
Pensiamo come prima ipotesi, alla condizione in cui
l'auto mantiene inalterato il rapporto di trasmissione tra il motore e
le ruote, cosa che avviene finché l'auto non cambia marcia.
In queste condizioni l'accelerazione del veicolo ha lo stesso andamento
della curva di coppia, e questo significa ad esempio che la massima
accelerazione si ha in corrispondenza della coppia massima. Allo stesso
modo se un'auto ha una curva di coppia migliore di un'altra, accelera
di più dell'altra. E' da osservare che una volta impostata
una marcia la potenza non conta nulla, e la velocità del
veicolo dipende solo dalla coppia erogata dal motore.
Allora a che serve la potenza ? la potenza rispetto alla coppia
aggiunge l'informazione del numero di giri a cui la coppia viene
erogata, infatti la definizione, come visto, è proprio
coppia per numero di giri. Questo implica che avere una potenza
maggiore a parità di coppia significa che il motore
è in grado di generare quella specifica coppia (e quindi
quella specifica forza per far avanzare il veicolo) ad un numero di
giri più alto. Questo è un grandissimo vantaggio
perché è possibile usare un rapporto di
trasmissione più corto (come andare in 3° marcia
invece che in 4°),
cioè avere molta più
forza che spinge il veicolo a parità di velocità
del veicolo. In sintesi avere più potenza permette di avere,
alla stessa velocità del veicolo, più coppia alle
ruote e quindi maggiore accelerazione.
Quindi quando si progetta un motore da corsa, si cerca di avere
più potenza possibile per poter avere più
accelerazione possibile, e si cerca di avere un' andamento della curva
coppia il più possibile progressivo in modo da non avere
strappi o cali.
In questa ottica è quindi poco importante sapere se la
potenza deriva da molta coppia a basso numero di giri o poca coppia ad
alto numero di giri. E' per questo che due vetture spinte da due motori
così diversi come un diesel o un benzina, se hanno la stessa
potenza si comportano in modo praticamente identico.
In
realtà la presenza del turbo (ormai sempre presente nei
moderni motori diesel) garantisce un'andamento di coppia più
ricco ai bassi regimi, rispetto ai benzina, che di solito sono
aspirati, con conseguente vantaggio per l'accelerazione del veicolo in
fase di ripresa.
La sovralimentazione
|
La sovralimentazione è un metodo,
adoperato nei motori a combustione interna, per ottenere un
aumento, anche elevato, della potenza del motore. In pratica come
abbiamo visto uno dei limiti dei motori è nella quantità di
carburante ed aria che riempie il cilindro prima della
compressione e dello scoppio. Infatti nei motori aspirati, è il
pistone che con il suo movimento nel cilindro richiama la miscela
dall'esterno. Lo scopo della sovralimentazione
è quello di utilizzare un marchingegno esterno, ad esempio una
pompa, che spari dentro il cilindro una quantità di miscela
superiore o spesso molto superiore a quella normale, ottenendo di
fatto un notevole incremento del coefficiente di riempimento con
il conseguente innalzamento del valore della pme e quindi della
potenza utile.
Per realizzare, nella pratica, la
sovralimentazione,
i metodi sono molteplici, ed assumono vari nomi. Il più usato,
efficiente, ed energeticamente furbo è quello basato sul
turbo-compressione, così che spesso si parla di turbo per parlare
della sovralimentazione
in generale.
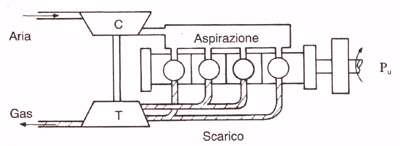 Il
turbo-compressore è un marchingegno che recupera l'energia dai gas
combusti espulsi dal motore per poi riutilizzarla per comprimere
la miscela in ingresso e poterla così sparare dentro il cilindro.
E' costituito da una turbina ed un compressore montati sullo stesso
albero che li fanno ruotare alla stessa velocità. Il
turbo-compressore è un marchingegno che recupera l'energia dai gas
combusti espulsi dal motore per poi riutilizzarla per comprimere
la miscela in ingresso e poterla così sparare dentro il cilindro.
E' costituito da una turbina ed un compressore montati sullo stesso
albero che li fanno ruotare alla stessa velocità.
La turbina è un disco munito di palette ed è usata allo scopo di
trasformare l'energia dei gas di scarico in energia.
Il compressore è simile, come costruzione, ma funziona esattamente
all'opposto. Prende energia dalla turbina, tramite l'alberino ed energizza il fluido
dandogli pressione e velocità.
Questo è il funzionamento schematico e nella sua
formulazione più semplice; vediamo ora il tutto in
dettaglio, analizzando pregi e difetti.
|
|
|
La turbina e i gas di scarico
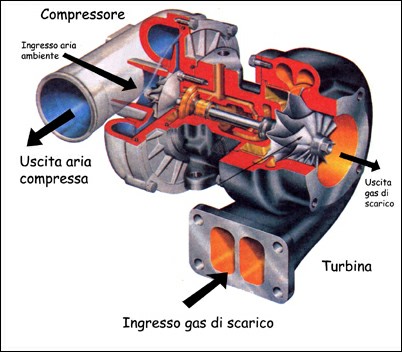 I gas di scarico vengono raccolti e
convogliati alla turbina, però essa lavora al meglio con un flusso di gas costante,
ma i gas di combustione vengono espulsi da ogni cilindro in maniera non continua.
Infatti la fase di scarico occupa solo un quarto del ciclo quindi
si manifesta per ogni cilindro ogni due giri dell'albero a gomiti .
Per questo motivo per certi motori (ma non per quelli per auto) si inserisce un "serbatoio" di
raccolta dei gas di scarico che fa si che i gas entrati in maniera
impulsiva, rallentino ed escano da questo come una corrente
continua.
Questo metodo ha il vantaggio di massimizzare il rendimento della
turbina, che è un tipo di macchina adatta a lavorare in condizioni
costanti, ma ha due svantaggi
evidenti: il primo è che spesso sotto il cofano di una vettura non
c'è lo spazio per ospitare questo serbatoio che deve essere di
notevoli dimensioni; l'altro
svantaggio deriva dal fatto che il serbatoio fa si che la turbina
risenta con un grosso ritardo del cambiamento di velocità del
motore e quindi non reagisca in maniera pronta alla richiesta di
potenza dal motore,
per questo motivo tale metodo è usato per motori a regime
costante, quali quelli per produzione d'energia. I gas di scarico vengono raccolti e
convogliati alla turbina, però essa lavora al meglio con un flusso di gas costante,
ma i gas di combustione vengono espulsi da ogni cilindro in maniera non continua.
Infatti la fase di scarico occupa solo un quarto del ciclo quindi
si manifesta per ogni cilindro ogni due giri dell'albero a gomiti .
Per questo motivo per certi motori (ma non per quelli per auto) si inserisce un "serbatoio" di
raccolta dei gas di scarico che fa si che i gas entrati in maniera
impulsiva, rallentino ed escano da questo come una corrente
continua.
Questo metodo ha il vantaggio di massimizzare il rendimento della
turbina, che è un tipo di macchina adatta a lavorare in condizioni
costanti, ma ha due svantaggi
evidenti: il primo è che spesso sotto il cofano di una vettura non
c'è lo spazio per ospitare questo serbatoio che deve essere di
notevoli dimensioni; l'altro
svantaggio deriva dal fatto che il serbatoio fa si che la turbina
risenta con un grosso ritardo del cambiamento di velocità del
motore e quindi non reagisca in maniera pronta alla richiesta di
potenza dal motore,
per questo motivo tale metodo è usato per motori a regime
costante, quali quelli per produzione d'energia.
Nel
caso automobilistico gli scarichi vengono convogliati direttamente
verso la turbina. Questo purtroppo farà lavorare la turbina in
maniera irregolare e quindi meno efficiente ma la
risposta sarà sicuramente più immediata, e
seguirà, un pò meglio, le richieste del motore. Anche il
modo di collegare gli scarichi, tra loro, prima di entrare nella
turbina, richiede degli accorgimenti: un ciclo del motore avviene in
due giri e ogni cilindro fa una fase di scarico in mezzo giro (di
più se consideriamo anticipi di apertura e ritardi di chiusura)
quindi se avessimo un solo cilindro avremmo una mandata per solo un
quarto del periodo del ciclo e il resto del periodo non avremmo flusso.
Se accoppiamo due cilindri le cose già migliorano e ancora
meglio con tre cilindri perchè riusciamo a riempire quasi
tutto il ciclo con del flusso.
|
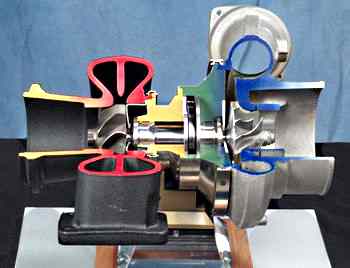
Spaccato Turbina
|
Invece se abbiamo più di tre cilindri collegati insieme
direttamente si rischia che i flussi interferiscano fra di loro.
Cioè può capitare che un cilindro che inizi a scaricare, trovi all'uscita
lo scarico di un'altro cilindro
che già aveva iniziato la fase di espulsione. Per questo è bene che i cilindri o
siano adeguatamente sfasati fra di loro (se sono minori meno di 3) o adottino particolari convogliatori
(se sono 4 o più).
Ovviamente se i cilindri sono multipli di tre si possono mettere
più turbine, ognuna alimentata dai tre cilindri. Ad esempio un 12
cilindri a V, da il massimo con 2 gruppi di turbo-compressori , uno
per bancata (BI-turbo), ognuno dei quali alimentati dai 6 cilindri
raggruppati in due blocchi di 3 cilindri divisi tra loro dai
convogliatori.
|
|
|
L'aria ambiente e il
compressore
Per quanto riguarda il lato
dell'aspirazione si ha il compressore che aspira aria dall'ambiente
e la manda dentro il motore. Nei sistemi un pò più sofisticati, ma
oggi praticamente sempre, prima di entrare nella camera di scoppio
l'aria compressa passa prima da un "itercooler". Infatti i gas,
quando vengono compressi, per loro
natura aumentano la loro temperatura. Questa alta temperatura
annulla in parte l'effetto della compressione perchè i gas caldi
sono più rarefatti. Quindi per evitare questo, si ricorre, appunto, all'intercooler
che non altro che uno scambiatore di calore aria-aria: è in pratica come il
normale radiatore dell'auto, ma
invece di avere al suo interno acqua, ha l'aria appena compressa; l'aria viene così
raffreddata fino a circa la temperatura ambiente e può finalmente entrare nel motore.
|
|
I Problemi del
Turbo-compressore
Come accennato, anche con la
soluzione di convogliare gli scarichi verso la turbina non
garantisce una perfetta risposta del turbo alle richieste del
motore. Infatti il motore e la turbina lavorano secondo un circolo
vizioso. Se il guidatore, schiaccia il pedale, perchè ha bisogno
di potenza per accelerare, il motore per far questo, deve
iniettare più aria e più carburante. L'arrivo dell'aria dipende in
buona parte dal compressore, il quale però usa l'energia della
turbina che si alimenta dai gas di scarico. Quindi la turbina per
fornire più energia al compressore ha bisogno di più gas di
scarico, ma questi non si producono se il compressore non alimenta
il motore con maggior aria e carburante. Per uscire da questo circolo il
motore ha bisogno i qualche istante, così che il guidatore, che
richiede potenza se la ritrova dopo un pò, magari quando non serve
più tutta quella potenza o
addirittura non serve proprio. Questo ritardo che è sempre
superiore a quello che può avvenire in un aspirato, in cui è
praticamente inavvertibile, può andare da alcuni millisecondi per
motori raffinati e che stanno girando ad alto numero di giri, a
svariati secondi per motori meno efficienti e che stanno girando a
basso numero di giri, generando notevoli inconvenienti, e
soprattutto rischi per la sicurezza.
Un'altro problerma è che l'effetto
benefico del turbo varia in funzione dei giri del motore, perchè
con i giri varia la portata dei gas di scarico prodotti. Se il
motore gira piano, produce pochi gas e la turbina non
riesce più a prenderene energia, sia perchè appunto
l'energia disponibile è poca sia perchè la turbina lavora in
condizioni estremamente lontane da quelle ottimali cioè con un
rendimento bassissimo. Quindi l'uso del turbo è estremamente utile
per i motori da competizione, o per quelli di serie molto
sportivi, in quanto da il meglio ad alti regimi di rotazione ed ad
alte potenze. Viceversa per i veicoli di serie normali, ha
poco senso utilizzarlo, in quanto, la maggior parte dell'uso del
motore viene fatta a bassi regimi.
Oltre a questo chi ha provato, un'auto
sovralimentata, specie se di vecchia generazione (ad esempio la
FIAT UNO), avrà avvertito un'altro dei suoi problemi. Il fatto è
che, l'effetto positivo del turbo inizia a funzionare solo ad un determinato numero di giri,
mentre al disotto di questo il turbo è addirittura un freno. Così
si ha che all'inizio , in fase di accelerazione il motore stenta a
salire di giri e quando il turbo "entra",
sembra che il motore raddoppi improvvisamente di potenza, dando
per un' istante una fortissima accelerazione, nota anche col
termine "tecnico" di "calcio in culo" ! E' ben comprensibile
che questa brusca accelerazione renda difficile e pericolosa la
guida, sia quella di tutti i giorni che quella al limite in
pista, e soprattutto se il fondo stradale è bagnato o scivoloso, o
se peggio si sta percorrendo una curva. Nelle moto poi questo
problema è ancor più sensibile, così che i modelli di moto turbocompresse,
da quando esistono le moto, praticamente si contanto sulle
punta delle dita.
Per migliorare queste problematiche, sono state inventate le
turbine a geometria variabile, nelle quali le alette all'ingresso
della turbina cambiano d 'incidenza, cioè ruotano su se stesse, in modo che a bassi
giri, i gas abbiano un angolo d'entrata che migliori il funzionamento
dalla turbina, cioè il suo rendimento e quindi di tutto il
turbo-compressore. Al contrario, per quando l'effetto del turbo è
superiore delle richieste del motore, (ad esempio quando dopo
un'accelerazione si frena), oltre a poter sfruttare la geometria
variabile per far peggiorare le prestazioni della turbina, esiste una valvola che permette di scaricare parte
dei gas combusto, abbassando di fatto la pressione nel condotto di
aspirazione.
Per sfruttare a pieno le geometrie
variabili e per compensare i problemi residui, oggi si ricorre ad
un massiccio uso dell'elettronica che fa in automatico quello che
farebbe un bravo pilota, permettendo a chiunque di guidare un
turbo anche di notevole potenza senza grossi problemi, però
peggiorandone, di fatto, l'efficacia, e spesso annullando il
fascino di questa soluzione tecnica.
Il
turbo nei motori a benzina : luci ed ombre
Nei motori a benzina l'uso del turbo
è estremamente limitato dalle caratteristiche chimico- fisiche del
carburante, così che il suo impiego per veicoli di serie è in
generale poco utile, se non per dare un carattere particolare al
propulsore.
Immaginiamo, quindi, di avere un motore
aspirato, di applicarci il turbocompressore e di vedere cosa succede. La pressione massima
che si raggiunge nel motore a seguito della combustione della
miscela, aumenterà sensibilmente, per effetto della sovralimentazine, in quanto
viene bruciata,
nella camera di combustione, una quantità di carburante e aria superiore.
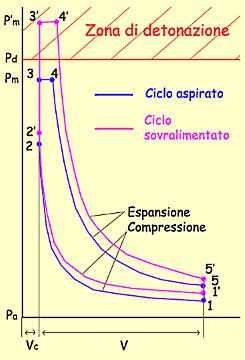 |
Questo comporta, per prima cosa, che il motore subirà
sollecitazioni
maggiori e probabilmente dannosi così che i motori turbocompressi
dovranno essere, in generale, più massicci e quindi più pensati dei
corrispondenti motori aspirati a pari cilindrata, ma spesso più
leggeri a parità di potenza erogata.
Inoltre avremo vari fenomeni di
combustione anomala tra i quali il più grave e preoccupante è
quello della
detonazione, dovuto soprattutto ad una temperatura e pressione
massime troppo elevate. In più la detonazione è totalmente imprevedibile e si
auto-alimenta per cui porta in breve tempo alla rottura degli
organi meccanici. (vedi pagina specifica)
V : Cilindrata
Vc : Volume camera di combustione
Pa : Pressione atmosferica
Pm : Pressione massima
P'm : Pressione massima per il ciclo sovralimentato
Pd : Pressione di inizio detonazione
|
Questo limita moltissimo il livello
di sovrappressione che può sviluppare il turbo, dato che già i
motori aspirati di serie sono tarati al limite della detonazione.
La strada giusta da seguire è quella di diminuire il rapporto di compressione
del motore, cioè aumentare il volume della camera di combustione,
a parità di cilindrata. Agendo in questo modo, la pressione raggiunta
quando il pistone è al pms, tornerà ai
valori ammissibili. Con questo metodo, si perde un pò di
rendimento ideale (che dipende dal rapporto di compressione) ma
si incrementa il coefficiente di riempimento, con la conseguenza
che globalmente aumenta la pme e quindi la potenza.
|
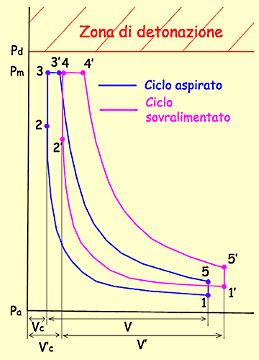 |
Si può vedere dai grafici le due
situazioni. Nel primo i due motori hanno lo stesso rapporto di
compressione, ma uno è sovralimentato e l'altro no.
Il ciclo aspirato rimane nella zona
sicura, mentre il secondo arriva nella zona della detonazione con
i problemi visti.
Nel secondo grafico la curva del
ciclo ha la stessa altezza massima, ma un rapporto di compressore
minore. Entrambi i cicli hanno una pressione massima che è in zona
"sicura" ma il ciclo sovralimentato ha un' area maggiore che
corrisponde, nella stessa maniera, ad un aumento del lavoro fatto
dal motore, e quindi della potenza.
V : Cilindrata
Vc : Volume camera di combustione
Pa : Pressione atmosferica
Pm : Pressione massima
P'm : Pressione massima per il ciclo sovralimentato
Pd : Pressione di inizio detonazione
|
|
|
|
|
|
|
Il turbo nei motori diesel : tutte luci
Quello che limita l'uso del turbo
nel benzina, è invece il grande pregio che ha permesso al motore
diesel di fare il salto di qualità diventando, oggi giorno, il
motore più venduto in Italia. Infatti nel diesel, la miscela di
carburante ed aria, non brucia a seguito dell'innesco tramite
scintilla come nel motore a benzina, ma esplode a causa della
compressione e della temperatura. E' quindi evidente che più
"roba" c'è nel cilindro e più saranno alte le pressioni alla fine
della corsa di risalita del pistone. Questo, da una parte,
permette di usare il sovralimentatore senza particolari limiti,
dall'altro introduce notevolissimi altri vantaggi. In primis la
maggior compressione garantisce una maggior velocità di
combustione, che significa più potenza, meno inquinati, meno
rumore, meno vibrazioni. Poi l'uso del turbo permette dei lavaggi
eccellenti e un' ottimo raffreddamento, perchè la sovrappressione
generata dal compressore fa scorrere molta aria nel cilindro
durante l'incrocio. Infatti il turbo nei diesel lavora solo con
l'aria, mentre il carburante viene vaporizzato direttamente nella
camera di combustione tramite uno o più ugelli , quando le valvole
sono tutte chiuse. Questa tecnica si chiama iniezione diretta. Poi
il turbo permette anche di costruire condotti di aspirazione anche
tortuosi ma con il pregio di poter generare alte turbolenze, che
garantiscono un'eccellente miscelazione tra il gasolio e l'aria
con notevoli benefici per la combustione.
L'unico aspetto negativo dei turbo-diesel moderni è che l'estrema
complicazione tecnica di tutti gli organi che devono lavorare in
perfetto sincronismo e con possibilità di errori ridottissime,
specie per rimanere nei limiti di legge per quanto riguarda le
emissioni inquinanti, obbliga ad un uso spaventoso di elettronica
che rende questi propulsori, complicati, pesanti, costosi, meno
affidabili e nei quali per metterci le mani bisogna essere
laureati in elettronica e in informatica.
|
|
Il Volumetrico : Poca sostanza,
molto marketing
Il compressore volumetrico, oggi usato
solo su pochissime vetture (ad esempio le Mercedes col nome
commerciale di Kompressor), è un tipo di sovralimentazione
inventato e utilizzato per la prima volta agli albori
dell'aviazione, per compensare la rarefazione dell'aria in alta
quota, ma fu subito abbandonato per i motivi che vedremo. In
pratica il compressore è montato sull'albero motore ed assorbe
energia da questo e comprime l'aria da inviare ai cilindri. Un
piccolo vantaggio come potenza finale si ottiene , ma dal punto di
vista energetico e dei consumi, non ha alcun senso utilizzarlo, in
quanto per generare la compressione si assorbe l'energia che
dovrebbe spingere il motore, invece di quella buttata con i gas di
scarico. In pratica il propulsore deve buttare via del carburante
per generare la potenza che serve ad ignettare altro carburante.
Per capirci meglio faccio un esempio: immaginiamo un motore che è
in grado di generare 10 di potenza con 10 di carburante. Gli
mettiamo il compressore volumetrico che assorbe 2 di potenza. Il
compressore inietta abbastanza carburante (14) da portare la
potenza del motore a 14. In totale quindi la potenza disponibile
per far avanzare il veicolo è 12, ma usiamo 14 di carburante.
Abbiamo quindi ottenuto maggiore potenza ma l'efficienza del
propulsore nel suo complesso è diminuita sensibilmente perchè ci
vuole 1.17 di carburante per 1 di potenza invece di 1a1.
L'unico vantaggio che ha questo tipo di sovralimentazione rispetto
al normale turbo, è che il compressore essendo trascinato dal
motore non ha problemi di ritardi o di brusche accelerazioni. In
pratica, fornisce un incremento di potenza modesto, ma su tutto
l'arco di utilizzo del motore.
Perchè viene usato? La risposta non è facile. Da un lato
probabilmente c'è una carenza tecnica nel saper fare motori
aspirati di buona qualità, ma soprattutto è una questione di
marketing, infatti la pubblicità fa credere che questo sia un
sistema rivoluzionario, innovativo, e raffinato quando
invece è una schifezza. Le auto per essere vendute hanno bisogno
di un qualche "appil" cioè di qualche carattere distintivo, e con
una buna campagna pubblicitaria si fa credere quello che si vuole.
|
|
Conclusioni
L'adozione del Turbo-compressore ha
in sintesi le seguenti caratteristiche:
PRO:
- riduce imgombro e peso a parità di potenza sviluppata
- può in generale diminuire i consumi specifici
- rende il motore meno rumoroso
- rende i gas di scarico meno inquinanti
- rende il motore poco sensibile alle variazioni di quota
CONTRO:
- aumento dei carichi meccanici e termici sugli organi del motore
- porta al pericolo di detonazione nei motori a benzina
- andamenti di coppia e potenza non adatte alla trazione stradale
- lunghi tempi di risposta nei transitori
Quindi l'adozione del
turbocompressore, porta a motori solidi, affidabili e alta potenza
specifica, ma non particolarmente adatti alla trazione degli
autoveicoli.

Logo della F1 usato dal 1987 al 1994
|
|
 |
La stagione 1983 è quella dell'addio
alle minigonne, le bandelle laterali che costituivano la componente
tecnica essenziale delle wing car. Le sfide tecniche della stagione
sono ora rappresentate dal c.d. fondo piatto e dai motori turbo. Ora,
per ottenere carico aerodinamico, la down force che tiene le vetture
incollate al suolo, bisogna puntare esclusivamente sugli alettoni non
essendo più possibile sfruttare le wing car con le loro
minigonne.
Il 1983 si situa in piena era turbo con propulsori
da 900 cavalli in gara e da 1200 in qualifica.
Nel 1983 la McLaren non avrà una buona stagione, salvo il
famoso gran premio di Long Beach con la doppietta Watson-Lauda ... ma
in realtà la McLaren è pronta per dominare il
1984. Al salone di Ginevra, infatti, viene presentato il propulsore
TAG-Porsche destinato ad equipaggiare la McLaren l'anno seguente. Il
motore che segnerà
una svolta per la McLaren, nasce grazie ai finanziamenti di Mansour
Ojjeh, già
partner della Williams.
Dunque, il colpo di genio di Ron, fu quello, nel 1983, di convincere la
Porsche a costruire un turbo da dare alla McLaren: al mondo non
esisteva un costruttore con maggior esperienza della Porsche per quanto
riguarda i turbo. Come abbiamo detto già, l'altra mossa
geniale di Ron Dennis fu quella di ottenere il sostegno economico della
TAG di Ojjeh che entrerà in seguito a far parte come
co-proprietario della McLaren International, di cui è
azionista ancor oggi.
Sempre in quel periodo, all'inizio del 1984, la McLaren si assicura un
uomo dall'esperienza unica nel settore del mondo delle corse (dire f1
sarebbe riduttivo): si tratta del messicano, Jo Ramirez che
rimarrà nel team McLaren sino al suo ritiro dalle corse nel
2001 ma che ancor oggi è uno di "famiglia" nel leggendario
team inglese. Ramirez assume la qualifica team coordinator: il suo
compito attiene all'organizzazione del lavoro quotidiano, alla gestione
del lavoro in pista, alla logistica in generale, insomma. Questa
divisione dei compiti, lascia quindi libero Dennis di occuparsi solo
dell'alta gestione del team, lasciando il prezioso lavoro di tutti i
giorni (che va seguito con costanza e totale attenzione minuto per
minuto) a Ramirez: anche questa organizzazione, nonchè le
qualità umane e professionali del nuovo arrivato, faranno
grande la McLaren negli anni seguenti.La vettura presentava come principale
caratteristica l'utilizzo della fibra di carbonio per la realizzazione
del telaio, soluzione adottata dalla McLaren sin dal 1981.
A differenza
del team anglo-neozelandese, il progettista Gordon Murray
utilizzò la fibra di carbonio solo per la parte superiore
del telaio, lasciando la parte inferiore in alluminio a nido d'ape,
copiando letteralmente la soluzione adottata dalla Ensign nel 1982.
La Brabham BT52Ma anche esternamente, la monoposto era molto diversa
rispetto a quella dell'anno precedente.
Le fiancate erano ora molto corte con una disposizione detta "a
freccia" che offriva oltre ad una bassa portanza, anche un arretramento
dei pesi verso il posteriore. Le sospensioni anteriori presentavano un nuovo schema, a quadrilateri
deformabili con puntone diagonale (in inglese detto push-rod) ancorato
alla parte bassa del mozzo ruote, che spingeva un bilancere nel telaio
per comprimere la molla-ammortizzatore. La monoposto montava pneumatici
Michelin.


Il motore era un 4 cilindri in linea BMW denominato
M12/13, montato in posizione posteriore longitudinale, la cilindrata
era di 1.499 cc e sovralimentato mediante singolo turbocompressore, era
capace di sviluppare in gara una potenza di 740 cv con sovrappressione
di 3 bar e accreditato della potenza di circa 800 cv durante le
qualifiche con una pressione di 3,2 bar.
Torniamo indietro all'83:
A vincere il titolo sarà il primo campione del mondo turbo
della storia.
Uno dei team più forti è la Brabham che alle sue
spalle ha uno sponsor come la Parmalat. Mentre la McLaren progetta il
dominio del 1984, la Brabham con motore turbo BMW è pronta a
far suo il titolo del 1983. A contendere il titolo alla Brabham sono la
Renault (altri specialisti del turbo) e la Ferrari.
A far suo il titolo piloti del 1983 sarà Piquet con la
Brabham BMW (con qualche polemica legata alla benzina usata dalla
Brabham), mentre per il 1984 la McLaren attuerà
effettivamente il dominio le cui base furono gettate al momento
dell'accordo con la Porsche. Il titolo piloti del 1984 è una
faccenda a due tra i piloti della McLaren: Lauda contro Prost, alla
fine prevale Lauda di 1/2 punto, 72 a 71,5. Terzo è De
Angelis con la Lotus Reanult. Una delle stelle di quel mondiale, seppur
per una sola gara, fu il giovanissimo Senna che con la Toleman diede
spettacolo sotto l'acqua a Montecarlo.
Per quanto riguarda la Coppa costruttori, ad aggiudicarsela per il 1983
è la Ferrari mentre nel 1984 è la McLaren.
Come si può facilmente comprendere, la scelta di abolire le
minigonne e l'effetto suolo (una scelta giusta a fronte della
pericolosità assurda di quelle vetture) ebbe un impatto
importante sulla f1 che vide le squadre impegnate puntare su altre
strade tra cui lo sviluppo dei motori turbo. Questo ha costretto le
squadre ad appoggiarsi alle grandi case costruttrici per realizzare i
motori turbo. |
|
|
|
Differenze tra un motore di F1 e un motore di una vettura stradale
 |
Le differenze dei motori che equipaggiano le vetture stradali da
quelli di una monoposto da F1 sono notevoli. Nonostante l'esistenza di
motori con cilindrata superiore a 3 litri (es. Lamborghini Diablo 6.0 da
6 litri), nessuno di questi arriva a potenze di 850 cavalli. Ciò è
dovuto sia all'inutilità di queste potenze in città o in autostrada, sia
perchè il consumo di benzina sarebbe troppo elevato, per non parlare
dei costi esorbitanti e del problema ambiente. Le differenze, comunque
si possono notare anche nella realizzazione di un motore da formula 1.
In essi ci sono componenti in ceramica e fibre di carbonio che si
dilatano meno del ferro alle alte temperature e sono meno pesanti.
Naturalmente questi componenti non possono essere utilizzati in parti
meccaniche che devono essere resistentissime (albero motore, pistone,
ecc.). Sebbene solo il 5% del motore è costituito da questi componenti
(infatti 1/3 è realizzato in acciaio e quasi 2/3 in alluminio), essi
svolgono un ruolo importante nell'incremento della potenza.
Altre differenze si possono trovare nella distribuzione che di norma
è a due alberi a camme in testa, con quatto o cinque valvole per
cilindro. L'adozione di due alberi a camme in testa consente di ridurre
al minimo assoluto il numero di componenti interposti tra ogni valvola e
l'eccentrico che le impartisce il moto.Questo vuol dire che l'inerzia
dei componenti in moto alterno risulta minore e che quindi, a parità di
sollecitazioni meccaniche, sarà possibile raggiungere regimi di
rotazione più elevati. |
|
Anche nei pistoni si può trovare una differenza d'altezza che è molto
ridotta rispetto al diametro, al fine di ridurre il peso e le perdite
per attrito,
sono sempre dotati di ampie sfiancature laterali.
Anche le bielle spesso sono in titanio, materiale
dalle elevatissime caratteristiche meccaniche, che ha un peso molto
contenuto ed un costo
elevatissimo, che ne ha sempre confinato
l'uso all'industria aerospaziale o al mondo della F1
|
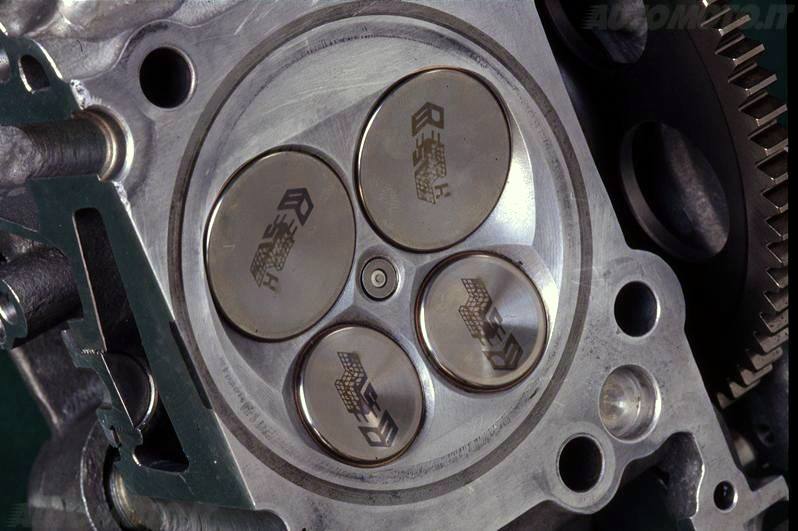 |
Camera di combustione molto appiattita e raccolta; valvole (in titanio) di grandi dimensioni
|
|
Per eliminare le deformazioni elastiche anomale delle molle di
richiamo delle valvole, si usa un sistema di richiamo pneumatico
chiamato "desmodromico". Normalmente le valvole vengono richiamate in
posizione di riposo da una molla, mentre nel sistema desmodromico anche
il movimento di ritorno viene comandato meccanicamente da un bilanciere,
nello stesso tempo in cui si comanda l'apertura della valvola. Questa
soluzione che consente di utilizzare alberi a camme che imprimono
notevolissime accelerazioni alle valvole sia in fase di apertura che in
fase di chiusura. Rispetto a un sistema tradizionale la valvola viaggia a
una velocità molto più elevata e impiega quindi meno tempo sia per
aprirsi che per chiudersi, favorendo quindi la respirazione del motore.
Un altro vantaggio del "desmo" risiede nel minor assorbimento di
potenza, in quanto non vi sono molle da comprimere per aprire le valvole
e la rotazione dell'albero a camme risulta molto più libera.
La trasmissione Così come le normali auto hanno la frizione, le marce e il differenziale, anche
le monoposto sono dotate della trasmissione che però è molto più sofisticata.
Basti pensare che deve poter scaricare su due ruote ben 800 hp di potenza.
Frizione Nelle monoposto la frizione è direttamente collegata al motore ed è
fissata proprio attraverso il motore e la scatola dei rapporti. Le
aziende che producono frizioni sportive sono due: "AP racing" e "Sachs",
che producono frizioni in carbonio che devono resistere a temperature
elevatissime (500 °C).
Per regolamento la frizione deve essere elettro-idraulica e normalmente
non pesa più di 1.5 kg. La frizione, essendo quasi automatica, non viene
usata
manualmente, ma si attiva da sola quando si cambia marcia (sia quando si
sale
che quando si scala). Solo alla partenza e al pit stop, cioè quando si
passa da N alla prima, si utilizza la frizione che oggi, grazie
all'elettronica non assolve più quella grande importanza che aveva
prima. Infatti alla partenza della gara, per evitare di far slittare le
ruote i piloti lasciavano la leva della frizione (è posizionata dietro
al volante sotto la leva per salire di rapporto) dolcemente. Oggi invece
interviene in ausilio l'elettronica che "limita" la potenza al motore
quando le ruote stanno per slittare.
La frizione di una monoposto ha una dimensione di circa 100 mm di
diametro
|
|
I freni delle vetture da F1 sono a dir poco stupefacenti. Infatti
essi possono rallentare una macchina da 300 km/h a 50 km/h in quattro
secondi percorrendo solo 130 metri!!!Nella figura si vede
come i freni Brembo della Minardi siano al massimo tanto che sono
diventati incandescenti misurando temperature oltre i 900°C . (la parte
nera è quella in cui si trovano le pinze). Normalmente però i freni
devono lavorare a temperature di 750°C e devono essere raffreddati
rapidamente pena uno spazio di frenata molto più lungo. Tra i freni del
semiasse anteriore e quelli del posteriore c'è una netta differenza di
surriscaldamento. Infatti i freni anteriori raggiungo temperature più
alte rispetto ai freni posteriori. Ciò è dovuto al fatto che in frenata
la maggior parte della massa si riversa in avanti e quindi si ripartisce
la frenata quasi sempre al 60% in avanti e al 40% al retro. Sotto da
sinistra sono stati fotografati i freni anteriori della Ferrari, e
quelli posteriori della McLaren del 1998 (notare la differenza di
diametro dei freni).
Per le qualifiche solitamente si usano freni molto più sottili del
normale per diminuire il peso del veicolo, ma che hanno le stesse
capacità di frenare la monoposto. Questi freni, invece, non vengono
usati in gara perchè facilmente potrebbero cedere facendo perdere la
gara al pilota. In gara si usano freni spessi 28 mm (che è il massimo
consentito), mentre in qualifica si usano freni da 21 mm. Il
funzionamento dei freni da F1 è lo stesso di quello dei normali freni a
disco. Nella foto in alto a sinistra si possono vedere quei forellini
nel freno. Essi servono solo a far uscire più rapidamente l'aria calda
in modo da raffreddarsi subito.Nell'immagine sottostante si vede come
funziona un freno a disco.
|
|
Il differenziale |
|

|
Elemento importantissimo nelle monoposto e in tutti i veicoli a
quattro ruote (ad eccezione di go-kart) è il differenziale. Il
differenziale è un elemento della trasmissione, disposto tra la scatola
del cambio e le ruote motrici, che gioca un ruolo importantissimo nella
tenuta di strada in curva. Infatti in una curva la ruota esterna dovrà
coprire una distanza maggiore rispetto alla ruota interna: in questo
caso, quindi ogni ruota presenterà una diversa velocità di rotazione. Al
verificarsi di questa situazione, se le due ruote motrici si trovano
entrambi sullo stesso asse di rotazione, questa differenza può non
esistere le due ruote possono ruotare alla stessa velocità, causando il
pattinamento del veicolo, offrendo quindi una scarsissima tenuta di
strada. |
Con un differenziale di tipo tradizionale, è possibile evitare
questo problema, distribuendo la coppia motrice su ciascuna ruota, in
modo che esse possano presentare una diversa velocità di rotazione. Lo
svantaggio principale di questo sistema tradizionale deriva, quando le
due ruote presentano condizioni di aderenza differenti, poichè in questo
caso, la maggior parte della coppia motrice viene distribuita sulla
ruota che presenta l'aderenza minore, producendo, quindi, una notevole
perdita di energia cinetica. I gruppi differenziale presenti sulle
vetture di F1 sono dotati di impianti elettronici, che possono adattarsi
a tutte le situazioni, trasferendo, se necessario, parte della coppia
motrice della ruota che gira più rapidamente, alla ruota che presenta la
maggiore aderenza: in questo caso, parliamo di bloccaggio. Solitamente
esistono 5 posizioni di trasferimento di coppia da una ruota all'altra.
Nella posizione uno, il differenziale trasferisce solo parte della
coppia motrice da una ruota all'altra e la velocità di trasferimento è
relativamente bassa (simile al differenziale tradizionale); nella
posizione cinque si ha un trasferimento massimo di coppia, con una
maggiore velocità di trasferimento che porta, però, ad un'improvvisa
perdita di aderenza sull'asse della ruota posteriore, in caso di
bloccaggio in curva. I piloti devono trovare un giusto compromesso,
nella regolazione di questo sistema, tra l'energia cinetica e la tenuta
di strada nelle curve: aumentando il coefficiente di bloccaggio si
guadagna motricità, riducendolo si migliora l'aderenza.
|
|
L'aerodinamica
I principi base
e l'evoluzione nella F1
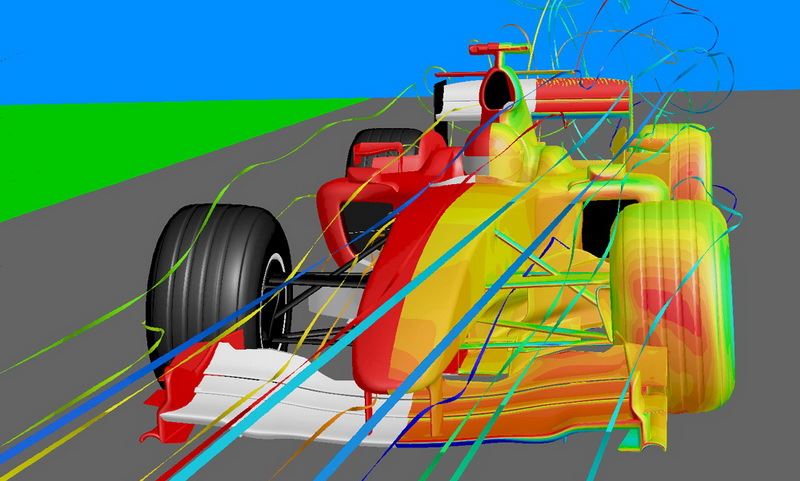 |
|
Cos'è
l'aerodinamica? Già il nome ci suggerisce che l'aerodinamica è
la scienza che studia la dinamica, cioè il movimento, del fluido
nel quale si muovono la maggioranza dei mezzi di trasporto
costruiti dall'uomo. Perché lo studio di questa scienza è così
importante nella progettazione delle automobili ed in
particolare di monoposto di F1? Perché l'aria (che si presenta
come un gas trasparente difficile da indagare e studiare con
semplici strumenti, tanto da rendere necessaria la costruzione
di costosissimi impianti quali le gallerie del vento) acquista
moltissima importanza quando un corpo si muove in
essa, condizionandone pesantemente il moto a causa della
resistenza che il fluido esercita sul corpo e delle interazioni
reciproche che si vengono a creare (basti pensare ad una piuma
che cade a terra molto più lentamente di una sfera di piombo,
nonostante la legge di gravitazione universale gli imponga (nel
vuoto!) di cadere con la stessa accelerazione di 9,8 m/s2).
E' evidente quindi quanto, fin dai
primordi, lo studio aerodinamico sia stato una componente
fondamentale della progettazione di auto da corsa e l'importanza
di questa componente aumentava con l'incremento delle potenze
dei motori e quindi delle velocità massime.
L'inizio
La
F1, rappresentando fin dagli esordi nei primi anni '50 la punta
di diamante delle competizioni automobilistiche mondiali, dette
modo ai progettisti di dare il meglio di sé in ogni settore. In
particolare l'aerodinamica assunse subito un ruolo abbastanza
importante (nonostante i limiti tecnologici dell'epoca), in
quanto, per definizione, le monoposto di F1 hanno il grosso
handicap delle ruote scoperte, che rappresentano un notevole
freno aerodinamico. Si presentava quindi il problema di trovare
una forma per i bolidi che garantisse la miglior penetrazione
nell'aria. I primi progettisti non dovettero sforzarsi più di
tanto nell'individuare tale forma, dato che era già presente in
natura: la goccia.

La leggendaria Auto Union Type C pilotata da Bernd Rosemeyer al Nürburgring
|
Seguendo
una moda che era già in voga nel periodo fra le due guerre, le
fusoliere venivano disegnate con la forma più affusolata
possibile, piazzando apposite bombature alle spalle del pilota o
nelle fiancate (vedi la D50) in modo da rendere il più
possibile laminare il movimento (relativo) dell'aria attorno al
corpo vettura e quindi da limitare le turbolenze.
La
Ferrari D50 (che era in origine un progetto Lancia) vinse il
mondiale di F1 nel '56 con Fangio
I primi progettisti non
dovettero sforzarsi più di tanto nell'individuare tale
forma, dato che era già presente in natura: la goccia.
Seguendo
una moda che era già in voga nel periodo fra le due guerre,
le fusoliere venivano disegnate con la forma più affusolata
possibile,
piazzando apposite bombature alle spalle del pilota o nelle
fiancate (vedi la D50) in modo da rendere il più possibile
laminare il movimento
(relativo) dell'aria attorno al corpo vettura e
quindi da limitare le turbolenze.
Gli
anni '60
Durante
gli anni '60 l'estremizzazione della ricerca della massima
penetrazione aerodinamica portò alla progettazione di macchine
sempre più lunghe (anche a causa del motore posteriore), e
sottili, con la posizione del pilota sempre più sdraiata, tanto
da rendere celebre la loro forma a "sigaro".
|
 |

Il
compianto Jim Clark con la mitica Lotus 33
|
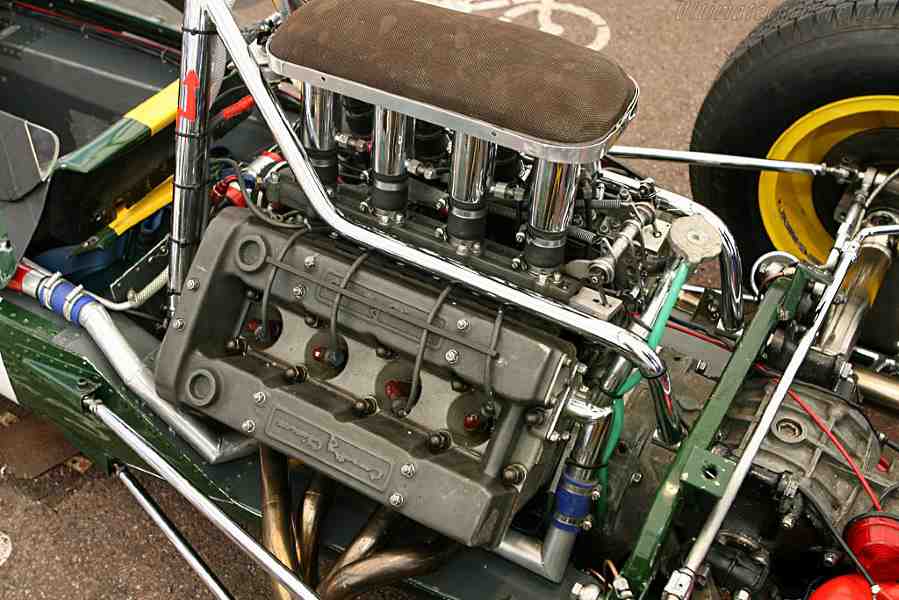
|
|
La Lotus 33
è una vettura monoposto impiegata in Formula 1, progettata da
Colin Chapman e costruita dal Team Lotus. Il progetto si basava sulla
precedente Lotus 25 portando la progettazione del telaio monoscocca ad
un nuovo livello. Sulla 33 veniva usato nuovamente il motore Climax da
1.500 cm³. La Lotus 33 era quasi identica alla 25 anche se
aveva il progetto delle sospensioni realizzato intorno ai nuovi e
più grandi pneumatici. Inoltre era più rigida e di
costruzione meno complessa delle vetture precedenti.
Realizzata per la stagione 1965, la 33 vinse con Jim Clark alla prima gara che si tenne in Sudafrica.
Durante la stagione la Lotus 33 vinse altre quattro volte conquistando
così il secondo titolo. Clark non partecipò alla gara di Monaco, gara mai vinta da Clark, per correre alla 500 miglia di Indianapolis
dove arrivò primo.
Rispetto al motore della Lotus 25 il nuovo Climax aveva una potenza
massima di 215-220 hp contro i circa 200 della versione precedente. La
potenza maggiore venne ottenuta a scapito dell'affidabilità e Clark fu
costretto al ritiro tre volte durante la stagione 1965. Fortunatamente
per lui questi ritiri non compromisero la sua corsa al titolo. La 33
venne utilizzata anche con il motore Climax V8 dalla cilindrata portata
a 2 litri grazie ad un alesaggio superiore e venne utilizzata per le
prime gare della stagione 1966 fino a quando non venne preparata la Lotus 43 con il motore BRM da 3 litri.
La Lotus 33 prese parte, sempre con Jim Clark alla guida, anche a
competizioni esterne al campionato del mondo e nel 1967 vinse la Tasman
Cup.
|
| La Brabham BT20 è un'autovettura da Formula 1 realizzata dalla Brabham nel 1966.
|
 |
|
La BT20 fu sviluppata da Jack Brabham e Ron Tauranac ed era dotata di un
telaio spaceframe multi-tubolare in alluminio ricoperto da una
carrozzeria in fibra di vetro. Il propulsore che la equipaggiava era un
Repco V8 3.0 da 311 cv di potenza derivato da un modello creato dalla
Oldsmobile.
|
|
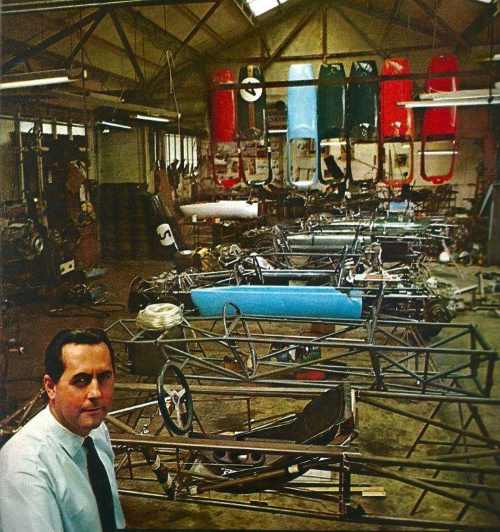
Jack Brabham
|
|
Ma
nel '67 su molte vetture comparvero delle appendici che
avrebbero stravolto la forma delle monoposto negli anni a
venire: le ali. L'introduzione delle appendici alari, sfruttando
la notevole spinta in basso prodotta, permise di incrementare
notevolmente le velocità di percorrenza delle curve e il
problema derivante dalla notevole resistenza all'aria che tali
appendici generavano venne quasi subito superata introducendo
gli alettoni mobili.
Queste appendici evolute venivano regolate direttamente dal
pilota in corsa, il quale, agendo su una leva, le inclinava
prima della frenata per rallentare più efficacemente,
percorreva la curva velocemente, sfruttando la maggior
aderenza sull'asfalto e una volta nel rettilineo posizionava
l'ala in orizzontale, così da minimizzare il freno aerodinamico
e sfruttare appieno la potenza del motore. Tuttavia lo scarso
livello della tecnologia dell'epoca e anche l'impossibilità di
evitare guasti ad un così delicato meccanismo, causarono
numerosi tragici eventi, che culminarono con un drammatico
incidente nel GP di Spagna del '69, dove cedettero le ali sulle
Lotus di Rindt e Hill. Per la prima volta il potere sportivo
impose dei limiti sull'aerodinamica delle vetture imponendo
delle ali fisse.

Jack Brabham - 1967 Test Brabham BT24
La vettura aveva in dotazione il medesimo propulsore che equipaggiava le
precedenti BT19 e BT20, e cioè il Repco V8 620, il quale era però stato
potenziato con diverse migliorie per ottenere una potenza di 350 cv. Le
migliorie comprendevano un nuovo basamento e nuove testate, e queste
ultime furono realizzate in configurazione uniflow, in quanto i condotti
di aspirazione e di scarico si trovavano localizzati nella medesima
parte. Le testate erano piatte e le camere di combustione erano ricavate
direttamente nel cielo dei pistoni. Queste, denominate Heron, vennero
impiegate per la prima volta su questa vettura ed ebbero una bona
notorietà successiva. La distribuzione era nuovamente monoalbero con
comando a catena e punterie a bicchiere e due valvole parallele per ogni
cilindro. Queste ultime avevano un diametro di 43 mm per quanto
riguarda quelle di aspirazione e 34 per quelle di scarico. Gli scarichi
fuoriuscivano dalle testate nella zona rivolta verso il centro della V
formata dalle due bancate di cilindri. Il telaio tubolare era formato da
un traliccio di tubi.
|
|
GLI INIZI
La stagione 1970 si apre con una certezza: l’aerodinamica. Temperate le
iniziali esuberanze grazie ai nuovi regolamenti, l’aerodinamica,
o meglio il suo corretto sfruttamento, diventano la nuova
frontiera della ricerca applicata alle corse.
Il concetto di deportanza rivoluzionò la concezione delle corse. Fino a
quel momento le vetture da corsa dovevano essere fondamentalmente
veloci, il più veloci possibile, per raggiungere la massima
velocità nei rettilinei, che erano la parte predominante di ogni
circuito. Velocità dell’ordine di 340 km/h erano state
raggiunte sui circuiti più veloci già negli anni ’30, e si
dovrà aspettare il 1982 perché vengano raggiunte di nuovo. Le
monoposto però, fino all’avvento dell’aerodinamica, dovevano
rallentare in maniera radicale per affrontare le curve. In questo
modo la differenza fra velocità massima e velocità di
percorrenza delle curve era enorme. Si pensi che le Auto Union del
1936 disponevano di 520 HP e di velocità di punta dell’ordine
dei 345 km/h. Su di un circuito velocissimo come Monza, un giro
era percorso alla media di circa 180 km/h. Trent’anni dopo le
monoposto, con circa 330-350 cavalli, e velocità massime non
superiori ai 280 km/h, giravano su quel circuito ad una media di
circa 200 km/h. Con l’avvento dei dispositivi aerodinamici, nel
1969 le monoposto migliori, con circa 420 HP ed una velocità massima non superiore ai 270 km/h, girarono a Monza a 236
km/h di media. Questi dati devono essere valutati in termini di
efficienza globale. Un motore potentissimo poteva essere usato per
andare forte in rettilineo, ma la velocità in curva restava
subordinata all’aderenza al suolo. Questa, a sua volta, era
legata alla sezione dei pneumatici, al loro coefficiente di
attrito, alla capacità delle sospensioni di tenere il pneumatico
aderente al suolo. Questi fattori erano, fino all’avvento delle
appendici aerodinamiche, evidentemente bassi, perché la velocità
di percorrenza della curva rimaneva molto distante dalla velocità
massima che la vettura poteva sviluppare in rettilineo. Il ricorso ai dispositivi aerodinamici ha quindi permesso di ridurre in
modo drastico la differenza fra velocità massima e velocità di
percorrenza delle curve. Si era quindi verificato un paradosso: il
tempo guadagnato in rettilineo da una vettura velocissima, ma
lenta nelle curve, era inferiore al tempo guadagnato da una
vettura lenta in rettilineo ma veloce nelle curve. A questa nuova concezione delle corse automobilistiche verrà subordinata
tutta l’evoluzione dello sport motoristico, fino ai nostri
giorni
Vediamo ora in dettaglio come la ricerca aerodinamica ha influenzato lo
sviluppo di tutti i settori.
|
|

|
1-TELAI La spinta aerodinamica verso il basso, ottenibile
con gli alettoni, poté essere subito quantificata nell’ordine
delle centinaia di chili. Questo peso ‘virtuale’ aumenta e diminuisce
in funzione della velocità, per sparire a vettura ferma. Ciò nonostante,
quando una vettura si muove ad alta velocità, é effettivamente
sottoposta a questo carico aggiuntivo. Lo sviluppo telaistico
quindi mirò prima di tutto all’ottenimento della necessaria robustezza
senza andare a scapito del peso reale. E’ infatti noto che le
prestazioni di una vettura, intese come possibiltà di accelerare
e frenare in tempi (e quindi spazi) brevi, sono innanzitutto influenzate
dal rapporto peso/potenza (o kg/HP). Le monoscocche di prima generazione
(del tipo Lotus 25), composte da pannelli di lega leggera rivettati
su ordinate di magnesio o leghe leggere, erano ormai superate.
Lo sviluppo dei telai delle F.1 si rivolse naturalmente alla industria
aeronautica, dove il peso è da sempre il nemico principale. All’inizio
degli anni ’70 si vide l’avvento delle prime scocche in scatolato
in lega di alluminio, di chiara derivazione aeronautica (Vedi
Fig. 5).
|
La
crescente velocità di percorrenza delle curve sottoponeva il telaio
a forze di torsione sempre più alte, spingendo i costruttori a
sofisticati calcoli per determinare le forze torsionali e trovare il
modo di contrastarle. La rivettatura dei pannelli si rivelò
anch’essa superata, e verso il 1975 apparvero i primi esempi di
scocche incollate con i collanti anaerobici di recente messa a
punto. La tappa successiva fu il ricorso ai materiali compositi,
anch’essi di derivazione aeronautica, costituiti da pelli
metalliche incollate su una struttura alveolare. La prima scocca di
questo tipo (McLaren, 1976) era composta da pannelli di pelli di
alluminio incollate su di uno strato di legno di balsa. La rapida
evoluzione dei compositi portò all’adozione dello honeycomb,
struttura composta dalle solite pelli di alluminio incollate su di
una matrice di cellette esagonali (come negli alveari, da cui il
nome). Questi nuovi materiali hanno permesso di ottenere telai
leggerissimi (una scocca nuda di quel periodo poteva pesare circa 70
kg) ed allo stesso tempo estremamente rigidi. Nonostante questi
miglioramenti strutturali, il tipo di telaio in uso fino al 1970
ricalcava le forme di quelli degli anni sessanta, essendo
invariabilmente caratterizzato dal radiatore frontale e da serbatoi
del carburante laterali (che furono all’origine di molti incidenti
a causa della facilità all’incendio). Colin Chapman presentò nel
1970 la sua Lotus 72, monoposto assolutamente rivoluzionaria per
varie ragioni. Essa aveva infatti
-
forma a cuneo, coi radiatori sdoppiati laterali al posto di guida
-
ripartizione dei pesi con preponderanza al posteriore, per favorire
la trazione
-
sospensioni a flessibiltà variabile (v.2.2.)
-
freni anteriori entrobordo (v. 2.3.) per diminuire le masse non
- alettone posteriore
in più profili, per migliorare il rapporto fra deportanza e resistenza
Come la Lotus 25 aveva rivoluzionato la formula 1 nel 1962, così la F.1
non poté essere più la stessa dopo la Lotus 72. Anche se alcuni
costruttori impiegheranno anni a convincersi della bontà della
formula (Ferrari adotterà i radiatori laterali solo nel 1974)
la strada del futuro era quella indicata dalla Lotus 72, come
confermato dalle venti vittorie in Gran Premio, due titoli piloti
(Rindt 1970 e Fittipaldi 1972) ed un titolo Costruttori ( 1972).
Un’altra monoposto innovativa del 1970 é stata la ferrari 312B progettata
da Mauro Forghieri. Fedele al 12 cilindri, dopo le deludenti prestazioni
del precedente V-12 a 60° (che in quattro anni vinse solo tre
G.P.) la casa modenese passò ad un inedito 12 cilindri a 180°,
detto (impropriamente) boxer. Questo motore, che gareggerà in
varie versioni per più di dieci anni, aveva fin dall’inizio una
notevole potenza (450 HP, cioè 150 HP/litro nel 1970) ed il vantaggio
di spostare in basso il baricentro. Nonostante il resto della
vettura fosse abbastanza tradizionale (radiatore anteriore, sospensioni
convenzionali, per quanto con ammortizzatori interni alla scocca)
la 312B fu l’unica monoposto a opporsi regolarmente alla Lotus
72. I suoi punti di forza erano l’ottima omogeneità, dovuta appunto
al baricentro basso, un’ottima distribuzione dei pesi e una grande
potenza disponibile. Vinse quattro Gran Premi nel 1970 con Ickx
e Regazzoni.
|
|
|
2 - MOTORI.
Come già detto, gli
anni ‘70 furono dominati da due motori: il Ford Cosworth V8 ed il
Ferrari 12 boxer. Alcune vittorie andarono anche ad altri V-12: il
Matra francese ed il B.R.M. inglese. L’evoluzione dei motori passò
per l’ottimizzazione di iniezione (sempre di tipo indiretto e
meccanico dell’inglese Lucas), accensione (di tipo elettronico
senza contatti), e della fasatura della distribuzione. Questi
miglioramenti portarono ad un costante, sebbene non spettacolare,
aumento del regime di rotazione e quindi della potenza disponibile.
Il boxer Ferrari ad esempio, passò dai 450 HP (150 HP/litro) a
11.000 g/m nel 1970 ai circa 520 HP (174 HP/litro) a 12.300 nel
1980. Il Cosworth V8 dai 400 HP 134 HP/litro) a 9750 g/m nel 1966 ai
490 HP (164 HP/litro) a 10800 g/m nel 1979. Nonostante la maggior
potenza, i V-12 furono sempre penalizzati da maggior peso, maggior
consumo, minore elasticità a basso regime.
E’ infine doveroso
segnalare il tentativo della Lotus di fare correre, nel 1970,
una monoposto a turbina, la 56B. Questa monoposto era derivata
dalla Tipo 56 che, nel 1968, aveva ridicolizzato i rivali americani
alla 500 miglia di Indianapolis, dove si ritirò a una ventina
giri dalla fine, dopo avere guadagnato un vantaggio incolmabile.
Dotata di una turbina Pratt & Whitney di derivazione aeronautica
e della trazione integrale, nelle mani di Emerson Fittipaldi corse
alcuni Gran Premi, senza grandi risultati, prima di essere bandita
dalla CSI.
|
|
|
|
Parallelamente allo sviluppo dei telai, anche le sospensioni furono ampiamente
migliorate. Dapprima si ricorse al progressivo allargamento delle
carreggiate, per rendere il corpo vettura meno sensibile al rollio.
Il rollio infatti, più pronunciato con carreggiate strette, altera
le condizioni di ‘lavoro’ delle superfici aerodinamiche. Per far
sì che il flusso che investe l’alettone sia il più possibile regolare,
é quindi indispensabile che questo subisca variazioni minime rispetto
al piano orizzontale su cui scorre la vettura, e ciò é possibile
solo limitando il rollio. Il ricorso a carreggiate larghe é possibile
con due soluzioni: allargare la scocca o allungare le braccia
della sospensione. La prima soluzione non é vantaggiosa, perché
comporta un aumento del peso e della superficie frontale (quindi
della resistenza aerodinamica). La seconda comporta bracci ed
ammortizzatori lunghi, col pericolo di flessione, quindi di irregolarità
di assetto. Per irrigidire le lunghe braccia di forza della sospensione
si fece quindi ricorso a triangoli sovrapposti sempre più aperti,
poi a bilanceri scatolati. L’ammortizzatore era stato fino a quel
momento trasversale, cioè ancorato alla base inferiore del portamozzo
ed alla parte superiore della scocca, soluzione che, come già
detto, era impraticabile nel caso di ruote molto distanti dalla
scocca, sia per la flessibilità di un lungo ammortizzatore, sia
per la resistenza aerodinamica che questo avrebbe comportato.
Il problema fu quindi risolto alloggiando l’ammortizzatore all’interno
della scocca, comandato direttamente dal bilancere superiore (Vedi
Fig. 6).
Questo tipo di sospensione, aerodinamicamente poco penalizzante, diminuiva
anche le masse non sospese, e quindi l’inerzia della sospensione,
migliorando la precisione di guida e la rapidità di risposta alle
sollecitazioni verticali (molleggio) e trasversali (sterzata).
Gli ammortizzatori utilizzati restavano però di tipo tradizionale, cioè
corpo idraulico e molla elicoidale coassiali. L’innovazione venne
ancora una volta da Colin Chapman, che nella sua Lotus 72 introdusse
le molle a barra di torsione separate dagli ammortizzatori (Vedi
Fig. 7). La sospensione a barra di torsione offre vantaggi enormi in termini di
regolazione e progressività. Si basa su di una barra metallica
ancorata ad una estremità sulla scocca, mentre all’altra estremità
é collegata alla ruota tramite un puntone. Lo scuotimento della
ruota viene comunicato dal puntone alla barra, che tenderebbe
a ruotare se non fosse imprigionata all’altra estremità sulla
scocca; in questo modo la resistenza alla torsione della barra
si sostituisce alla resistenza alla compressione di una molla
elicoidale in acciaio. Il diametro della barra e la distanza fra
l’ancoraggio sulla scocca e quello del puntone determinano la
progressività del molleggio. Questo tipo di sospensione consente
di avere un molleggio ‘morbido’, che permette quindi alla ruota
di meglio seguire le asperità della strada, senza il pericolo
che la sospensione vada ‘a tampone’ cioè a fondo corsa, dove non
esiste più molleggio e la ruota perde contatto col suolo. La Lotus
72 aveva quindi la possibilità di un molleggio estremamente efficace
pur consentendo al pilota un buon comfort di guida ed una sensibilità
dello sterzo che i classici ammortizzatori coassiali non offrivano
più. Questa idea di Chapman era talmente innovativa, che si dovrà
aspettare il 1989 perché John Barnard la riprenda in mano, modernizzandola
e miniaturizzandola (sulla Ferrari 639), realizzando una sospensione
che, nonostante i miglioramenti inevitabili in più di un decennio,
é ancora attuale.
Verso la metà degli anni settanta, Ralph Bellamy della McLaren sviluppò
positivamente un progetto di sospensione a flessibilità variabile
(rising rate, vedi Fig. 8) a cui lavorava fin dal ‘72. Il principio si basava su di un bilancere che
aziona il gruppo molla/ammortizzatore (sempre di tipo coassiale
tradizionale) attraverso un fulcro intermedio che, facendo variare
l’angolo di azionamento a seconda della compressione, irrigidiva
progressivamente la sospensione. Soluzione meno elegante di quella
Lotus, aveva però il vantaggio di costi più bassi e di rapidità
di regolazione. Questo tipo di sospensione fu alla base dei sistemi
di azionamento mediante bielletta e bilancere, detti prima pull
rod, (vedi Fig. 9)
a seconda che lavorassero in trazione o in compressione che sono ancora
oggi adottati.
Infine la Ferrari, sempre su progetto di Forghieri, introdusse nel 1971
una sospensione posteriore in cui l’ammortizzatore era alloggiato
in alto sul motore, ed azionato da una piramide triangolare di
tubi (Vedi Fig. 11).
Anche questo espediente mirava alla riduzione delle masse non sospese,
ma non funzionò mai correttamente a causa della flessibilità del
comando. Rimane un tentativo che, assieme al già citato esempio
McLaren, aprirà la strada, negli anni ‘80, ai sistemi pull rod
e push rod .
|
|
|
4 - FRENI.
Introdotti negli anni cinquanta (dalla Jaguar Sport che vinse a Le Mans
nel 1953) e generalizzati negli anni sessanta, gli impianti frenanti
a disco metallico hanno avuto una discreta evoluzione negli anni
settanta. Dopo le esperienze fatte a Le Mans, dove i Prototipi
percorrevano il lungo rettilineo delle Hunaudières a 360
km/h per poi rallentare fino a 60 km/h per affrontare il tornante di
Mulsanne, gli ingegneri si resero conto che gli sbalzi termici
imposti dalle moderne vetture da corsa causavano tensioni e
surriscaldamenti che incrinavano il metallo dei dischi. Si
sperimentarono quindi con successo dischi forati radialmente, che
furono chiamati autoventilanti. Questo tipo di disco fu
universalmente adottato da tutte le F.1.
Una evoluzione più significativa interessò il sistema di attuazione (le
‘pinze’) ed i materiali di attrito. La Dunlop e la Girling
misero a punto pinze ‘autoflottanti’, in grado cioè di seguire
gli scuotimenti del disco durante le sollecitazioni della frenata.
Dal comando meccanico si passò al comando idraulico, e dal
pistoncino semplice (che spinge la guarnizione di attrito contro il
disco, e quindi il disco contro la guarnizione d’attrito
dall’altra parte del disco) si passò al doppio pistoncino (per
esercitare una pressione simmetrica sul disco) poi ai quattro
pistoncini (per aumentare la zona di pressione esercitata dalle
guarnizioni sul disco).
I dischi metallici, le pinze e le tubature del circuito idraulico
rappresentavano però una notevole massa non sospesa, con gli
effetti negativi di cui abbiamo già parlato.
Colin Chapman, sulla Lotus 72, adottò freni anteriori entrobordo, collegati
cioè alle ruote da semiassi metallici. Questa soluzione consentiva
una eccezionale sensibilità dell’avantreno ed una precisione di
guida ineguagliabile dagli altri sistemi. Purtroppo, nel corso
delle prove del G.P. di Italia a Monza, uno dei semiassi di collegamento
si ruppe nella violenta frenata della Parabolica, causando uno
sbandamento della vettura di Jochen Rindt, che perse la vita.
Chapman fu messo sotto processo, e l’elegante soluzione dei freni
anteriori entrobordo non ebbe praticamente seguito.
|
|
5 - RUOTE E PNEUMATICI.
Nella prima metà degli anni sessanta le F.1 correvano su pneumatici
larghi circa 130 mm all’anteriore e 180 al posteriore, montati su
cerchi di grande diametro (mediamente 15 pollici). Queste sono
misure di larghezza (non di diametro) oggi adottate dalla Panda (135
mm) o la Punto (185 mm). Nel 1970 la misura più diffusa era di 255
mm anteriori su cerchi da 13 pollici e 400 mm al posteriore su
cerchi da 15 pollici. Nel 1975 le gomme posteriori raggiungevano i
520 mm di larghezza e nel 1978 i 660 mm, su cerchi da 13 pollici.
Questo aumento della larghezza, unito alla diminuzione del diametro
del cerchio, fu reso possibile dall’abolizione delle camere
d’aria, ed impose una riduzione progressiva del diametro dei
dischi dei freni, col conseguente bisogno di adottare prese d’aria
per il raffreddamento di dischi e pinze. I pneumatici invece,
progressivamente sempre più larghi, furono resi sempre più rigidi
nella banda di rotolamento e sulla spalla, per diminuire la deriva
rispetto all’angolo di sterzata.
Diminuendo il diametro del pneumatico, aumenta però la velocità di
rotazione del battistrada sull’asfalto, e la forza centrifuga a
cui é sottoposto. Per evitare negative
deformazioni del battistrada, o addirittura il suo distacco
dalla carcassa per centrifugazione, la scolpitura del pneumatico
diminuì quindi di profondità, arrivando ad una semplice serie di
intagli nel 1971, per
consentire al battistrada di dilatarsi all’aumentare della
temperatura senza deformarsi. Nel 1973 apparvero i primi pneumatici
slick, lisci (della Firestone americana), per mettere a terra la
massima superficie di gomma. Da allora la guerra delle gomme é
stata una delle componenti strategiche più importanti della F.1. Al
pneumatico non si chiedeva più solamente di esercitare un dato
coefficiente di attrito, ma di giungere vicino al punto di fusione
della gomma per esercitare una vera e propria azione adesiva
sull’asfalto. L’aderenza che questi pneumatici assicuravano era
comunque legata a complicatissimi parametri di temperatura e
dilatazione, che imposero il gonfiaggio con azoto, gas meno
sensibile dell’aria alle variazioni di volume in funzione della
temperatura.
In seguito al progressivo irrigidimento delle sospensioni, attuato come
già detto per consentire alle appendici aerodinamiche di lavorare
in regime praticamente rettilineo, i pneumatici furono chiamati a
svolgere parte del compito fino ad allora assicurato dalle
sospensioni: il molleggio. I pneumatici delle F.1, gonfiati a
pressioni basse (1-2 atm., invece che le 4-5 degli anni ’50 e
’60) assicuravano, con la loro flessibilità, l’assorbimento
delle piccole asperità che le sospensioni (occupate a garantire un
assetto costante) non potevano più assicurare.
Nelle stagioni 1972-73 le case costruttrici di pneumatici americane
Goodyear e Firestone tentarono l’introduzione di caracasse a
‘cintura bassa’. Questo concetto, oggi diffusissimo sulle
vetture di serie, impiega una spalla del pneumatico di dimensione
molto inferiore alla superficie aderente. Per esempio, un pneumatico
di misura 205/60 ha l’altezza della spalla uguale al 60% della
impronta al suolo, cioè: 205x60%= 123 mm. La minore altezza del
fianco (la ‘spalla’) del pneumatico dà origine ad una minore
flessione dello stesso, quindi ad una minore ‘deriva’ del
pneumatico. La ‘deriva’ non é altro che la differenza fra
l’angolo di sterzo e l’effettivo angolo di sterzata. Più il
fianco del pneumatico é ‘basso’, più piccolo sarà l’angolo
di deriva, cioè si eliminerà il bisogno di ruotare il volante più
dell’effettivo angolo di sterzata (sottosterzo). Il pneumatico a
cintura bassa consente una notevole diminuzione della deriva al
costo di una minore flessibilità. Come già visto, le sospensioni
delle F.1 devono essere rigide, e l’adozione dei pneumatici a
spalla bassa portò ad una tale rigidità complessiva da non potere
essere sopportata né dai piloti né dalla meccanica. I pneumatici
infatti, legati alla monoposto da sospensioni rigidissime e dotati
di grande aderenza, cominciarono a sviluppare vibrazioni tali da
indurre la deformazione della struttura (ondulazione dell’impronta
a terra) che vanificava l’aderenza. Si tornò quindi ai pneumatici
a spalla tradizionale.
Nonostante questo passo indietro, la struttura dei pneumatici continuò
ad evolvere per quel che riguarda la carcassa (che rimaneva comunque
di tipo tradizionale a tele diagonali) e le componenti della gomma
(la mescola). Si arrivò addirittura a pneumatici ‘dedicati’, per
ottenere la massima aderenza su di un dato tipo di circuito. Il
limite dei pneumatici a carcassa diagonale era però evidente:
la centrifugazione. Con l’aumento della velocità di rotazione
il pneumatico si deformava, aumentando di diametro, allungando
quindi il rapporto finale di trasmissione, ed assumendo una forma
leggermente piramidale, che diminuisce la superficie di gomma
a contatto con l’asfalto. Questi limiti furono superati con l’avvento
dei pneumatici a carcassa radiale.
|
|
6 - TENTATIVI DI INNOVAZIONE.
Nella prima metà degli anni ‘70, le monoposto di successo furono le
logiche evoluzioni della Lotus 72, ma almeno quattro progettisti
tentarono vie innovative: Robin Herd (March), Derek Gardner (Tyrrell),
Gordon Murray (Brabham) e Mauro Forghieri (Ferrari).
La neonata March presentò per il 1970 una monoposto che fece scalpore:
su di uno stretto telaio monoscocca abbastanza tradizionale,
venivano montati sui fianchi i serbatoi, contenuti in strutture
metalliche a forma di ala rovesciata. Lo scopo era chiaro a tutti:
disporre di superfici deportanti enormi rispetto agli alettoni
consentiti dai regolamenti. Il telaio fu acquistato da varie
squadre: STP (con Andretti) Tyrrell (Stewart e Servoz-Gavin), John
Walker (Siffert) Antique Automobiles (Elford, Peterson). Nonostante
le aspettative, la vettura si rivelò un fallimento. E’ però
importante ricordarla per l’intuizione dei profili alari laterali.
Ripresi da Chapman nel 1978, e racchiusi all’interno di pontoni
stagni, i profili alari furono all’origine dell’effetto suolo
che sarà l’ennesima rivoluzione introdotta dalla Lotus (V. § 3).
Derek Gardner, ingenere della Ditta Ferguson, specializzata in
trasmissioni (che aveva presentato negli anni ’60 una F.1 a
trazione integrale che non scese mai in pista), partecipò al
progetto Matra MS 84, nel ’69. Questa monoposto, derivata dalla MS
80 (che vinse il campionato di quell’anno) era dotata di
trasmissione integrale. Lotus (con la 63) e McLaren (con la M-10)
avevano tentato la stessa strada senza risultati, per cui la
trazione integrale venne abbandonata. Gardner era però entrato
nell’orbita di Tyrrell (che gestiva nel ’69 i telai Matra con
motori Cosworth). Assunto nel 1970 per progettare un’alternativa
alla deludente March, disegnò le Tyrrell vincenti degli inizi degli
anni ’70. Nel 1976 fece scendere in pista la incredibile Tyrrell
P-34, a sei ruote, di cui quattro anteriori sterzanti. Il
ragionamento alla base di tale progetto era semplice: l’enorme
sezione frontale delle F.1 era (ed é) determinata dalle ruote
anteriori che, per regolamento, devono essere scoperte. Gardner pensò
quindi di ridurne il diametro fino a farle scomparire dietro il
musone aerodinamico. Per compensare la sezione ridotta dei
pneumatici anteriori, ne montò quattro di piccolo diametro. Questa
monoposto vinse un solo G.P. (Svezia 1976 con Scheckter), pagando
l’inadeguatezza dei pneumatici Goodyear a carcassa tradizionale.
La centrifugazione di questi piccoli pneumatici, aggravata dal
ridotto diametro, rendeva l’impronta a terra insufficiente, con
gravi problemi di instabilità. Se la P-34 avesse potuto disporre di
pneumatici radiali avrebbe sicuramente inaugurato una nuova era. Le
sei ruote vennero proibite dal 1977.
Gordon Murray, giovane ingegnere sudafricano, cresciuto alla scuola di
Gordon Coppuck (McLaren), si era già segnalato alla Brabham con una
scocca a sezione trapezioidale (la BT- 44), poi per il tentativo di
abolire i radiatori, sostituendoli con pannelli a sfioramento di
origine aeronautica. Progettò poi la prima Brabham-Alfa Romeo (la
BT-45) col 12 cilindri boxer della casa milanese. Nel 1977, al GP di
Svezia, presentò una monoposto dotata di un grande ventilatore
posteriore, che ufficialmente doveva servire a raffreddare il
motore. In realtà tutto il perimetro della monoposto era sigillato
da striscie di plastica semirigida che toccavano il suolo. Quando il
motore veniva avviato, il ventilatore estraeva l’aria dalla parte
sottostante la vettura e le striscie di plastica sigillavano
l’area, producendo uno schiacciamento della monoposto verso il
suolo. L’idea, non inedita, essendo già stata portata in corsa
dalla Chaparral 2G della serie CanAm nel 1974, consentiva di
eliminare tutta l’aria che scorre sotto la monoposto, aumentando
l’efficacia degli alettoni e producendo un effetto analogo a
quello che si ottiene tappando il tubo di un aspirapolvere, cioè
uno schiacciamento al suolo dovuto al vuoto d’aria creatosi sotto
la vettura. La monoposto (BT-46B-Fan) fu infatti subito
soprannominata ‘aspirapolvere’, e vinse con Lauda in maniera
clamorosa. I rivali si lamentarono però del fatto che, assieme
all’aria, il ventilatore sparava verso il retro ogni sorta di
detrito, impedendo i tentativi di sorpasso. Anche i ventilatori
furono quindi proibiti, fin dalla corsa successiva.
L’importanza della realizzazione di Murray consiste nell’avere
dimostrato che, creando una depressione sotto la macchina, si
produce una fortissima aderenza. Quando Chapman (sempre lui!) trovò
il modo di ottenere una depressione senza ventilatore, la prima F.1
ad effetto suolo vide la luce.
La Ferrari, dopo la notevole 312B, e la promettente, ma poco vittoriosa,
312B-2, entrò in una profonda crisi tecnica con la 312B-3. Di
questa monoposto corsero ben quattro versioni nella stessa stagione,
il 1973, che vide Mauro Forghieri messo in discussione all’interno
dello staff tecnico della Ferrari. Si arrivò a commissionare un
telaio in Inghilterra (allo specialista Thompson), pensando che
Forghieri fosse incapace di progettare un telaio all’altezza della
concorrenza inglese. Gli scarsi risultati ottenuti col telaio
inglese riportarono alla ribalta Forghieri, che nel frattempo
aveva sviluppato l’ennesima versione della monoposto. La quarta
versione della B-3, che corse nella stagione 1974, era ispirata
alla massima concentrazione delle masse attorno al baricentro
ed adottava una aerodinamica innovativa. Per la prima volta una
Ferrari adottava i radiatori sdoppiati davanti alle ruote posteriori,
ma in posizione longitudinale. Il posto di guida era stato avanzato
e le appendici aerodinamiche erano a forma di freccia. Questa
monoposto si aggiudicò tre G.P. e perse il mondiale per tre punti
all’ultima gara della stagione. La successiva monoposto era un
affinamento della precedente, dotata di un cambio trasversale
(da cui il nome 312T) che riduceva praticamente a zero le masse
a sbalzo, eliminando così i momenti di inerzia polare. La 312
T vinse con Lauda il campionato 1975, mancò quello 1976 per il
noto incidente di Lauda al Nurburgring, riconquistò, sempre con
Lauda, quello del 1977 (312T-3) e quello del 1979 (312T-4) con
Scheckter. Monoposto innovativa ed estrememente omogenea, con
un grande potenziale di sviluppo, é sicuramente da annoverare
fra i progetti più riusciti e longevi della F.1, come le citate
Lotus 72 e McLaren M-23.
7 - LA FINE DI
UNA ERA.
Riassumendo, le
monoposto vincenti nella prima metà degli anni settanta erano
evoluzioni più o meno sofisticate della Lotus 72 (che del resto
corse fino al 1975). Ricordiamo le Tyrrell 001 e 003, progettate
da Derek Gardner e vincitrici con Jackie Stewart dei Campionati
1971 e 1973; la McLaren M-23 (progetto di Gordon Coppuck, vincitrice
dei campionati 1974 1976
con Fittipaldi e Hunt). La Ferrari, pur con vetture ostinatamente
differenti dalle rivali inglesi, conquistò i campionati 1975 e
1977 (con Lauda) e 1979 (con Scheckter) , mancando di un soffio
quello del 1976. Ma erano gli ultimi fuochi di un’epoca ormai
alla fine. Colin Chapman stava ancora una volta mettendo a punto
una monoposto rivoluzionaria. Renault stava per debuttare con
un motore turbocompresso. Michelin sarebbe presto scesa in gara
con pneumatici radiali. Una nuova era si stava per aprire.
|
Gli
anni '70
Gli
anni '70 hanno rappresentato a mio avviso il decennio più
fertile e generoso di idee per la F1, perlomeno nel campo delle
innovazioni aerodinamiche delle vetture, con l'introduzione e
l'affermazione di nuovi concetti alla base della progettazione
dei telai e delle appendici. Nei primi anni del decennio
le vetture erano caratterizzate dalle ali, obbligatoriamente
fisse, agganciate al corpo vettura in posizione più bassa
rispetto alle prime apparizioni nelle auto degli anni '60 (che
avevano appendici rialzate rispetto alla scocca). L'aumento
delle dimensioni delle ruote, l'introduzione dell'airscoop (la
presa d'aria per l'alimentazione del motore) e lo spostamento
dei radiatori nelle fiancate fecero mutare radicalmente
l'aspetto delle monoposto, che apparivano ora più larghe e
schiacciate al suolo, con varie estremità che rendevano vario e
spigoloso l'andamento della carrozzeria.

La
Lotus 72 rappresenta un altro esempio delle capacità progettuali
innovative di Colin Chapman. La vettura era dotata difreni
montati all'interno, radiatori sistemati sui lati ed in apposite
fiancate - non più sul muso come era uso comune sin dal 1950 - oltre
alla presa d'aria per il motore realizzata sopra la testa del pilota.
Il
design della 72 era completamente innovativo e la faceva assomigliare
ad una freccia su ruote. La vettura si ispirava alla precedente Lotus
56, dotata di turbina a gas, mentre la configurazione riprendeva quella
della Lotus 63 utilizzata come banco prova per una vettura a quattro
ruote motrici. La forma della vettura ne aumentava la penetrazione e ne
aumentava la velocità. In un confronto diretto contro la Lotus
49 la Lotus 72 risultò più veloce di 20 km/h pur
montando lo stesso motore Ford.
Lo sforzo creativo di Chapman produsse uno dei progetti più importanti e di successo della storia della Formula 1. Con il motore
che fungeva da elemento portante, tecnica già impiegata sulla Lotus 49 e
grazie all'avanzata aerodinamica venne costruita una vettura che si
dimostrò anni avanti alle sue rivali. All'inizio dovettero però essere
superati dei problemi di maneggevolezza dovuti alla geometria delle sospensioni
anti affondamento che erano progettate in modo da prevenire
l'abbassamento eccessivo della vettura sotto l'effetto di staccate
decise. Le sospensioni posteriori erano realizzate con un geometria anti squat, in modo da impedire alla vettura di ondeggiare sotto l'effetto delle accelerazioni.
Una volta modificate le sospensioni non ci furono altri problemi. La
vettura fece scalpore tra gli appassionati e tra i media con molte
persone che la volevano vedere correre.
|
|

Emerson
Fittipaldi, iridato nel '72 con la Lotus
Per quanto riguarda i radiatori questi sulle auto da competizione,
erano situati in corrispondenza del muso, una posizione ottima per
questi dispositivi, che dovevano essere investiti dall'aria fresca per poter raffreddare l'acqua e l'olio motore,
in quanto il regolamento non consentiva e non consente ancora oggi,
l'uso di ventole. Negli anni però, vennero introdotte diverse
innovazioni, come quella di posizionare il motore alle spalle del
pilota. In questo modo, mantenendo il radiatore sul muso dell'auto,
aumentava la lunghezza dei vasi d'espansione, perciò vi erano problemi
di circolazione dei fluidi, dovuti alle perdite di carico più elevate.
Chapman scelse di spostare i radiatori ai lati dell'auto, subito
davanti al motore. Questo consentiva di avere comunque una buona
ventilazione, in quanto l'aria che arriva in quella zona (seppur
disturbata dalla presenza delle sospensioni e delle ruote), aveva una
portata elevata, inoltre non erano più presenti i problemi di
circolazione, poiché i radiatori erano situati immediatamente davanti al
motore. Tra l'altro, anziché avere un grosso dispositivo sulla parte
anteriore, ve ne erano due più piccoli, per ogni lato, e ciò consentiva
anche di ridurre i problemi di affidabilità dei radiatori stessi.
|
|
Come detto l'auto era molto avanzata sotto il profilo aerodinamico.
In un certo senso, anche questa caratteristica dipendeva dalla
soluzione adottata per i radiatori. Infatti senza il grosso radiatore
anteriore, si poteva assottigliare il muso, riducendone in modo
esponenziale la sezione frontale, e di conseguenza offrire meno
resistenza all'aria. Questo comporta un eccellente miglioramento della
capacità di penetrazione, e quindi velocità decisamente superiori nei
rettilinei. Tuttavia i modelli 72, soprattutto dalla Lotus 72C in poi, e
dunque anche sulla 72D, avevano un muso sottile, ma largo, con un
andamento trapezoidale,
che andava allargandosi man mano che ci si avvicinava alle ruote.
Dunque oltre ad essere in grado di penetrare bene l'aria, era pure una
sorta di alettone, che aveva un discreto effetto deportante, dunque la
macchina era in grado di fornire prestazioni ottime sia in curva che in
rettilineo. Per questo motivo le appendici alari anteriori di queste
macchine erano più piccole rispetto a quelle delle altre
scuderie.
Si
può concludere la disquisizione sulla parte tecnica, parlando
dei freni entrobordo. Normalmente i freni sono montati sul portamozzo
di ogni ruota. In questo caso erano posizionati all'interno del telaio,
e solidali con i semialberi calettati sulle ruote (quelli anteriori con
quelli posteriori in uscita dal differenziale). È uno schema che
riduce le cosiddette masse non sospese, cioè tutto il peso
dovuto alle ruote e alle strutture che le sostentano. Tutto ciò
va a beneficio della stabilità della macchina, soprattutto in
curva, grazie a una riduzione dei momenti polari d'inerzia, e una
tenuta di strada superiore.
|
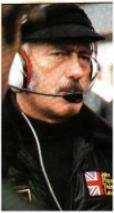
Era
un periodo in cui era molto facile riconoscere una squadra
dall'altra, per la grande diversità e varietà delle soluzioni
adottate da ogni progettista, un periodo in cui anche una
piccola squadra, come la Hesketh, poteva togliersi la
soddisfazione di stare davanti ai marchi più blasonati
semplicemente sfruttando l'ingegno e l'intuito dei propri
ingegneri. Forse fu proprio la nuova forma assunta dai telai, più
bassi, larghi e schiacciati a terra, a suggerire a Colin Chapman
di sfruttare un'altro principio della fluidodinamica, dopo
l'introduzione delle ali, dando il via ad una nuova rivoluzione:
l'effetto Venturi.
La
prima macchina ad "effetto suolo", la Lotus 78 del
'77, non passò certo alla storia per le sue poco esaltanti
prestazioni, ma fornì la base per la vettura evoluzione, la
Lotus 79, che vinse il mondiale nel '78 e dettò legge in fatto
di progettazione delle monoposto degli anni a venire.

Lotus
79 campione del mondo con Andretti nel '78
Tanto
era efficace la deportanza creata dall'effetto suolo che si
ridussero sempre più, fin quasi a sparire, le
"vecchie" appendici alari che ormai presentavano più
svantaggi che vantaggi (quella anteriore "sporcava" il
flusso d'aria in entrata nelle fiancate).
|
La macchina che cambiò
la Formula 1….. e di più …..
Per ottenere dall'effetto suolo una
deportanza, occorre modificare le forme, in modo che sotto la vettura
passi un flusso d'aria con una velocità maggiore
di quello che passa sopra la vettura, per ottenere ciò si
sfruttano
le proprietà del tubo venturi.
|
|
 |
|
|
 |
La grande stagione disputata dalla Lotus nel 1978
ha come punto di forza una soluzione innovativa, introdotta dalla Lotus
qualche anno prima ed ora finalmente perfezionata: l’effetto
suolo.
Non è la prima volta che la Lotus introduce
un’innovazione tecnica fondamentale: la Lotus 25 introdusse
il concetto di monoposto dotata di scocca. Se era toccato al modello 78
introdurre l'effetto suolo, ora spetta alla Lotus 79, del 1978, portare
al successo l’idea. La Lotus 78, infatti, fu il laboratorio
su cui Chapman perfezionò l'idea. Quest'ultima sarebbe stato
già pronta nell’estate del 1976, ma Chapman, che
rimase stupefatto, nel test che venne effettuato in quel periodo, dal
constare quanto l’auto fosse veloce, decise di tenerla
“nascosto” fino all’inizio della stagione
1977 per non dare modo agli altri di copiare l’idea.
Come detto prima, la stagione ’77 servì per
perfezionare il concetto. Solo con il modello 79, schierato nella
stagione 1978, la Lotus sarà pronta alla vittoria del
mondiale. L’innovazione introdotta della Lotus, il concetto
di “wing car”, sarà di tale portata da
influenzare le scelte tecniche di tutti i progettisti che da allora,
tra il 1979 e il 1982, introdurranno anche loro auto ad effetto suolo.
Approfondiamo la storia dell’introduzione del concetto di
Wing Car. L’idea fu di Chapman ma lo sviluppo di questa
intuizione fu affidato a Peter Wright.
Come funziona l’effetto suolo? Esso si basa su un sistema che
impedisce all’aria che passa sotto la vettura di essere
espulso dai lati. Tale sistema, costituito da bande rigide, montate
nelle fiancate, che scorrono in verticale è detto
“minigonne”. Il risultato è una specie
di Tubo Venturi, in cui il flusso di aria accelera nel punto
più vicino al suolo mentre rallenta nella parte posteriore,
in quella parte denominata “profili estrattori”. La
differenza di velocità tra l’aria che passa sotto
e quella che passa sopra ha come risultato una forte pressione verso il
basso esercitata sulla vettura che quindi risulta incollata al suolo.
L’idea di Chapman, come spesso accade, divenne fonte di
ispirazione per altri team (in particolare Williams, ndr). In questo
modo, mentre Chapman estremizzava il concetto con la in
realtà poco efficiente Lotus ’80 (che faceva
addirittura a meno dell’alettone anteriore), gli altri
perfezionavano il concetto: in particolare, la Williams FW07 e la sua
versione migliorata (FW07B) che corse nel 1980. |
|
| Lunghezza: 4,420 m - Larghezza: 2,146 m - Altezza:
0,965 m - Peso: 575 kg - Carreggiata anteriore: 1,730 m - Carreggiata
posteriore: 1,630 m - Passo: 2,718 m - Trazione: posteriore - Cambio: 5
marce e retromarcia - Freni: pinze in alluminio - Motore: tipo Ford
Cosworth DVF, 8 cilindri a V 90°, 2997cc, aspirato, circa 480 CV |
|
| Inizialmente non ci fu nessun controllo delle
depressioni ne dei flussi laterali, siamo nell'epoca della pre -
deportanza, i flussi sul sottoscocca non hanno nessun tipo di
incanalamento ma sono liberi di muoversi. |
|
| La scoperta della deportanza condusse in tempi
molto rapidi fino al suo sfruttamento più esasperato,
rappresentato dalle "minigonne" ovvero bandelle laterali, scorrevoli
verticalmente fino a terra, capaci di contenere con una barriera fisica
i flussi laterali. L'altezza da terra del fondo era di circa 6- 7 cm. |
|
| Con l'abolizione delle minigonne, e con
l'estensione del fondo piatto, fu necessario riconquistare la
deportanza persa, riducendo drasticamente l'altezza da terra, l'unico
ripiego inizialmente escogitato per ridurre i flussi laterali (ridurre
la loro sezione di passaggio). |
|
 |
|
|
 |
Oltre alla sezione di passaggio si
lavorò sui coefficienti di efflusso ad essa associati:
spigoli vivi (e non arrotondati), "labbri borda" ed infine con
l'esempio sfortunato della Ferrari F92A, unico esempio della creazione
di una minigonna aerodinamica (sfortunato perché dava in
galleria del vento ottimi valori di deportanza, ma sulla pista
incontrava dei problemi, dovuti alla variazione d'altezza).
Oggigiorno è stato introdotto un fondo scalinato, con
l'unico compito di limitare la superficie di fondo piatto, e di
aumentare l'altezza da terra, non mancano esempi di fondi piatti come
quello della Mclaren che è riuscita a recuperare la
deportanza persa con uno studio molto meticoloso dei flussi dell'aria
ed adottando un fondo piatto che somiglia alla chiglia di una barca. |
|
 |
|
|
 |
| Consideriamo che avere vetture molto basse,
comporta la creazione di un effetto pompante della strada, che
può essere considerato come una parete mobile, che nel moto
relativo si muove con una velocità uguale alla
velocità di corsa, in queste condizioni la teoria di Venturi
va rivista. Il risultato di tutti questi fenomeni e ce il corpo vettura
genera una notevole deportanza, il contributo della deportanza totale
ovviamente varia a seconda della configurazione della vettura, in
quanto il contributo del corpo vettura rimane pressoché
sempre lo stesso, cambia molto in base alla configurazione il
contributo dell'alettone. |
|
Per chi ha vissuto con interesse la F.1 di fine
’70 ed inizio ’80, uno dei miti sicuramente
incancellabili è la Lotus 79.
Senza esagerare, si può tranquillamente affermare che ha
segnato la storia della F.1 e di tutto l’automobilismo in
generale, perché, per la prima volta in modo chiaro ed
inequivocabile, è cambiato il modo di vedere
un’autovettura dal punto di vista aerodinamico, da quel 1978
si è capito che non si deve pensare solo al flusso di aria
che passa sopra la carrozzeria, ma anche quello sotto e che i due
flussi devono lavorare in sinergia..
In realtà, ciò fu già immaginato ed
applicato dal (guarda caso) geniale Jim Hall della Chaparral (la stessa
dell’alettone “altissimo”), che
utilizzò delle ventole per estrarre l’aria
forzatamente da sotto e “sputarla” da dietro per
“appiccicare” la macchina al suolo, quasi come
un’ aspirapolvere, ma la soluzione fu prontamente vietata a
causa della pericolosità per chi seguiva per ovvi motivi
(per poi essere tollerata nello stesso ’78, almeno per il GP
di Svezia, alla Brabham di …… Bernie
Ecclestone….) .
La Lotus 79 non fu effettivamente la prima vettura a sfruttare il
“ground-effect” derivante dai due semi-tubi di
Venturi posti sotto le pance laterali, in realtà tale
sistema esisteva già sulla precedente Lotus, la 78, ma Colin
Chapman ed il suo staff tecnico, forse perché compresero
l’importanza della novità tecnica e che,
astutamente, bisognava far passare ed ammettere il principio delle
“bandelle laterali mobili” (poi definite
“minigonne”) in modo “soft” (il
regolamento, di norma, non poteva ammettere parti mobili sulla
carrozzeria), realizzarono l’anno prima una macchina non
ancora completamente votata all’effetto-suolo.
Si narra che al tempo, per depistare la concorrenza (e le commissioni
tecniche…), Colin & C. davano diverse spiegazioni
sui motivi dell’uso delle minigonne, che sulla 78 erano delle
bandelle fisse flessibili e non rigide e scorrevoli verticalmente come
sulla 79, o attribuivano la già ottima aderenza della 78 a
strani marchingegni, tipo differenziali rivoluzionari e cose simili.
La 79, invece, nacque come una vettura completamente disegnata per lo
sfruttamento totale dell’effetto suolo e tutti i suoi
particolari meccanici erano concepiti per utilizzare al meglio il
flusso d’aria sotto le pance.
L’effetto-ventosa, addirittura, causò il ritardo
del debutto della Lotus 79 per l’esigenza di avere
più deportanza aereodinamica sull’anteriore, visto
che dietro la macchina era incollata….. |
|
|
  Quindi, il pilota spostato in avanti, il musetto a
punta e aerodinamicamente “pulito”, gli
ammortizzatori interni al telaio davanti e nella trasmissione dietro, i
dischi ed i freni dietro posti sui mozzi delle ruote, il telaio ed il
gruppo motore-trasmissione il più stretto possibile (furono
anche aiutati dalla forma naturale del V8 Cosworth), i radiatori nei
fianchi con l’uscita dell’aria verso
l’alto, gli scarichi in alto dietro il cofano, tutta la parte
posteriore carenata, insomma, tutto era stato progettato e realizzato
per non dare alcuna noia al flusso d’aria che passava sotto
le fiancate.
Se andate a rivedere le foto delle F.1 del tempo, noterete che in quel
’78 tutte le macchine della concorrenza erano molto diverse
tra loro nelle forme esterne, mentre nel ’79
vedrete….. come si assomigliavano tutte, chi più
e chi meno, alla Lotus 79.
Si dice ancora che se debuttasse oggi, la Lotus 79, a parte i
cambiamenti regolamenti, non sembrerebbe certamente una macchina
progettata più di 30 anni fa.
Solo l’incidente mortale di Peterson a Monza
offuscò la gloria (ed il titolo mondiale) di quel 1978 della
Lotus 79, anche se lo sfortunato pilota utilizzava
nell’occasione una vecchia (e singhiozzante…..) 78
come muletto alla partenza di quel maledetto GP.
Quindi, il pilota spostato in avanti, il musetto a
punta e aerodinamicamente “pulito”, gli
ammortizzatori interni al telaio davanti e nella trasmissione dietro, i
dischi ed i freni dietro posti sui mozzi delle ruote, il telaio ed il
gruppo motore-trasmissione il più stretto possibile (furono
anche aiutati dalla forma naturale del V8 Cosworth), i radiatori nei
fianchi con l’uscita dell’aria verso
l’alto, gli scarichi in alto dietro il cofano, tutta la parte
posteriore carenata, insomma, tutto era stato progettato e realizzato
per non dare alcuna noia al flusso d’aria che passava sotto
le fiancate.
Se andate a rivedere le foto delle F.1 del tempo, noterete che in quel
’78 tutte le macchine della concorrenza erano molto diverse
tra loro nelle forme esterne, mentre nel ’79
vedrete….. come si assomigliavano tutte, chi più
e chi meno, alla Lotus 79.
Si dice ancora che se debuttasse oggi, la Lotus 79, a parte i
cambiamenti regolamenti, non sembrerebbe certamente una macchina
progettata più di 30 anni fa.
Solo l’incidente mortale di Peterson a Monza
offuscò la gloria (ed il titolo mondiale) di quel 1978 della
Lotus 79, anche se lo sfortunato pilota utilizzava
nell’occasione una vecchia (e singhiozzante…..) 78
come muletto alla partenza di quel maledetto GP.
|
|
|
Non
solo, c'e chi esasperò questa ricerca dell'effetto suolo, come
la Brabham nel 78 che portò ad un gran premio un macchina col
fondo completamente sigillato ed un ventilatore sulla parte
posteriore che toglieva aria dal fondo vettura, abbassandone la pressione. Un effetto
suolo forzato! La squadra sostenne che il ventilatore
serviva a raffreddare il motore, ma a fine gara l'irregolarità
divenne palese e scattò la squalifica.
aria dal fondo vettura, abbassandone la pressione. Un effetto
suolo forzato! La squadra sostenne che il ventilatore
serviva a raffreddare il motore, ma a fine gara l'irregolarità
divenne palese e scattò la squalifica.
Il carico deportante
generato dalle fiancate ad ala rovesciata (da qui il nome di
vetture-ala) abbinate alle minigonne, sorta di bandelle, strisce
scorrevoli di materiale rigido, che sigillavano il fondo delle
vetture, con l'aggiunta delle enormi potenze raggiunte con
l'introduzione dei motori turbo proprio negli stessi anni,
resero le Formula 1 dei mezzi difficilissimi da gestire da parte
dei piloti. In curva si raggiungevano livelli di accelerazione
laterale da pilota d'aereo, sottoponendo il fisico ad un
grandissimo sforzo. Ne risentì moltissimo anche lo stile di
guida, a causa delle sospensioni, che dovevano essere regolate
più rigide per mantenere la vettura parallela all'asfalto, e le
auto erano come poste su dei binari, era impossibile o quasi
cambiare traiettoria in curva, una volta impostata. Le macchine
erano difficilmente controllabili, spesso era difficile
correggere un errore di guida, il controsterzo stava sparendo (Gilles
Villeneuve era un'eccezione che però conferma la regola!!).
 |
E c'è da dire anche che
quando una vettura, urtando, alzava il musetto, in velocità,
quasi sempre spiccava il volo, proprio per quella particolare
forma alare, finendo a volte anche nelle tribune.
Questi
fattori e anche altri, come i frequenti cedimenti delle
minigonne, furono la causa di molti gravi incidenti, proprio per
questo motivo nell'83 la federazione internazionale pose
un'ulteriore, pesante limite sulle vetture di F1, bandendo l'uso
delle minigonne e dell'effetto Venturi (tollerato solo
limitatamente agli estrattori), mettendo fine ad un'era.
|
 |
Proprio
nel bel mezzo dell'epoca delle minigonne e dei fondi ad effetto
suolo, si fece notare una squadra , la Tyrrel, che presentò una
soluzione molto interessante che rappresentò però un episodio
abbastanza isolato e quasi subito stroncato dalla federazione
internazionale. Si tratta del progetto della monoposto a 6
ruote, finalizzato alla ricerca di una migliore penetrazione
dell'aria, attraverso l'uso di quattro piccole ruote anteriori,
anziché le consuete due più grandi. naturalmente gli
inconvenienti tecnici non erano pochi, a cominciare dalla
maggior forza centrifuga subita dal pneumatico (a parità di
velocità della monoposto una ruota più piccola deve girare più
velocemente) e anche il sistema di tiranti dello sterzo era
decisamente complicato (dovendo garantire un'inclinazione
diversa per ogni ruota). Nonostante ciò la monoposto si fece
notare con alcune vittorie, prima di essere bandita per
regolamento. |
Proprio
nel bel mezzo dell'epoca delle minigonne e dei fondi ad effetto
suolo, si fece notare una squadra , la Tyrrel, che presentò una
soluzione molto interessante che rappresentò però un episodio
abbastanza isolato e quasi subito stroncato dalla federazione
internazionale. Si tratta del progetto della monoposto a 6
ruote, finalizzato alla ricerca di una migliore penetrazione
dell'aria, attraverso l'uso di quattro piccole ruote anteriori,
anziché le consuete due più grandi. naturalmente gli
inconvenienti tecnici non erano pochi, a cominciare dalla
maggior forza centrifuga subita dal pneumatico (a parità di
velocità della monoposto una ruota più piccola deve girare più
velocemente) e anche il sistema di tiranti dello sterzo era
decisamente complicato (dovendo garantire un'inclinazione
diversa per ogni ruota). Nonostante ciò la monoposto si fece
notare con alcune vittorie, prima di essere bandita per
regolamento.

Jody Scheckter impegnato al Gran Premio di Germania 1976 con la P34
|

La prima stagione (1976)
La Tyrell fece esordire una P34 nel quarto gran premio della stagione sul circuito di Jarama in Spagna. Patrick Depailler,
alla guida della monoposto, riuscì a qualificarsi con il terzo miglior
tempo e la vettura si dimostrò competitiva anche in gara fino al 26º
giro, quando un guasto tecnico lo costrinse al ritiro.
A
partire dal gran premio successivo la scuderia schierò sempre
due P34, ottenendo diversi podi e anche una vittoria nel Gran Premio di
Svezia 1976, dove marcò una storica doppietta (primo Jody
Scheckter e secondo Patrick Depailler). Al termine della stagione
giunse terza nel campionato di quell'anno, grazie ai 49 punti
conquistati da Scheckter nella stagione.
|
|

La
Tyrrel P34-Ford nel '76
|
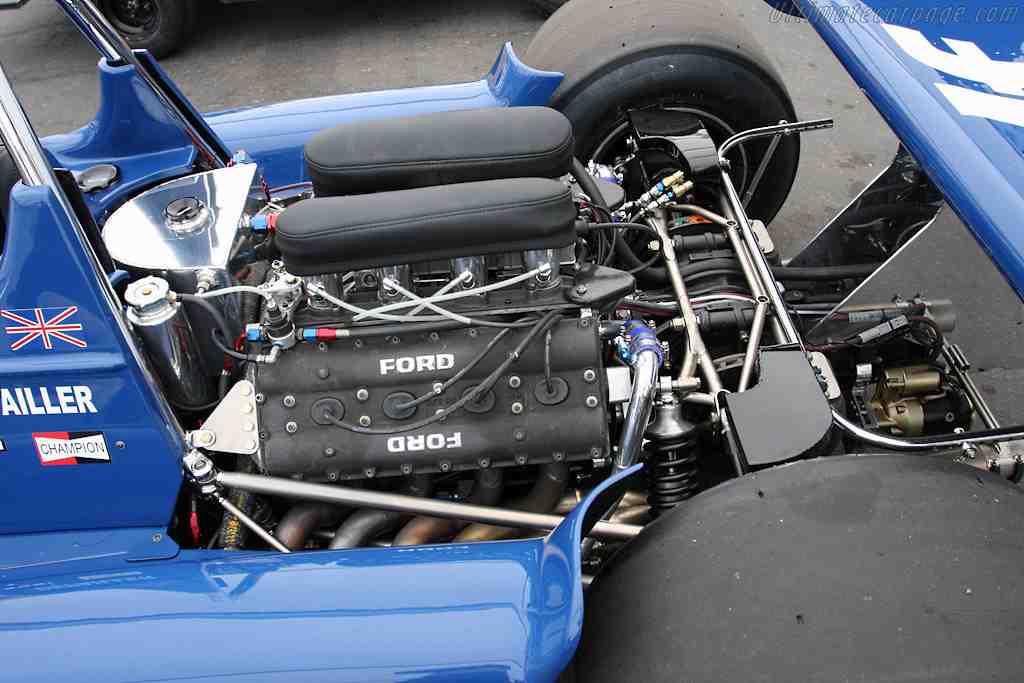
La seconda stagione (1977)
L'anno
successivo la P34 non riuscì a ripetere i risultati del 1976 e la
stagione fu costellata da molti ritiri, in gran parte dovuti ai problemi
causati dal surriscaldamento. Al termine della stagione Patrick
Depailler e Ronnie Peterson
avevano conquistato complessivamente 4 podi ma collezionato ben 19
ritiri e nella classifica finale la Tyrrell non andò oltre i 27 punti
complessivi e il sesto posto nel campionato costruttori.
|
Gli
anni '80
Negli
anni '80, a seguito della forte limitazione dell'effetto suolo,
si vide un rifiorire di appendici alari, anche molto vistose,
fatto che evidenzia il notevole sforzo dei progettisti per
tenere a terra quei mostri che avevano ormai raggiunto i
1400 cavalli di potenza (in qualifica). La monoposto più
celebre e significativa del periodo è la Brabham dell'83, con
la caratteristica forma a freccia.
Patrese
con la Brabham BT 52 BMW Turbo
Ma
ben presto si instaurò una nuova tendenza, la rastremazione
delle fiancate ed in particolare della parte posteriore delle
vetture, dando origine alla famosa forma a
"coca-cola", il cui precursore è stato l'allora
progettista della Mclaren, John Barnard.
In
effetti non si tratta altro che della ricerca, ancora una volta,
della miglior penetrazione aerodinamica, cercando di favorire il
defluire dell'aria attraverso la vettura nel modo meno
turbolento possibile, una ricerca necessaria, in quanto nella F1
moderna il freno aerodinamico non è più costituito solo dalle
ruote scoperte, ma anche e soprattutto dagli alettoni!(Vedi: il
Cx delle F1 moderne).
Allinizio
degli anni '90 vide la luce, sulla Benetton progettata da Rory Byrne,
un'altra soluzione che cambierà significativamente l'aspetto
delle monoposto: il muso alto. Pur presentando lo svantaggio di
innalzare il baricentro della vettura, il muso alto permette un
maggiore afflusso di aria nel fondo scocca, il quale, nonostante
l'assenza di sigilli e l'altezza minima da terra fissata per
regolamento, presenta ancora un certo effetto suolo.
Gli
anni '90
 |
Allinizio
degli anni '90 vide la luce, sulla Benetton progettata da Rory
Byrne, un'altra soluzione che cambierà significativamente
l'aspetto delle monoposto: il muso alto. Pur presentando lo
svantaggio di innalzare il baricentro della
vettura, il muso alto permette un maggiore afflusso di aria nel
fondo scocca, il quale, nonostante l'assenza di sigilli e
l'altezza minima da terra fissata per regolamento, presenta
ancora un certo effetto suolo.
Durante
gli anni '90 le forti restrizioni nelle misure delle appendici
alari hanno reso le monoposto molto più simili fra loro ed è
diventato molto più difficile per gli ingegneri inventarsi la
scelta totalmente controtendenza che alla fine ripaghi in
termini di prestazioni. L'unico vero cambiamento è stato l'uso
generalizzato, dopo il '95, del muso alto stile Benetton.
|
on
a caso l'ultima "genialata" in ordine di tempo, che ha
lasciato tutti a bocca aperta per l'azzardo mostrato e anche per
il vantaggio effettivo ricavato, riguarda l'introduzione del
muso "semi-basso" nella Mclaren di Newey del '98
(Vedi: muso alto o muso basso?).
Lo
studio aerodinamico si è spostato oggi su dettagli come le
carenature delle sospensioni , i deviatori i flusso, i nolder,
le paratie degli alettoni, studio che necessita delle gallerie
del vento, enormi, costosissimi impianti che riproducono le
condizioni di gara. Le
ultime soluzioni riguardo le appendici aerodinamiche riguardano
la ricerca di materiali elastici, con cui costruire ali
"variabili" a seconda delle velocità. Un ritorno
all'antico, ma molto al limite del regolamento, a discapito
della sicurezza (vedi: ali che si flettono). .
|
Allinizio
degli anni '90 vide la luce, sulla Benetton progettata da Rory
Byrne, un'altra soluzione che cambierà significativamente
l'aspetto delle monoposto: il muso alto. Pur presentando lo
svantaggio di innalzare il baricentro della
vettura, il muso alto permette un maggiore afflusso di aria nel
fondo scocca, il quale, nonostante l'assenza di sigilli e
l'altezza minima da terra fissata per regolamento, presenta
ancora un certo effetto suolo.
Durante
gli anni '90 le forti restrizioni nelle misure delle appendici
alari hanno reso le monoposto molto più simili fra loro ed è
diventato molto più difficile per gli ingegneri inventarsi la
scelta totalmente controtendenza che alla fine ripaghi in
termini di prestazioni. L'unico vero cambiamento è stato l'uso
generalizzato, dopo il '95, del muso alto stile Benetton.
Non
a caso l'ultima "genialata" in ordine di tempo, che ha
lasciato tutti a bocca aperta per l'azzardo mostrato e anche per
il vantaggio effettivo ricavato, riguarda l'introduzione del
muso "semi-basso" nella Mclaren di Newey del '98
(Vedi: muso alto o muso basso?).
Lo
studio aerodinamico si è spostato oggi su dettagli come le
carenature delle sospensioni , i deviatori i flusso, i nolder,
le paratie degli alettoni, studio che necessita delle gallerie
del vento, enormi, costosissimi impianti che riproducono le
condizioni di gara.
Le
ultime soluzioni riguardo le appendici aerodinamiche riguardano
la ricerca di materiali elastici, con cui costruire ali
"variabili" a seconda delle velocità. Un ritorno
all'antico, ma molto al limite del regolamento, a discapito
della sicurezza (vedi: ali che si flettono).
L'aerodinamica nella F1 moderna
"L'aerodinamica è il settore dove
può essere creato il miglior guadagno in termini di
performance, ma ottenere questi progressi tanto da diventare
competitivi è difficile". In questa frase del progettista
della Jordan, Mike Gascoyne è sintetizzata l'importanza
dell'aerodinamica nella F1 moderna, profondamente diversa dalla F1 di
30 anni fa, dove spesso la potenza e l'affidabilità di
motori quali il Ford-Cosworth e il FerrariV12 sopperivano alle
insufficienze aerodinamiche delle vetture che li montavano. Oggi molto
spesso si può guadagnare, su una pista media, anche mezzo
secondo al giro solo portando ad un gran premio un'evoluzione di un'ala
provata per qualche giorno in galleria del vento con la spesa di poche
migliaia di dollari, mentre per ottenere lo stesso vantaggio di
prestazioni con un'evoluzione del motore occorrerebbero mesi e milioni
di dollari, con lunghi test al banco ed in pista ed il pericolo di un
guasto che si moltiplica con l'incrementare delle prestazioni.
Per questo è fondamentale oggi lo studio quasi maniacale dei
dettagli di una monoposto, dalle paratie degli alettoni anteriori a
quelle posteriori, dai deviatori di flusso, alle sospensioni col
profilo alare (vedi: le sospensioni dell'Arrows A21), dalla zona
"coca-cola" sempre più rastremata, alle alette davanti alle
ruote posteriori, alla forma dell'airscoop, al disegno delle protezioni
ai lati del casco dei piloti, agli estrattori, al divergente
posizionato sotto il muso, fra le ruote anteriori, alle prese d'aria,
alla sezione del muso sempre più piccola (anche sfruttando
stratagemmi al limite del regolamento).
Senza entrare troppo nella trattazione di ogni singola parte della
monoposto che risulterebbe qui troppo ampia si possono fare alcuni
esempi per rendersi conto del livello di sofisticazione raggiunto oggi
Il primo riguarda la galleria del vento della Benetton, costruita nel
'98 e costata oltre 15 miliardi, che presenta ancora una volta una
soluzione presa in prestito dall'aeronautica, la pressurizzazione.
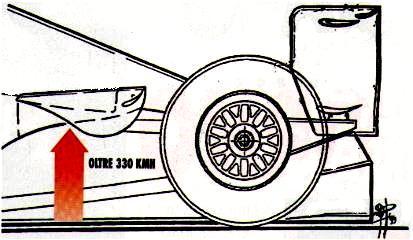 |
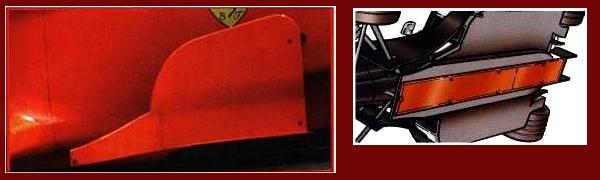
Le gallerie del vento usate oggi dalle scuderie in
F1 non sono in grado di ospitare modelli in scala 1:1, arrivando al
massimo a modelli 1:2, con i conseguenti limiti di validità
dei parametri riscontrati nelle prove. Attraverso la pressurizzazione a
2 atmosfere i valori registrati sono molto più simili alla
realtà anche per modelli in scala.
|
|
L'importanza della corrispondenza fra i valori reali e quelli misurati
in galleria del vento è evidente e spesso i limiti di queste
pur costosissime strutture hanno giocato dei brutti scherzi ai teams,
come alla Ferrari che l'anno scorso sviluppò un'aletta
davanti alle route posteriori che in galleria (dove si raggiungono al
massimo velocità relative del vento rispetto al modello di
250 Km/h) dava buoni valori di deportanza, ma in una successiva prova
sul rettilineo di Vairano, superati i 330 Km/h, dava addirittura
portanza!
Deviatore - Fondo scalinato
Deviatori di flusso sono una delle componenti delle
monoposto più studiate degli ultimi anni, ma sul loro reale
valore ci sono molte perplessità (non solo dovute a presunte
irregolarità...). Basti pensare alla bellissima gara di
Schumacher in Austria nel '98, quando in un'uscita di pista perse
completamente queste appendici, esibendosi in una rimonta che ha fatto
venire il dubbio a molti se quelle alette non facciano andare
più piano...
L'importanza delle ali come risorsa per garantire più grip
alle ruote sull'asfalto è cresciuta in particolar modo dopo
il '94, quando in seguito ai drammatici incidenti di Barrichello,
Ratzenberger e Senna, la FIA introdusse in fondo scalinato, che impone
alla vettura un limite minimo di altezza da terra di 5 cm, al di fuori
di un canale centrale dove è normalmente posizionata la
zavorra della vettura e dove la federazione ha imposto uno "scivolo" di
legno che garantisca il rispetto delle norme (lo scivolo di legno non
si può consumare oltre 1 mm!).
Nella F1 moderna il carico deportante è da attribuire in
media per 2/3 alle ali (in particolare quella posteriore) e solo per
1/3 al fondo e all'estrattore posteriore |
|
Basi di Fluidodinamica:
L'aerodinamica non è che un caso
particolare della fluidodinamica, che è lo studio della
dinamica, del movimento dei fluidi in generale. Il moto di un corpo in
un fluido, quando è abbastanza lento, risulta "laminare",
cioè il fluido si sposta come se fosse costituito da tante
lamine sottili che scorrono l'una sull'altra. Quando il moto del corpo
nel fluido è troppo veloce, si definisce "turbolento", in
quanto si formano in modo caotico tanti piccoli vortici e le
velocità differiscono notevolmente anche per punti molto
vicini e cambiano rapidamente nel tempo. Una opportuna forma
dell'oggetto può favorire il moto laminare: la forma a
goccia: Il moto laminare è quello che garantisce la minor
resistenza all'avanzamento, in più facilita notevolmente lo
studio dei fenomeni che caratterizzano la fluidodinamica. |
|
|
|
 |
Se qualcuno avesse dubbi sui vantaggi aerodinamici
della forma a goccia, notate bene i coefficienti scritti sotto ad
ognuna delle seguenti figure:
Il profilo a goccia dà una resistenza 7 volte inferiore alla
sfera!!!
Esiste anche una formula per calcolare approssimativamente la
resistenza F dell'aria rispetto ad un corpo:
1/2DAV²
dove D è la densità dell'aria, A è
l'area frontale del corpo e V è la velocità. |
|
Come funzionano le ali:
Il principio di funzionamento delle ali
può essere ricondotto al teorema di Bernoulli per la
fluidodinamica, secondo il quale (per il moto laminare) lungo un alinea
di flusso la pressione è inversamente proporzionale al
quadrato della velocità. Nella figura in basso sono indicati
due profili, uno curvilineo, ed uno piano. Facendo scorrere un fluido
su queste superfici si nota che il la linea di fluido che scorre sul
profilo superiore deve percorrere più strada, nello stesso
tempo, rispetto al profilo inferiore. L'aria è quindi
più veloce sopra l'ala ed è minore la pressione
dell'aria.
Questa differenza di pressione fa sì che l'ala subisca una
spinta verso l'alto detta PORTANZA (la freccia blu). |
|
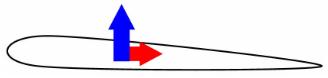 |
Inclinando il profilo aumenta la depressione ed
aumenta di conseguenza la deportanza, ma aumenta anche il freno
dell'aria (la sezione frontale è maggiore). |
|
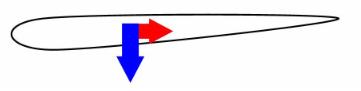 |
Inclinando il profilo aumenta la depressione ed
aumenta di conseguenza la deportanza, ma aumenta anche il freno
dell'aria (la sezione frontale è maggiore). |
|
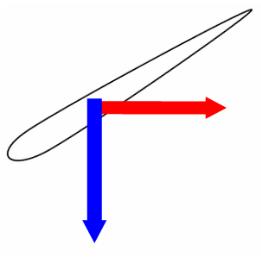 |
Inizialmente questo "inconveniente" venne superato
con lo stratagemma delle ali mobili, ma nella F1 moderna, in tempi di
ali fisse (o quasi, vedi: Ali che si flettono), è
fondamentale trovare il miglior compromesso fra carico deportante e
resistenza dell'aria.
Dato che le ali servono fondamentalmente in
curva, saranno i circuiti più tortuosi a richiedere un
maggior carico alare, sacrificando la velocità massima in
rettilineo, mentre nei circuiti con i rettifili più lunghi
saranno utilizzate ali quasi orizzontali. |
|
 |
| Inizialmente questo "inconveniente" venne superato
con lo stratagemma delle ali mobili, ma nella F1 moderna, in tempi di
ali fisse (o quasi, vedi: Ali che si flettono), è
fondamentale trovare il miglior compromesso fra carico deportante e
resistenza dell'aria. Dato che le ali servono fondamentalmente in
curva, saranno i circuiti più tortuosi a richiedere un
maggior carico alare, sacrificando la velocità massima in
rettilineo, mentre nei circuiti con i rettifili più lunghi
saranno utilizzate ali quasi orizzontali. |
|
|
Configurazioni alari della F399
rispetti vamente a Montecarlo e a Monza. vamente a Montecarlo e a Monza. |
Effetto Venturi:
Anche l'effetto Venturi è
un'applicazione del teorema di Bernoulli che sfrutta l'accelerazione
dell'aria in un condotto ricavato fra l'asfalto
ed il fondo vettura.
Il condotto era sigillato perfettamente dalle "minigonne", le bandelle
laterali che, scorrendo lungo le fiancate, impedivano all'aria di
entrare
nel fondo vettura dai lati.
Dato che la portata (quantità di aria al secondo) dell'aria
sotto le fiancate non cambia, l'aria era costretta ad accelerare nel
punto
di restringimento del condotto, portando ad una diminuzione della
pressione che determinava la deportanza |
|
 |
|
 |
Era fondamentale quindi garantire il massimo
afflusso di aria con moto non turbolento (il teorema di Bernoulli non
è più valido per il moto turbolento, si riduce
l'efficienza del profilo alare) e il massimo deflusso nella parte
posteriore, che avveniva per mezzo di opportuni "estrattori" (condotti
a sezione via via più grande.
Nel tentativo di ridurre l'efficienza di tale soluzione la federazione
internazionale impose ben presto delle minigonne fisse, non
perfettamente aderenti al suolo ed arrivò nell'83 ad
introdurre un nuovo fondo piatto in cui l'effetto Venturi era limitato
ai soli diffusori (altro nome degli estrattori) posteriori.
Anche il fondo piatto tuttavia non è esente da rischi di
"decolli", basti vedere queste immagini:
|
Monza '93
|
|
|
Il Cx delle F1 moderne:
Chi pensa alle F1 come fossero dei Jet con le ruote
si sbaglia. Il coefficiente che quantifica la prestazione aerodinamica,
il Cx appunto, è molto alto (cioè indica una
prestazione pessima!), superiore a quello di una utilitaria, a causa
delle ruote scoperte, ma anche delle superfici alari, che si presentano
come vere e proprie barriere contro l'aria. Sotto questo aspetto sono
eloquenti i 280 Km/h di velocità di punta dell'Hungaroring
ed i 360 Km/h di Monza
(vedi: Come funzionano le ali). |
|
 |
|
|
 |
Perché non ci sono
più sorpassi in F1?
E' la domanda-tormentone che si fa ogni
appassionato di questo fantastico sport quando si ritrova a dover
assistere ad un Gran Premio nel quale solo qualche fumata ogni tanto
(si spera non delle rosse!) rompe la monotonia di un trenino di vetture
che si rincorrono senza la possibilità (o la
volontà?) di sorpassi da parte dei piloti. In
realtà il problema è decisamente vecchio e si
può ricondurre alla nascita delle ali, che incrementano la
velocità di percorrenza delle curve da parte delle vetture,
ma risentono molto della turbolenza di un'eventuale vettura che
precede.
La turbolenza generata dalla vettura davanti fa perdere carico sull'ala
anteriore della propria vettura, aumentando il sottosterzo in curva,
ovvero, la macchina, a parità di velocità
rispetto alla macchina davanti, non riesce a mantenersi in traiettoria,
tendendo ad allargare con l'anteriore. |
|
 |
|
|
 |
Di questo fatto si lamentavano già i
piloti degli anni '70 e 80. Verrebbe allora da chiedersi
perché proprio in quegli anni sono state scritte le pagine
più belle della Formula 1,con gli epici duelli a suon di
sorpassi di Gilles Villeneuve, Arnoux, Senna, Piquet, Alboreto,
Mansell, Prost, etc...
In effetti si potrebbe arrivare alla conclusione che quei piloti erano
fatti di un'altra pasta, ma in difesa dei piloti odierni, si
può obiettare che le monoposto moderne sono molto
più spinte, delicate, sono vetture "estreme", difficili da
guidare e con le quali è difficile far risaltare le doti di
ogni singolo pilota. La FIA poi, ci ha messo del suo prendendo dei
provvedimenti, come la riduzione delle carreggiate e l'introduzione
delle gomme scanalate, che di certo se hanno migliorato la situazione
dal punto di vista della sicurezza, non hanno certo facilitato il
lavoro dei piloti, aumentando l'instabilità delle vetture. I
rifornimenti in gara costituiscono inoltre un ulteriore deterrente
contro il tentativo di sorpasso, visto che qualche posizione la si
può guadagnare al pit stop.
In realtà l'unica via possibile per tornare a vedere
sorpassi in F1 su tutte le piste ed in tutte le condizioni sarebbe
incrementare il grip (aderenza all'asfalto) meccanico (cioè
quello dovuto al lavoro delle ruote, delle sospensioni e del telaio)
che facilita i piloti nel controllo della vettura nelle manovre
più ardite, e ridurre il grip aerodinamico (quello dovuto
alle ali ed al fondo piatto) che è disturbato dalla vettura
che precede.
Magari gli sponsor non sarebbero molto contenti di veder tolti quegli
enormi cartelloni pubblicitari che sono le ali odierne, ma
probabilmente ritroveremo il gusto delle gare di 30 anni fa, dove era
determinante il gioco delle scie e l'astuzia e la perizia dei piloti
era esaltata ai massimi livelli. |
|
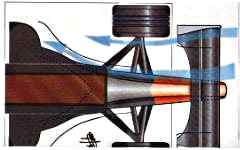 |

| Ecco cosa succedeva alle F1 senza ali... |
|
|
Muso alto o muso basso?
 |
Una delle grandi questioni di fine secolo che hanno
animato le menti dei progettisti in F1 è lo "scontro" fra i
sostenitori del muso alto, con al primo posto la Ferrari, e quelli del
muso basso, con il progettista Mclaren Adrian Newey il primo piano.
Ogni soluzione presenta sia dei vantaggi che degli svantaggi. Per
esempio il muso alto, sviluppato all'estremo nella F1-2000 da Rory
Byrne, l'ex progettista Benetton che per primo l'aveva introdotto,
permette un maggior afflusso di aria "pulita" nel fondo scocca,
favorendo l'effetto Venturi (molto limitato, a causa del fondo
scalinato, vedi: Come funziona un F1 moderna). Per contro un muso
più alto alza il baricentro della vettura, sfavorendone le
prestazioni (aumentano il beccheggio ed il rollio), cosa che ha cercato
di evitare il Adrian Newey nella Mp4/13 del '98, abbassando il musetto
di molto rispetto alle vetture dello stesso anno e disegnandolo con una
particolare sezione a V in modo da permettere comunque un discreto
afflusso d'aria nella parte inferiore della vettura. |
|
|
Nel '98 e '99 ha nettamente prevalso la scelta di
Newey, con la duplice vittoria della sua monoposto e la tendenza da
parte di molti teams ad adeguarsi al muso basso. La Ferrari,
però ha proseguito per la sua strada e quest'anno ha con
coraggio ulteriormente sviluppato il muso rialzato e scavato nella
parte inferiore, in controtendenza rispetto alle altre squadre,
riuscendo ad ottenere un netto salto di prestazioni
(naturalmente
dovuto anche ad altre componenti). |
|
Le sospensioni dell'Arrows A21:
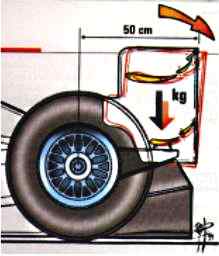 |
In tema di ricerca aerodinamica estrema, che
dà un grande peso anche ai dettagli vale la pena di citare
l'Arrows che quest'anno cha presentato la nuova vettura progettata
dall'aerodinamico ex Williams Eghbal Hamidy con una soluzione vecchia,
ma comunque interessante, dato che nessuna squadra la usava
più da anni. si Tratta della sospensione anteriore "pull
rod", ansiché "push rod", ovvero non c'é
più il puntone che preme quando la ruota viene spinta verso
l'alto, ma un tirante che svolge la stesa funzione di ammortizzamento
appunto in tiraggio.
Senza entrare nel dettaglio basti sapere che un tirante a
parità di forza, può essere costruito con un
diametro minore rispetto ad un punto. In sostanza all'Arrows si sono
messi a progettare una sospensione nuova, difficile da metter a punto
con il muso semi-basso che va di moda oggi, solo per guadagnare
qualcosa in penetrazione aerodinamica.
Sono impazziti? Le prestazioni, almeno quelle velocistiche, che hanno
mostrato fin'ora suggerirebbero proprio di no (anche se ancora una
volta, il complesso delle prestazioni dipende da molti fattori). |
|
|
Ali che si flettono
Il caso è scoppiato a Suzuka nel '97 e
da allora praticamente non si è più chiuso. Anche
in televisione era evidente la flessione dell'alettone anteriore della
Ferrari di Michael Schumacher, flessione che avvicinava le paratie
laterali dell'ala al suolo, migliorandone il rendimento (maggior
effetto Venturi). Naturalmente l'alettone ritornava in posizione
corretta a vettura ferma, consentendo alla monoposto di superare le
verifiche post gara. Indiscrezioni parlarono di una soluzione simile,
proprio nello stesso GP, anche sull'alettone posteriore della Williams
di Jacques Villeneuve. Da allora, con l'aumentare delle prove di nuovi
materiali deformabili da parte di molte squadre, sono diventate sempre
più frequenti le rotture di ali sia durante i test privati
che durante le gare, portando la FIA ad imporre dei test di
elasticità delle appendici alari (in precedenza il
regolamento diceva soltanto che queste dovevano essere rigidamente
collegate al corpo vettura, ma non specificava il coefficiente di
elasticità dei materiali di costruzione).
Il vantaggio fornito da un'ala deformabile è facilmente
intuibile, dato che all'aumentare della velocità la
resistenza dell'aria appiattisce l'ala, tendendo a renderla
più orizzontale, quindi con una minor resistenza
all'avanzamento. |
|
 |
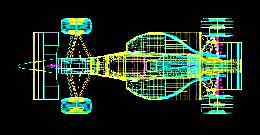 |
La difficoltà da parte della FIA nel
l'imporre dei parametri sta però nel fatto che le appendici
alari devono avere una certa elasticità, in modo da
assorbire le notevoli vibrazioni causate dagli alti regimi del motore,
una eccessiva rigidità infatti causerebbe lo spezzarsi dei
supporti degli alettoni.
Il problema della rigidità delle appendici alari
è decisamente complesso e rappresenterà
probabilmente uno degli sviluppi futuri della ricerca aerodinamica, che
oggi si avvale di potenti software di cam-cad e simulazione,
prospettando un futuro nel quale le gallerie del vento saranno
sostiuite
da potenti calcolatori. |
|
La sicurezza
Il Cockpit
|
L'abitacolo è la zona della monoposto dove il pilota controlla il
mezzo. Nell'abitacolo il pilota deve entrare e uscire con rapidità
altrimenti in caso di incendio potrebbe rimanere ustionato. Infatti
quando si prende la "SuperLicenza" (licenza per guidare una monoposto in
F1) occorre dimostrare agli esaminatori che si è in grado di uscire
dall'abitacolo velocemente. Nell'abitacolo le cinture di sicurezza
devono stringere fortemente il pilota che deve sostenere forze pari a 7g
in accelerazione, fino a 4g negative in frenata e fino a 2g laterali in
curva.
|

|
Nell'abitacolo (cockpit) il volante deve avere tutti i pulsanti ben
visibili e che siano facilmente raggiungibili dalle dita senza che la
mano lasci lo sterzo. Anche la posizione di guida è fondamentale perchè
condiziona, anche se minimamente, la stabilità del veicolo. Gli
ingegneri di F1 stanno studiano un metodo per abbassare il centro di
gravità poichè anche se la macchina pesa circa 600 Kg, bisogna contare
il peso del pilota che è di circa 70 Kg in modo che la monoposto in
curva sia ancora più stabile di quanto lo sia ora. Per questo motivo i
piloti più bassi si trovano svantaggiati da questo fatto.
Infatti essi
poichè vedono solo la parte più alta delle gomme potrebbero sbagliare il
loro posizionamento in griglia in quanto non vedrebbero la linea bianca
a terra o non vedrebbero correttamente chi sta dietro mediante gli
specchietti retrovisori. |
Per quanto riguarda la sicurezza esiste oltre
alle cinture un sistema che blocca la spalla e il collo in modo da
evitare colpi di frusta. Questo sistema esiste nella F. Cart americana e
fra uno o due anni sarà obbligatorio anche in Formula 1.
|
Volante e pedali
|
Nel lontano 1996 la Ferrari adottò il primo volante con il cambio e
le principali funzioni di guida sul volante (ripartitore di frenata,
TALK con il box, limitatore di velocità ai pit stop ecc.). I vantaggi
erano molti: non si dovevano più staccare le mani dal volante per
cambiare i rapporti (come invece noi facciamo quando dobbiamo cambiare
marcia), non ci si distraeva più per modificare il ripartitore di
frenata e inoltre (forse è il vantaggio più grosso) il cambio fu per la
prima volta sequenziale e conseguentemente non si sbagliava più a
inserire la marcia superiore o inferiore, come invece accadeva alcuni
anni fa. Difetti?
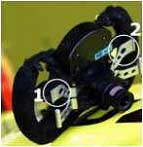 |
Il costo (varia da 80 a 100 milioni di lire), ma
d'altronde in F1 la tecnologia non ha prezzo. Sui volanti attuali è
montato un led rosso che indica il numero di giri e permette di cambiare
rapporto senza errori. Dal campionato 2002 sarà obbligatorio avere
altri led colorati che indicheranno la bandiera gialla, quella blu,
rossa, nera senza quindi far esporre i leoni della CEA che rischiano la
vita. Le leve per cambiare i rapporti sono due: quella di destra serve
per salire di marcia, mentre quella di sinistra serve per scalare di
marcia eccetto Villeneuve che usa i comandi in modo particolare. |
Infatti lui usa solo la mano destra e per salire di marcia tira verso
di se la leva, mentre quando deve scalare di marcia spinge la leva
verso l'esterno. Dall'immagine a sinistra (volante della Jordan) si
vede la leva destra (1) e quella sinistra (2). Sotto alle leve del
cambio si notano le leve della frizione che permettono di risparmiare
spazio tra i pedali. La pedaliera è specifica per ogni pilota in quanto
varia la distanza dal sedile in base all'altezza del pilota, la
grandezza del pedale che varia al variare della lunghezza del piede. Ci
sono piloti che usano la pedaliera al contrario, cioè con il pedale
destro frenano e con quello sinistro accelerano.Nella foto sottostante
abbiamo analizzato il volante della F2002.
|
|

|
- 0 (limitatore di velocità) serve a limitare la velocità ai box
- 1 (radio) serve a comunicare con i box
- 2 i tre manettini rosso, giallo, e nero servono per la regolazione di alcuni parametri del motore
- 3 Serve per incrementare un settaggio
- 4 Regola alcuni parametri per le partenze, e il tasto blu per
cambiare schermate.Il tasto OK serve per attivare o meno la telemetria
bidirezionale
- 5 Spegnere il motore
- 6 Controllo dei parametri del traction control.I due manettini
superiori servono per la regolazione del differenziale.Il tasto OIL
serve per aprire il serbatoio dell'olio.Il tasto F (fuel) serve per
aprire lo sportello della benzina
- 7 Partenza
- 8 Scalate multiple. Il tasto N serve per portare la vettura a
folle. I due piccoli display posti alla sinistra della M e sopra al
tasto L indicano quando cambiare marcia.
|
Il sedile del pilota deve perfettamente adattarsi alla sua schiena e
deve ridurre le fortissime vibrazioni prodotte dal motore. I sedili sono
anche rimovibili perchè in caso di utilizzo del muletto devono essere
immediatamente cambiati.Le cinture di sicurezza sono a cinque punti,
proprio come in un aereo da guerra e sono costituite da una fibra molto
resistente. Queste cinture sono molto resistenti e quindi in caso di
incidente il pilota rimane "incollato" al sedile. L'unico difetto di
queste cinture è che occorre sempre un'altra persona (solitamente è un
meccanico) che stringa le cinture.
| TECNOLOGIE DI SICUREZZA ATTIVA |
|
Le automobili moderne sono spesso e volentieri
degli autentici concentrati di tecnologie di sicurezza attiva,
ovverosia quei dispositivi che aiutano il guidatore nella conduzione
sicura del veicolo: i 3 principali possono essere considerati
l’ABS, il controllo della stabilità (VDC o ESP o
MSP o TSC, ogni costruttore automobilistico utilizza una propria sigla
di identificazione, anche se il dispositivo rimane lo stesso) e il
controllo della trazione ASR.
In aggiunta il continuo progresso dell’elettronica ha portato
allo sviluppo di diversi sistemi: il ripartitore della frenata EBD,
l’MSR e tante altre tecnologie di ausilio alla guida.
Ma attenzione: questi dispositivi non vincono i limiti della fisica! La
parte più importante di un’auto rimane sempre
l’uomo che la guida! |
|
L’ABS è stato il primo
dispositivo di sicurezza attiva “elettronica” ad
essere sviluppato ed impiegato in massa in campo motoristico. Evita il
bloccaggio delle ruote, garantendo in situazioni di
emergenza/imprevisto il miglior spazio di arresto e mantenendo sempre
la direzionalità, permettendo di evitare un eventuale
ostacolo.
Mentre senza ABS si rischia il bloccaggio delle ruote, e per evitare un
ostacolo si dovrebbe rilasciare il freno (per recuperare
direzionalità) e sterzare per evitare l’ostacolo
appunto, con l’ABS ci si deve preoccupare solo di frenare al
massimo (e sterzare, ovviamente se necessario, ma senza alleggerire
minimamente la pressione sul freno). Una vibrazione sul pedale freno
avverte dell’entrata in funzione del sistema. |
|
con la Ferrari 156.
| L’ASR mantiene sotto controllo eventuali
perdite di aderenza dovute alla potenza del motore e al conseguente
pattinamento delle ruote motrici: appositi sensori misurano lo
scostamento tra la velocità delle singole ruote e quella del
veicolo. Quando non c’è corrispondenza tra i due
valori, il sistema agisce su freni ed elettronica del motore
equilibrando la situazione ed impedendo la sbandata
dell’anteriore o del posteriore (a seconda delle ruote
motrici). |
|
con la Ferrari 312 T.
L’ESP® è il sistema
più evoluto di controllo della stabilità:
migliora la stabilità, non solo durante le fasi di frenata e
di accelerazione, ma in ogni condizione di guida. Se esiste il rischio
di una perdita di aderenza di una o più ruote del veicolo,
il sistema ESP® regola la potenza del motore e
contemporaneamente frena singolarmente le ruote permettendo il recupero
della stabilità della vettura.
L’ESP® individua un inizio di sbandata del veicolo
già nelle primissime fasi e lo contrasta rapidamente.
Ciò migliora notevolmente la sicurezza di guida.
ABS e ASR (incorporati nel sistema) sono in grado di aiutare il
guidatore in caso di variazioni anomale della velocità
longitudinale del mezzo, in particolare regolando
l’accelerazione e la frenata del mezzo.
L’ESP® in aggiunta assiste il guidatore nei movimenti
trasversali rispetto alla direzione di marcia. Attraverso un sensore di
angolo di sterzo, che appunto misura l’angolo di rotazione
dello sterzo, il sistema rileva la direzione di marcia voluta dal
guidatore. Contemporaneamente ed in modo integrato ulteriori sensori
misurano il movimento rotatorio del veicolo intorno al proprio asse
verticale e la sua accelerazione laterale. Tramite l’analisi
di queste informazioni il sistema analizza lo spostamento reale del
veicolo, confrontandolo ben 50 volte al secondo con la direzione
desiderata. Se i valori non corrispondono il sistema reagisce
istantaneamente senza alcuna necessità di intervento da
parte del guidatore. ESP® adatta l’erogazione di
potenza del motore per ripristinare le condizioni di
stabilità della vettura. Se ciò non fosse
sufficiente il sistema interviene anche frenando in modo differenziato
le singole ruote. Tale azione determina un momento di rotazione opposta
alla rotazione generata dalla sbandata in modo tale che, nei limiti
dati dalla fisica, la vettura viene ribilanciata e riportata nella
corretta posizione di marcia. |
|
|
I Caschi
|
I caschi sono una delle componenti della divisa del pilota che spesso
salvano la vita. Essi sono costituiti da un materiale leggero e
resistente agli urti. Il casco deve comunque essere sempre molto leggero
perchè altrimenti il collo ne risentirebbe. Il peso medio di un casco è
di circa 1.25 Kg ed è costituito da fiberglass. L'imbottitura è invece
di polistirolo compresso che è uguale per tutti i tipi di casco per
moto. La visiera è spessa 3mm e deve resistere a urti violentissimi ma
deve anche essere impermeabile, così in caso di pioggia l'acqua scivola
via e il pilota può vedere la strada.
 |
I caschi però non devono solo
proteggere la testa, ma devono anche essere aerodinamici. Infatti spesso
i piloti esano una bavetta deportante (5) sotto la mentoniera e un
piccolo spoiler che bilancia il casco e indirizza quanta più aria
possibile alla presa d'aria del motore.Nel casco è presente una
cannuccia dove il pilota può bere acqua quando ne ha bisogno premendo un
tasto sul volante. Può, premendo un apposito tasto chiamare i box
parlando con il microfono (10) Il costo è di circa 3.500.000 con la
radio e personalizzato. In media un pilota usa 7~10 caschi a stagione. |
I caschi usati sono cinque: Arai, Bell, Shoei, Bieffe e recentemente
Schuberth. I fratelli Schumacher e Nick Heidfeld stanno usando un casco
speciale realizzato proprio per loro dalla nuova Schuberth. Qui sotto è
stato ridisegnato il casco che M. Schumacher provò lo scorso anno e che
era dotato di schermo interattivo al posto della tradizionale visiera.
Questo casco è molto simile (in quanto a funzioni) a quello dei piloti
militari, perchè in tempo reale indica alcuni parametri come i giri del
motore, la velocità, il rapporto inserito la quantità di benzina ecc.
sulla visiera.

|
Non è stato utilizzato più, perchè secondo il campione
tedesco il continuo via-vai di queste informazioni può distrarre il
pilota in fasi concitate della gara. Tutto questo si realizza grazie
all'ausilio di una mini centralina (1), posizionata proprio sotto la
visiera.Lo scorso 20 giugno 2001 il presidente Fia Max Mosley ha
presentato un nuovo casco, prodotto dalla Trl britannica.
E' in carbonio
e offre il 70% in più di resistenza all'urto,un margine di sicurezza
altrettanto grande in caso di rotazione violenta della testa (causa
molte lesioni) e una maggiore impenetrabilità. Il punto debole di molti
caschi, infatti è proprio quello di offrire scarsa protezione all'urto
con oggetto acuminati. Questo casco è stato preso in considerazioni da
molti piloti, ma ancora non è stato usato da nessuno.
|
|

L'Alfa Romeo 159 della stagione 1951 era caratterizzata da telaio tubolare "a sigaro", carreggiata molto stretta e motore anteriore.

La Tyrrell 006
del 1973 fu una vettura di transizione, che utilizzava una serie di
elementi innovativi (radiatori laterali, "periscopio", alettoni) senza
fonderli in un armonico disegno.
|
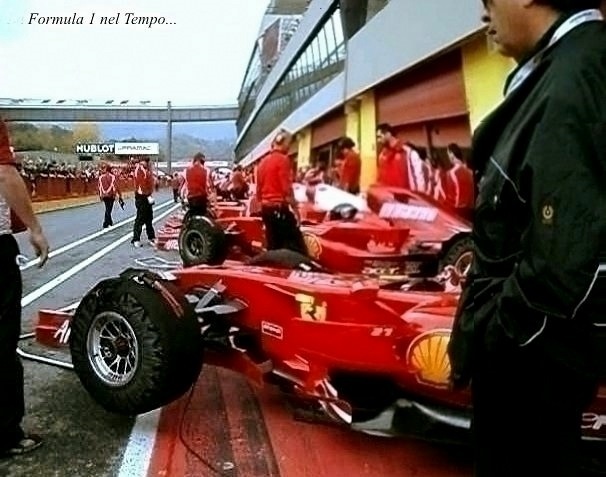 |
La McLaren M23, una delle monoposto più vincenti nella storia
della Formula 1.

Juan Pablo Montoya, con la Williams,
ottenne in prova a Monza nel 2004 la media di 262,24 km/h, migliorando
il record da lui già stabilito sulla stessa pista nel 2002.
|
|
|
Il primo motore turbo della FERRARI in F1 negli anni ’80: IL famoso 126 C
La Ferrari fu la prima scuderia di F1 a seguire l’esempio della Renault
nella costruzione di un motore turbo negli anni ’80. L’ingegner
Forghieri, capo indiscusso dell’ufficio tecnico Ferrari in quel periodo,
e il suo gruppo riuscirono a costruire in 6 mesi un motore
turbocompresso a 6 cilindri disposti a V di 120° di 1500 cm³ di
cilindrata. La scelta cadde su questo grado di frazionamento della
cilindrata (250 cm³, cioè un quarto di litro per ogni cilindro) e sulla
relativa disposizione geometrica delle bancate di cilindri a V di 120°.
Ciò consentì un punto d’incontro fra le due opposte tendenze:
- Conservazione di un basso baricentro del corpo motore (il limite
massimo era rappresentato dal famoso motore boxer Ferrari a 12 cilindri a
V a 180°)
- Predisposizione ottimale degli spazi geometrici intorno e sotto il
motore atti a ottenere il miglior effetto suolo con le canalizzazioni
(effetto tubo di Venturi).
Questo motore fu chiamato con la sigla 126 C dove:
a) il numero 12 indicava le decine di gradi (quindi 120°) dell’angolo compreso fra i cilindri
b) il numero 6 indicava il numero dei cilindri
c)la lettera “C” indicava che il motore era sovralimentato con compressore
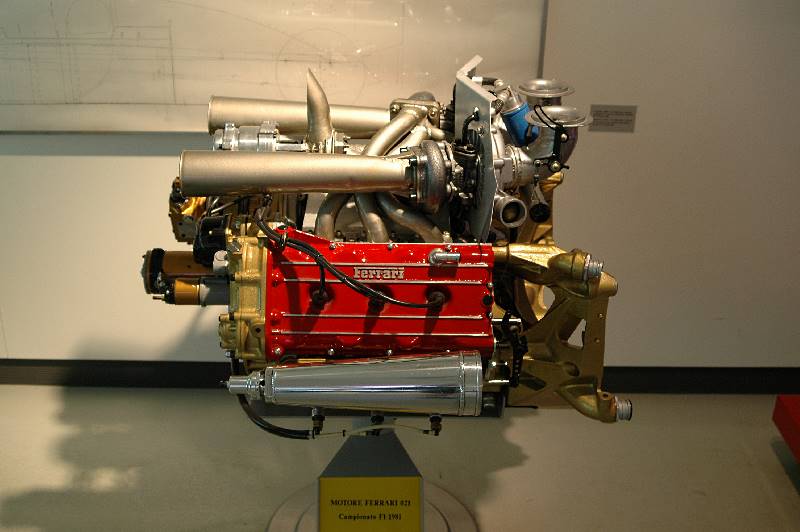
Figura 1 il motore F1 turbo Ferrari 126 C del 1981
|
Le caratteristiche di tale motore erano;
- cilindrata
1496
cm³
- numero di cilindri 6
- disposizione V a 120°
- alesaggio (d ) 81 mm
- corsa (c ) 48,4 mm
- rapporto caratteristico corsa/diametro 0,6
- potenza
Max
660
Cv
- numero di giri Max 11000 giri/minuto
- turbocompressore 2 (uno per bancata) a chiocciola fissa della KKK con 140.000 giri/minuto della turbina
- pressione di alimentazione 1,8 bar
- coppa
Max
40,1
kgm a 9000 giri/minuto
- rapporto di compressione 6,5 : 1
- distribuzione 4 valvole per cilindro con 4 alberi a camme in testa
- alimentazione sovralimentato ad iniezione meccanica indiretta Lucas
Questo motore V6 era costituito da:
- monoblocco compatto in lega d’alluminio (mentre Renault come abbiamo
visto aveva il monoblocco in ghisa speciale in quanto Renault riteneva
che il monoblocco d’alluminio non avesse la necessaria rigidezza
strutturale)
- 2 testate in lega leggera con doppio albero a camme comandato da ingranaggi
- 4 valvole per cilindro, 2 di aspirazione 2 di scarico
- camera di combustione quasi piatta
- basso rapporto di compressione (6,5 : 1 ) a causa della sovralimentazione
- rapporto caratteristico corsa / alesaggio = 0,6 decisamente basso.
Questo basso valore consentiva di abbassare il valore dell’accelerazione
del pistone con riduzione delle forze d’inerzia associate.
Venne scelta la soluzione 6 cilindri a V a 120° fra loro, perché
questo permise una costruzione semplice ed economica dell’albero a
gomiti in quanto composto da solo 3 manovelle. Infatti le teste delle
bielle dei cilindri adiacenti ad ogni bancata venivano applicate, a due a
due, ad uno stesso bottone di manovella. In tal modo l’albero a gomiti
era costituito da soli 3 gomiti a 120° l’uno dall’altro ( vedi fig.2 )

Figura 2 le tre coppie di cilindri a V
con angolo di 120°
|
L’albero a gomiti risultava più corto perché costituito da sole 3
manovelle, di conseguenza anche il motore risultava più corto. Anche il
rendimento totale del ciclo Otto veniva massimizzato grazie all’ordine
di scoppio che avveniva ogni 120° di rotazione dell’albero motore.
Questa soluzione produceva tuttavia vibrazioni molto pericolose per
la resistenza del materiale, le cosiddette forze d’inerzia alternate del
1° ordine prodotte dalle masse degli elementi in moto alternativo (nel
capitolo tecnico dedicato vedremo in dettaglio la genesi delle forze
d’inerzia alternate e come vengono equilibrate).
A causa di questi fenomeni l’albero a gomiti del motore turbo 126C fu
equipaggiato con contralberi di equilibratura per evitare rotture, ma
con un relativo aumento di peso.
Per l’impianto di sovralimentazione, poiché si era capito che la potenza erogata
era legata quasi unicamente alla pressione di sovralimentazione, la
Ferrari decise di sperimentare l’utilizzo dei 2 turbo compressori e in
alternativa l’utilizzo di un compressore volumetrico (detto Comprex e
progettato dalla Brown Boveri).a
|
era legata quasi unicamente alla pressione di sovralimentazione, la
Ferrari decise di sperimentare l’utilizzo dei 2 turbo compressori e in
alternativa l’utilizzo di un compressore volumetrico (detto Comprex e
progettato dalla Brown Boveri).
Come vedremo nei prossimi capitoli la differenza tra i due sistemi di sovralimentazione è sostanziale.
Il turbocompressore era, ed è tutt’oggi, costituto dalla girante del
compressore calettata sull’alberino della turbina azionata dai gas di
scarico,gas che comunque sarebbero andati persi. Il compressore
volumetrico sviluppato dalla Brown Boveri si basava sulle onde di
propagazione dei gas di scarico e il loro salto di temperatura. Il
compressore, per comprimere l’aria da inviare alla camera di
combustione, veniva fatto girare da una cinghia di trasmissione
collegata all’albero motore generando così una dissipazione di potenza
del motore stesso. Quest’ultimo sistema fornì al banco prova delle
officine di Maranello risultati superiori in termini di potenza (arrivò
oltre i 600 CV) rispetto al sistema con turbocompressore, ma alla prima
vera uscita, il Gran Premio di Long Beach del 1981, si dimostrò
inaffidabile a causa dei continui cedimenti della cinghia che lo
azionava nonostante un regime di soli 13.500 giri/minuto,(quindi di poco
superiore a quello dell’albero motore) contro i 140.000 giri/minuto
delle giranti del turbo. Dopo questa esperienza negativa negli USA non è
stato mai più montato un Comprex sulla Ferrari. Venne scelto
definitivamente di dotare il motore di 2 turbocompressori (uno per ogni
bancata) che sebbene avessero un’inerzia più elevata e creassero
problemi di turbo-lag (ritardo nella risposta) garantivano 2 cose
importanti:
- una potenza molto elevata distribuita in un arco di giri molto più ampio
- un’affidabilità maggiore
Da un punto di vista architettonico, la soluzione con angolo di
bancata di 120° permise il posizionamento dei collettori di scarico e le
turbine KKK all’interno delle bancate, mentre i collettori di
aspirazione risultavano all’esterno. Con gli scarichi all’interno del V e
la posizione rialzata e ben esposta al flusso d’aria delle 2 turbine
KKK, e con la valvola di sovralimentazione “waste-gate” sullo stesso
asse, l’alimentazione fu realizzata mediante pompa ad iniezione
indiretta Lucas e l’accensione mediante una sofisticata apparecchiatura
elettronica della Marelli. La Ferrari iniziò, per prima fra tutto il
circus della F1, su questo motore turbo la sperimentazione del controllo
elettronico dell’alimentazione. Il controllo dell’iniezione, sempre
costituito da una pompa Lucas-Ferrari, permise dosaggi di carburanti
molto precisi e regolati da 4 parametri quali:
- pressione di sovralimentazione
- regime di rotazione
- posizione della valvola a farfalla
- temperatura
La Ferrari alla ricerca di potenze sempre maggiori, per contrastare
il motore BMW M12/13 della Brabham (visto precedentemente), rischiava
spesso la rottura dei propri motori. Riuscì a portare su questo motore 3
innovazioni molto importanti:
- Iniezione d’acqua nella benzina, praticata mediante un sistema di
emulsione (detta emulsystem) brevettato dall’Agip (che forniva alla
Ferrari carburanti e lubrificanti) con lo scopo di abbassare le
temperature al termine della fase di combustione riducendo il fenomeno
di battito in testa e per migliorare il rendimento termodinamico del
ciclo Otto.
- Sistema di iniezione di carburante anche in turbina nelle fasi
inattive del motore. Tale sistema riusciva a tenere elevato il regime di
rotazione delle 2 giranti e ridurre l’effetto turbo-lag.
- Il passaggio, nel 1984, dall’iniezione indiretta tramite pompa
meccanica, al sistema con centralina elettronica ed elettroiniettori (2
per cilindro) per il controllo elettronico dell’alimentazione. Questo
progetto della Weber e Magneti Marelli permetteva una regolazione più
fine del rapporto stechiometrico a tutto vantaggio della potenza erogata
e soprattutto dei consumi.
Ci furono vari aggiornamenti di questo motore turbo a partire dal
1981 fino al 1987 (dal 1989 la FIA decise il ritorno ai motori
aspirati), con ridisegnazione delle sue parti meccaniche con
l’obiettivo di:
- Ridurre ulteriormente le dimensioni del basamento conservando le dimensioni dell’alesaggio e della corsa
- Rivedere l’angolo delle valvole e la geometria della camera di combustione e conseguente il rapporto di compressione
- Abbassare il baricentro del motore di 25 mm
- Rivedere, con l’obbiettivo di ridurre il peso, la geometria e
relativa distribuzione della massa del manovellismo biella-manovella.
Alla fine di tale percorso La Ferrari ottenne :
- Una riduzione di peso del motore di 12 ÷ 14 Kg
- Coppia massima passata da 40,1 Kgmt a 9000 giri/minuto al nuovo valore di 45 Kgmt a 7500 giri/minuto
- Potenza massima passata da 580 Cv a 11.000 giri/minuto al valore
massimo di 660 Cv a 11.000 giri/minuto con 2 atm. di pressione del
turbo.
Concludendo il motore turbo Ferrari 126 C (e le sue release)consegui’ 9 vittorie nei Gran Premi disputati.
Il pilota più famoso fu Gilles Villeneuve . Ricordiamo le sue
storiche vittorie a Montecarlo e a Jarama (Spagna) nel 1981.
L’8 maggio del 1982 durante le prove a Zolder (Olanda) purtroppo
Gilles Villeneuve perse la vita dopo un pauroso impatto con la March di
Jochen Mass. |
La Ferrari 158 è stata la monoposto con cui la Scuderia Ferrari ha corso nel Campionato mondiale di Formula 1 tra il 1964 e il 1965.
Con il pilota britannico John Surtees vinse il campionato del 1964 piloti e costruttori.

La Ferrari 158 nella livrea rosso Ferrari
|
|
Il difficile biennio 1962-1963 fu un argomento sufficiente per convincere la Ferrari
a mettere da parte il motore Dino V6 e cimentarsi in una vettura
completamente nuova. La scuderia di Maranello però non si limitò a
progettare ex novo un solo motore, ma si mise all'opera sia su un V8 a
90°
che su un 12 cilindri a 180°; poi, sulla base dei risultati ottenuti,
si sarebbe dovuta operare una scelta definitiva su quale motore
utilizzare. La decisione di progettare non uno, ma ben due motori
completamente nuovi, fu alquanto coraggiosa in quanto la scuderia di
Maranello ben sapeva che avrebbe potuto utilizzare questi motori per due
stagioni soltanto in quanto, a partire dal 1966, la cilindrata in F1
sarebbe stata portata a 3 litri per regolamento.
Entrambi i motori
rappresentavano una scelta alquanto inedita.
Infatti il V8 su una Ferrari di Formula 1 lo si era visto solo sulla 801
ma non era nient'altro che il V8 Lancia che equipaggiava la D50
leggermente modificato. Anche il 12 cilindri a 180° era una scelta
singolare in quanto non lo si era mai visto su un'auto da corsa prima di
allora se si fa eccezione per un paio di prototipi Alfa Romeo e
Cisitalia.
Quest'ultimo motore servì comunque da base per tutte le Ferrari
F1 che seguirono, almeno fino all'avvento dei motori turbo.
158 F1
Per la
progettazione della 158 F1, la Ferrari prese la rivoluzionaria Lotus
"25" come modello. Ne replicò infatti la struttura monoscocca a
traliccio in tubi d'acciaio, su cui vennero rivettati
dei pannelli d'alluminio da entrambi i lati che aumentavano la rigidità
complessiva della vettura contenendone allo stesso tempo il peso. La
collocazione dei serbatoi lateralmente e davanti al posto guida permise
di ridurre la sezione frontale, solo 1 cm in più della Lotus, e
migliorare la ripartizione dei pesi così come le sospensioni montate
all'interno della scocca e i freni posteriori collocati all'uscita del
differenziale.
Altra innovazione furono i cerchioni da 15" a cinque razze in lega di magnesio.
Il motore
aveva anche funzione portante e nella sua prima versione (1963) era
alimentato da 4 carburatori Weber
per una cilindrata totale di 1487 cm³. La potenza era di 190 CV a
10 700 giri/min. Nel 1964, per aumentare il regime di rotazione, venne
diminuita la corsa e aumentato l'alesaggio per una cilindrata totale di
1489 cm³ e l'adozione della nuova iniezione diretta, fornita dalla Bosch
e progettata da Michael May, portò la potenza a 210 CV a 11 000
giri/min.
512 F1
Contemporaneamente allo sviluppo del V8, l'ing. Mauro Forghieri
intraprese la strada del 12 cilindri a 180° per realizzare una vettura
da affiancare alla 158 F1 ed eventualmente sostituirla. Tecnicamente 158
e 512 F1 sono praticamente identiche fatta eccezione per il motore, il
passo di 2 cm superiore e un lieve aumento del peso. Anche esteticamente
si fa molta fatica a distinguerle perché l'unica differenza tra le due è
il numero dei collettori d'aspirazione (8 per la 158 e 12 per la 512).
La gestazione di questo nuovo motore fu piuttosto lunga ragion per cui
la 512 venne impiegata per la prima volta nelle ultime due gare della
stagione 1964 contribuendo così alla conquista del titolo costruttori.
Il 12 cilindri era stato concepito nell'inedita configurazione a
180° per renderlo il più compatto possibile collocando l'alternatore, la
pompa della benzina e l'alimentazione alla sua sommità e abbassare di
conseguenza il baricentro della vettura. Realizzato inizialmente con
l'iniezione indiretta Lucas,
venne ben presto equipaggiato con l'iniezione diretta della Bosch
contemporaneamente all'adozione delle due candele per cilindro. Nella
sua versione definitiva questo motore poteva erogare 225 Cv a 11 500
giri/min
|
 |
|
Come propulsore venne impiegato un 4 cilindri twin-cam 2.5 progettato
da Stuart Tressillian ed abbinato a due carburatori Weber in grado di
generare la potenza di 280 cv con coppia di 278 Nm. Il cambio he lo
gestiva era a quattro rapporti. Il telaio era del tipo spaceframe in
acciaio avvolto da una carrozzeria in alluminio. Come sospensioni erano
presenti degli ammortizzatori con molle elicoidali nella sezione
anteriore mentre nella posteriore era presente un ponte DeDion con
ammortizzatori a tamburo. L'impianto frenante era costituito da freni a
disco Lockheed, mentre i cerchi, per risparmiare peso, erano in lega.
Nel 1958 la vettura subì una modifica al telaio e vennero
introdotti ammortizzatori elicoidali su tutte le sezioni del mezzo,
mentre nel 1959 fu montato un nuovo sistema di raffreddamento e i freni
Lockheed furono cambiati con degli esemplari costruiti dalla Dunlop.
Nel 1959 venne realizzata la versione P48. Rispetto alla Type 25,
aveva il propulsore in posizione centrale per ottenere migliori
prestazioni.
|

Niki Lauda su McLaren MP4/2 a Dallas nel 1984
A
metà stagione 1983 era ormai chiaro che i motori aspirati non
avrebbero retto a lungo la competitività dei motori
sovralimentati. Infatti i piloti che lottavano per il titolo guidavano
tutti Brabham, Ferrari e Renault, ossia vetture turbo. La decisione
della Cosworth di continuare a sviluppare un propulsore aspirato
indusse Ron Dennis ad interessarsi della ricerca di un produttore che
realizzasse propulsori sovralimentati per la sua scuderia. Tuttavia,
non vi erano case disposte a fornire motori al team inglese,
poiché già tutti impegnati con altre scuderie.
La soluzione fu trovata in casa: da circa un anno, era entrato in
società con Mansur Ojjeh, titolare della TAG. Questi si offrì allora di
finanziare il progetto di un motore, costruito partendo totalmente da
zero. Per far ciò si rivolse alla Porsche, la quale non era intenzionata
a tornare in Formula 1, ma disponibile come fornitore di Engineering
regolarmente pagata.
La progettazione risultò essere abbastanza travagliata, in quanto
le richieste di John Barnard, che puntava ad una vettura assai
innovativa, non erano molto gradite ai motoristi, che denunciavano di non poter organizzare liberamente il loro lavoro[senza fonte].
S'innescò un circolo vizioso, dove i telaisti pretendevano che il
motore venisse concepito in funzione della scocca, mentre i motoristi
pretendevano il contrario. Poiché però l McLaren era la committente, che
pagava per vedere realizzato il progetto, la Porsche decise di
sottostare alle richieste del suo cliente.
I primi test, effettuati nel 1983 da Niki Lauda, fecero
trasparire una potenza di 550 CV a 10.500 giri/min, una differenza non
così esagerata rispetto al vecchio Cosworth DFV,
mentre la coppia era decisamente superiore, anche se il propulsore
soffriva di turbo-lag, ossia un ritardo di risposta tra il momento in
cui il pilota accelerava e il momento in cui il motore incrementava il
suo regime di rotazione.
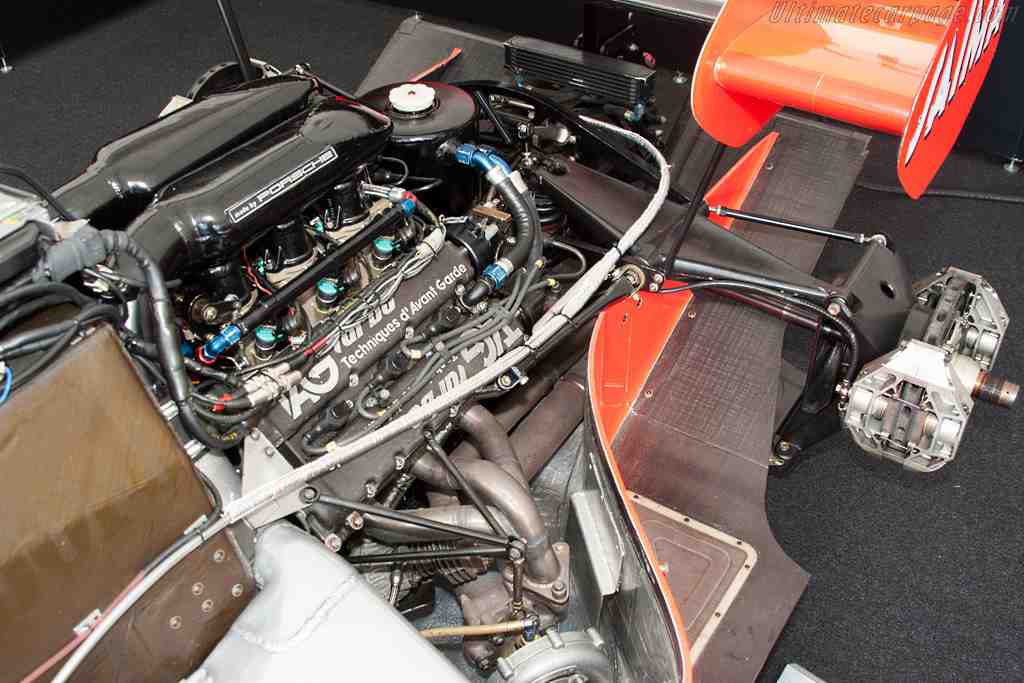
Tutti problemi vennero risolti in tempo record. Infatti nel 1984,
la McLaren dominò decisamente il campionato, vincendo quello piloti con
Lauda, seguito a mezzo punto, dal compagno Prost. Ovviamente vinse
anche quello costruttori. Tuttavia il motore non era il più prestante
del gruppo, per quanto erogasse 715 CV in gara e 800 CV in qualifica (al
regime di 11.200 giri/min). I punti di forza della vettura era invece
la perfetta integrazione tra telaio e propulsore, che rendeva semplice
sia la guida che la messa a punto della macchina, ma soprattutto
l'esperienza in tema di consumi e di controllo elettronico del motore,
maturata dalla Porsche e dalla Bosch nelle gare di durata con il motore
della Porsche 956. In quell'anno infatti entrò in vigore la limitazione a 220 litri della quantità di benzina utilizzabile in gara,
|
Ferrari 212 F1
La 212 F1 è un'autovettura monoposto da competizione prodotta dalla Ferrari nel 1951 in due esemplari. |
 |
| Il
modello debuttò nelle competizioni l'11 marzo 1951 al Gran
Premio di Siracusa. In questa gara si classificò al secondo
posto con Dorino Serafini, preceduto da Gigi Villoresi su una 375 F1 e
seguito da Rudolf Fischer sull'altro esemplare della 212 F1, che
correva per la scuderia Ecurie Espadon.
|
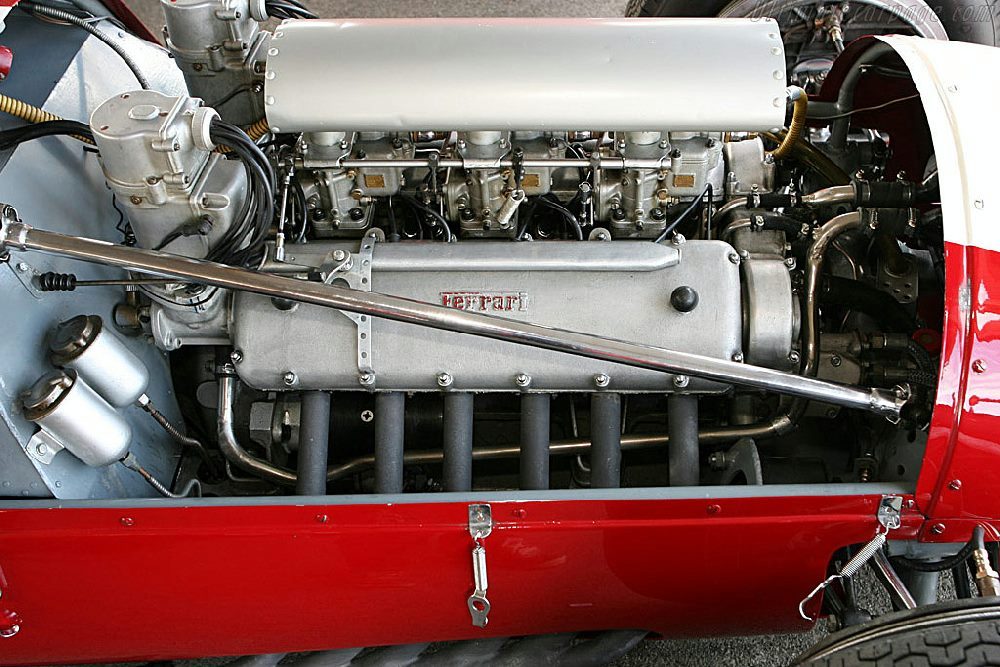 |
|
Il motore era un V12 a 60° anteriore e longitudinale. L'alesaggio e la corsa erano rispettivamente di 68 mm
e 58,8 mm, che portavano la cilindrata totale a 2562,5 cm³.
Il rapporto di compressione era di 12:1. La testata ed il monoblocco
erano in lega leggera[. La potenza massima erogata dal propulsore era di 200 CV a 7500 giri al minuto.
La distribuzione era formata da un singolo albero a camme in testa
che comandava due valvole per cilindro. L'alimentazione era assicurata
da tre carburatori di marca Weber e modello 32 DCF. L'accensione era
singola ed il relativo impianto comprendeva due magneti. La lubrificazione era a carter secco, mentre la frizione era monodisc.
manualeLe sospensioni anteriori erano indipendenti, con quadrilateri
trasversali e balestra inferiore montata allo stesso modo, mentre
quelle posteriori erano formate da una balestra trasversale e da
semiassi oscillanti o da un ponte De Dion. Entrambe erano indipendenti
ed avevano montato ammortizzatori idraulici. I freni erano a tamburo
sulle quattro ruote, mentre la trasmissione era formata da un cambio a
cinque rapporti più la retromarcia. Lo sterzo era a vite senza fine e settore dentato. La trazione era posteriore.
Il telaio era tubolare in acciaio, mentre la carrozzeria era monoposto da Formula 1.
|

Winkelhock su ATS D7 a Dallas
|
L'ATS D7 fu una monoposto di Formula 1 che corse nella stagione 1984. Fu pilotata da Manfred Winkelhock e da Gerhard Berger.
Spinta da un motore turbo BMW, fu concepita da Gustav Brunner, come evoluzione della precedente D6.
Il telaio monoscocca fu realizzato in fibra di carbonio e grazie alla
potenza del propulsore tedesco ottenne sempre discreti risultati in
qualifica. Quest'ultimo era un BMW M12 gestito da un cambio ATS-Hewland a
cinque rapporti che erogava una potenza di 750 cv e 480 Nm di coppia.
L'impianto frenante era costituito da freni a disco.
Proprio il cambio inadatto alle notevoli potenze del turbo ,unito
a problemi interni alla squadra (Brunner se ne andò dopo l'ennesimo
litigio con il titolare del team, Gunther Schmidt durante i test in
Brasile ad inizio stagione per passare all'Alfa Romeo)
La stagione non andò per il meglio e la squadra non ottenne
nemmeno un punto in classifica, nonostante un sesto posto di Berger al
GP d'Italia che però non fu conteggiato in quanto ottenuto dalla seconda
vettura non iscritta al campionato. Litigi interni alla squadra e la
prossima cessione della società di cui la scuderia era emanazione
penalizzarono il progetto D7 ed al termine della stagione 1984 la ATS si
ritirò della Formula 1, anche per il rifiuto di BMW di continuare la
fornitura di motori. |
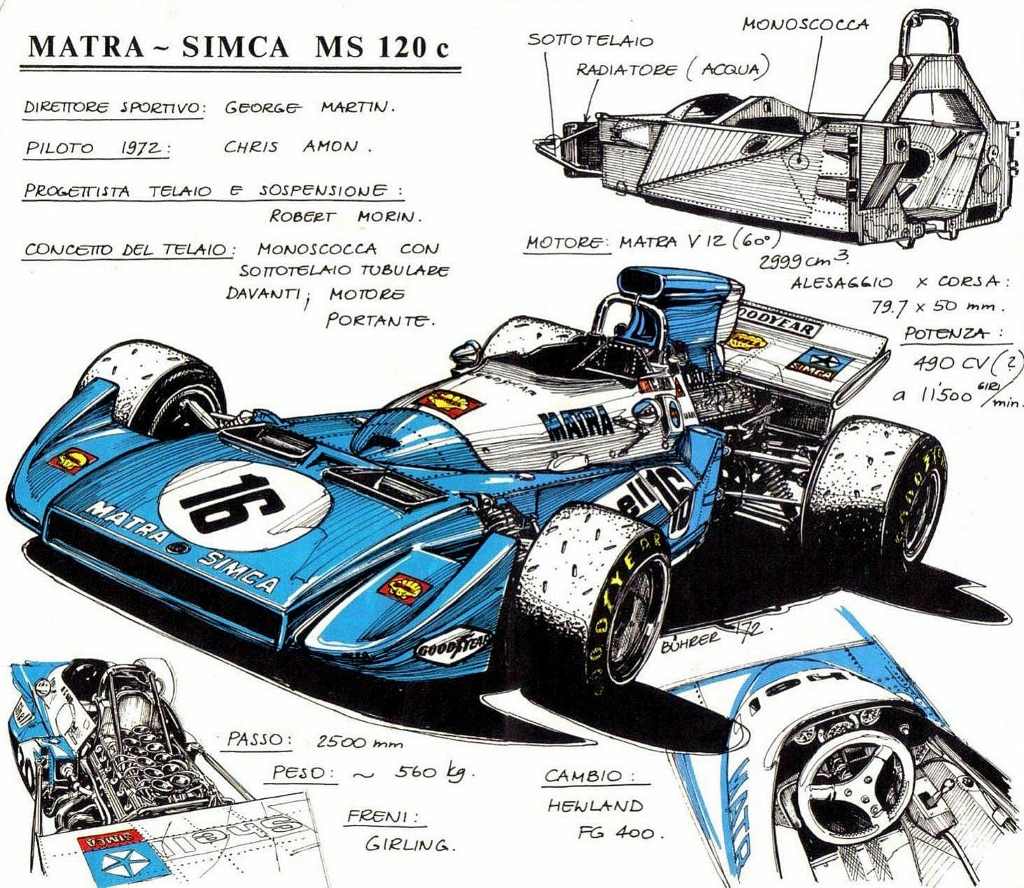
La Matra MS120, chiamata anche Matra-Simca MS 120,
è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia francese Matra
per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 1970.
L'MS120 è stata successivamente sviluppata in varie evoluzione, chiamate Matra MS120B, Matra MS120C e Matra MS120D.
La vettura fu costruita a Vélizy-Villacoublay, nella periferia
sud-occidentale di Parigi, progettata sotto la direzione di
Gérard Ducarouge e Bernard Boyer.
|
Elettronica
Il ruolo dell'elettronica in una monoposto di F1
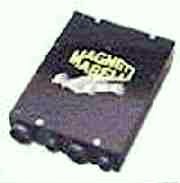
Tutte le 22 monoposto sono dotate di apparecchi elettronici che hanno
una grande importanza nell'andamento della vettura. In ogni auto ci sono
più due km di cavi che sono collegati a oltre 100 sensori e attuatori
che esaminano molte parti del mezzo. Raramente una gara finisce senza
che nessuna auto si sia ritirata per problemi elettronici.
Tecnica Moderna
Uno dei motivi per cui i motori della F1 riescono ad avere potenza pari a
860 hp è perchè esiste un dispositivo elettronico di controllo del
motore che ne incrementa di circa 120~140 hp la potenza. L'elettronica
non serve solo al motore. Permetta infatti di utilizzare o controllare
al meglio dispositivi che hanno una grande utilità per le monoposto. Ad
esempio dalla Stagione 2000 la FIA ha autorizzato le scuderie che
partecipano al Campionato del Mondo di Formula 1 a utilizzare il
controllo della trazione(vietato nuovamente dal 2003). Questo
dispositivo impedisce che gli oltre 850cv di potenza dei motori vengano
scaricati bruscamente sull'asfalto, impedendo alle ruote di "fumare"
alle partenze. Questo apparecchio certamente ha diminuito l'importanza
che le partenze hanno spesso avuto in alcuni Gp, come quello di Monaco,
dove quasi il 70% del gran premio si giocava proprio alla partenza,
visto che una volta iniziata la gara era davvero difficile poter
effettuare sorpassi. Il controllo di trazione ha un sistema di sicurezza
che evita lo spegnimento accidentale del motore, ma quando il pilota
manomette il C.T. può inserirsi il sistema di protezione che non solo fa
il suo lavoro al contrario spegnendo il motore ma lo blocca in prima
marcia.
Funzioni
Una centralina non solo controlla la trazione, ma ha anche compiti più
ardui. Infatti controlla l'iniezione del combustibile, il numero di giri
del motore. Anche questo è un compito difficile, perchè il motore deve
mantenersi tra i 15000 rpm e 18.500 rpm e la centralina ha il compito di
evitare che il regime di rotazione salga più del limite massimo.
Inoltre controlla il differenziale elettronico, e i rapporti. Infatti se
il motore ha un alto numero di giri e si tenta di inserire una marcia
più bassa di quella in uso, la centralina interviene impedendo ciò.

Jenson Button a bordo della BGP 001 - Gran Premio di Spagna 2009
|

Il controverso diffusore della BGP 001
|
|
La vettura, inizialmente sviluppata dalla Honda, è stata successivamente ceduta alla Brawn GP, stante il ritiro della casa nipponica dalla Formula 1.
Nei mesi intercorsi tra l'annuncio dei giapponesi e l'esordio in pista,
la vettura ha continuato a essere migliorata, pur in presenza di
difficoltà finanziarie e incertezze in merito alla nascita della nuova
scuderia. Al momento dell'esordio, la vettura era del tutto priva di
sponsor, sfoggiando una livrea bianca con inserti gialloneri.
Il primo test, svolto a Barcellona, mostra subito la potenzialità della vettura che segna tempi molto interessanti.Nel
secondo giorno l'altro pilota, Rubens Barrichello completa ben 111 giri
col terzo miglior tempo fra tutte le vetture impegnate in Spagna. Il
giorno seguente Button torna in vetta ai tempi con oltre un secondo di
vantaggio su Felipe Massa e la sua Ferrari, completando 130 giri.
Massa afferma come la BGP 001 sia la vettura più competitiva nei test
invernali e di come la Ferrari sia indietro rispetto alla monosposto
della Brawn GP.
Nell'ultimo giorno di test è ancora Barrichello a far segnare il
miglior tempo di giornata con un vantaggio di 8 decimi su Nico Rosberg
della Williams, compiendo 110 giri.
Anche nei test svolti sul Circuito di Jerez
la vettura continua a impressionare, distanziando di 6 decimi la
Renault di Fernando Alonso, e girando per 107 tornate. Alonso fa
segnare il tempo miglior il secondo giorno, con Barrichello secondo e
Button terzo.
Nell'ultima giornata Button torna a far segnare il miglior tempo, con
un vantaggio di due secondi su Rosberg, e con Nelson Piquet Jr. e Lewis
Hamilton ancor più staccati.
Le
soluzioni tecniche adottate nella zona del diffusore posteriore portano
a un reclamo ufficiale di Renault, Red Bull e Ferrari. Tale reclamo
coinvolge anche la Williams FW31 e la Toyota TF109. I commissari
sportivi in Australia rigettano il ricorso: la BGP 001 è al via
del primo gran premio stagionale senza modifiche.
|
|
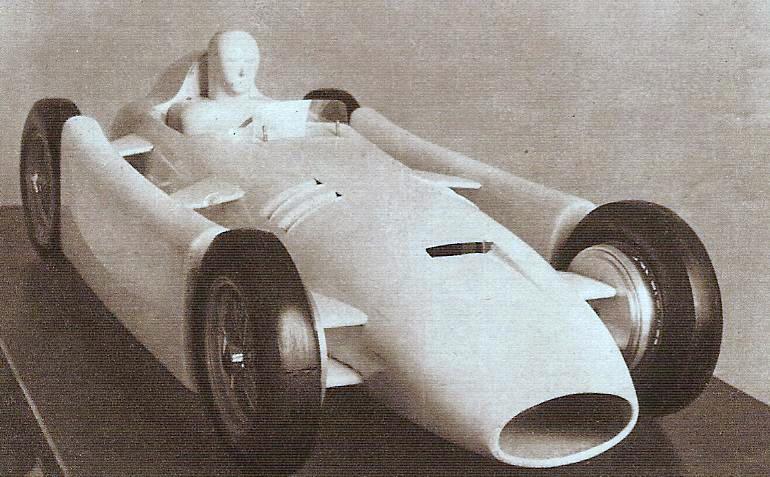
Il modellino in legno scala 1:10 della D50 utilizzato nel 1953 per le
prove di aerodinamica effettuate
nella "galleria del vento" del
Politecnico di Torino
|
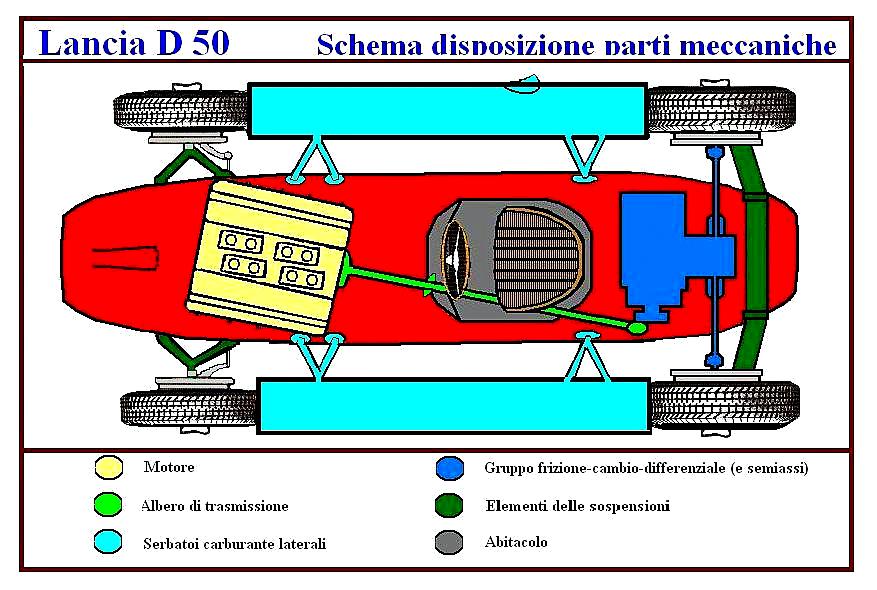 |
|
Nell'estate del 1953 Gianni Lancia decide di tentare l'avventura della Formula Uno.
Il celebre progettista di casa Lancia, Vittorio Jano, termina la
progettazione esecutiva nel settembre 1953. Il problema piloti è
presto risolto, dal momento che Gianni Lancia riesce a convincere della
bontà del progetto due nomi altisonanti: Alberto Ascari e Luigi
Villoresi, che il 21 gennaio 1954 firmano il contratto con la Lancia,
snobbando le offerte di Enzo Ferrari. Naturalmente il fatto desta
perplessità ed anche qualche polemica: si favoleggia di ingaggi
super milionari, ma probabilmente Ascari decide di passare alla Lancia
per via dei frequenti contatti avuti negli ultimi periodi, sembra anche
per motivi mondani, con Gianni Lancia in persona.
In ogni caso, il compenso minimo garantito ad Alberto Ascari per il
biennio 1954/55, 25 milioni di Lire annui, non è affatto
disprezzabile. Quanto a Villoresi, la sua decisione non meraviglia
poiché è ben noto il legame di profonda amicizia che lo
lega ad Alberto. Della squadra Lancia fa parte anche Eugenio
Castellotti, pupillo di Ascari (che in un certo senso vede in lui il
suo successore): Castellotti tuttavia nel 54 corre con le vetture Sport
e debutta in Formula Uno soltanto nel '55.
La monoposto della
casa torinese, denominata con la sigla D50, fa la sua prima uscita il
20 febbraio 1954 e, come del resto la stampa specializzata ha
anticipato, la caratteristica più saliente del nuovo bolide
risiede nella sistemazione dei serbatoi del carburante, collocati, uno
per lato, a sbalzo del corpo della vettura, tra le ruote anteriori e
quelle posteriori. Il motore, ad alimentazione atmosferica, è un
8 cilindri a V di 90° da 2,5 litri di cilindrata, limite fissato
dal regolamento della Formula Uno in vigore dal 1º gennaio 1954.
Le sospensioni
sono a ruote indipendenti all'avantreno, a ponte De Dion al retrotreno.
Il gruppo frizione/cambio/differenziale è al retrotreno. Il
cambio, disposto trasversalmente, è a 5 rapporti.
La vettura si
distingue per le impeccabili finiture (inusuali in una monoposto da
competizione) e per un peso piuttosto contenuto, inferiore a quello
delle Formula Uno dirette concorrenti: al debutto, la D50 pesa a vuoto
circa 620 kg, contro i 690 delle nuovissime Mercedes W196 in
versione “normale” (720 kg è invece il peso
della versione “carenata”), i 670 delle Maserati 250F ed i
650 delle Ferrari 4 cilindri tipo 625.
La gestazione della
D50 è però lunga e travagliata: il debutto, inizialmente
previsto per il 20 giugno (Gran Premio di Francia), viene via via
rimandato ed avverrà con quattro mesi di ritardo, il 24 ottobre,
a Barcellona (Gran Premio di Spagna). Nel frattempo, Ascari e
Villoresi, pur proseguendo nei test, sono lasciati liberi di correre
con monoposto di altri costruttori.
Con la denominazione
Lancia-Ferrari, le D50 vengono portate dalla Ferrari a Monza per il
Gran Premio d'Italia di settembre ma non corrono per motivi legati alla
marca di pneumatici da utilizzare e chiudono la carriera ad Oulton Park
(ottobre 1955) dove ottengono una buona prestazione alla Gold Cup, con Mike Hawthorn secondo alle spalle di Stirling Moss.
Il bilancio finale della D50, in circa un anno di Gran Premi, è
soltanto poco più che discreto, dal momento che dalla partecipazione ad 8
corse sono scaturiti i seguenti migliori risultati: due vittorie
(Torino e Napoli) e tre piazze d'onore (Pau, Monaco e Oulton Park),
mentre nelle rimanenti 3 occasioni (Spagna, Argentina e Belgio) nessuna D50 ha visto il traguardo.
L'anno successivo
(1956) le D50, che ormai vengono identificate come Ferrari-Lancia,
subiscono modifiche non solo marginali e si aggiudicano il Campionato
mondiale di Formula Uno 1956, grazie anche all'apporto dell'argentino
Juan Manuel Fangio.
|
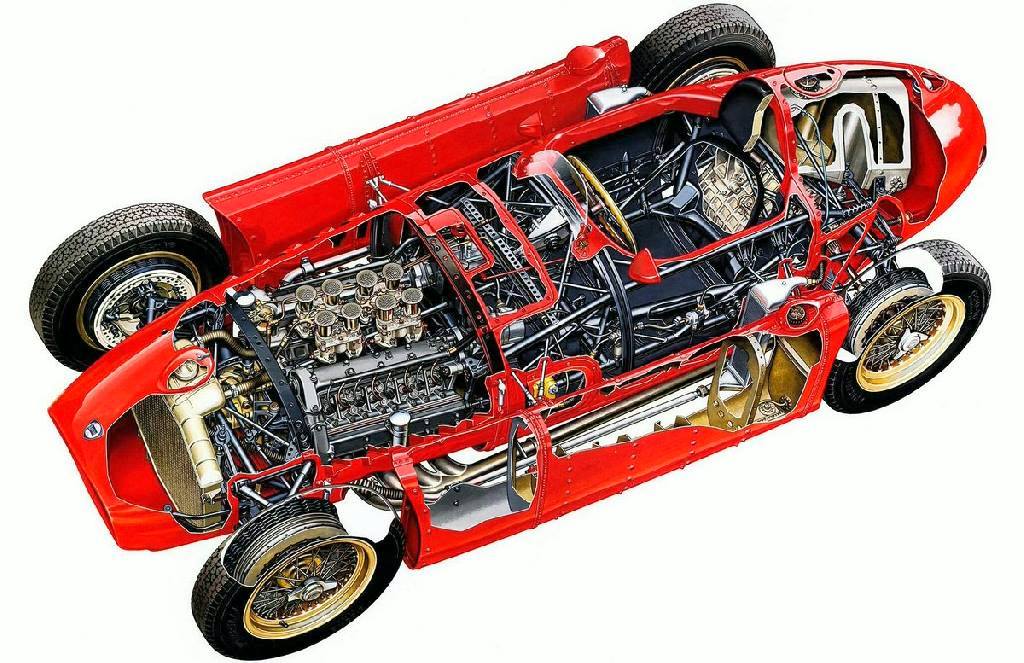
|
|
La Lancia D50 è un'automobile monoposto da competizione di Formula Uno
realizzata dalla casa torinese Lancia che corse nel biennio 1954/55 e
nel 1956 donata alla Scuderia Ferrari. Si tratta dell'unica vettura
costruita dalla casa per questo tipo di competizioni.
|
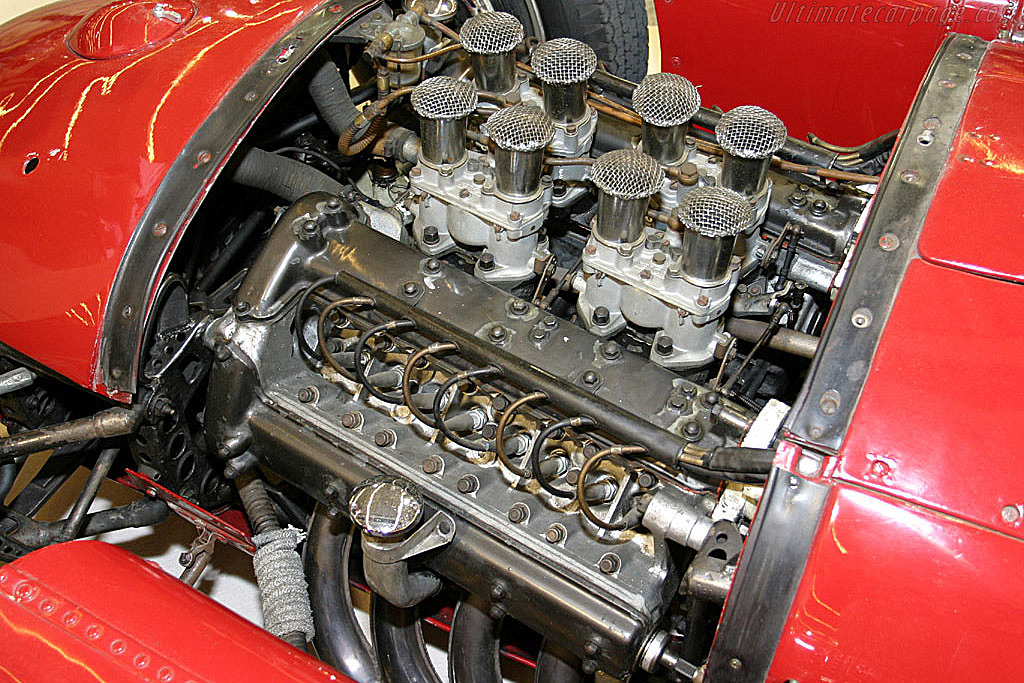 |
|
La caratteristica saliente del progetto risiede nella sistemazione dei serbatoi
del carburante, l'idea è sicuramente apprezzabile in quanto si
hanno vantaggi di tipo aerodinamico con miglioramento del valore del CX
lo avrebbero dimostrato una serie di prove effettuate nella galleria
del vento del Politecnico di Torino con un modellino della monoposto in
scala 1:10. L'altra faccia della medaglia, invece sembra derivare dalla
estrema variabilità del centraggio della vettura a seguito del
continuo calo del livello del carburante dovuto ovviamente al consumo
in gara. La D50 sembra infatti godere di una stabilità che
è eccezionale nella marcia a serbatoi pieni ma cala mano a mano
che i serbatoi si svuotano.
Il
regolamento per la Formula Uno che entra in vigore col 1º gennaio
1954 prevede una cilindrata massima del motore di 2500cm³ (se
alimentato atmosfericamente) oppure di 750 cm³ nel caso di
motore sovralimentato (con compressore) e non pone limiti di peso
né restrizioni di sorta circa le caratteristiche del carburante
da utilizzare. Considerati i precedenti di Jano, che ha sempre
prediletto i motori sovralimentati, sorprende che non sia stata neppure
presa in considerazione la progettazione di un motore con tale sistema
di alimentazione, ma probabilmente a frenare gli eventuali entusiasmi
è stato il troppo penalizzante limite di cilindrata
(coefficiente 3,333:1 rispetto ai motori “aspirati”).
|
 |
|
Inizialmente,
forse anche per ragioni di economicità, viene messo in cantiere
un motore direttamente derivato da quello di tre litri adottato sulla
D20 sport, quindi un 6 cilindri a V di 60° opportunamente
ridimensionato nella cilindrata (alesaggio mm 82 e corsa mm 78, per una
cilindrata totale di cm³ 2471,52) che, al banco, eroga 235 hp a
7200 giri. Ma Vittorio Jano, convinto che questo motore non avrebbe
consentito adeguate possibilità di sviluppo, preme per la
realizzazione di un 8 cilindri a V di 90°. Il progetto viene
affidato al “motorista” per eccellenza di casa Lancia,
Ettore Zaccone Mina, che realizza una unità motrice da
2485,99 cm³ di cilindrata (alesaggio mm 76, corsa mm 68,5).
Una delle caratteristiche peculiari di questo motore, che si distingue
per le leghe leggere utilizzate (per il monoblocco e per i due blocchi
dei cilindri), è data dal fatto che il basamento del motore
è parte integrante della struttura stessa della macchina,
essendo rigidamente connesso con elementi del telaio tubolare. Quanto
alla distribuzione, che è con quattro alberi a camme in testa
(due per ciascuna bancata) mossi da ingranaggi, la singolarità
è data dalla particolare attenzione riservata al raffreddamento
delle valvole di scarico, che sono posizionate (“annegate”)
nel condotto dell'acqua di raffreddamento delle testate. Il comando
delle valvole avviene con molle a spillo, mentre i bilancieri (tra le
camme e gli steli delle valvole) sono del tipo “a dito”.
Qualche discussione tra i tecnici di casa Lancia, ed in particolare tra
Vittorio Jano ed Ettore Zaccone Mina, riguarda il sistema di
alimentazione: il primo è decisamente a favore
dell'alimentazione di tipo tradizionale, mentre il secondo (e
spalleggiato, sembra, da Gianni Lancia) sembra propendere per
l'alimentazione “ad iniezione diretta” (che la Mercedes sta
a sua volta per adottare sulle Formula Uno che avrebbero debuttato a
breve). Pare che venga addirittura costruito un motore monocilindrico
sperimentale di poco più di 310 cm³ (esattamente 1/8
della cilindrata del motore previsto per la D50) alimentato ad
iniezione. Ma alla fine, a prevalere è l'idea di Vittorio Jano e
la D50 nasce con un sistema di alimentazione del tutto tradizionale, tramite quattro carburatori
invertiti doppio corpo Solex 40 PIJ. Nella versione iniziale i due
serbatoi laterali contengono circa 90 litri cadauno (secondo alcune
fonti, la capacità sarebbe di 80 litri). L'accensione è a doppia candela
per ciascun cilindro. Il motore viene montato con una inclinazione di
12° circa rispetto all'asse longitudinale della vettura, onde far sì che
il passaggio dell'albero di trasmissione avvenga alla sinistra del
sedile di guida e consenta l'abbassamento del sedile stesso con la
conseguente riduzione della sezione dell'abitacolo a tutto vantaggio
dell'aerodinamica.
Come nelle Aurelia di serie e nelle D20/D23/D24
“sport” il gruppo frizione/cambio/differenziale è posto al retrotreno:
nella D50 però il cambio è a 5 rapporti più retromarcia e, soprattutto, è
disposto trasversalmente. Le sospensioni sono a ruote indipendenti
all'avantreno e semi-indipendenti con ponte De Dion al retrotreno.
Il
20 febbraio 1954 la nuova monoposto compie i primi passi (o meglio i
primi giri di ruota) all'aeroporto di Torino-Caselle: alla guida della
D50, dopo che il capo-collaudatore Giuseppe Gillio ha avviato il motore
ed ha percorso poche centinaia di metri, siede il bi-Campione del Mondo
(1952 e 1953) Alberto Ascari. Poiché l'intenzione di Gianni
Lancia è quella di far debuttare la D50 nel Gran Premio di
Francia, in calendario per il 4 luglio 1954, i collaudi procedono a
ritmo sostenuto: nell'inverno e all'inizio della primavera del 1954 la
vettura, anche per fattori meteorologici, viene spedita spesso sulla
riviera ligure, sul circuito di Ospedaletti, poi, a maggio, a Monza,
Alberto Ascari è addirittura vittima di un incidente che
però non ha conseguenze.
I collaudi proseguono per opera di Giuseppe Navone, già in forza
con quel ruolo alla Ferrari. Viene anche montato un motore quasi
“quadro” con misure di alesaggio e corsa diverse da quelle originarie
(alesaggio mm 73 e corsa mm 74, cilindrata totale cmc 2477,75) che viene
accreditato di una potenza superiore ai 250 HP e che pare possa ruotare
fino a 9.000 giri al minuto. Luigi Villoresi ed Alberto Ascari, alla
fine di aprile 1954, sottoscrivono un accordo in base al quale la Lancia
consente loro di partecipare a GP con macchine di altra marca fino al
momento in cui la D50 sarà a punto e potrà correre. I due peraltro
proseguono nei collaudi. Il previsto debutto in Francia
salta: la macchina non è ancora ritenuta in grado di poter correre.
Gianni Lancia è profondamente amareggiato, anche perché al Gran Premio
dell'Automobile Club di Francia debutta invece la Mercedes W196:
ed è un debutto “col botto”, visto che Juan Manuel
Fangio conduce l'argentea macchina tedesca alla vittoria.
Finalmente, dopo una serie di convincenti prove effettuate
all'inizio di ottobre in quel di Caselle e ad Ospedaletti e dopo che in
un test a Monza, Alberto Ascari segna 1'56” (quasi 3 secondi meglio
della “pole” della Mercedes W196 carenata di Juan Manuel Fangio alle
prove ufficiali del Gran Premio d'Italia del 5 settembre 1954) due D50 vengono spedite a Barcellona per il Gran Premio di Spagna
in calendario per il 24 ottobre 1954. Il debutto viene deciso malgrado
persistano problemi di frenata imputati al complicato impianto a tre
ganasce messo a punto da Vittorio Jano. A Barcellona le D50, rapidissime
in prova, sperimentano motori con dimensioni diverse, tra cui un D50A
avente mm 74,00 di alesaggio e mm 72,20 di corsa (in totale cmc
2484,17).
Dopo
il GP di Spagna dell’ottobre 1954, nel 1955 le D50 disputano, con
alterna fortuna, altri 5 Gran Premi (Argentina, Torino, Pau, Napoli,
Monaco) poi, dopo la morte del pilota di punta Ascari (avvenuta con una
Ferrari nel corso di una occasionale prova a Monza), la Lancia annuncia
la sospensione dell'attività agonistica, evento che avviene
pressoché in contemporanea con l'abdicazione di Gianni Lancia.
Tuttavia, prima di abbandonare l'Italia per il Sud America,
l'ingegner Lancia ha il tempo di concedere una vettura ad Eugenio
Castellotti per correre il Gran Premio del Belgio a Spa in giugno.
Subito dopo la disputa del Gran Premio del Belgio
e l'abdicazione forzata di Gianni Lancia, in seno alla fabbrica si
profilano due fazioni: da una parte c'è chi vorrebbe evitare di
disperdere le esperienze fatte in ambito agonistico, migliorare il
materiale esistente e proseguire l'attività sportiva interrotta, e
dall'altra chi invece non vede l'ora di disfarsi di tutto il “materiale
da corsa” nel più breve tempo possibile, magari svendendolo. I
sostenitori della seconda tesi hanno ben presto la meglio.
Trapelata la notizia, molti si fanno avanti per rilevare a buon
prezzo tutto il materiale: tra i potenziali acquirenti, in prima fila,
pare ci sia addirittura la Mercedes Benz. Per evitare che preziose
esperienze italiche finiscano all'estero, il principe Filippo Caracciolo
(suocero di Gianni Agnelli e Presidente dell'Automobile Club d'Italia) si attiva presso la Fiat
fino ad ottenere un accordo a tre, in base al quale la Lancia dona alla
Ferrari il suo materiale da corsa e la Fiat si impegna ad erogare alla
casa modenese, per cinque anni, un contributo finanziario non
indifferente (50 milioni di lire all'anno).
La cerimonia del “passaggio” avviene il 26 luglio 1955
nel cortile della Lancia in Via Caraglio a Torino: gli onori di casa
sono fatti dall'avv. Domenico Jappelli e dal sig. Attilio Pasquarelli,
mentre per la Ferrari sono presenti l'ing. Mino Amorotti ed il cav.
Luigi Bazzi. La Fiat è rappresentata dal dr. Pestelli, mentre per
l'Automobile Club d'Italia c'è il Vicepresidente ing. Arnaldo Trevisan.
Tra gli altri intervenuti, oltre a Vittorio Jano, il Conte Carlo
Biscaretti di Ruffia (Vice Presidente dell'Automobile Club di Torino) ed
il Dr. Giovannetti dell'A.N.F.I.A.A. (Associazione Nazionale Fra
Industrie Automobilistiche ed Affini). Per la cronaca, le D50 di Formula
Uno donate alla casa modenese sono sei: ad esse vanno aggiunte due
scocche di F1, una normale e l'altra carenata (la prima è forse munita
di qualche organo meccanico, mentre la seconda ne è probabilmente priva)
oltre naturalmente a molti ricambi ed parti meccaniche in genere. Con
l'occasione, anche il celebre progettista Vittorio Jano passa dalla Lancia alla Ferrari.
Tra l'ottobre 1954 (debutto in Spagna) ed il giugno 1955 (Gran
Premio del Belgio), la D50 subisce, come del resto è normale accada in
una monoposto di Formula Uno, una serie di modifiche tese ad
incrementare prestazioni ed affidabilità: la capacità dei serbatoi del
carburante viene portata a 200 litri (capacità ritenuta necessaria per
evitare rifornimenti in gara), le prese d'aria sul cofano
e sui “pontoni” laterali vengono spesso modificate (ampliate e/o
ridotte), il circuito di lubrificazione subisce parecchie migliorie, l'impianto frenante
(uno dei punti deboli della vettura) è oggetto di continue attenzioni,
le sospensioni vengono talvolta rese più morbide od irrigidite, il parabrezza
viene rimpicciolito e munito di inclinazione regolabile. Altri valori
che subiscono spesso variazioni, anche se di minima entità, sono quelli
del passo
e delle carreggiate: il primo spazia da cm 220 a cm 230, le seconde da
cm 125 a cm 129,4 (la carreggiata posteriore arriva a misurare cm 133).
Nel periodo, la D50 assume anche la denominazione D50A.
Quanto al motore, è difficile (anzi, impossibile) definire
esattamente dati, potenze e dimensioni dei propulsori utilizzati di
volta in volta: comunque, secondo stime attendibili, la potenza
erogata varia da un minimo di 250-255 HP ad un massimo di 265 HP, i
regimi di rotazione si collocano tra gli 8.000 ed i 9.000 giri/minuto,
il rapporto di compressione
tra 10,5:1 e 12:1. I diversi motori impiegati (tutti 8 cilindri a V di
90°) hanno le seguenti dimensioni: 1.) 2485,99 cm³ di cilindrata
(alesaggio mm 76,00 e corsa mm 68,50); 2.) 2488,02 cm³ (alesaggio mm
73,60 e corsa mm 73,10); 3.) motore definito D50A da 2477,29 cm³
(alesaggio mm 74,00 e corsa mm 72,00). La velocità
massima raggiungibile dalla D50, nella sua versione più potente e con
il rapporto di demoltiplicazione più “lungo” è dell'ordine dei 300 km
all'ora.
|

Il motore era sito anteriormente in posizione longitudinale, e trasferiva il moto alle ruote posteriori.
In principio venne usato un motore Coventry Climax V8
di 1100 cc, ma successivamente fece spazio a un 4 cilindri in linea
2000 cc sempre Coventry Climax. Quest'ultimo è quello impiegato in
Formula 1. Ambedue erano motori aspirati.
Fino
a qui però, nessuna innovazione.
I salti in avanti riguardarono le sospensioni posteriori, il cambio e
l'impiego di materiali di nuova concezione, diversi dagli acciai.
Chapman
era sempre alla continua ricerca di soluzioni che permettessero di
ridurre il peso del mezzo, ed abbassarne il baricentro.
Per far ciò, costruì dei particolari cerchioni in lega di
magnesio, che permettevano di ridurre il peso e mantenere invariata la
resistenza.
Inizialmente
la Lotus 12, avrebbe dovuto adottare il ponte De Dion, come soluzione
per le sospensioni posteriori, ma Chapman decise di utilizzare una
sorta di configurazione MacPherson, meglio nota come Chapman strut.
Questa configurazione ben si sposa col principio del telaio monoscocca,
che lui stesso svilupperà.
In ultima analisi si può parlare del cambio, il quale era
studiato in modo da poter eliminare il tunnel di trasmissione, e poter
dunque fa sedere il pilota il più in basso possibile, migliorando
notevolmente il punto ove si trovava il centro di gravità e dunque la
tenuta di strada della macchina.
Questo congegno però non venne architettato da Chapman, ma dai tecnici
Richard Ansdale e Harry Mundy, i quali tuttavia, non riuscirono ad
eliminare il problema della lubrificazione degli ingranaggi.
|
La Williams FW12C, è la monoposto con la quale il team Williams F1 corse nel campionato mondiale di Formula Uno 1989.

La Williams FW12C di Riccardo Patrese col nuovo motore Renault.
La
FW12C, guidata da Riccardo Patrese e Thierry Boutsen, consentì
alla squadra di risollevarsi dopo un anno di totale crisi; tuttavia non
prese parte a tutte le gare del campionato, in quanto nel Gran Premio
del Portogallo venne sostituita dalla Williams FW13, che però
non si rivelò ancora particolarmente affidabile.
Perciò, nella gara seguente, Patrese guidò la FW12C
mentre Boutsen la FW13: la FW12 venne definitivamente rimpiazzata dalla
FW13 solamente nelle ultime due gare in Giappone e Australia.
Le
prestazioni della vettura si rivelarono sufficientemente buone da
permettera alla Williams di diventare vicecampione del Mondo
costruttori, dietro solo alla McLaren che vinse la maggior parte delle
gare, mentre Patrese ottenne il terzo posto nel mondiale piloti, alle
spalle di Alain Prost e Ayrton Senna, i due alfieri della
McLaren-Honda. I passi avanti vennero fatti anche in qualifica, infatti
Patrese ottenne una pole position, e le due vetture si qualificavano
spesso tra la seconda e quarta posizione. Boutsen si piazzò
invece quinto, ma a differenza del compagno vinse anche dei gran premi
(in Canada con la FW12C e in Australia con la FW13).
Nonostante la ritrovata competitività la Williams peccò in
affidabilità, subendo numerosi ritiri anche se in minore misura rispetto
al 1988: senza questi inconvenienti la scuderia britannica avrebbe
potuto incrementare i suoi punti, ma difficilmente avrebbe potuto
lottare contro le McLaren, che dimostrarono un'ampia superiorità sul
resto dello schieramento.
|

|
Nuovo motore, auto vecchia
La
FW12C non era molto diversa dalla FW12 da cui derivava, dato che
quest'ultima possedeva una configurazione aerodinamica abbastanza
valida.
Nel 1988 la Williams era stata privata dei motori turbo dalla
Honda, malgrado un contratto valido per tutto il 1988. Scaduto questo
contratto con la Honda, che al termine del 1987 aveva lasciato la
Williams e pagato i motori Judd, derivati da un progetto Honda del 1980,
per rispettare il contratto.
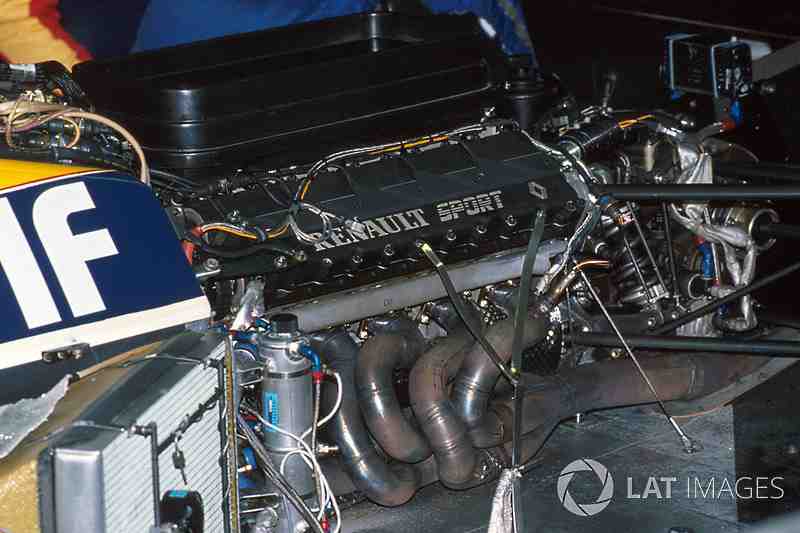
Per
il nuovo campionato la Williams trovò un accordo con la Renault,
la quale aveva già partecipato al Campionato mondiale di Formula
1 come pioniera dei motori turbo prima con vetture proprie e poi come
fornitrice dei propulsori ad altre squadre, tra il 1976 e il 1986,
quando l'azienda francese decise di ritirarsi con il profilarsi
all'orizzonte del ritorno dei motori aspirati e con problemi di
bilancio, superati i quali si convinse a tornare nel mondo delle corse
con una nuova tecnologia e nel 1989 fece esordire sulle Williams un
nuovo potente ed affidabile motore V10.
Il motore Renault a pari
cilindrata del Judd V8 era ovviamente più lungo. Per questo
motivo la FW12 venne modificata neltelaio e nelle dimensioni delle prese d'aria, in modo da migliorare lo smaltimento termico.
La
configurazione V10 adottata dalla Renault e dalla Honda sarà
adottata da tutte le altre squadre e successivamente imposta dalla FIA
dal 2001 al 2005. Per il resto la vettura era praticamente identica
alla FW12, dato che il cambio era il solito Hewland trasversale a 6
marce e le sospensioni quelle dell'anno prima.
|
Williams FW14
Nel
1992 la vettura, aggiornata e rinominata FW14B, ha vinto sia il
Campionato mondiale costruttori di Formula 1 sia il Campionato mondiale
piloti di Formula 1, grazie a Nigel Mansell. In entrambe le stagioni in
cui ha corso i piloti sono stati Mansell e Riccardo Patrese.
È una delle più
vincenti e sofisticate vetture nella storia della Formula 1 e viene
tuttora ricordata con un nomignolo (l'auto venuta da un altro pianeta)
affibbiatole nel 1992, grazie alla sua superiorità sulle vetture
avversarie. È inoltre ricordata positivamente dagli appassionati per la
sua estetica morbida e proporzionata.
|
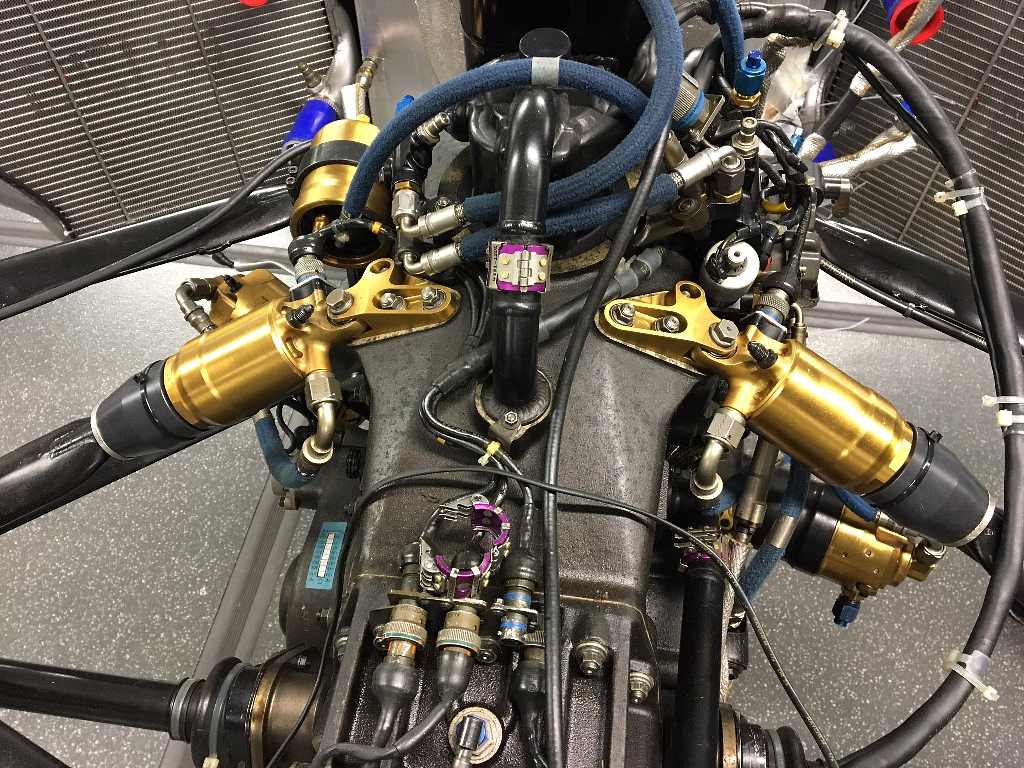 |
|
La vettura nacque dalla necessità, avvertita in egual misura dalla Williams e dal suo partner Renault,
di effettuare un ulteriore salto di qualità dopo due stagioni, il 1989
ed il 1990, caratterizzate da buone prestazioni ma non pienamente
soddisfacenti. Adrian Newey, proveniente dalla March a metà della
stagione 1990, iniziò immediatamente a lavorare sul progetto riguardante
la vettura per il 1991. Nella sua sino ad allora breve carriera in
Formula 1 il progettista inglese aveva disegnato vetture decisamente
innovative dal punto di vista aerodinamico, tanto da risultare fin
troppo estreme e molto difficili da mettere a punto. Le scarse risorse
economiche della March non permisero mai un adeguato sviluppo,
rivelandosi uno dei motivi degli scarsi risultati ottenuti dalla March
(e poi Leyton House) tra il 1989 e il 1990, ma il budget messo a
disposizione dalla Williams e la collaborazione con uno dei migliori
direttori tecnici di sempre quale Patrick Head permisero ad Adrian Newey
di sviluppare concretamente e sino in fondo le proprie idee,
realizzando allo stesso tempo una vettura avveniristica ma comunque
facile da regolare e da guidare.
Il progetto, mostrato a Nigel Mansell, era talmente valido da
convincere il pilota inglese ad accantonare i suoi progetti di ritiro
dalle corse facendo così ritorno alla corte di Frank Williams dopo il
controverso biennio passato in Ferrari. La vettura, spinta dal nuovo
motore Renault RS3 V10 da 3500 cm³, molto più leggero e compatto del
propulsore dell'anno prima e dotato di distribuzione a valvole con
richiamo pneumatico e, in un secondo momento, anche di tromboncini di
aspirazione ad altezza variabile, era la monoposto più sofisticata in
griglia già nella versione originale nel 1991, ma fu soprattutto la
FW14B del 1992, equipaggiata di cambio semiautomatico, sospensioni
attive, controllo della trazione e, per un breve periodo, ABS, a
risultare talmente avveniristica da non poter essere assolutamente
paragonata alle vetture concorrenti come la McLaren MP4/6, la Ferrari F92 A
oppure la Lotus 107. La FW14B ebbe un successo talmente grande che la
sua erede, la FW15C, pronta a debuttare a metà stagione, non fu
mai utilizzata nel 1992 ma fu riservata alla stagione 1993.
|
 |
| La FW14 debuttò al Gran Premio degli Stati Uniti del 1991
e si dimostrò subito velocissima anche se poco affidabile. Nelle prime
cinque gare, infatti, nonostante le brillanti prestazioni in prova, i
piloti della Williams riuscirono ad ottenere soltanto due secondi posti,
in Brasile con Patrese e poi a Monaco con Mansell ed un terzo posto in Canada
con l'italiano. I problemi, che afflissero soprattutto Mansell, erano
dovuti alla fragilità del nuovo cambio semiautomatico. A partire dal Gran Premio del Messico
e per tutta la parte centrale della stagione la Williams FW14 dominò la
scena, permettendo ai suoi piloti di vincere sette Gran Premi (cinque
vittorie per Mansell e due per Patrese) e soltanto l'affidabilità della
McLaren, uno straordinario Ayrton Senna,
oltre ad una certa dose di sfortuna (in Canada Mansell fu costretto a
fermarsi all'ultimo giro per un problema elettrico mentre era in testa
ed in Portogallo l'inglese dopo aver dominato tutta la prima parte di
gara viene squalificato per aver sostituito una gomma fuori dalla zona
deputata per rimediare ad un pasticcio combinato dai suoi meccanici)
impedirono a Mansell di conquistare il suo primo titolo mondiale ed al
team di primeggiare tra i costruttori.
La stagione della Williams si concluse con il secondo posto nella
classifica costruttori, fra i piloti Mansell si classificò al secondo
posto e Patrese al terzo. Nonostante l'affermazione dei rivali, la
superiorità della vettura di Grove era evidente e in tanti, Ayrton Senna
in primis, avevano capito che la McLaren l'anno successivo avrebbe
difeso il titolo mondiale con moltissime difficoltà.
|
| 1992 - In vista della successiva stagione vennero migliorati il cambio e le
sospensioni attive, tanto che la vettura si rivelò così nettamente
superiore alle altre da essere soprannominata la vettura venuta da un altro pianeta.
La Williams instaurò definitivamente il dominio tecnico
già manifestato nel 1991 e che durerà fino al 1997.
Mansell conquistò il titolo piloti ottenendo nove vittorie e tre
secondi posti, Patrese il secondo posto titolo mondiale piloti, mentre la Williams vinse il quinto titolo costruttori
con 10 vittorie e 164 punti, 65 in più della McLaren-Honda.
|
|
 |
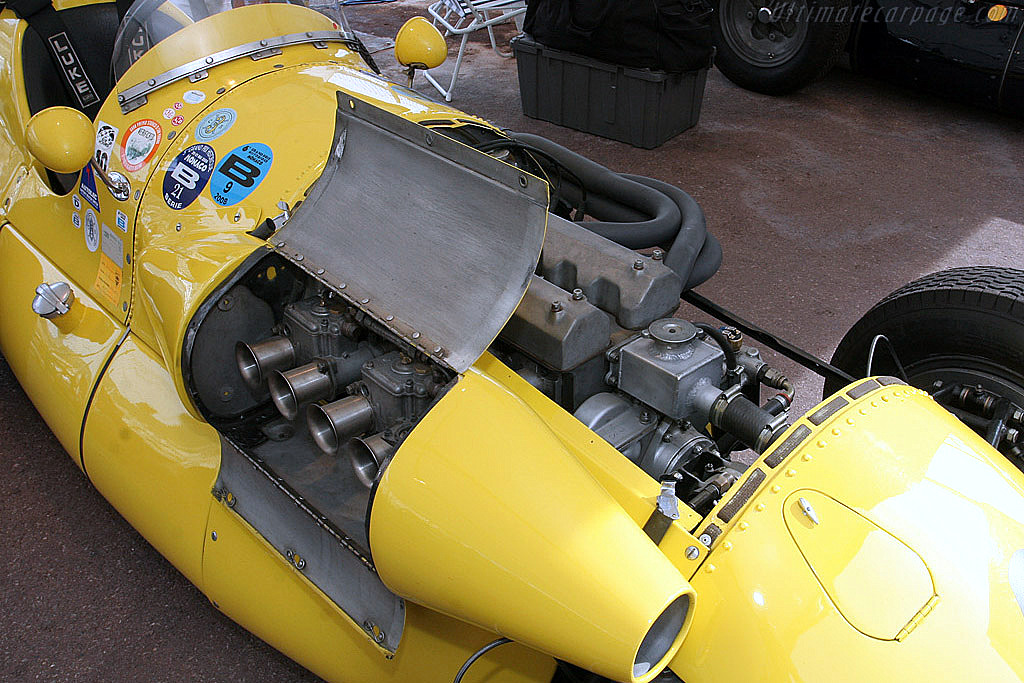 |
| Connaught
Engineering fece il suo debutto nelle corse durante la stagione 1952.
Tra le altre vetture di Formula 2 che gareggiano nel Campionato del
Mondo, il loro telaio A-Type si dimostrerebbe competitivo e capace, ma
soprattutto nelle gare che si svolgono da qualche parte sulle isole
britanniche. |
|
La Benetton fu la prima auto che innalzò il muso anteriore della vettura
La Benetton B195
fu l'undicesima monoposto prodotta dalla Benetton Formula per prendere
parte al campionato mondiale di Formula 1. Impiegata nella stagione
1995, fu guidata da Michael Schumacher e Johnny Herbert.
Fu la vettura più vincente mai prodotta dal team, giacché riuscì a
conquistare il secondo titolo piloti consecutivo e il primo (e unico)
titolo costruttori della storia della Benetton. Fu inoltre l'ultima
monoposto ad essere omologata con licenza britannica: la vettura
dell'anno seguente, la B196, venne infatti dotata di licenza italiana.

Johnny Herbert, Montreal, 1995
Progettata
dall'ingegnere Rory Byrne e sotto la supervisione del direttore tecnico
Ross Brawn, la B195 riprendeva ed aggiornava l'antesignana B194,
adattandosi al contempo ai nuovi regolamenti di sicurezza varati sulla
scia dei tragici avvenimenti del Gran Premio di San Marino 1994. Si
provvide pertanto a creare uno scalino nel fondo della vettura che la
rialzasse di almeno 5 cm dal suolo.
I più evidenti cambiamenti rispetto alla monoposto del 1994
consistettero in un ulteriore aumento della dimensione delle pance
laterali e un affinamento dell'aerodinamica dell'alettone posteriore e
del retrotreno in generale. Vennero inoltre introdotte delle alette
davanti alle ruote posteriori per aumentare il carico aerodinamico.

La
principale innovazione era comunque rappresentata dal motore: per
espressa volontà di Flavio Briatore, il V8 Ford ZR venne
sostituito dal nuovo V10Renault da 3000 cm³, che rispetto
alla versione del 1994, pur avendo dovuto subire ai sensi del nuovo
regolamento una decurtazione di 500 cm³ di cilindrata, era
più leggero, consumava meno e garantiva un regime di rotazione
di 800 giri al minuto in più.
|
La Telemetria
Ogni aspetto della vettura, la velocità di rotazione del motore, la
velocità, la temperatura del motore, i movimenti della sospensione, i
movimenti del pedale, la forza g laterale, i tempi sul giro, gli
intermedi e tantissimi altri parametri ancora sono controllati da
sensori posizionati su tutta la vettura che trasmettono tutto alla
centrale (scuderia). In media ogni scuderia porta ad un GP quasi 30 kg
di apparecchiature che controllano tutti questi parametri che possono
essere di grande aiuto sia ai meccanici sia al pilota quando avrà
terminato le prove.Ogni auto di F1 ha due tipi di telemetria:
-
il primo è costituito da una serie di impulsi che vengono inviati via
etere dall'auto ogni qual volta essa passa dal traguardo. Questi
segnali sono di circa 4 Mb di informazioni e dati, che danno un'idea
delle condizioni della monoposto. Altri 40 Mb vengono scaricati
dall'auto ai computer quando esse vanno ai loro box in modo da dare in
maniera particolareggiata tutte le minime informazioni che prima non
potevano dare. Queste informazioni si ottengono collegando un computer
alla vettura con un cavo.
-
il secondo tipo di telemetria è costituito da un sistema che
trasmette in tempo reale piccole informazioni. Queste informazioni sono
trasmesse dall'antenna che si trova sul musetto del veicolo o si trova
integrata sugli specchietti retrovisori.
Telemetria bidirezionale
La vera rivoluzione nel campionato di F1 del 2002 è la telemetria
bidirezionale o a due vie. La rivoluzione consiste nel nuovo modo di
gestire la vettura durante un GP, la gestione delle risorse della
monoposto. Ma cosa è questo tipo di telemetria e quali sono i suoi
vantaggi? Detto in due parole è la possibilità di intervenire sulla
vettura in corsa, dai box senza possibilità di errore. Infatti lo
svantaggio della "vecchia" telemetria era dovuto al fatto che i vari
settaggi della vettura potevano solo essere effettuati dal pilota,
attraverso il computer-volante, ed erano anche molto pochi (solo cinque
opzioni). Queste variazioni di settaggi come la diversa ripartizione di
frenata, o la diversa combustione del motore potevano essere effettuate
mediante delle leve presenti sul volante: ciò poteva anche essere fonte
di distrazione per il pilota, che oltre ad essere concentrato per la
gara, doveva azionare le leve giuste al punto giusto. Ora invece
mediante le telemetria a due vie tutte quelle leve presenti sul volante
spariranno poichè quelle "ridicole" cinque opzioni saranno modificate
via radio dai box in aggiunta ad altre 600 parametri, senza ovviamente
distrarre minimamente il pilota e senza sbagliare un colpo! Facciamo un
esempio pratico. Mentre un pilota sta gareggiando, i tecnici si
accorgono che a causa di problemi X (per esempio una notevole usura
della ruota anteriore destra) in alcune curve l'aderenza è minore che,
naturalmente, costringe il pilota a ridurre la velocità con cui esegue
quella curva. I tecnici, dai box, inviano immediatamente un segnale alla
monoposto regolando, ad esempio, la sospensione di quella ruota
ripristinando le condizioni iniziali della monoposto. Il tutto senza che
il pilota influisca minimamente sui comandi. Voi direte perchè non
applicare le telemetria bidirezionale anche alla partenza per
ottimizzarla ancora di più? Ebbene la Fia ha già pensato a questo
problema impedendo alle scuderie di intervenire sulla telemetria a due
vie. Ciò che sarà più difficile è invece rendere pratico ciò che è sulla
carta. Infatti la Fia, benchè dotata di apparecchiature sofisticate,
non sempre sarà, a mio avviso, capace di controllare tutte le telemetrie
della varie scuderie. Un altro fenomeno che pian piano emergerà sarà
la lotta a come disturbare meglio i segnali delle altre società di F1.
Viene quasi da ridere, ma non di rado accadrà di vedere una monoposto
fermarsi senza un'apparente causa. Infatti una scuderia, se riesce a
trovare il segnale di trasmissione (che ovviamente è criptato) di
un'altra squadra, può inviare segnali errati alle monoposto avversarie e
far spegnere, ad esempio, il motore!Insomma ci sarà una lotta non solo
tra le scuderie, ma anche tra le società che producono i software delle
telemetrie.
Software
I team usano solitamente i software dei loro patners che sono Hewlett
Packard, Compaq, TAG Electronics. La McLaren usa un sistema avanzato di
telemetria denominato "ATLAS" (Advanced Telemetry Linked Acquisition
System) e si ritiene che sia uno dei più sviluppati sistemi di
telemetria che esiste in F1 tanto che molte scuderie hanno un sistema
analogo a questo, ma che non arriva alle sue prestazioni.
È stata presentata il 6 febbraio 2002 a Maranello. Ha vinto il titolo
piloti e costruttori di F1 ed è ha ottenuto la 150esima vittoria, in
Canada, con Schumacher
La vettura presenta la classica colorazione rossa con inserti bianchi, dovuti agli sponsor Marlboro e Vodafone.
.

La F2002 conservata al Museo Ferrari
|
La F2002 si configura come una vettura decisamente diversa dalle
precedenti monoposto realizzate dalla scuderia di Maranello: se la F2001
rappresentava l'estrema evoluzione delle soluzioni adottate dai tre
modelli precedenti (Ferrari F300, Ferrari F399 e Ferrari F1-2000) la
nuova monoposto, pur mantenendo una linea non dissimile dalla
progenitrice, è foriera di numerose modifiche e migliorie.
La F2002 presenta vistose novità soprattutto al retrotreno: alla base di
tali modifiche si individua la necessità di ridurre gli ingombri della
trasmissione ottimizzando al tempo stesso, ai fini di ottenere
un'aerodinamica posteriore ancora più sofisticata, lo schema delle
sospensioni. Le fiancate, rispetto alla F2001, risultano più lunghe in
quanto l'abitacolo, per poter avere un serbatoio della benzina più
grande, è stato spostato in avanti. Le pance risultano pertanto più
voluminose nella parte iniziale e più basse e strette nella zona
posteriore. I tecnici della Ferrari hanno poi unito lo sfogo dell'aria
calda allo sfiato degli scarichi, che ora indirizzano l'aria calda
uscente dagli scarichi in orizzontale e non più verso l'alto. A
protezione delle sospensioni posteriori vi sono poi delle piccole
paratie orizzontali. I deviatori di flusso, posti davanti alle prese
d'aria delle fiancate, risultano molto più grandi rispetto a quelli
della F2001 e presentano una forte svergolatura. Il muso della F2002 è
stato ulteriormente alzato, in quanto il flusso aerodinamico è stato
ottimizzato grazie all'effetto estrattore dei gas di scarico, ma non
presenta differenze sostanziali rispetto a quello della vettura
precedente.
|

Vista laterale della F2002 di Schumacher al GP di Francia 2002
|
La sospensione posteriore è stata modificata in modo da renderla più
compatta: i bracci superiori ed inferiori, per non ostacolare il flusso
d'aria in uscita dal fondo, sono stati distanziati di pochi centimetri
mentre i punti di ancoraggio alla scocca sono stati ravvicinati
determinando, in combinazione con l'aderenza consentita dagli pneumatici
e dai carichi aerodinamici, un aumento della capacità di sforzo
dell'intero sistema sospensivo. A protezione delle sospensioni
posteriori vi sono poi delle piccole paratie orizzontali.
Per ciò che concerne il motore, la zona degli scarichi è stata angolata
di 90° potendo così integrarla con gli sfoghi dell'aria sfruttando così
un effetto estrattore dovuto alla depressione determinata dalla velocità
e temperatura dei gas di scarico e consentendo di presentare fiancate
totalmente lisce: tali modifiche hanno avuto la conseguenza di ottenere
più deportanza a parità di incidenza.
|
 |
La Lotus 96T, vettura pensata per il campionato Indycar.
L'innovazione principale è rappresentata dall'introduzione di una prima
forma di paratie nella parte delle prese d'aria laterali.
La
vettura si dimostra molto competitiva soprattutto in prova e nella
prima parte di stagione . Tra la seconda gara (Gran Premio del
Portogallo) e la sesta (Gran Premio del Canada) conquista cinque pole
consecutive (4 con Senna e 1 con De Angelis), e la vittoria in
Portogallo (con Senna - la prima in carriera per il brasiliano) e a
Imola (con De Angelis). La scarsa affidabilità e gli elevati
consumi del motore Renault, penalizzano Senna che per ben sette gare
dopo la vittoria in Portogallo non conquista punti. Senna rimase senza
benzina (all'epoca limitata a 220 litri) a pochissimi giri dalla fine
in due gran premi (San Marino, Gran Bretagna, ed in almeno altrettanti
fu costretto a rallentare per terminare la gara, rinunciando alla
vittoria.
Nella
parte centrale della stagione la vettura conquista però ancora
dei podi, per poi chiudere con altre tre pole di Senna, e la vittoria
del brasiliano in Belgio.
In totale la vettura conquista 71 punti (frutto di 3 vittorie, 2
secondi posti, 4 terzi, 1 quarto, 6 quinti e 1 sesto), facendo chiudere
la scuderia al quarto posto nella classifica costruttori, a pari punti
con la Williams, terza. La vettura coglie anche 3 giri veloci.
 |
 |
| Ayrton Senna |
Elio De Angelis nel gran Premio di Germania 1985 |
|
|
La Ferrari 553/555 F1, soprannominata supersqualo per via delle sue forme,
è la vettura con cui la Scuderia Ferrari corse parte del Campionato mondiale di Formula 1 1955.

Nino Farina prova la nuova Ferrari 555 F1 all'aerautodromo di Modena (1955)
. In fondo, con gli occhiali scuri, si riconosce Enzo Ferrari.
|
 |
|
Alla fine del 1954, la 553 F1
fu sottoposta a radicali modifiche mirate a migliorarne le prestazioni
che si erano rivelate alquanto deludenti. Il risultato di queste
modifiche fu la 555 F1 che per il 1955 avrebbe dovuto rappresentare la
vettura di punta della Scuderia Ferrari, quella su cui la casa di
Maranello avrebbe concentrato tutti gli sforzi per contrastare Mercedes e
Lancia.
Nel complesso la 555 F1 venne rivista nel telaio, che ora
inglobava la sospensione posteriore, e adottava le nuove sospensioni
anteriori che erano già state provate a partire dal GP di Spagna 1954 |
 |
| Venne inoltre adottato un nuovo radiatore più piccolo che permise di migliorare l'aerodinamica del muso, che ora si
presentava più rastremato, accentuando così la caratteristica formale
della vettura. Il motore rimase invece invariato.
Come per la 553 F1 il nome, contrariamente alla tradizione del
marchio, si riferiva alla cilindrata unitaria (499 cm³ approssimata per
eccesso a 500 cm³) solo nella prima cifra seguita dall'anno di
produzione della vettura, in questo caso il 1955.
Tuttavia la 555 F1 non ebbe particolare successo e le sue prestazioni, anche a causa delle potenti Mercedes W196,
risultarono alquanto deludenti tanto che in alcune gare della stagione
1955 le venne preferita la vecchia 625 F1 che si dimostrò
più competitiva e affidabile. A nulla valsero gli sforzi della
Ferrari che costrinsero i tecnici di Maranello a un lavoro frenetico
per cercare e, possibilmente, recuperare lo svantaggio tecnico nei
confronti della Mercedes che disponeva di un ben superiore potenziale tecnico ed economico |
 |
| A partire dal 1956 venne sostituita dalla più competitiva Lancia-Ferrari D50.
|
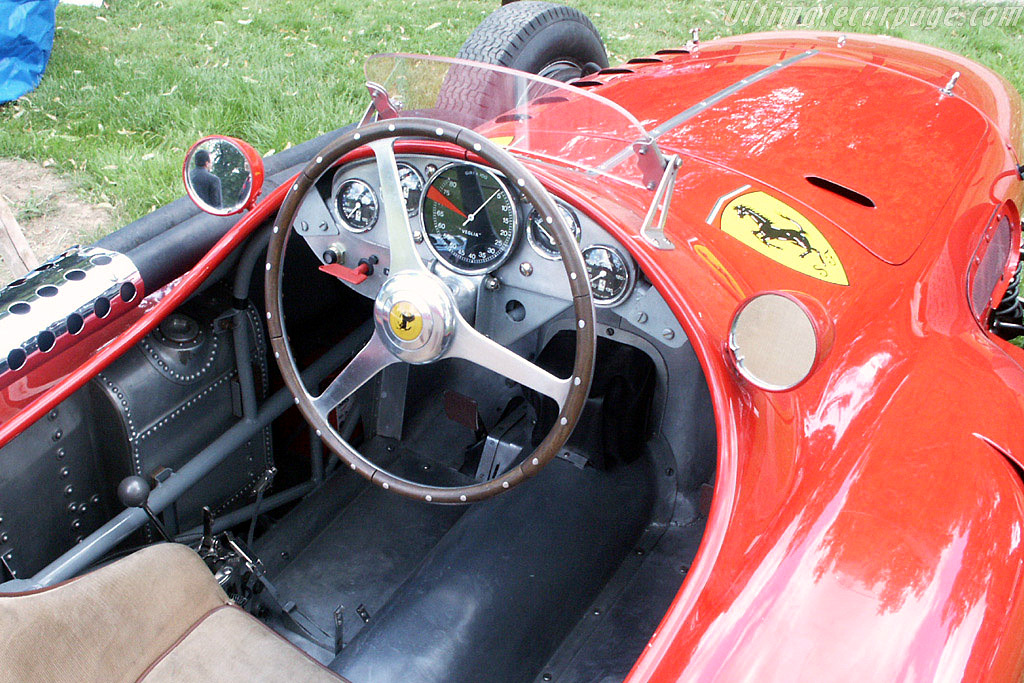 |
|
Complessivamente
i risultati della 555 F1, nelle poche gare a cui prese parte, furono
piuttosto altalenanti e senza soluzione di continuità. L'esordio
in F1 avvenne al GP di Monaco 1955, ma, mentre la 625 F1 di Maurice
Trintignant conquistava il gradino più alto del podio
nonché l'unica vittoria stagionale della Scuderia Ferrari, le
due 555 F1 arrancarono non poco con Taruffi che arrivò solo
ottavo mentre Harry Schell fu costretto al ritiro per problemi al
motore. La gara successiva, il GP del Belgio, fu più fortunata
con Farina 3º al traguardo seguito da Paul Frère 4°.
A
partire dal GP d’Olanda si unirono alla squadra Eugenio
Castellotti, orfano della Lancia dopo che quest'ultima aveva deciso di
rinunciare alle corse a causa della tragica morte di Alberto Ascari, e
Mike Hawthorn, reduce da una poco felice esperienza con la Vanwall. Nel
GP olandese la 555 F1 condusse un'altra gara anonima con Castellotti
5°, Hawthorn 7° e Trintignant ritirato per la rottura del
cambio. L'ultima gara in carriera della 555 F1 fu il Gran Premio
d'Italia dove ben figurò grazie a Castellotti che
conquistò un onorevole 3º posto.
In seguito la poco fortunata monoposto di Maranello, sostituita
dalla Lancia- Ferrari D50, continuò a figurare in qualche gara di
formula libera anche se con un diverso motore.
|
|

La BRM P126 è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia inglese BRM per partecipare
al Campionato mondiale di Formula 1 1968 e Campionato mondiale di Formula 1 1969.
|
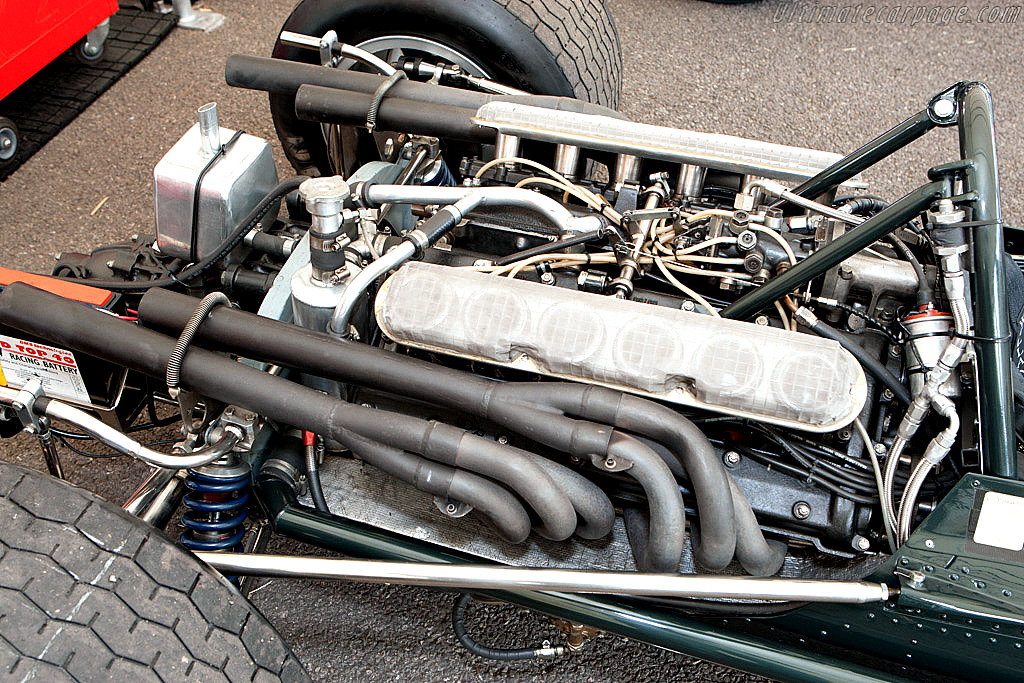 |
|
Dopo due stagioni passate concentrandosi sullo sviluppo di un nuovo
propulsore V16, la direzione tecnica del team inglese, visti gli scarsi
risultati ottenuti, decise di dedicarsi alla progettazione di una nuova
unità V12, più semplice da gestire e realizzare.
La vettura progettata da Len Terry era equipaggiata con un propulsore
V12 dalla potenza di 370 cv gestito da un cambio Hewland manuale a
cinque rapporti. Il telaio era in configurazione monoscocca realizzato
in alluminio, mentre l'impianto frenante era costituito da quattro freni
a disco ventilati. Le sospensioni, in tutte le sezioni, erano composte
da doppi bracci trasversali, molle elicoidali e ammortizzatori..
|
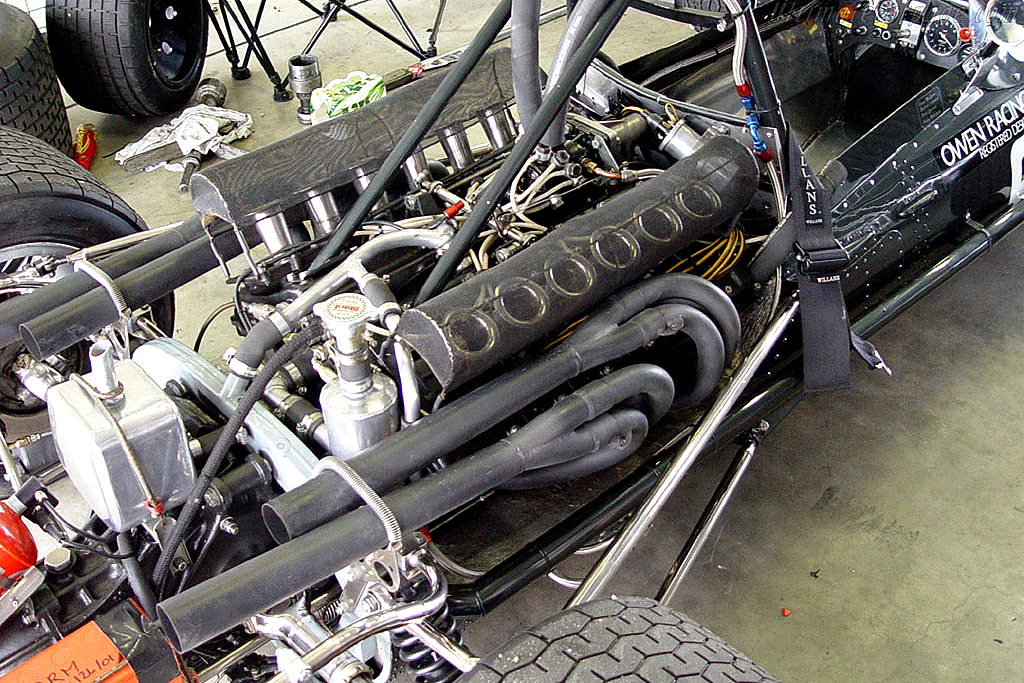 |
| La P126, durante la stagione 1968 del campionato di Formula 1, ottenne
diversi secondi posti che le permisero di arrivare quinta nel mondiale
costruttori.
A metà della stagione 1968 la P126 venne sviluppata e il nuovo
modello venne denominato P133, nonostante quest'ultimo mostrasse delle
modifiche estremamente lievi.
|
 |
| Motore Renault-Gordini EF1 1.5 V6 (Turbo) in prova al banco prova-1979 |
 |
Il Renault EF1 nella versione a due turbine e doppio collettore di aspirazione
sulla Renault RE20 di Jean-Pierre Jabouille del 1980 |
Gomme

1940-1952: Nasce il moderno Pneumatico Radiale
Tra il 1940 ed il 1948 la società cambia denominazione sociale divenendo Manifattura della Gomma Michelin
e lo stabilimento di Cataroux, distrutto dai bombardamenti del 1944
viene completamente ricostruito e modernizzato.
Nel 1946 la casa
francese brevetta la sua (forse) più importante scoperta tecnologica, il
Pneumatico Radiale (il padre dei pneumatici moderni). Brevettato il 4 giugno, il radiale viene commercializzato con il nome di Michelin X.
Sempre in questi anni la metropolitana parigina corre per la prima
volta su pneumatici e Lancia equipaggia le proprie auto con gomme
Michelin X come 1° equipaggiamento.
I pneumatici Michelin sono ormai
amati e rispettati in tutto il mondo; tutte le più gradi case
automobilistiche fanno a gara per montare le gomme del Bibendum come
primo equipaggiamento. Anche nelle competizioni, i pneumatici Michelin X
sono molto ambiti e riescono ad affermarsi. Durante infatti la 24 Ore
di Le Mans, una Lancia B20 gommata Michelin X e una Renault 4 CV
equipaggiata con gomme Michelin convenzionali vincono nelle rispettive
categorie.
|

1955-1967: Nasce il 1° pneumatico asimmetrico: il Michelin XAS
In questi anni la maggior parte dei
costruttori europei adottano la soluzione del pneumatico radiale,
pneumatico che, per la sua tecnologia viene sviluppato anche in versioni
speciali pensate per le macchine del Genio Civile.
Michelin impiega ormai 81.000 persone in tutto il mondo di cui 37.400
solo in Francia. Proprio in questi anni la casa apre il proprio Centro
di Ricerca e Sviluppo Tecnologico di Ladoux e presenta al suo
pubblico il 1° pneumatico asimmetrico, il Michelin XAS, una gomma pensata appositamente per auto potenti e veloci.
|
|

1981-1990: Michelin X Air. Il primo pneumatico radiale per aerei
Tra il 1981 e i primi anni ’90 Michelin brevetta il 1° pneumatico radiale per aerei
e dopo essere diventata azionista di maggioranza di Kleber – Colombes
(Francia) apre uno stabilimento a Columbia (Carolina del Sud, USA).
Sempre in questi anni la casa presenta un ulteriore brevetto di
importanza mondiale: il 1° pneumatico radiale per moto, pneumatico che sarà commercializzato nel 1987. Venfono aperte inoltre fabbrice in Asia, Thailandia e Giappone.
|
|
Le gomme per le monoposto da formula 1 devono resistere a temperature
elevate (pari a 125°C) e a giri di rotazione pari a 3000 rpm alla
massima velocità.Le gomme sono riempite con speciale azoto e aria
compressa che fanno sì che la sua pressione interna rimanga inalterata
per tutto il suo utilizzo. Le gomme sono realizzate con tre essenziali
composti: carbonio, polimeri e oli speciali. Per ogni gran premio è
possibile utilizzare due tipi di mescole per le ruote da asciutto: o
dure o morbide. Purtroppo se il sabato si usano o le gomme morbide o
quelle dure, per regolamento, occorre utilizzare le stesse anche la
domenica. Ciò potrà essere un vantaggio il sabato perchè ad esempio
potrebbe rendere più veloce la macchina, ma la domenica potrebbe essere
penalizzante nei risultati. Ciò è avvenuto nel gran premio di Spagna
alle McLaren che il sabato hanno avuto scarsi risultati ma la domenica i
risultati furono positivi. Le gomme più morbide danno molto grip ma si
usurano molto rapidamente, mentre le gomme dure danno meno grip ma si
usurano in più giri.
Qui accanto sono stati disegnati i tre tipi di battistrada che possono
essere utilizzati in un gran premio. A sinistra c'è il battistrada da
asciutto con le scanalature per diminuire la velocità dei veicoli.
Invece alcuni anni fa le ruote erano totalmente lisce come accade ora
per la formula 3000 e per LeMans. In mezzo vi è la gomma "intermedia"
che si usa quando l'asfalto è leggermente bagnato a causa di un lieve
temporale o quando solo alcune parti della pista sono bagnate. Quando
invece la pista è dichiarata ufficialmente bagnata dai commissari di
percorso occorre usare la gomma da bagnato. Essa deve avere le seguenti
caratteristiche: deve avere almeno il 75% di contatto con l'asfalto. Il
resto (25%) deve essere la zona del battistrada che rimuove l'acqua
attraverso le scanalature. Se si dovesse usare la gomma da bagnato su
asfalto che si sta asciugando, essa potrebbe surriscaldarsi fino a
perdere grip. Proprio per questo motivo a volte si vede Schumacher che
"va a cercare la parte bagnata" dell'asfalto per raffreddare i
copertoni.
Pressione delle gomme
 Anche la pressione delle gomme influenza le prestazioni di una vettura
da F1. Infatti ci sono due parametri che variano al variare della
pressione. Il primo riguarda la reattività del pneumatico. Quanto
maggiore è la pressione di gonfiaggio del pneumatico, tanto minore sarà
la sua deformazione in curva e la zona di contatto con il suolo varierà
solo leggermente, offrendoti un potenziale di aderenza, più veloce e più
reattivo. Al contrario, quanto minore sarà la pressione di gonfiaggio
del pneumatico, tanto più occorrerà ottenere il suo massimo potenziale
di aderenza anche se si usurerà prima del tempo e sarà meno reattivo in
accelerazione.Il secondo parametro riguarda il potenziale di aderenza
del pneumatico al suolo (grip). Quanto maggiore sarà la pressione di
gonfiaggio, tanto minore sarà la sua zona di contatto con il suolo.
Invece la riduzione di pressione porterà alla comparsa di infossature
nel centro del battistrada, riducendo notevolmente la zona di contatto e
conseguentemente aumentando la perdita di aderenza. (Attenzione: la
stessa cosa accade per le vostre auto e quindi le gomme devono avere la
pressione giusta che è sempre indicata sul libretto d'istruzione).Infine
la variazione della pressione delle gomme produce effetti
sotto/sovrasterzanti. Anche la pressione delle gomme influenza le prestazioni di una vettura
da F1. Infatti ci sono due parametri che variano al variare della
pressione. Il primo riguarda la reattività del pneumatico. Quanto
maggiore è la pressione di gonfiaggio del pneumatico, tanto minore sarà
la sua deformazione in curva e la zona di contatto con il suolo varierà
solo leggermente, offrendoti un potenziale di aderenza, più veloce e più
reattivo. Al contrario, quanto minore sarà la pressione di gonfiaggio
del pneumatico, tanto più occorrerà ottenere il suo massimo potenziale
di aderenza anche se si usurerà prima del tempo e sarà meno reattivo in
accelerazione.Il secondo parametro riguarda il potenziale di aderenza
del pneumatico al suolo (grip). Quanto maggiore sarà la pressione di
gonfiaggio, tanto minore sarà la sua zona di contatto con il suolo.
Invece la riduzione di pressione porterà alla comparsa di infossature
nel centro del battistrada, riducendo notevolmente la zona di contatto e
conseguentemente aumentando la perdita di aderenza. (Attenzione: la
stessa cosa accade per le vostre auto e quindi le gomme devono avere la
pressione giusta che è sempre indicata sul libretto d'istruzione).Infine
la variazione della pressione delle gomme produce effetti
sotto/sovrasterzanti.
| Quanto incidono i pneumatici anteriori sull'aerodinamica? |
| Effetto suolo anteriore |
Effetto suolo posteriore |
% effetto di suolo |
Resistenza avanzamento |
Efficienza aerodinamica |
Sensibilità all'altezza da terra |
Raffreddamento |
| - |
- |
- |
16% |
- |
- |
- |
| Quanto incidono i pneumatici posteriori sull'aerodinamica? |
| Effetto suolo anteriore |
Effetto suolo posteriore |
% effetto di suolo |
Resistenza avanzamento |
Efficienza aerodinamica |
Sensibilità all'altezza da terra |
Raffreddamento |
| - |
- |
- |
17% |
- |
|
Ferrari, Renault, McLaren, Williams, Tyrrell, Sauber, Arrows,
sono questi i nomi dei team che hanno sviluppato negli anni il concetto
di “mono chiglia”, “doppia
chiglia” e “attacco a V”, arrivando
a
soluzioni anche estreme e spesso copiate da molte altre squadre. Ma
cosa si intende con questi tre termini?
Quali sono i vantaggi che derivano dall’utilizzo di una o
dell’altra soluzione?
Per rispondere bisogna iniziare il discorso partendo dalle vetture
degli anni ottanta, quando tutte le vetture di Formula 1 avevano un
muso basso e largo ai lati del quale erano attaccati i bracci della
sospensione anteriore. Sia il triangolo superiore che quello inferiore
erano sdoppiati, cioè il componente destro non aveva
contatto con quello sinistro, l’aria che passava sotto la
vettura non aveva nessun passaggio di incalanamento e quello che gli
ingegneri cercavano di sfruttare era la pressione generata
dall’aria
sulla parte superiore del muso stesso.
|
|

La Tyrrell 019 con il muso alto ad ala di
gabbiano
Agli inizi degli anni novanta, però, la
Tyrrell, con la sua 019, introdusse per la prima volta il musetto alto
su una monoposto di Formula 1. Fin dall’inizio gli ingegneri
della Tyrrell avevano capito che lo sfruttamento del flusso
d’aria che scorre sotto la vettura poteva dare enormi
vantaggi per quanto riguarda il carico deportante che schiaccia la
vettura a terra. Con l’introduzione del musetto rialzato,
però, non si potevano più ancorare i braccetti
inferiori direttamente ai lati del muso, questo perché la
carrozzeria era troppo rialzata e attaccare tutto ad essa non avrebbe
lasciato abbastanza spazio tra il triangolo superiore e quello
inferiore pregiudicando il funzionamento della sospensione stessa;
allora i progettisti introdussero il concetto di “mono
chiglia”.
|
|

La monochiglia della Ferrari
Questa soluzione consiste nel creare sotto il
musetto una sorta di pinna molto spessa dove ancorare i braccetti
inferiori della sospensione.
Si viene a creare un puntone sotto al musetto dove da un unico punto
partono i braccetti sinistri e destri della sospensione anteriore.
Questa soluzione consente di avere sia il musetto alto, che uno schema
delle sospensioni valido (triangolo superiore ed inferiore sono ben
distaccati) e rigido nel suo insieme.
Ma per sfruttare al meglio il flusso d’aria che si incanala
sotto il musetto bisognava eliminare lo “scoglio”
dell’attacco delle sospensioni, troppo ingombrante al punto
da interrompere il flusso d’aria e quindi annullare il
vantaggio del muso alto. Il problema fu risolto dalla Jordan nel ’92, quando il suo
ingegnere, Gary Anderson, introdusse un attacco dei braccetti inferiori
della sospensione anteriore sdoppiato. Questa soluzione, denominata
“doppia chiglia” consisteva nel creare due piccole
alette laterali che si allungassero verso il basso partendo dai lati
del musetto, in modo da ricreare una superficie laterale simile a
quella delle vetture anni ottanta, ma che al contempo lasciasse libera
la parte centrale del musetto formando così una sorta di
tunnel dove l’aria potesse incanalarsi per finire sotto il
fondo piatto senza incontrare ostacoli all’altezza delle
sospensioni.
|
|
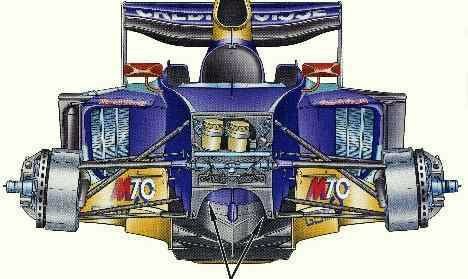
La doppiachiglia della Sauber
L’idea era nel contempo semplice e
geniale ed infatti fu copiata da molte altre squadre, tra le quali:
Sauber, McLaren, Wlliams, Arrows e Jaguar. Naturalmente ogni team ha
personalizzato l’idea iniziale con cambiamenti spesso molto
estremi; ad esempio l’Arrows ha introdotto le due paratie
laterali molto lunghe e dritte, che fanno parte di un raffinato
pacchetto aerodinamico per l’anteriore della vettura.
|
|
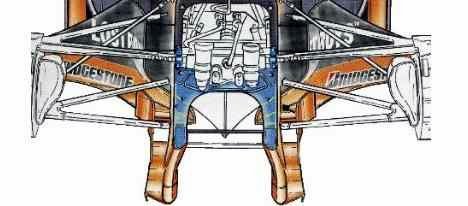
Il raffinato complesso a doppiachiglia
dell’Arrows
L’idea era nel contempo semplice e
geniale ed infatti fu copiata da molte altre squadre, tra le quali:
Sauber, McLaren, Wlliams, Arrows e Jaguar. Naturalmente ogni team ha
personalizzato l’idea iniziale con cambiamenti spesso molto
estremi; ad esempio l’Arrows ha introdotto le due paratie
laterali molto lunghe e dritte, che fanno parte di un raffinato
pacchetto aerodinamico per l’anteriore della vettura.
|
|
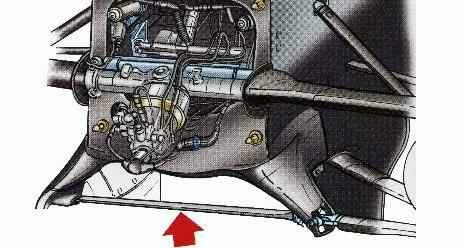
Un’altra soluzione estrema è
quella della Williams, che nel 2004 ha presentato un muso altissimo e
corto, dove le pinne di attacco delle sospensioni si protraevano, oltre
che verso il basso, anche verso la parte anteriore del muso, divenendo
i sostegni per l’ala anteriore.
|
|

Il cortissimo musetto a "tricheco" della
Williams
Questa soluzione, difficoltosa da realizzare per
via delle dimensioni del musetto molto corto e quindi difficilmente
adattabile a resistere ai crash test imposti dalla FIA, consentiva,
però, una portata d’aria enorme verso il fondo
della vettura, creando così idealmente un effetto di
deportanza.
|
|
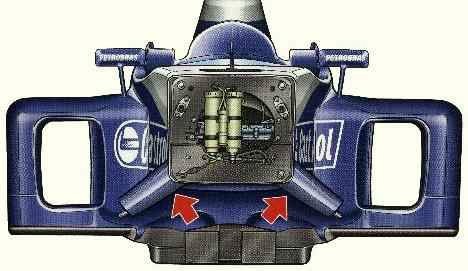
I doppi attacchi larghissimi della William
nella versione "tricheco"
Purtroppo i calcoli teorici non furono confermati
dai risultati in pista: la struttura del musetto, infatti, non aveva
abbastanza rigidità per sostenere al meglio sia
l’ala anteriore che i bracci delle sospensioni rendendo
difficoltoso il set-up della vettura; inoltre l’aria che
fluiva sotto la vettura era troppa e una volta schiacciata sotto il
fondo piatto della vettura creava un effetto di
“pompaggio” destabilizzando la monoposto, che in
pratica risultava inguidabile alle alte velocità.
In pratica la soluzione Williams aveva amplificato sia i vantaggi che
gli svantaggi della soluzione a “doppia chiglia”:
da un lato la possibilità di sfruttare un flusso pulito di
aria sotto la vettura per creare deportanza, dall’altro lato
lo scotto di avere una struttura non del tutto rigida, la quale rendeva
spesso difficile settare la vettura.
In alcuni casi questo problema è stato risolto unendo le due
ali laterali con un elemento trasversale che irrigidiva la struttura,
ma sporcava il flusso d’aria riducendo i vantaggi del muso
alto. Con il passare degli anni, sia la “mono
chiglia” cha la “doppia chiglia” si sono
evolute, ma è stato nel 2006 che finalmente due team sono
giunti a quella che pare la soluzione migliore, quella soluzione che
abbina la rigidezza della prima soluzione con i vantaggi aerodinamici
della seconda; Renault e McLaren, questi sono i due team, hanno creato
una sorta di mini struttura sotto il musetto a forma di V.
|
|

Il mini telaio della Renault che ancora i
bracci inferiori della sospensione
A questa struttura vengono ancorati i bracci
inferiori della sospensione anteriore come la “mono
chiglia”, ma lascia lo spazio libero per il flusso
d’aria come la “doppia chiglia”.
Così come accade ogni volta che qualche mente brillante
escogita una soluzione vincente, anche questa volta tutti gli altri
team si sono adeguati copiando l’idea adattandola alle
proprie vetture, tanto che nel 2007 praticamente tutti i team
presentano questa soluzione.
|
|
Misurare
la velocità in F1
Vi
siete mai chiesti che cos'è quell'antennina che le F1 hanno
all'altezza delle sospensioni anteriori, a forma di L rovesciata ?
Quella che a prima vista sembra una comune antennina per comunicare con
i box, in realtà nasconde un geniale quanto raffinato metodo
per misurare la velocità della vettura.Un tachimetro un
pò più preciso di quello che abbiamo normalmente
sulle nostre vetture stradali, ma che si basa su un concetto fisico
molto semplice. Questo rilevatore di velocità è
costituito da 2 tubicini concentrici (vedi zona 3), cioè uno
dentro l'altro, che viene posto sul cofano delle f1.La parte utile
dello strumento è la punta e il tratto orizzontale , mentre
la parte verticale serve solo per sostenere la precedente Ho disegnato
questo schemettino al Cad dal quale credo sia facile capire il
funzionamento e al quale farò riferimento in questa
spiegazione. Il tratto superiore di questo strumento deve essere
orizzontale perchè deve essere coincidente con il flusso
dell'aria che io ho disegnato con le frecce azzurre . La posizione
dello strumento non è casuale. Quello è l'unico
punto in cui l'aria arriva di moto laminare cioè non ha
subito le perturbazioni degli alettoni , ne delle ruote o di altri
componenti della macchina. In più la sua lontanza dal cofano
dovuta al collo molto alto, fa si che non si crei una depressione come
in vicinanza delle superfici della vettura.Questi accorgimenti e un
'oppurtuna taratura permettono di avere misurazioni precise e sempre
attendibili.
- L'aria arriva nella zona 1 che è l'imboccatura del tubo
più piccolo , quello Rosso.Il tubo rosso in fondo
è chiuso e in 1 il flusso d'aria trova un blocco , un
ostacolo e comprime l'aria all'interno del tubino rosso, facendone
aumentare la pressione.
- L'aria che non rimane bloccata in zona 1 scorre aderendo alle pareti
del tubo Blu, e passa sopra le aperture che ho indicato col numero 2 .
Nella zona tra il tubo Blue quello Rosso la pressione si mantiene
uguale a quella dell'aria che arriva come se non ci fossero ostacoli,
cioè alla pressione dell'aria davanti alla vettura. Sotto il
cofano dove entra il collo del pitot , c'è uno strumento che
registra la pressione del tubo rosso e quella della zona tra tubo blu e
rosso.La differenza tra queste 2 pressioni è proporzionale
alla velocità.Questo avviene ovviamente perchè
all'aumentare della velocità relativa tra la vettura e
l'aria , la pressione all'interno del tubo rosso aumenta , mentre
l'atra nel tubo blu rimane praticamente invariata.
Semplice e efficace ! |
 |
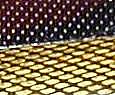 |
Vi
siete mai chiesti che cos'è quell'antennina che le F1 hanno
all'altezza delle sospensioni anteriori, a forma di L rovesciata ?
Quella che a prima vista sembra una comune antennina per comunicare con
i box, in realtà nasconde un geniale quanto raffinato metodo
per misurare la velocità della vettura.Un tachimetro un
pò più preciso di quello che abbiamo normalmente
sulle nostre vetture stradali, ma che si basa su un concetto fisico
molto semplice. Questo rilevatore di velocità è
costituito da 2 tubicini concentrici (vedi zona 3), cioè uno
dentro l'altro, che viene posto sul cofano delle f1.La parte utile
dello strumento è la punta e il tratto orizzontale , mentre
la parte verticale serve solo per sostenere la precedente Ho disegnato
questo schemettino al Cad dal quale credo sia facile capire il
funzionamento e al quale farò riferimento in questa
spiegazione. Il tratto superiore di questo strumento deve essere
orizzontale perchè deve essere coincidente con il flusso
dell'aria che io ho disegnato con le frecce azzurre . La posizione
dello strumento non è casuale. Quello è l'unico
punto in cui l'aria arriva di moto laminare cioè non ha
subito le perturbazioni degli alettoni , ne delle ruote o di altri
componenti della macchina. In più la sua lontanza dal cofano
dovuta al collo molto alto, fa si che non si crei una depressione come
in vicinanza delle superfici della vettura.Questi accorgimenti e un
'oppurtuna taratura permettono di avere misurazioni precise e sempre
attendibili.
- L'aria arriva nella zona 1 che è l'imboccatura del tubo
più piccolo , quello Rosso.Il tubo rosso in fondo
è chiuso e in 1 il flusso d'aria trova un blocco , un
ostacolo e comprime l'aria all'interno del tubino rosso, facendone
aumentare la pressione.
- L'aria che non rimane bloccata in zona 1 scorre aderendo alle pareti
del tubo Blu, e passa sopra le aperture che ho indicato col numero 2 .
Nella zona tra il tubo Blue quello Rosso la pressione si mantiene
uguale a quella dell'aria che arriva come se non ci fossero ostacoli,
cioè alla pressione dell'aria davanti alla vettura. Sotto il
cofano dove entra il collo del pitot , c'è uno strumento che
registra la pressione del tubo rosso e quella della zona tra tubo blu e
rosso.La differenza tra queste 2 pressioni è proporzionale
alla velocità.Questo avviene ovviamente perchè
all'aumentare della velocità relativa tra la vettura e
l'aria , la pressione all'interno del tubo rosso aumenta , mentre
l'atra nel tubo blu rimane praticamente invariata.
Semplice e efficace !
GLOSSARIO
ACCELLERATORE ELETTRONICO
Nella "F1" attuale, il comando "drive-bywire" è
generalizzato. Infatti sul pedale c'è un potenziometro che
serve a informare la centralina
di regolare l'apertura del gas (tramite
un servomotore).
AQUAPLANING
Deriva dal verbo inglese “to aquaplane” che
significa scivolare con l’acquaplano. Nel mondo dei motori
indica la perdita dell’aderenza dei pneumatici
sull’asfalto bagnato dovuto a uno strato d’acqua,
quando si superano determinate velocità. Tutto
ciò ha come risultato la perdita
del controllo della vettura
da parte del pilota.
ADERENZA
Consiste nell’attrito tra la ruota motrice
dell’auto e il piano viabile, quando il primo non striscia
sul secondo e dunque impedisce alla ruota stessa di slittare. Si
possono verificare “perdite di aderenza” in tre
casi: per eccesso di potenza del motore ( le ruote girano
più velocemente della effettiva velocità
dell’auto), per eccesso di frenata (l’auto
è più veloce delle ruote) e per eccesso di
velocità in curva (a quel punto il pilota perde il controllo
della vettura).
AERODINAMICA
Quando si parla di aerodinamica di una vettura ci si riferisce al suo
"Cx", cioè a quel numero che indica la resistenza all'aria.
Quando viene moltiplicato per la sezione trasversale, definisce la
resistenza che si oppone al movimento e dunque la potenza che il motore
deve fornire per vincerla.
AIRBOX
E' la presa d'aria sopra al roll-bar che serve per portare aria fresca
al motore.
ALLINEAMENTO RUOTE
Si tratta dell'angolo delle ruote di un asse, in relazione all'asse
longitudinale della vettura.
AMMORTIZZATORE:
Assorbono urti, dissipando l'energia accumulatasi nelle molle delle
sospensioni, impedendo alle ruote di deflettersi per un tempo
eccessivo.
ANGOLO DELLA V
Definisce l'angolo che si viene a formare tra le due bancate dei
pistoni. Infatti i motori di F1 non sono lineari o Boxer ma hanno una
configurazione a V. Per risolvere i problemi di vibrazione i motori era
a V di 72°. Ma molte scuderie usano anche i V di 90° o
addirittura
a 110° senza però avere problemi
relativi alle vibrazioni date dal motore.
ANGOLO D'INCIDENZA DELLO SPOILER
Si tratta dell'angolo dello spoiler in relazione all'attrito dell'aria.
Quanto maggiore sarà l'angolo, tanto maggiore
sarà la spinta negativa
e, di conseguenza, anche la
resistenza aerodinamica.
ANTISPIN
In caso di forte accelerazione l’antispin (detto anche
“antipattinamento”) è un dispositivo in
grado di evitare lo slittamento delle ruote. Funziona attraverso
l’utilizzo di sensori, che, attraverso impulsi alla
centralina elettronica, tolgono tanta potenza al motore
quanto basta
affinché le ruote ritrovino |
|
BARRA ANTIROLLIO O STABILIZZATRICE
Elemento della sospensione che serve a limitare il rollio (v.).
BARRA DI TORSIONE
Ha sostituito la vecchia molla elicoidale nelle sospensioni, con grandi
vantaggi d'ingombro e di praticità nella messa a punto.
BANDIERA A SCACCHI
Viene sventolata quando il vincitore taglia il traguardo. La
caratteristica forma a scacchi bianco-nera è stata
introdotta nel GP del Principato di Monaco, circuito cittadino
caratterizzato da un fascino unico e mondano, in quanto più
visibile della bandiera a piccoli rombi bianco-rossi del principato.
BECCHEGGIO
Angolazione della carrozzeria in rapporto all'asse laterale.
BORDO DI ATTACO DEL FONDO
Il fondo piatto deportante inizia nella parte anteriore con una
sporgenza laminare (sperone) sottostante il muso della monoposto e da
esso separata. Il bordo d'attacco così configurato ha il
compito di "tagliare") orizzontalmente il flusso aerodinamico
avviandone la parte più ricca sotto il fondo e quella
superiore |
|
C.A.D.
"computer-aided design" programmi che servono per realizzare progetti
sul computer e vuol dire "disegno aiutato dal computer".
CAMBIO
In tutte le monoposto è elettroidraulico (con leve di
comando al volante), sequenziale a 6 o 7 marce. La scatola del cambio
è in magnesio, mentre si va ormai affermando la tecnologia
più progredita della microfusione in titanio che per la
prima volta è stata usata dalla Minardi e seguita quest'anno
dalla Ferrari. Questo tipo di cambio ha pareti sottili che assicura un
notevole risparmio di peso (4-5 kg rispetto al magnesio) e, insieme, un
guadagno di rigidezza del 50%.
CAMPANATURA DELLE RUOTE
E'il numero di gradi, in base ai quali la parte superiore della ruota
può inclinarsi verso l'interno o l'esterno, rispetto al
piano verticale.
CARICO VERTICALE
Rappresenta la somma di tutte le forze a cui è soggetto il
veicolo: il peso della vettura, e le forze dovute all'aerodinamica e
all'inerzia
nella fase di accelerazione o di frenatura.
CONDOTTO DEL FRENO
Componente in fibra di carbonio che dirige aria nel sistema frenante
per aumentare il suo raffreddamento.
CONTROLLO DI TRAZIONE
Sistema elettronico che permette alle ruote della monoposto di non
pattinare al via e ogni qual volta si accelera al massimo.
CRASH TEST
Test che si effettuano prima di disputare il mondiale e servono per
verificare che l'abitacolo sia resistente |
|
DIFFERENZIALE
Sistema disposto tra la scatola del cambio e le ruote motrici che
permette alle due ruote di ruotare a velocità diverse in
curva per evitare
di slittare e perdere aderenza.
DIFFUSORE
Struttura aerodinamica che permette di avere aderenza nel posteriore e
dare più spinta negativa |
|
ECU
Unità di controllo elettronica. Controlla tutti i sistemi
elettronici della macchina e del motore e li trasferisce al box. |
|
FEA
Metodo computerizzato e complesso per determinare lo stress e le forze
a cui i componenti sono sottoposti.
FIA
Federation Internationale de l'Automobile. E' la federazione che si
occupa di organizzare il campionato mondiale di automobilismo. |
|
GALLERIA DEL VENTO
Grande edificio in cui si esamina l'aerodinamica della macchina. L'aria
è accelerata su un modello statico per ricreare la vera
macchina che viaggia attraverso l'aria.
GRIGLIA
Ordine in cui si posizionano i piloti alla partenza, secondo i tempi
fatti segnare nelle prove. Prima dell’introduzione delle
qualifiche, l’ordine di partenza era determinato da
un’estrazione.
GRIP
Indica il grado dell'aderenza delle gomme con l'asfalto. Diminuisce se
le ruote non sono in temperatura ideale. |
|
LECCA LECCA
Il lecca-lecca non è nient’altro che l'asta
utilizzata dal meccanico messo davanti alla monoposto durante i
pit-stop. Deve essere abbassata al momento della fermata della vettura
ai box e alzata velocemente a fine rifornimento |
|
NOMEX
Materiale ignifugo. |
|
PITCH
Viene usato anche per indicare le oscillazioni di un aereo o di una
imbarcazione. Tuttavia il pitch, ovvero il beccheggio, è
sostanzialmente il movimento della carrozzeria della monoposto rispetto
a un asse trasversale. Ha luogo sia in accelerazione che in frenata, ma
provoca due effetti diversi. Ovvero l’abbassamento della coda
e l’innalzamento del muso della monoposto (accelerazione) e
viceversa (frenata). |
|
RESISTENZA AERODINAMICA
Come avviene per tutti i corpi che devono penetrare l'aria, la scocca
della vettura e i suoi componenti la rallentano: questa caratteristica
è nota come resistenza aerodinamica. Questa forza
è proporzionata al quadrato della velocità.
ROLL-BAR
Consiste in un resistente arco metallico che si trova alle spalle del
pilota, in posizione trasversale e sopraelevata, con la funzione di
proteggerlo dagli incidenti in cui la vettura dovesse cappottarsi
mettendo a rischio l’incolumità del pilota.
ROLLIO
Angolazione della carrozzeria del veicolo in rapporto all'asse
longitudinale. Questa angolazione dipende dalla forza centrifuga in
curva, ma anche dal passaggio della ruota sopra ad un ostacolo, oppure
su una strada in pendenza. |
|
SENSORI LAMBDA
Apparecchiature piccole localizzate negli scappamenti misurano il
rapporto dell'aria/benzina.
SHAKEDOWN
Ha differenti significati il temine nello slang americano (da
“estorsione” a “letto di
fortuna”), ma nel pianeta motori vuol dire una cosa sola: il
primo collaudo al quale viene sottoposta una vettura che sia stata
appena assemblata.
SOSPENSIONI ATTIVE
Sospensioni proibite dal lontano '93 perché usufruiscono di
un sofisticato computer che fa adattare le ruote a qualsiasi terreno
rendendo la guida più facile. Spesso sono montate su
autovetture di serie.
SPINTA NEGATIVA O DOWNFORCE
E' una forza verso il basso che aumenta il carico verticale (v.),
spingendo il veicolo al suolo. La spinta negativa dipende dal quadrato
della velocità. La forza esercitata sarà di 3 o 4
superiore al peso della vettura. |
|
TAMPONI IN GOMMA
Elemento in gomma dura montato sugli ammortizzatori. Esso viene
utilizzato per irrigidire le molle dopo un certo spostamento quando la
ruota si sposta verso il basso in relazione alla carrozzeria.
TELEMETRIA
Si tratta di una strumentazione complessa, di estrema importanza per
ogni pilota, che desidera mettere a punto la vettura. Attraverso la
telemetria si può calcolare la velocità in un
determinato punto della pista.
TIRANTE
Parte del motore che connette il pistone all'albero a gomiti.
TRECCE DI BERENICE
In astronomia la “chioma della Berenice”
è una costellazione scoperta nel 1551 e si trova vicino a
quella del Leone, tanto che originariamente era vista come la sua coda.
Per tornare con i piedi per terra, nella Formula 1 le trecce di
Berenice sono i vortici che si generano ai lati degli alettoni
posteriori (a causa dell’umidità
dell’aria) e che appaiono come strisce bianche.
TUBO DI PITOT
Tubicino posizionato sull'avantreno e serve a calcolare la
velocità dell'aria.
ZAVORRA
Si usa se il peso della monoposto è sotto i limiti imposti
dal regolamento e per equilibrare il centro di gravità.
ZONA DI CONTATTO
Area della gomma che sta toccando davvero la superficie della strada.
|
|
|
|
|
 VETTURE A 6 RUOTE VETTURE A 6 RUOTE
|
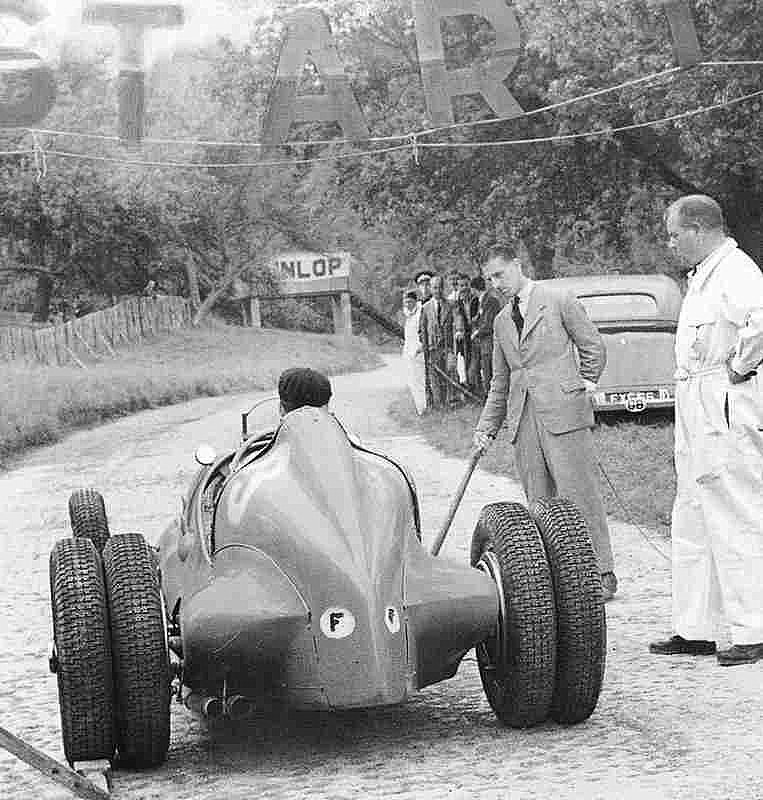
Prescot 1939 Jean-Pierre Wimille Bugatti 59/50 B
Molte sono state le vetture a 6 ruote in Formula 1: sicuramente la più
famosa non può non essere la Tyrrell P34, la prima. Non è stata certo
l’unica visto i tentativi di Lotus, March e Williams con la FW08B, di
cui parleremo più avanti. Tornando alla P34, questa fu un progetto molto
ambizioso e al quanto rivoluzionario, ideato da Derek Gardner.
Presentato ad inizio 1976 (una delle annate più
belle, almeno personalmente, della storia della F1) destando meraviglia
e scetticismo generale. la P34 fu la risposta della Tyrrell ad una
annata, quella 75, molto difficile che la vide conquistare solamente 25
punti a dispetto dei 72,5 della coppia Lauda-Ferrari. La vettura,
teoricamente, doveva essere sensazionale: il muso a “martello” e i 4
piccoli pneumatici anteriori, progettati appositamente in collaborazione
con Goodyear, dovevano ridurre drasticamente la resistenza
all’avanzamento, migliorando l’efficienza aerodinamica della monoposto.
La lunghezza complessiva degli pneumatici anteriori della P34 era
paragonabile a quella di uno pneumatico standard cosa che, sempre
teoricamente, non avrebbe dovuto comportare problemi, garantendo
prestazione di una normale monoposto. 6 ruote.
|
La Tyrrell Project 34 è sicuramente una della
automobili da competizione più famose e riconoscibili in assoluto.
|
Ma
l’unica monoposto a sei ruote ad aver partecipato al Campionato del
Mondo di Formula Uno non è il solo tentativo di sfruttare due ruote in
più delle canoniche quattro nel mondo delle competizioni
automobilistiche.
|
 |
 |
|
La P34 fa il suo debutto ufficiale alla quarta gara
dell’anno, sul circuito spagnolo di Jarama, Madrid. Depailler ottenne il
terzo posto in qualifica, ritirandosi poi in gara per un incidente.
Anche il compagno di team, Jody Scheckter, vide concludere la sua gara
anticipatamente, a causa di un problema al motore. La gara successiva,
sul circuito belga di Spa, segnò il primo risultato importante per la
nuova vettura: il 4° posto di Scheckter (anche se a oltre 1’30″ dal
vincitore, Niki Lauda).La prima soddisfazione di una monoposto che a
quel punto sembrava davvero poter puntare al podio. Infatti nella gara
successiva di Monaco, la coppia Scheckter-Depailler ottiene il secondo e
il terzo posto, con il sudafricano a soli 10 secondi dal vincitore,
guarda caso sempre Lauda .Ancor meglio in Svezia: la musica cambia. Pole di Scheckter al sabato e
doppietta la domenica! La stagione fu coronata da altri podi e
piazzamenti. Complessivamente, la P34 fu una buona vettura, soprautto
nelle mani di Scheckter, anche se non al livello di Ferrari e McLaren
che si diedero battaglia fino all’ultima gara del campionato.Il
progetto, però, fu abbandonato l’anno successivo: Goodyear cominciò a
disinteressarsi e bloccò lo sviluppo delle piccole coperture anteriori.
Fu un grosso problema perché proprio le stesse coperture iniziarono a
patire un grosso surriscaldamento. Fu questo uno dei motivi che spinsero
il deluso
Gardner a lasciare il team. Per risolvere il problema del
surriscaldamento il nuovo progettista, Maurice Philippe, fu costretto ad
allargare le carreggiate
e far quindi fuoriuscire le piccole ruote
dalla carenatura, vanificando di conseguenza lo scopo iniziale del
progetto che fu definitivamente abbandonato.
|
March 2-4-0 Silverstone Classic 2012

|
Visti gli iniziali successi della Tyrrell P34, March Engeneering
realizzò nel tardo 1976 la March 2-4-0,
una versione modificata della
March 761 con quattro ruote motrici posteriori aventi le stesse
dimensioni di quelle anteriori.
Purtroppo la casa stava attraversando un difficile periodo
economico e abbandonò il progetto anche se i collaudatori, una volta
provato
il prototipo parlarono di una “trazione posteriore incredibile”.
Il concetto delle 6 ruote fu ripreso anche dalla Lotus (con la 56B).
|
Anche la Scuderia Ferrari diede il suo effimero apporto al filone
delle monoposto a sei ruote: nel 1977 sperimentò una versione della
312T2 (312T6) con ruote posteriori gemellate, delle stesse dimensioni
delle anteriori.
Lo scopo del progettista Mauro Forghieri era, anche in questo caso,
quello di ridurre il freno aerodinamico generato dalle enormi coperture
posteriori standard, ma probabilmente anche quello di evitare la
notevole deformazione cui questi pneumatici erano soggetti in
curva. Niki Lauda e Carlos Reutemann collaudarono la monoposto sui
circuiti di Fiorano e Nardò.
L’austriaco si disse favorevole, mentre l’argentino bocciò la vettura
dopo aver avuto un incidente e successivamente una rottura della
sospensione.
Lo sviluppo fu fermato ad uno stadio in cui la monoposto superava la
larghezza massima consentita dal regolamento della Formula Uno.
|
  |
|
Lauda prova la Ferrari a sei ruote

|
| Forghieri non fu tuttavia il primo a pensare alle ruote gemellate. Già
prima della Seconda Guerra Mondiale alcuni costruttori avevano pensato a
questa soluzione per permettere ai loro bolidi di mettere a terra tutta
la potenza possibile, sui terreni più difficili, attraverso la limitata
impronta a terra degli pneumatici dell’epoca. |
Le gomme posteriori non erano posizionate una dietro
l’altra, bensì erano affiancate! La vettura, però, non scese mai in
pista a livello
ufficiale in quanto bocciata, ma solo per qualche test,
visto anche il brutto incidente occorso a Reutmann a Fiorano durante
il
collaudo della vettura. La leggenda narra (perché non si hanno fonti
certissime) che la Ferrari stesse testando anche la 312 T8,
una vettura
con 8 ruote: 4 all’anteriore e 4 al posteriore, ma come abbiamo detto
sembrerebbe più fantascienza che realtà anche
se ci sono alcune foto
(non del tutto attendibili).
|

|
Altra vettura a sei ruote è la FW08B, forse una delle vetture più
innovative della storia della Formula 1. Anche se fu solamente un
prototipo (in qunato bandita dalla FIA), la Williams FW08B del 1982 si
dimostrò subito velocissima nei test. Il progetto di Adrian Newey e
Patrick Head presenta un punto di partenza, ma allo stesso tempo di
arrivo visto l’esasperazione aerodinamica, ovvero dell’effetto suolo, a
cui puntava la vettura. Vettura intelligente perché dilatava l’impronta a
terra delle ruote motrici, 4, posizionate al posteriore, quindi
differenti dalla Tyrrell P34, che le presentava all’anteriore. Inoltre
le misure degli pneumatici erano diverse: se sulla P34 erano piccoli e
creati appositamente, sulla FW08B erano standard, come le ruote
anteriori. Con l’introduzione delle due gomme aggiuntive al posteriore,
questa vettura si presentava 25cm più lunga rispetto alla sua versione
“standard”, ovvero quella che parteciperà al campionato. Il progetto
puntava molto sull’effetto suolo: l’aumento della deportanza dovuta alla
sua configurazione fa si che la tecnologia a 6 ruote venga
immediatamente bandita dal regolamento. Questo perché i flussi
canalizzati nella parte inferiore della monoposto, trovano una
conformazione del fondo nettamente più efficace: la maggior lunghezza
della parte terminale, dovuta sia alla trasmissione “allungata” e alla
presenza delle due ruote aggiuntive, è convertita ad estensione dei
condotti. Conseguentemente l’aera di depressione diventa maggiore e
viene massimizzato il carico.
Da ciò ne deriva un’aderenza
impressionante che aiuterebbe la vettura ad avere una maggior velocità
in curva.
Troppo rischiose? Troppo costose? Sta di fatto che la Federazione, con
il progetto FW08B, impone l’obbligo di adottare solo vetture a 4 ruote,
facendo irrimediabilmente svanire ogni tentativo di sviluppo delle
vetture a sei (o più) ruote. |
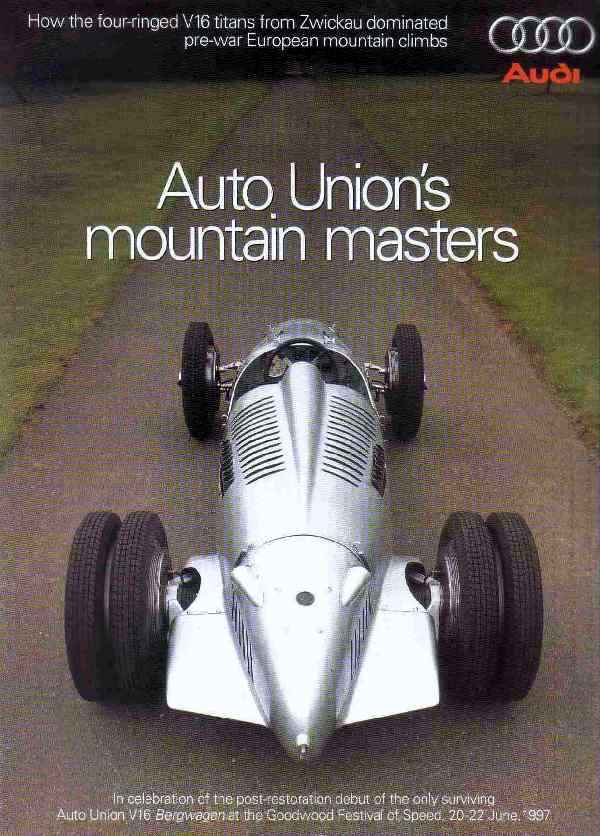 http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html
 http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html
Il posteriore e il vano motore della Auto Union Type C
|

|
 |
| L'Auto Union Type C del 1936 (V16 6 litri con compressore volumetrico da
oltre 500 cv) che poteva essere equipaggiata con ruote gemellate per
limitare il sovrasterzo nelle curve lente delle gare in salita. |
Un’altra variante al concetto della monoposto a sei ruote è l’utilizzo
di quattro ruote motrici posteriori su due assi. In questo caso lo scopo
è l’incremento di trazione rispetto alle due ruote motrici con
conseguente miglior sfruttamento della potenza del motore. Il primo
esempio in questo senso è la Kurtis Kraft-Offenhauser 500G “Pat Clancy
Special” che prese parte alla 500 Miglia di Indianapolis nel 1948 e
1949. |
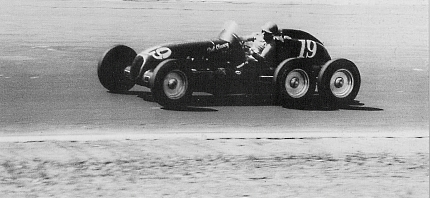 |
 |
A Indyanapolis nel 1948 la Kurtis Kraft esordi' con 6 ruote su 3 assi,
di cui 2 al posteriore |
Soluzione questa ripresa anche dall'Alfa Romeo
per uno studio sulla sua 33 |
|
|
|
|

Le squadre di F1, per guadagnare millesimi di
secondo, utilizzano computers, porticolari controlli, banchi di prova
per simulare in fabbrica le prestazioni in pista. I test possono
ridurre la frenata, la reazione della macchina in curva, nonche i
sobbalzi su ogni tipo di pista.
POSTAZIONE DI CONTROLLO IDRAULICO
AVANTRENO
Le ruote vengono appoggiate sulle postazioni idrauliche. Appositi
sensori posti vicino al musetto rilevano le frenate e l'aerodinamica.
RETROTRENO
Due postazioni idrauliche, collegate sui lati del motore, simulano le
vibrazioni l'accellerazione e le forze aerodinamiche. |
|
PNEUMATICI
La riduzione della pressione dell'aria aumenta notevolmente l'aderenza.
ALETTONE ANTERIORE
Genera una spinta verso il basso per migliorare la traiettoria in curva. |
|
LA CELLULA DI SOPRAVVIVENZA
Il pilota siede in un guscio di sicurezza realizzato in fibra di
carbonio.
Gli alettoni anteriori sono stati alzati di 50 cm per ridurre la
velocità in curva. Struttura per assorbire gli urti.
Pannelli per gli impatti laterali. Spazio libero 70mm sopra la testa.
Se il pilota riporta una lesione alla spalla, può essere
estratto dell'abitacolo, rimuovendo solo due viti. Cinture di sicurezza
a sei punti. Estintore. Il serbatoio è in Kevlar flessibile
antiperforazione. |
|
| PIT STOP - IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' |
|
Ogni scuderia e ogni pilota cerca di guadagnare
frazioni di secondo durante il pit-stop, che spesso si traducono in
vantaggi significativi in pista.
Gli ufficiali di gara garantiscono che non vengono superati i limiti di
velocità
Chi viola il limite viene punito con 10 secondi di attesa ai box. In
termini reali si possono perdere più di 25 secondi, per
l'ingresso e l'uscita dai box. |
|
Al Gran Premio di Spagna, dopo un assenza di sette
anni torna il controllo elettronico della trazione attraverso la
gestione totale del motore: il pilota accellera ed il computer
stabilisce come dosare il gas in base al numero dei giri e al
pattinamento delle ruote. In questo modo è più
facile uscire dalla curva e utilizzare tutta la potenza dei motori.
1 - SENSORI DELLE RUOTE
Rilevano la velocità di rotazione delle quattroruote.
2 - COMPUTER DI BORDO
Confronta la velocità delle ruote. |
|
Il casco è fonte inesauribile di
ricerche che investono la parte aereodinamica, quella legata all'uso
dei materiali e ovviamente all'aspetto delle comunicazioni.
A fronte di una grande resistenza strutturale agli urti, un moderno
casco di Formula 1 pesa soltanto 1,300 grammi. |
|
PNEUMATICO FORMULA 1
Garantisce la massima aderenza (grip) a temperatura definita
(90°-100°c) su certi tipi di superficie. (Meno
è liscia meglio è).
PILOTARE AL LIMITE
Il cerchio della trazione è il punto in cui si ha la massima
aderenza. L'abilità del pilota sta nel trasformare frenata,
curva e accellerazione in un unica manovra al limite della
capacità del pneumatico. |
|
|
| Le regole d'oro per guidare in sicurezza |
|
|
|
Mai le braccia troppo distese
Altrimenti in curva saremmo costretti a sollevare le spalle dal sedile e
quindi assumeremmo una posizione scorretta, scomoda ma soprattutto vi sarà una
diminuzione della sensibilità di guida.
|
|
Occhio al poggiatesta!
Il poggiatesta se non regolato in maniera corretta può provocare gravi
lesioni in caso di urto, pertanto regolatelo sempre portandolo qualche
centimetro sopra il capo, 2-3 cm almeno.
|
Cintura di sicurezza sempre e comunque!
Nudo, è così che mi sento quando non indosso la cintura. Anche voi dovreste
cominciare a provare questa sensazione. Una volta abituati non la sentirete più.
Senza la cintura si rischia grosso ed indossarla non costa nulla pertanto
usatela... inoltre è obbligatorio!
|
Sulla neve frenare il meno possibile
Poiché essendo già scarsa l'aderenza "chiederne" dell'altra ai pneumatici
significherebbe portarli al bloccaggio. Cercate quindi di percorrere le discese
in seconda marcia e sterzate in maniera più graduale possibile. Usate il freno
motore, ma occhio alle scalate troppo repentine! Se invece la vostra auto è
dotata di pneumatici invernali allora potrete usare il freno con un po' più di decisione.
|
In autostrada meglio andar piano o...
mantenere una velocità adeguata alle condizioni del traffico? Spesso guidare
troppo piano in autostrada può provocare incidenti allo stesso modo di quanto
non avvenga a velocità sostenute. Se il traffico è scorrevole meglio tenere
un'andatura sostenuta (sempre entro il limiti) anziché tenere la destra a 60-70
km/h! Perché così facendo costringeremmo TUTTI gli altri guidatori a sorpassarci
(magari anche i camion), ed è proprio nel momento del sorpasso che avvengono il
maggior numero degli incidenti. Per chi viaggia in autostrade a tre corsie si
ricordi che la corsia di destra NON è riservata ai camion e ma solo a chi
viaggia più lentamente! Pertanto se non ve la sentite di andare oltre un certo
limite allora mettetevi sulla destra anziché occupare la corsia centrale!
|
Mi imbatto in un aquaplaning, che fare?
A questo punto il pedale del freno si trasforma da nostro migliore amico nel
nostro peggiore nemico. Frenare non serve a nulla (stiamo galleggiando...anche
se a forte velocità lo stiamo facendo) ma non appena riprenderemo aderenza se
stessimo frenando l'auto scarterebbe improvvisamente facendoci perdere del tutto
il controllo. Pertanto impugnando fermamente, ma senza eccedere, il volante
dobbiamo prepararci al "riacquisto d'aderenza" mantenendo la direzione del
manubrio e gas costante per tutta la durata del fenomeno
A questo punto il pedale del freno si trasforma da nostro migliore amico nel
nostro peggiore nemico. Frenare non solo non serve a nulla (stiamo
galleggiando... anche se a forte velocità lo stiamo facendo) ma si rivelerebbe
molto dannoso con alta probabilità di perdere del tutto il controllo del mezzo.
Pertanto impugnando fermamente, ma senza eccedere, il volante dobbiamo
prepararci al "riacquisto d'aderenza" mantenendo direzione e gas costante per
tutta la durata del fenomeno (ricordate la posizione delle mani alle 9,15? Ecco... non limitatevi a ricordarla!).
|
Due è sempre meglio di una!
Sempre le mani sul volante questa è la prima regola che ci viene insegnata ma
spesso è la prima che si ci dimentica. La mano fissa sul cambio è da evitare
sempre!
|
Entro in curva e l'auto sbanda
In caso di sovrasterzo è bene evitare di frenare altrimenti si
"scaricherebbe" l'asse posteriore che così perderebbe ulteriore aderenza,
accentuando al massimo la sbandata. Poi c'è il caso del sovrasterzo di potenza.
Cosa bisogna fare in questa situazione? Ricordare, intanto, che per controllare
una qualsiasi situazione d'emergenza bisogna eliminare la causa che l'ha
generata. Nel caso del sovrasterzo di potenza (quello generato da eccessiva
accelerazione su auto a trazione posteriore) dovete quindi rilasciare
l'acceleratore ma non in maniera troppo brusca. Evitate inoltre di frenare
altrimenti si "scaricherebbe" l'asse posteriore che perderebbe così ulteriore
aderenza, accentuando al massimo la sbandata.
Ricordate di mantenere ben saldo
il volante e di effettuare un veloce controsterzo.
|
| E se incappo in un sottosterzo? |
|
|
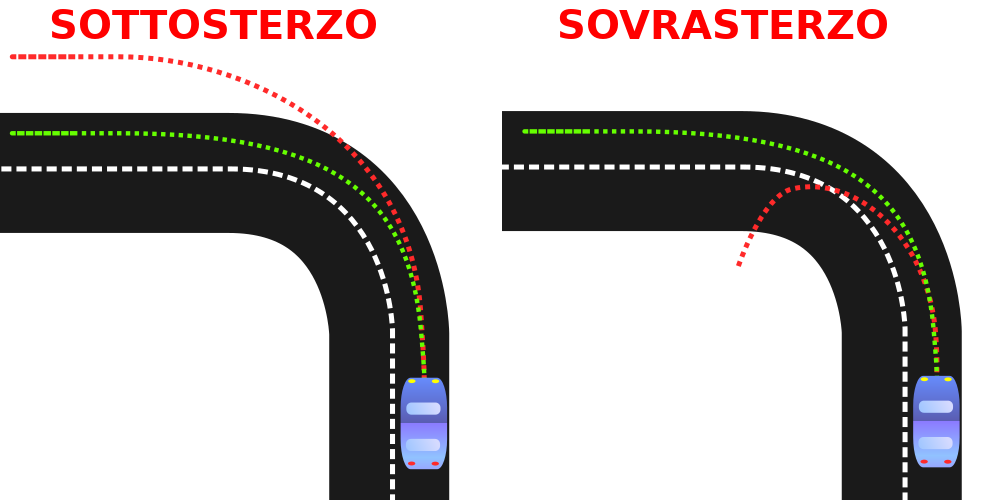
Sottosterzo:
cosa si tratta e come agire in caso di emergenza
Con il termine sottosterzo in particolare si intende
lo sbandamento dell’asse anteriore del veicolo rispetto a quello
posteriore. Più concretamente, nel caso del sottosterzo l’automobile
avrà una maggior rischio di procedere diritto e di prendere la curva
esternamente.
In queste situazioni, l’auto una volta giunta alla curva tenderà ad
allargare la traiettoria con un verso opposto a quello che noi stiamo
dando: se stiamo percorrendo una curva che va verso destra, in caso di
sottosterzo la traiettoria del veicolo si dirigerà verso sinistra.
Per poter agire è necessario per prima cosa mantenere calma e freddezza,
evitando di poter peggiorare la situazione. Successivamente, sarà
necessario alzare il piede dal pedale dell’acceleratore e facendo ciò si
restituisce carico alle ruote anteriore in modo tale che queste possano
recuperare l’aderenza necessaria per poter mantenere la giusta
traiettoria.
Nonostante ciò è bene sapere che un eccessivo recupero da parte delle
ruote anteriore può talvolta innescare il meccanismo opposto del
sovrasterzo.
Situazione diversa, ma non per questo poco comune, è quando stiamo
viaggiando su una strada bagnata e sdrucciolevole con bassa e scarsa
aderenza. In questo caso sarà sufficiente girare lo sterzo nella
direzione che sta prendendo l’auto in corso di sbandamento, per poter
recuperare l’aderenza delle ruote anteriori.
|
|
Sovrasterzo:
cause e strategie di correzione del fenomeno
Con il termine sovrasterzo si intende ovviamente la
condizione opposta, ossia quella secondo la quale l’auto mostra uno
sbandamento (o deriva) dell’asse posteriore rispetto a quello anteriore.
In questo modo l’auto tende ad accentuare la traiettoria della curva
che il conducente ha stabilito ed è come se il veicolo tendesse a
curvare di più, andando a stringere troppo la curva.
Nei casi in cui abbiamo sia il fenomeno del sovrasterzo appena
descritto che la perdita di aderenza delle ruote posteriori, si
verificherà quello che da molti viene definito come testacoda.
Nonostante il rischio che si incorre ogni volta che si presenta questo genere di problema, è possibile comunque correggere il fenomeno del sovrasterzo con un’azione nota come controsterzo.
Per fare ciò sarà sufficiente girare lo sterzo in direzione opposta a
quella della curva, regolando la velocità del veicolo in base al tipo
di trazione che esso monta (con un veicolo a trazione anteriore sarà
necessario accelerare, mentre nel caso della trazione posteriore dovremo
andare a sollevare il piede dall’acceleratore diminuendo la velocità).
|
|
|
Piove? Lontani dal ciglio della strada..
ma non troppo!
In caso di forti piogge i canali di scolo non fanno in tempo a
smaltire tutta l'acqua provocando un allagamento, spesso solo parziale, della
carreggiata. Siccome tali canali si trovano di norma vicini al bordo della
strada, è qui che si ha maggiore probabilità di incappare in un aquaplaning!
|
In autostrada meglio una vista "lunga"
Concentrare la nostra vista solo sull'auto che ci precede è sbagliato poiché
la distrazione del conducente che ci sta davanti potrebbe essere fatale anche
per noi. Difatti se il conducente dovesse frenare di colpo noi reagiremmo solo
all'accendersi dei suoi stop e quindi già in ritardo. Mentre se noi avessimo
visto prima di lui l'ostacolo, perché maggiormente attenti, saremmo in grado di
reagire in un tempo di certo minore scongiurando al massimo una quasi certa
collisione. Questo consiglio vale anche nella guida di tutti giorni, ma
ovviamente commisurato alle condizioni del traffico.
|
Non funzionano i freni... aiutoo!
E' una situazione abbastanza inusuale con le auto di oggi ma non si sa mai!
Se il calo di efficienza dell'impianto è dovuto al surriscaldamento (fenomeno
conosciuto come fading) meglio aiutarci con le marce e "pompare" con il pedale
cercando di togliere le eventuali bolle formatesi. Se i freni non dovessero
funzionare del tutto cercare di scalare le marce frenando con il freno motore e
nel peggiore dei casi buttarsi da un lato cercando di arrestare la vettura
mandandola in testa coda, aiutandosi con il freno di emergenza (freno a mano).
Un ultimo consiglio, gli attuali circuiti frenanti, poiché servoassistiti, non
funzionano a motore spento quindi che non vi venga in mente di scendere da una
discesa a motore spento!!
|
|
Conoscere le reazioni del veicolo spinto al limite
della tenuta si differenziano nettamente da quelle del normale
utilizzo, in genere si manifestano per la prima volta in caso di
emergenza, cogliendo impreparato il conducente.
Le tecniche di guida insegnano a individuare, a percepire e a
fronteggiare le perdite di aderenza anche nella guida di tutti i
giorni.
Individuare e interpretare i segnali che l'auto trasmette mentre guidi,
è l'unico modo per imparare a dominare correttamente le
reazioni dinamiche del veicolo.
In Italia ci sono scuole di pilotaggio che si avvalgono di piloti -
istruttori professionisti che organizzano corsi di guida sicura e sportiva per mettere gli
allievi nelle migliori condizioni di affinare e sviluppare la conoscenza delle
tecniche necessarie per la totale padronanza della propria vettura.
|
|
|
|
|
Questo è un sito-blog personale non a scopo di lucro.
Si propone di rivivere alcuni frammenti storici della F1:
quella dove la guida delle monoposto apparteneva ai
piloti,
su piste che oggi giudicheremmo assurde, circuiti disegnati
dal computer piuttosto che dal cuore.
Riproduzione Vietata
|
|
|
 |

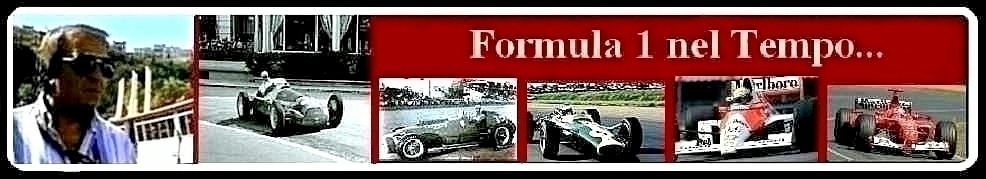




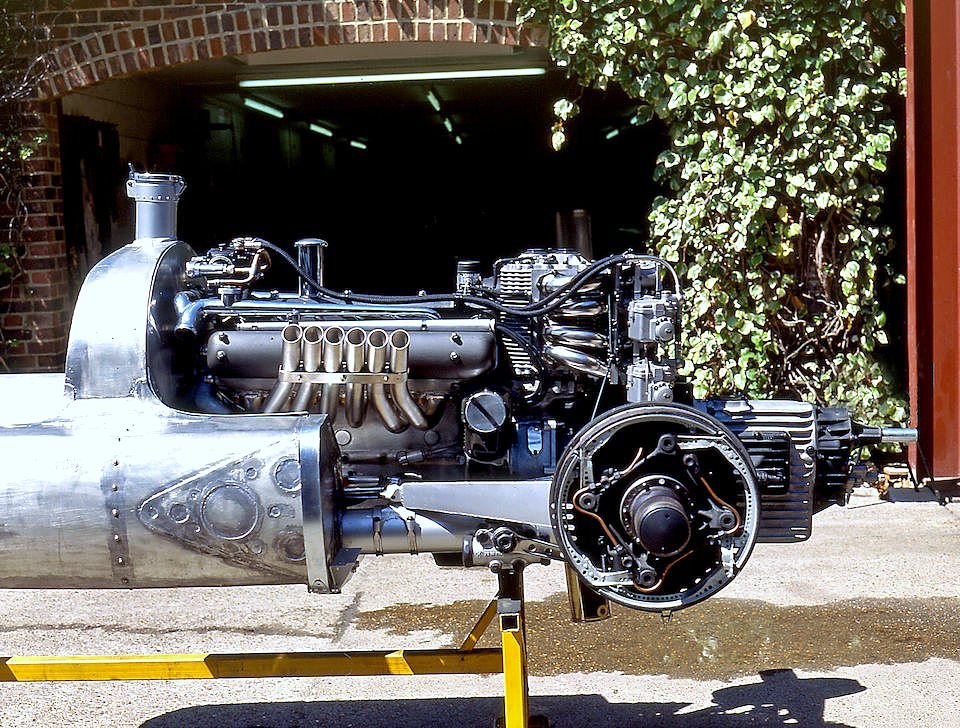

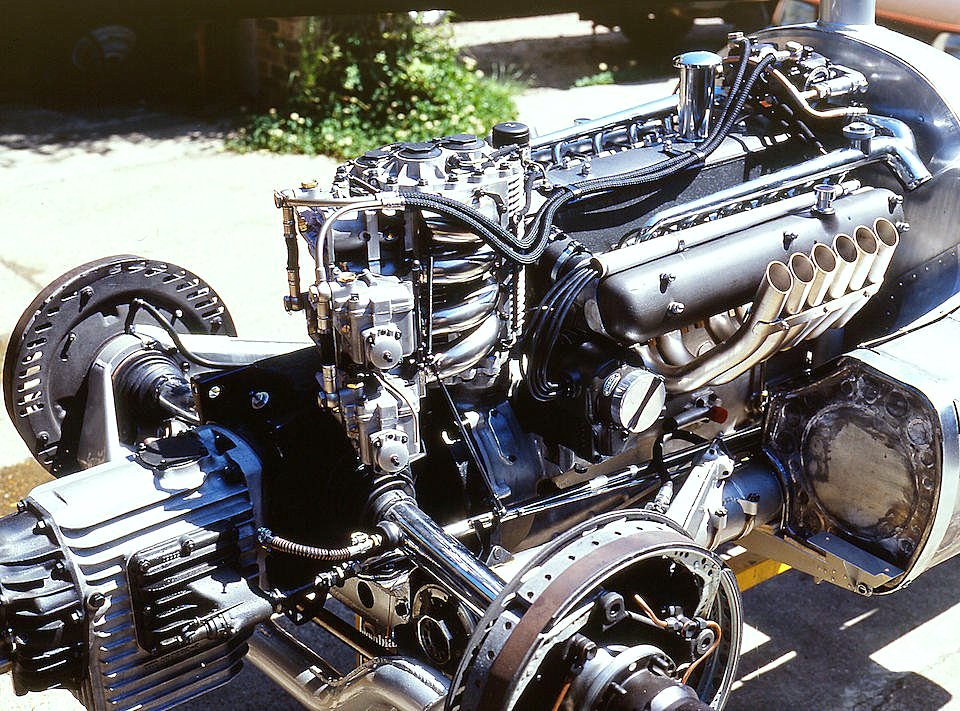




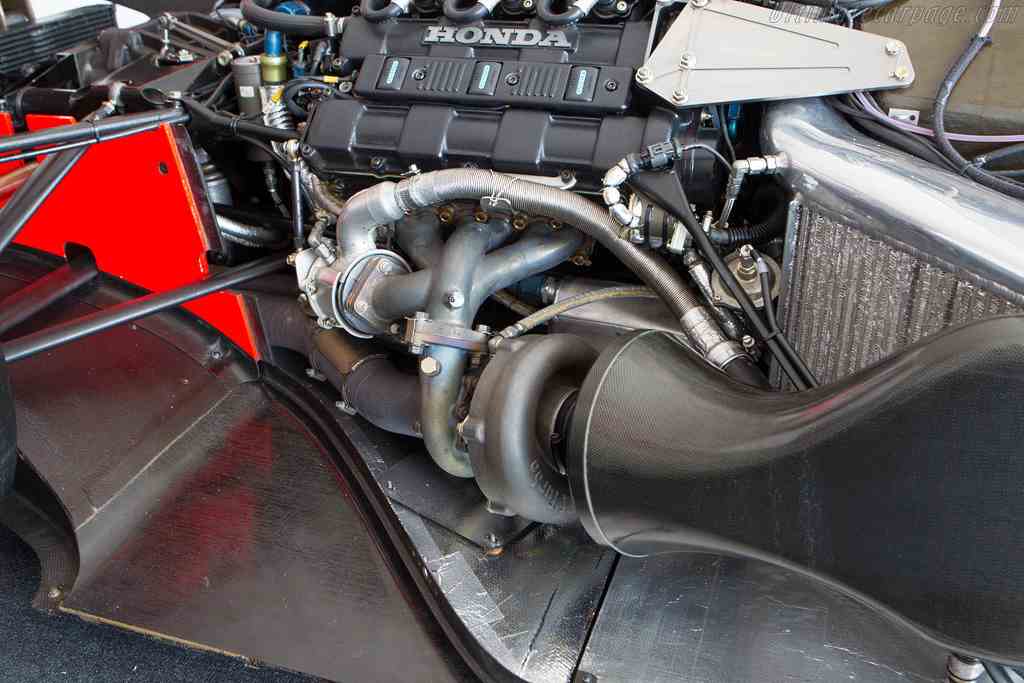
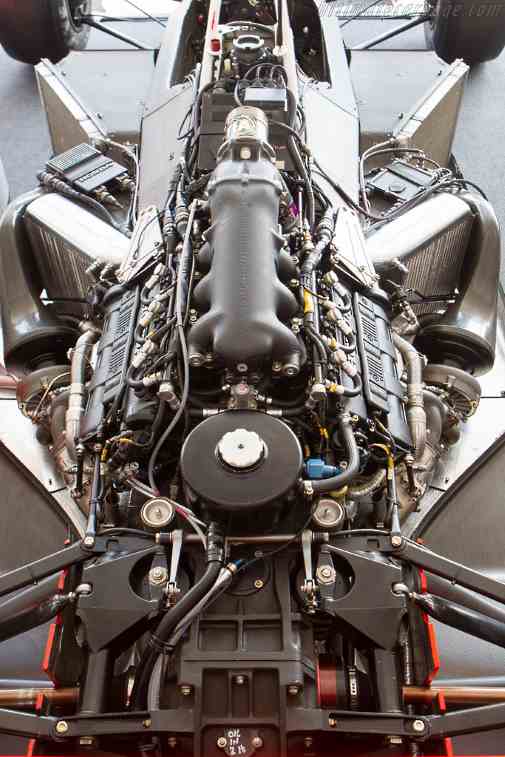
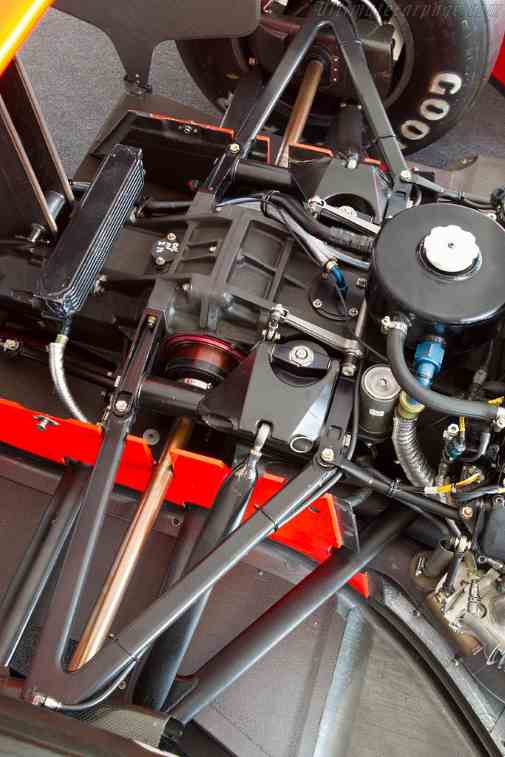
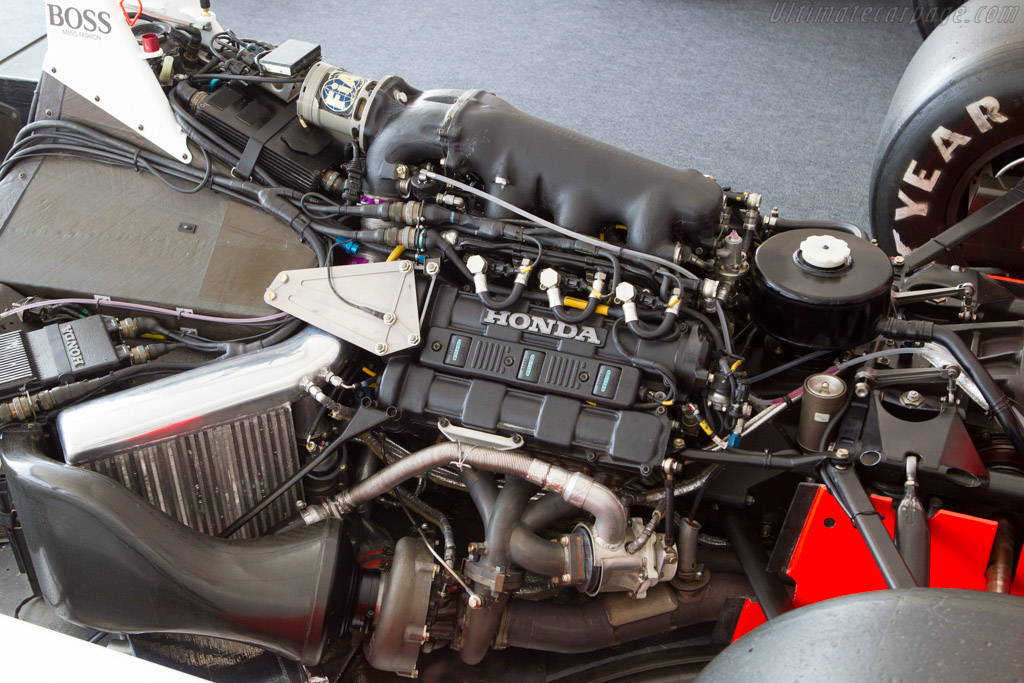




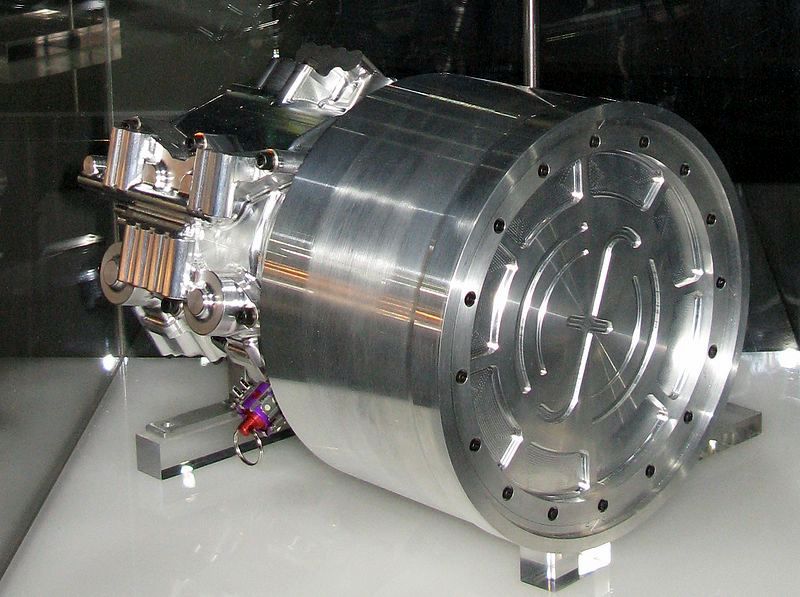
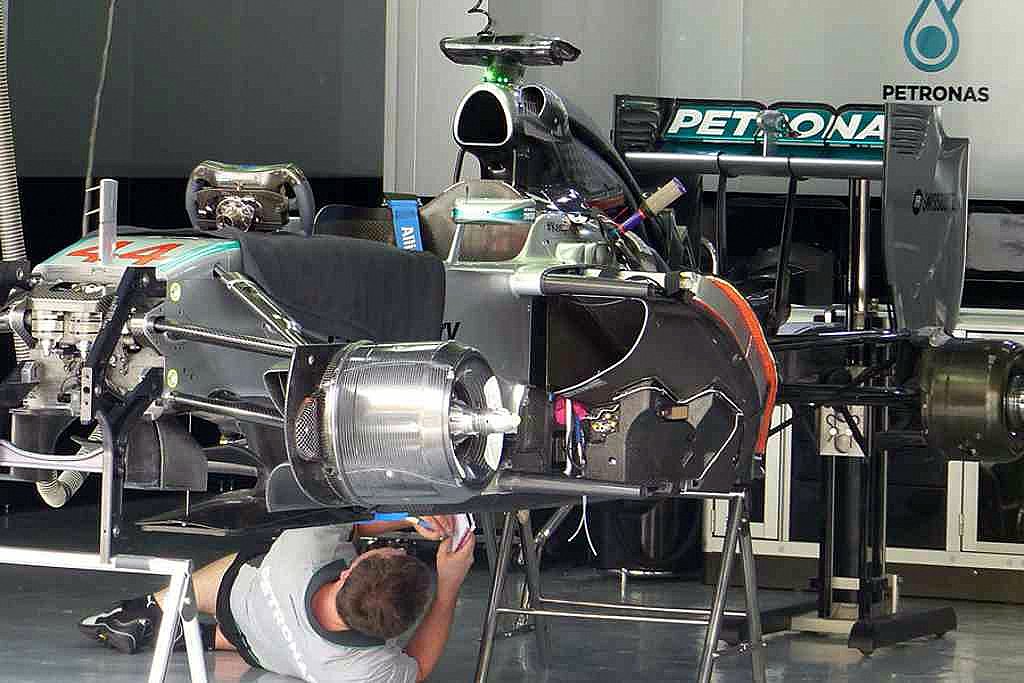

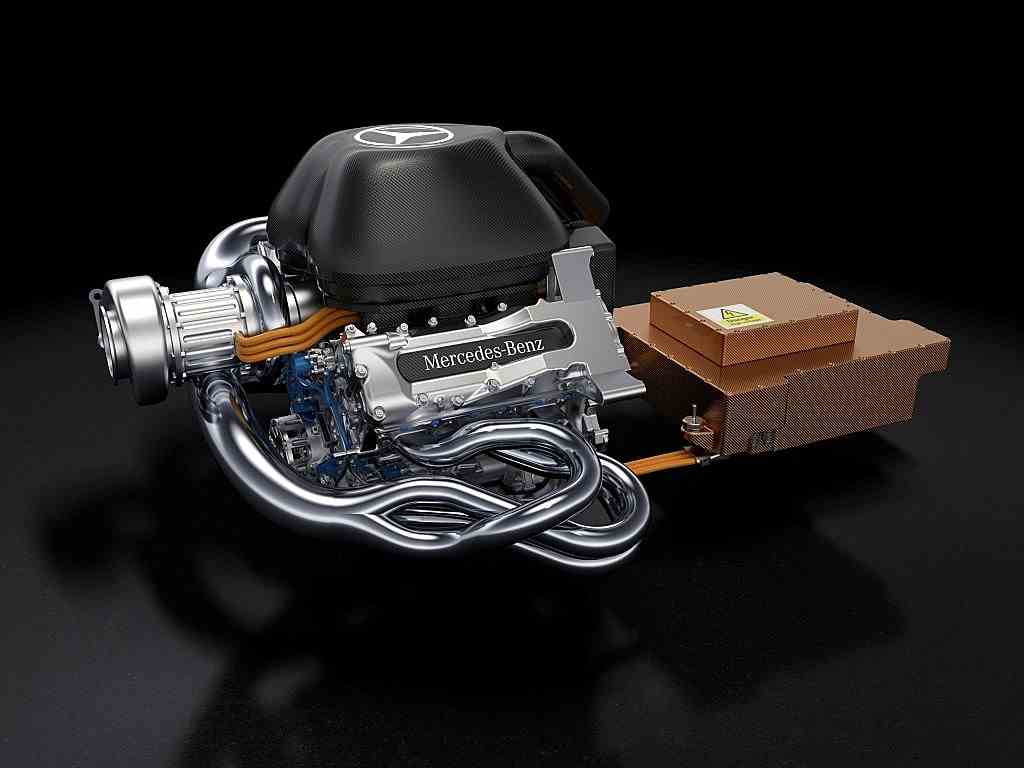










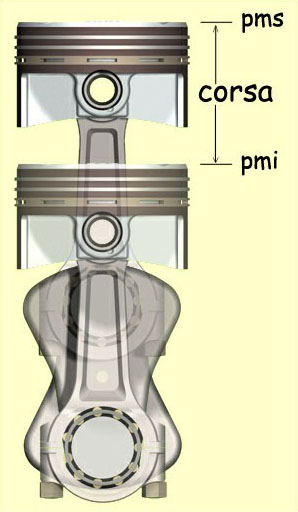 E'
necessario dare qualche nome alle dimensioni caratteristiche di un
motore.
E'
necessario dare qualche nome alle dimensioni caratteristiche di un
motore.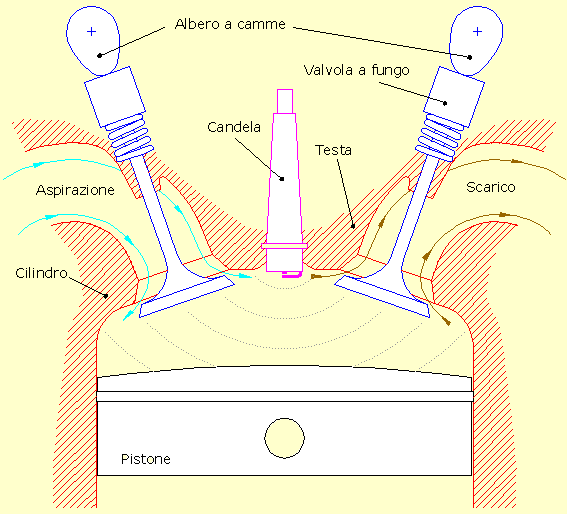
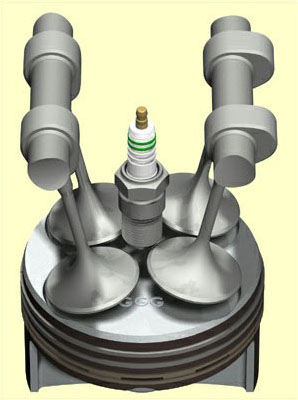
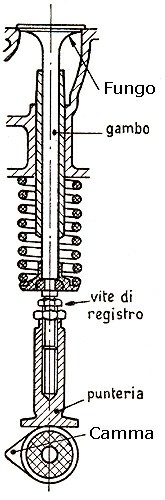

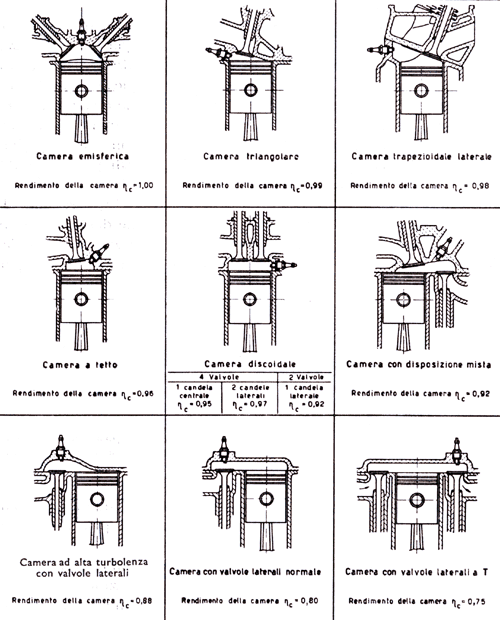
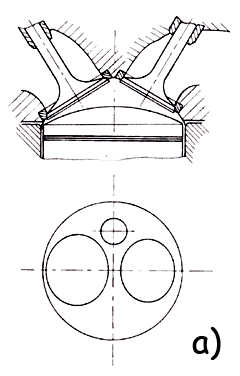
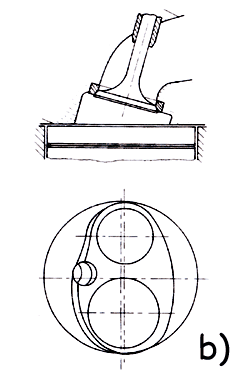
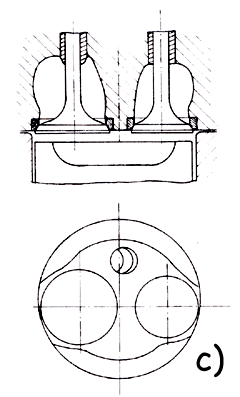
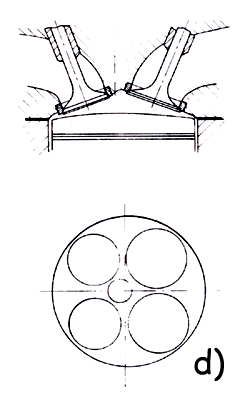

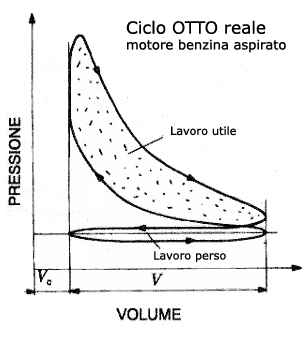






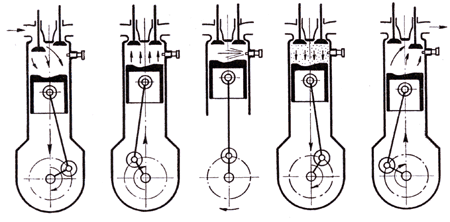
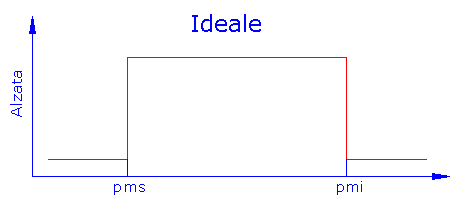
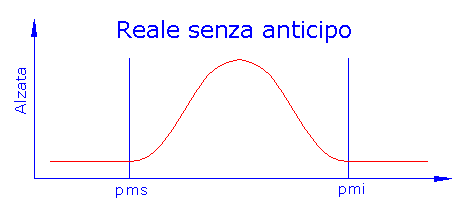
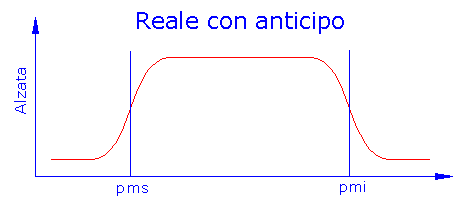
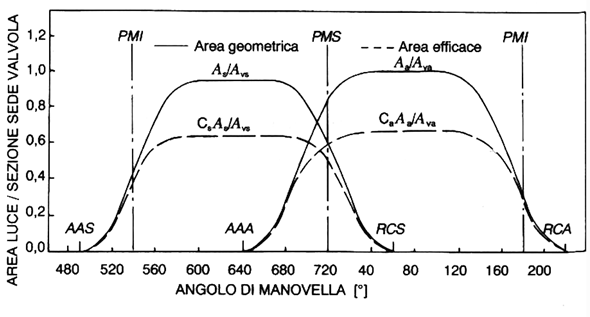
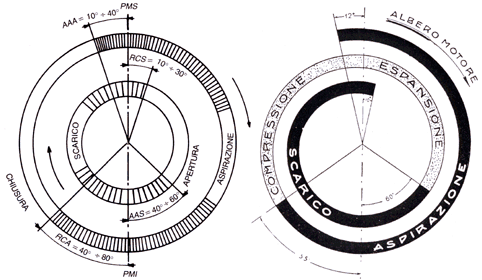
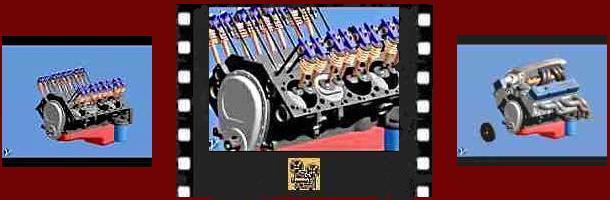
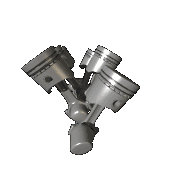
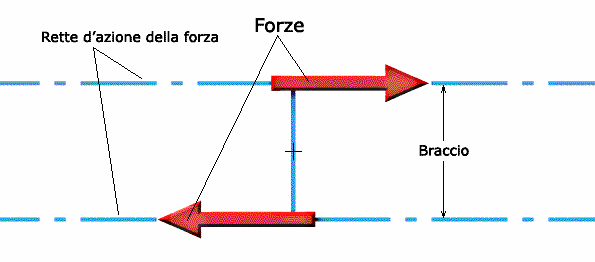
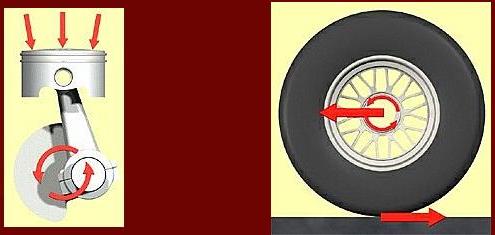

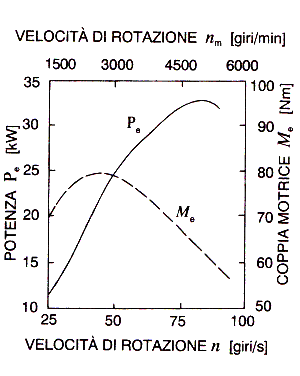
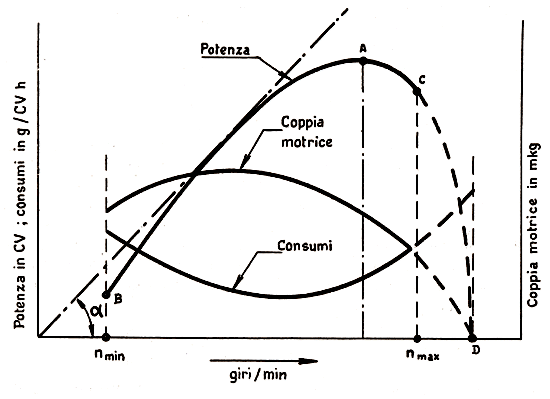
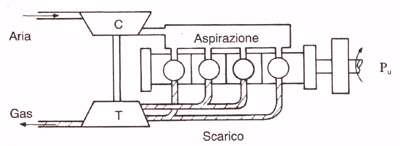 Il
turbo-compressore è un marchingegno che recupera l'energia dai gas
combusti espulsi dal motore per poi riutilizzarla per comprimere
la miscela in ingresso e poterla così sparare dentro il cilindro.
E' costituito da una turbina ed un compressore montati sullo stesso
albero che li fanno ruotare alla stessa velocità.
Il
turbo-compressore è un marchingegno che recupera l'energia dai gas
combusti espulsi dal motore per poi riutilizzarla per comprimere
la miscela in ingresso e poterla così sparare dentro il cilindro.
E' costituito da una turbina ed un compressore montati sullo stesso
albero che li fanno ruotare alla stessa velocità.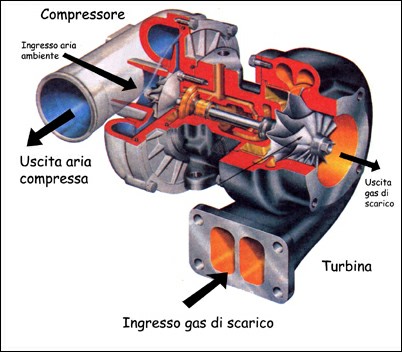
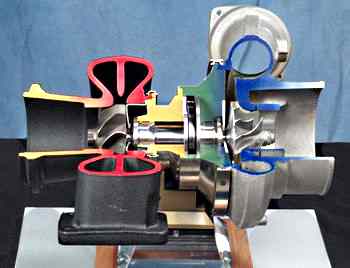

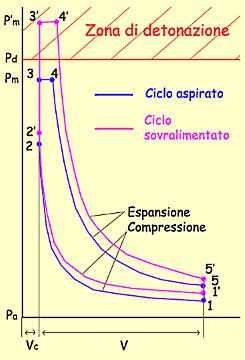
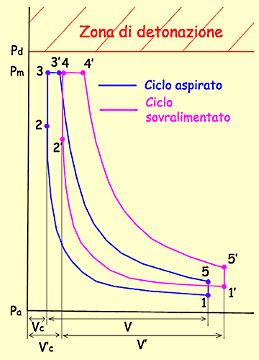





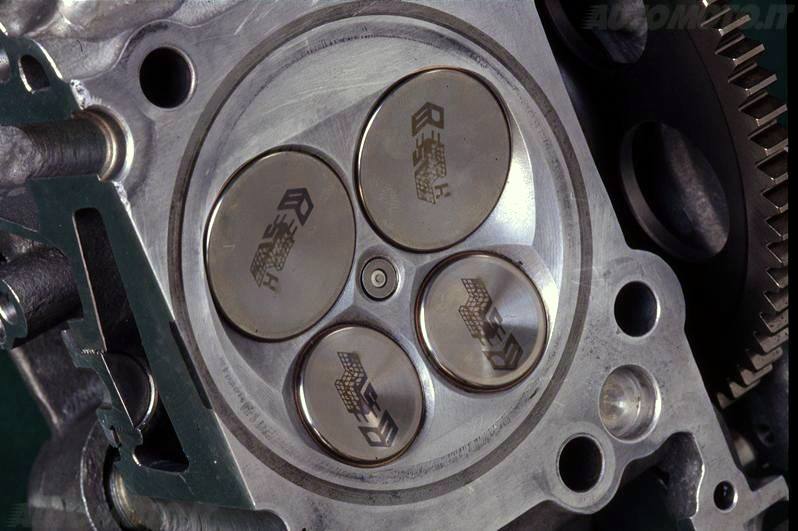

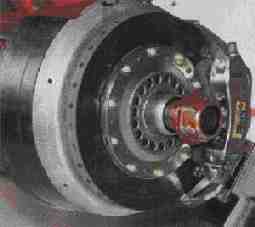


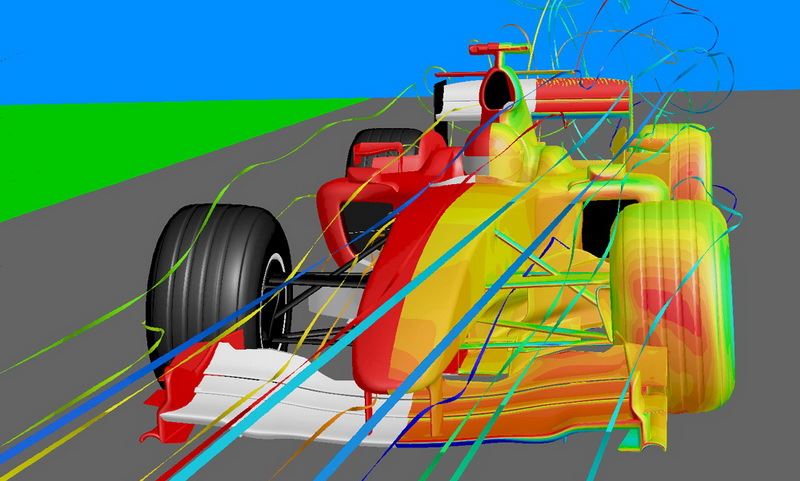

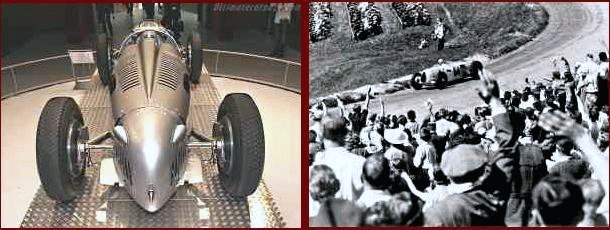







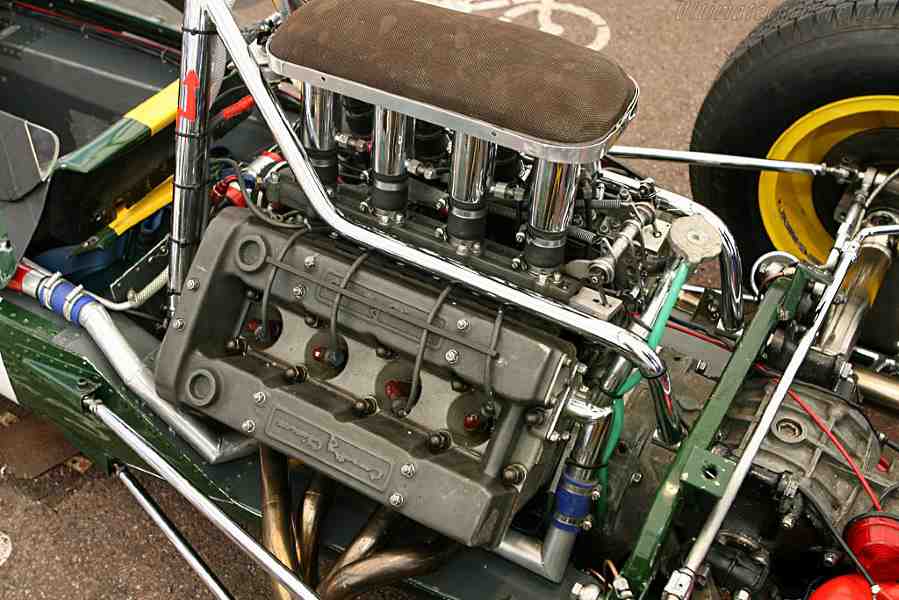



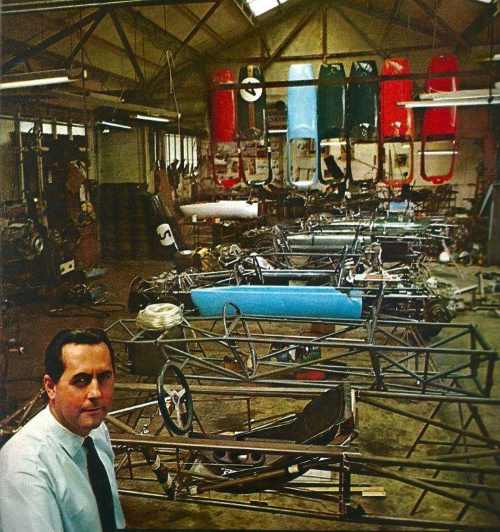


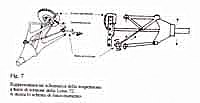
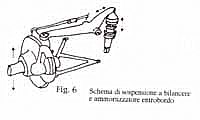
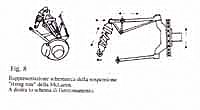
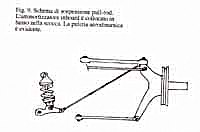
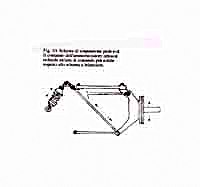
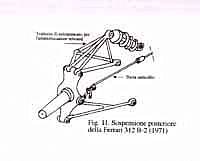


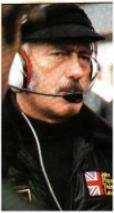


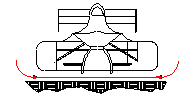
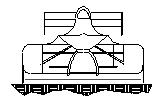
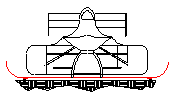
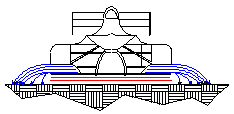
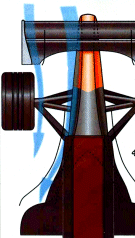



 aria dal fondo vettura, abbassandone la pressione. Un effetto
suolo forzato! La squadra sostenne che il ventilatore
serviva a raffreddare il motore, ma a fine gara l'irregolarità
divenne palese e scattò la squalifica.
aria dal fondo vettura, abbassandone la pressione. Un effetto
suolo forzato! La squadra sostenne che il ventilatore
serviva a raffreddare il motore, ma a fine gara l'irregolarità
divenne palese e scattò la squalifica.




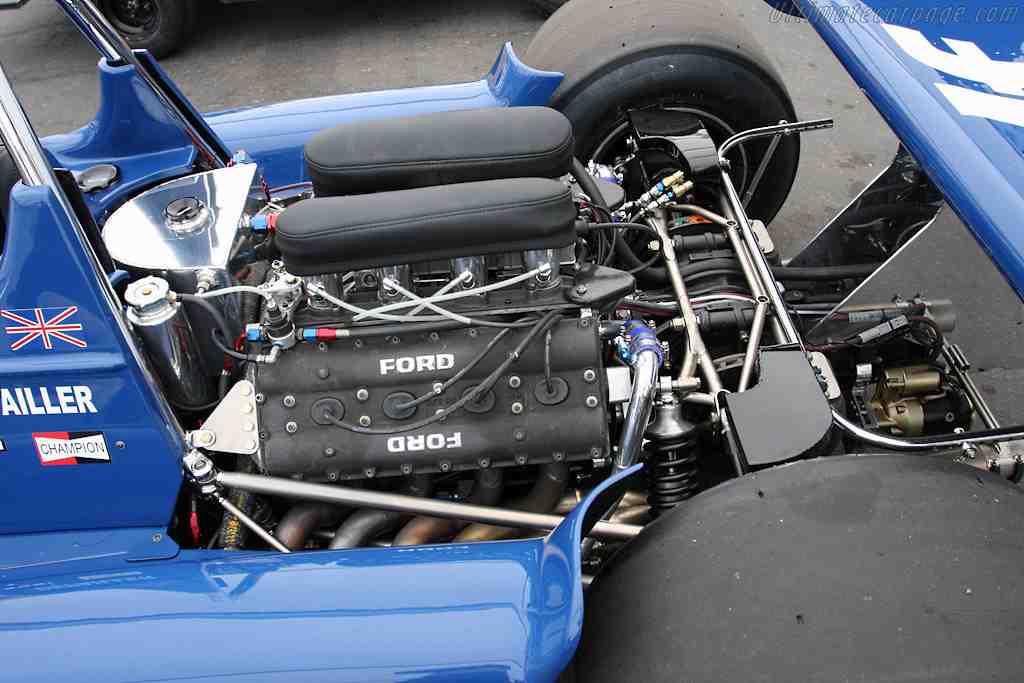



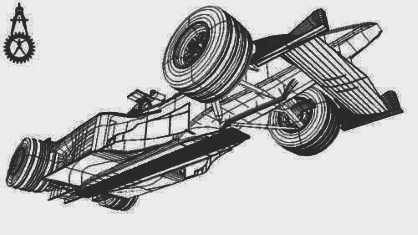
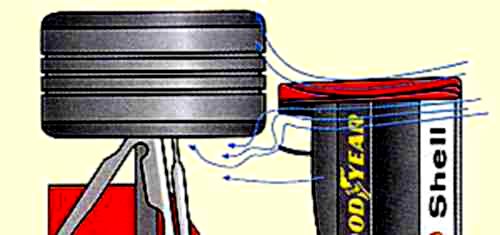
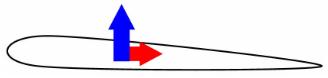
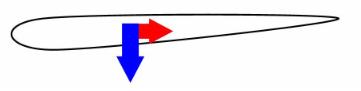
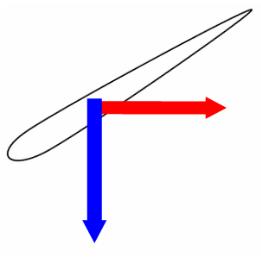
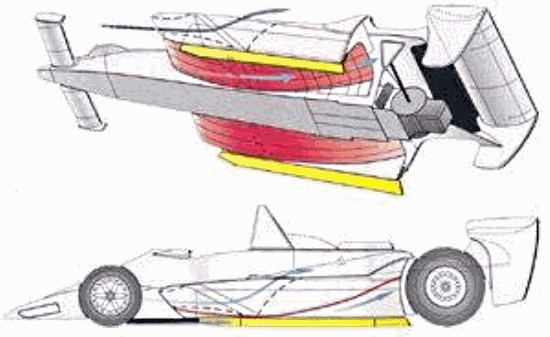
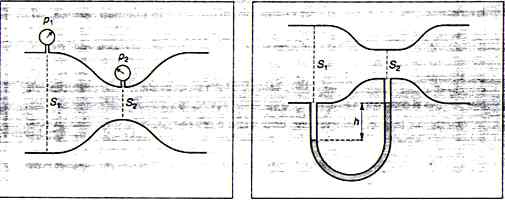

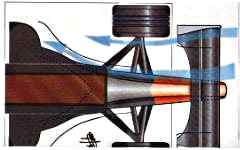

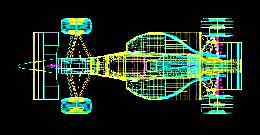

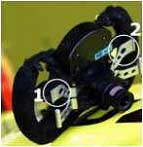





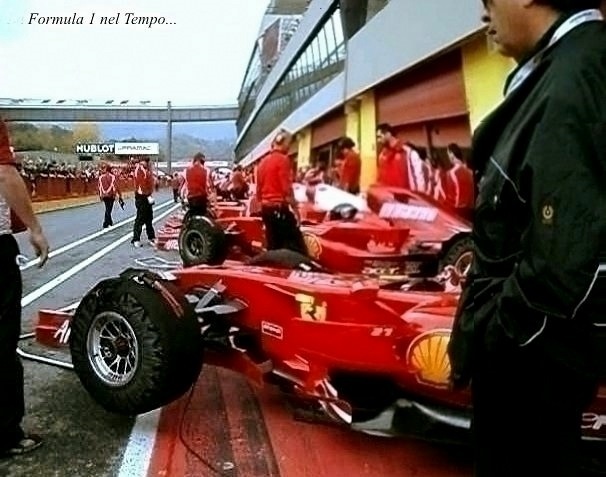



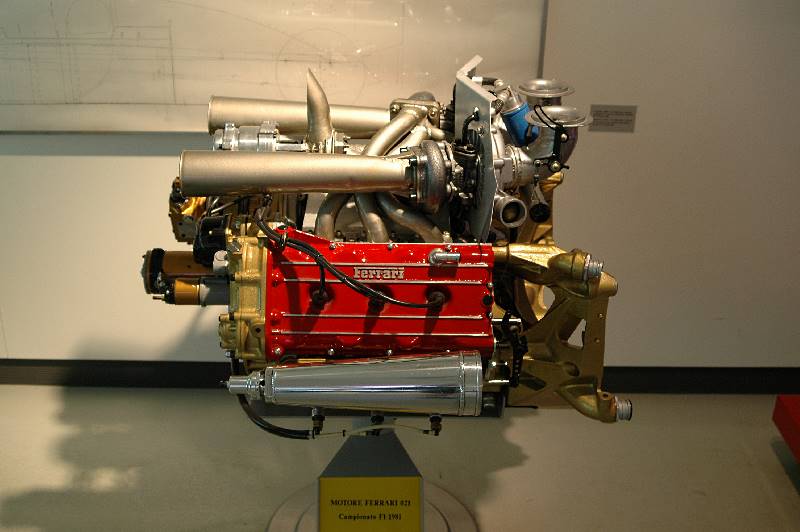

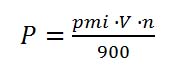

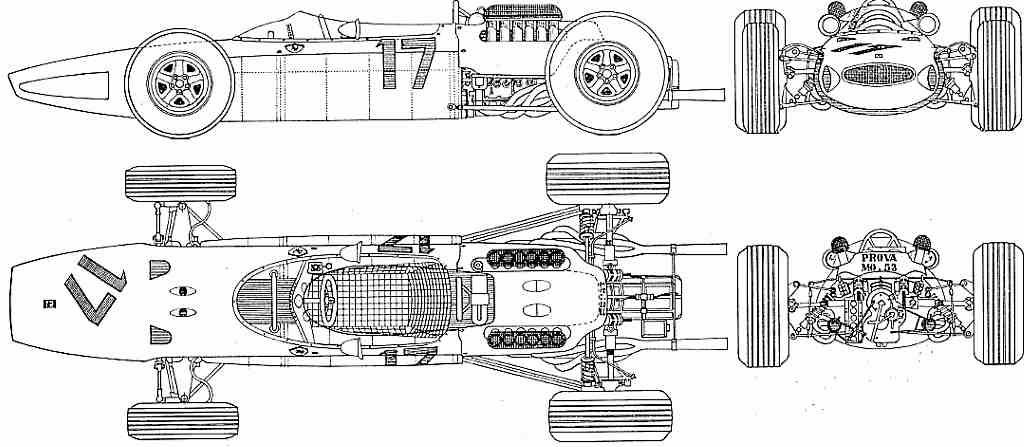

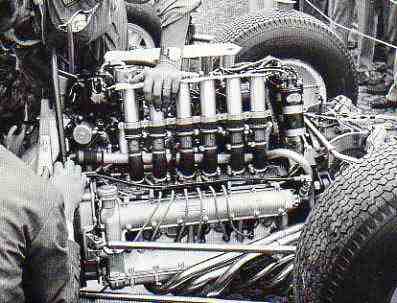


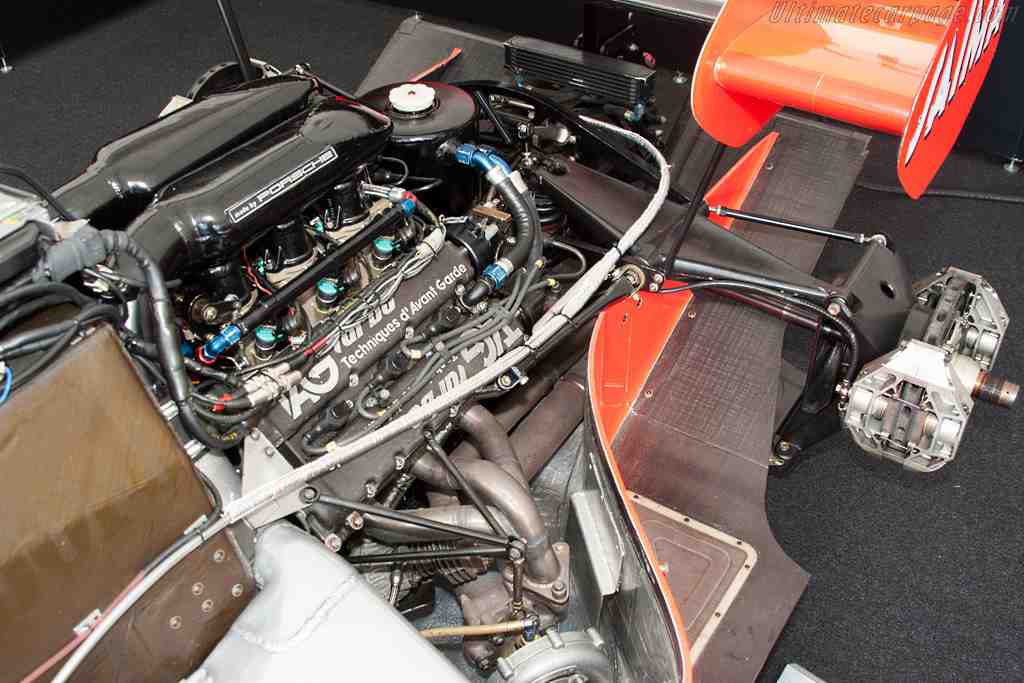

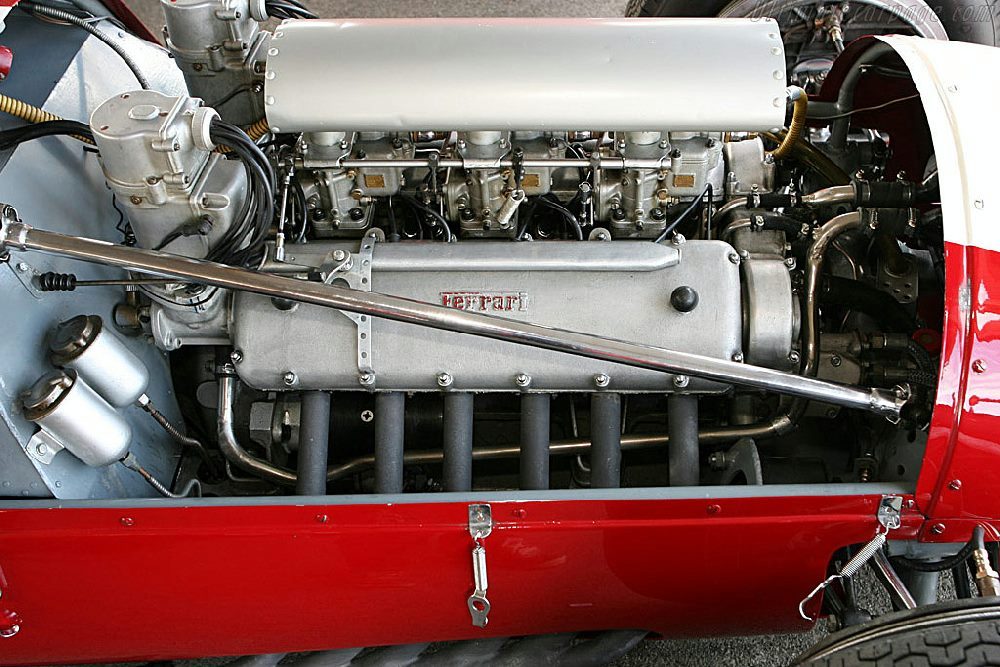

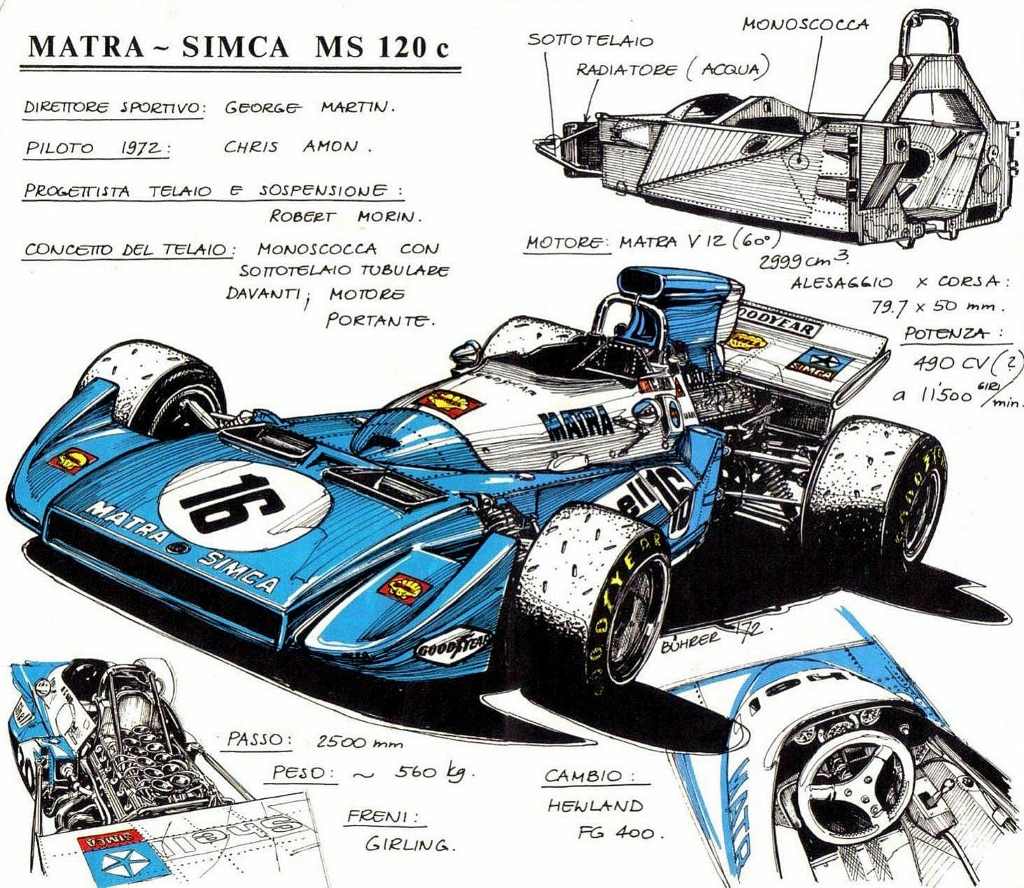
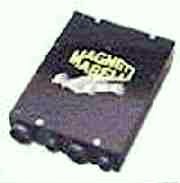


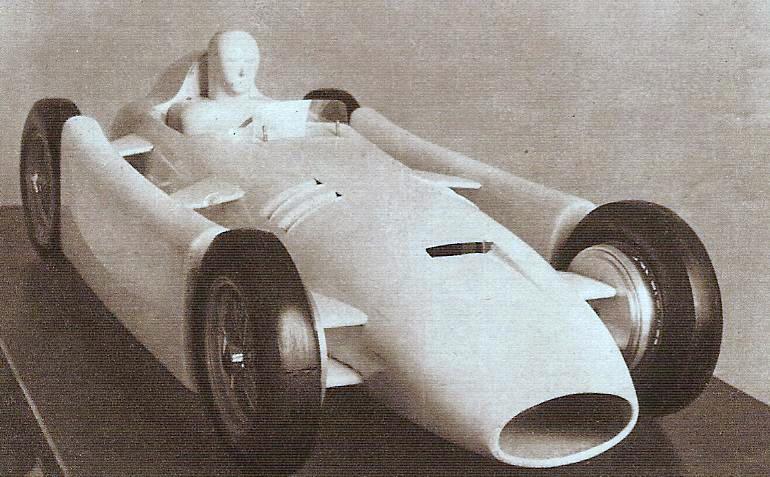
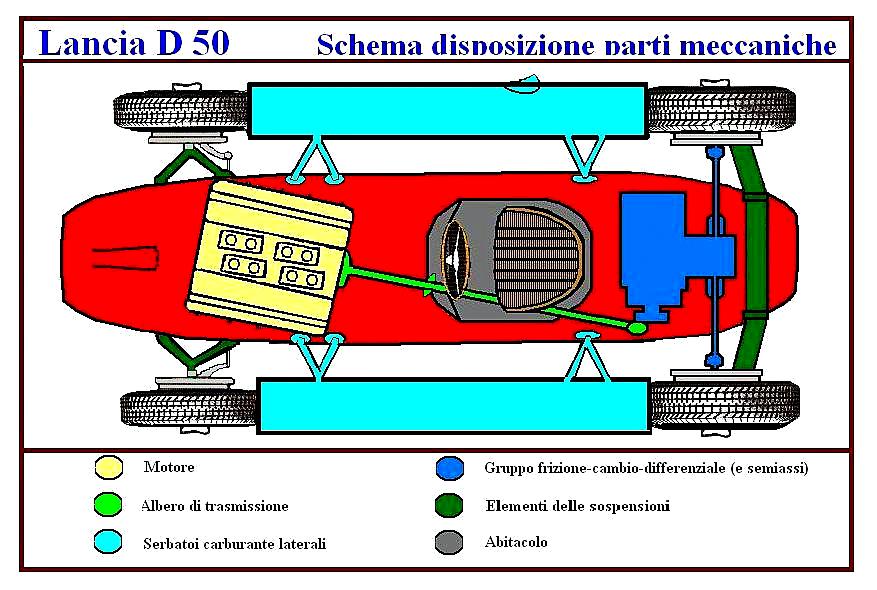
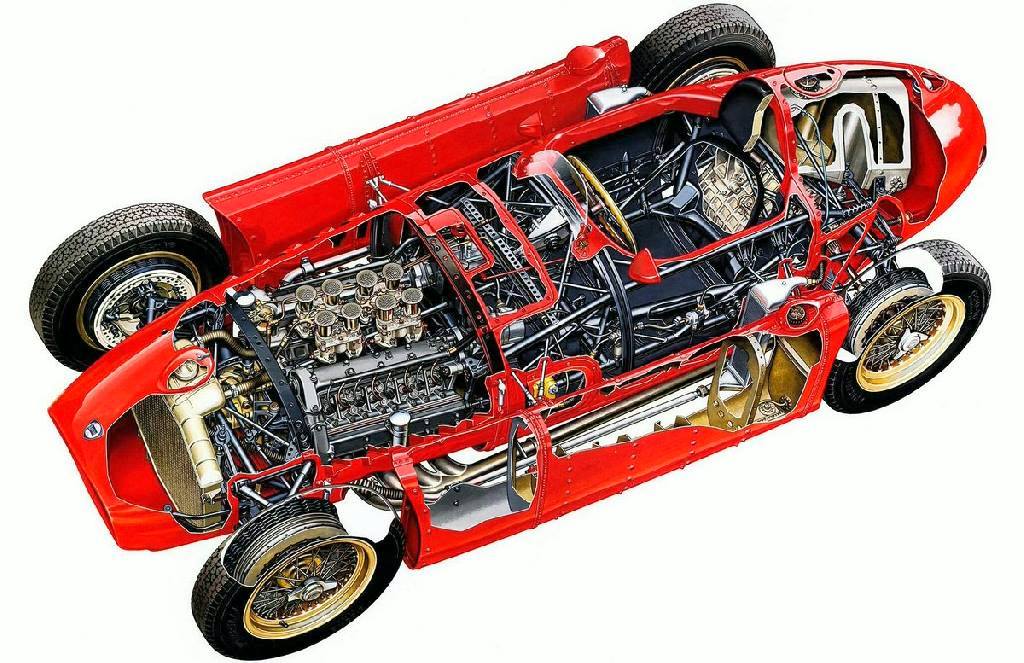
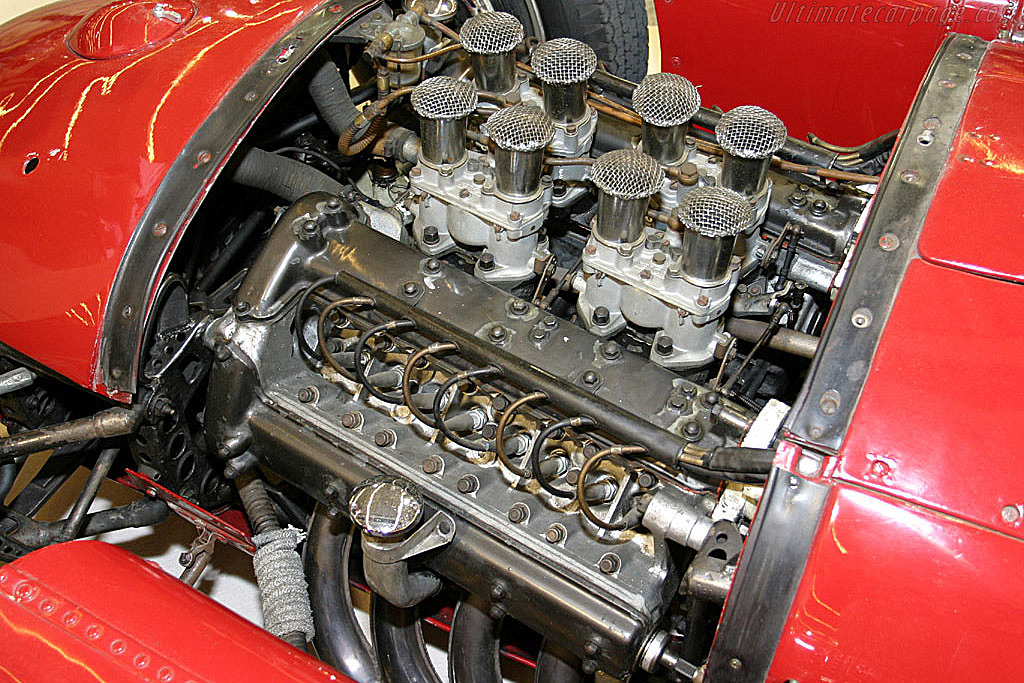




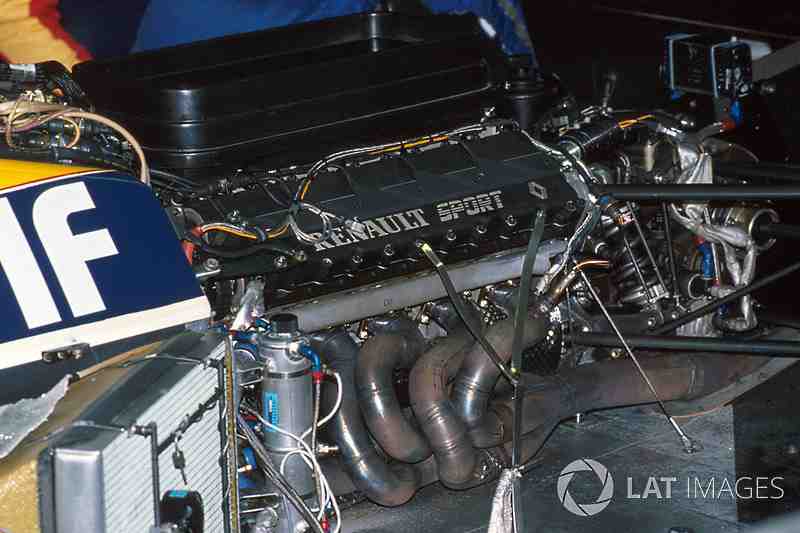
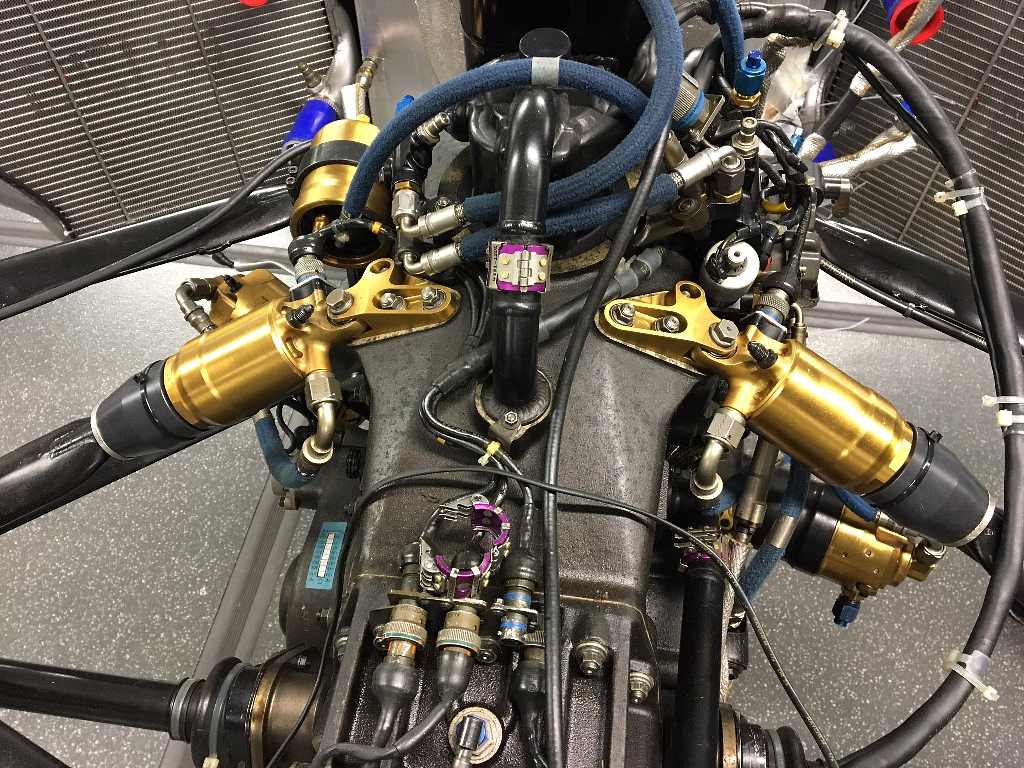


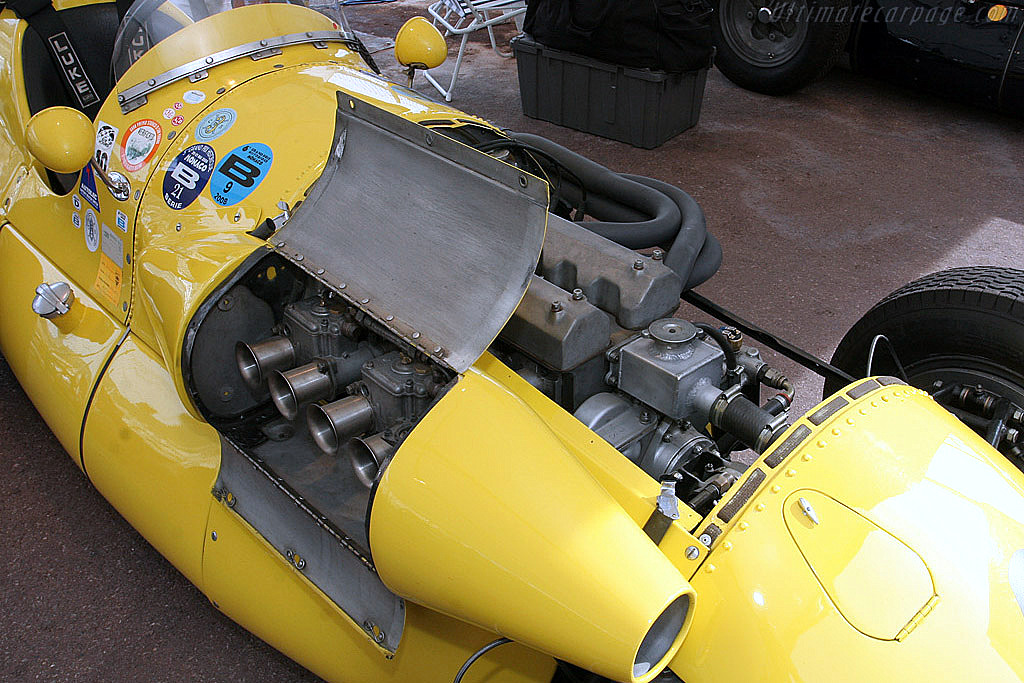











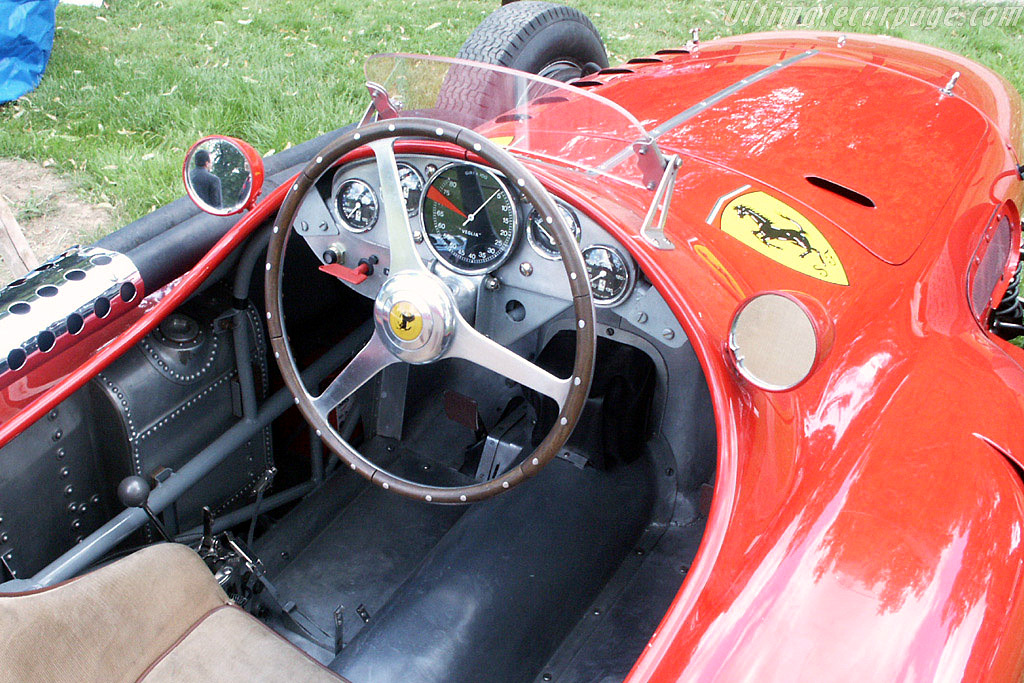

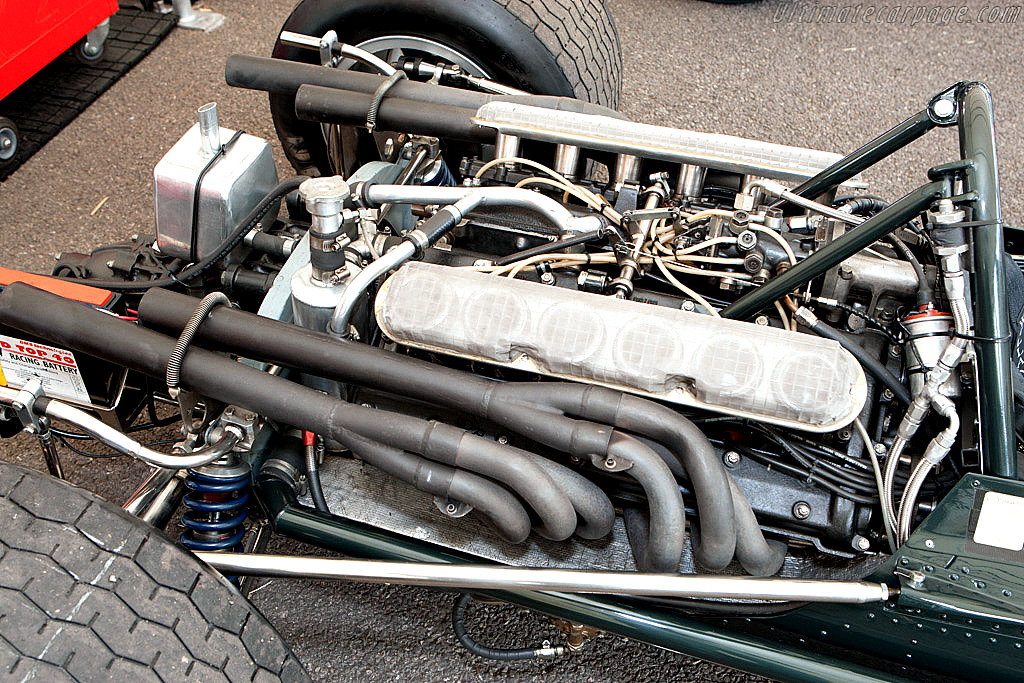
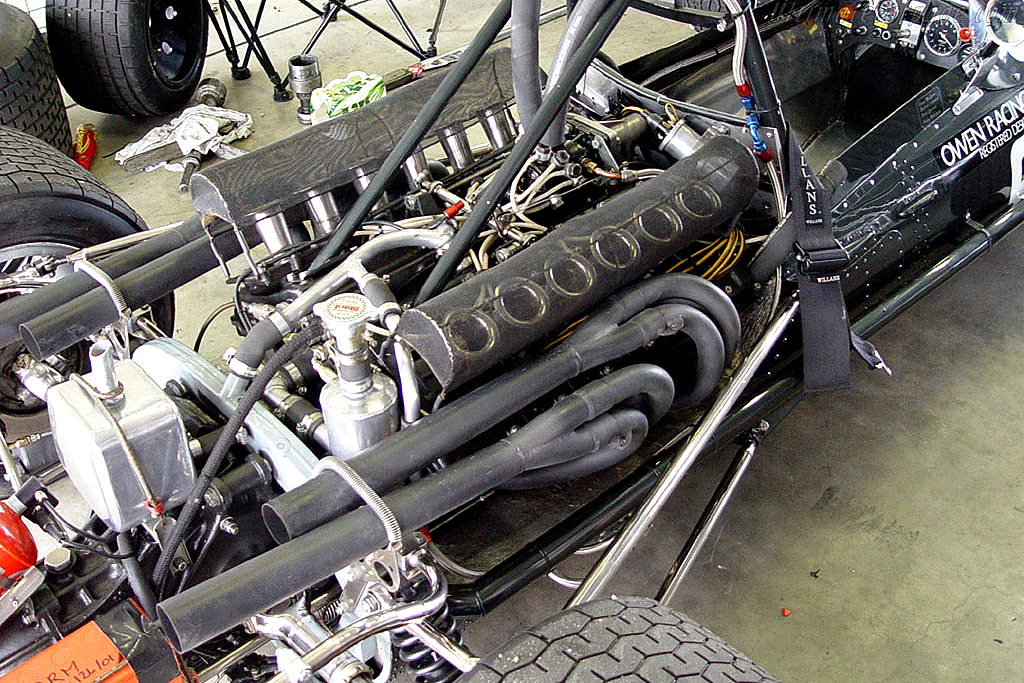













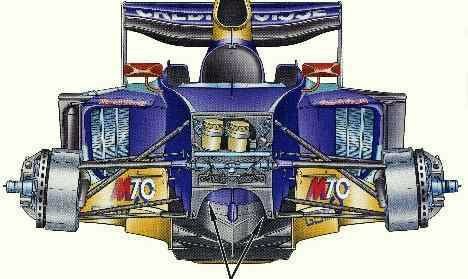
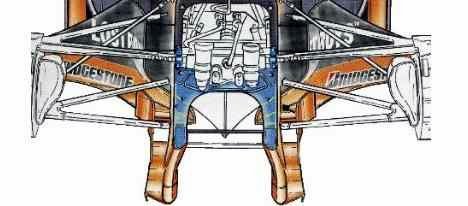
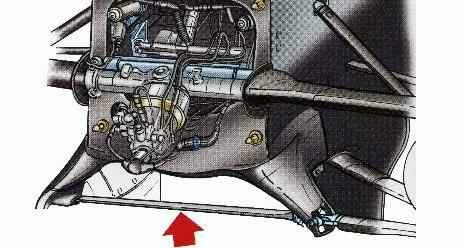

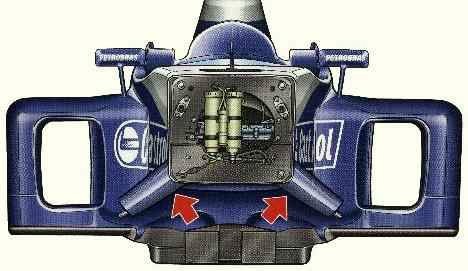



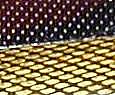

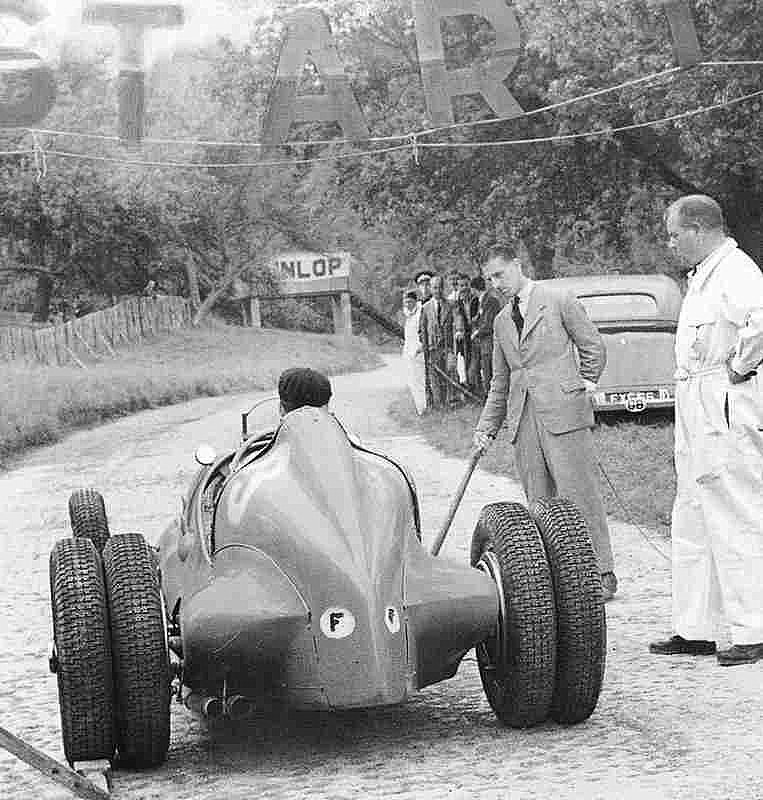







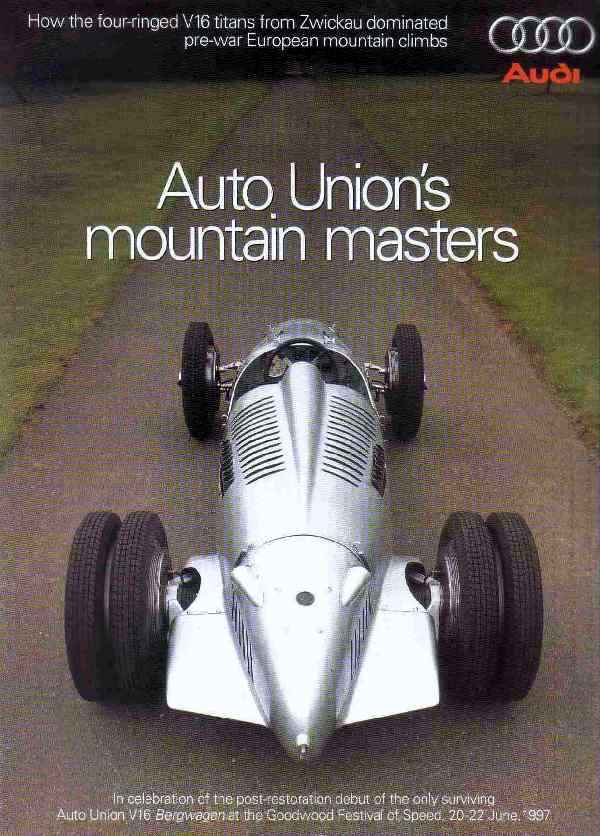 http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html
http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html
http://www.formula1neltempo.it/TECNICA.html