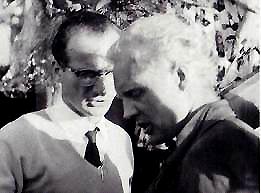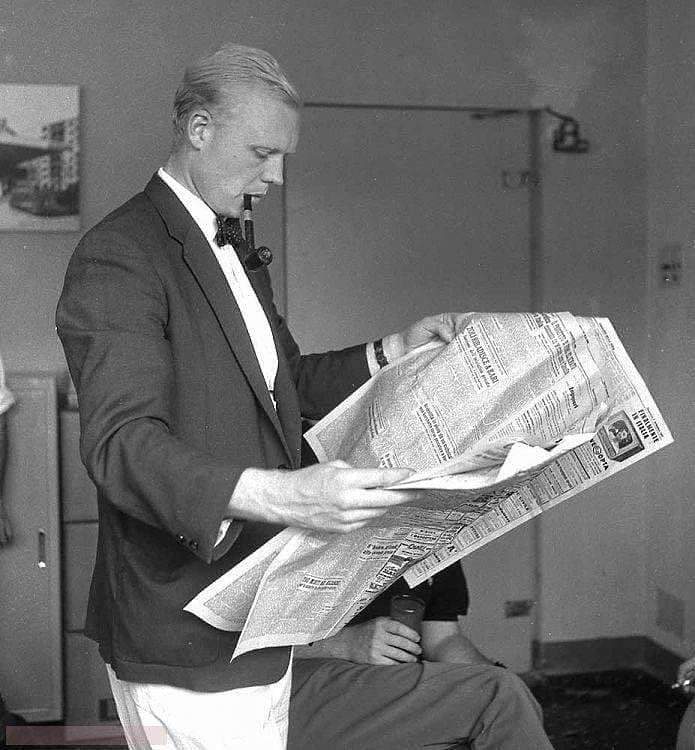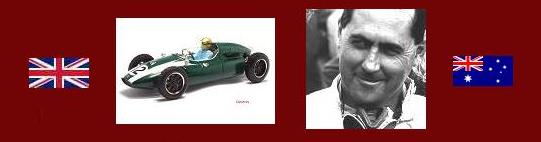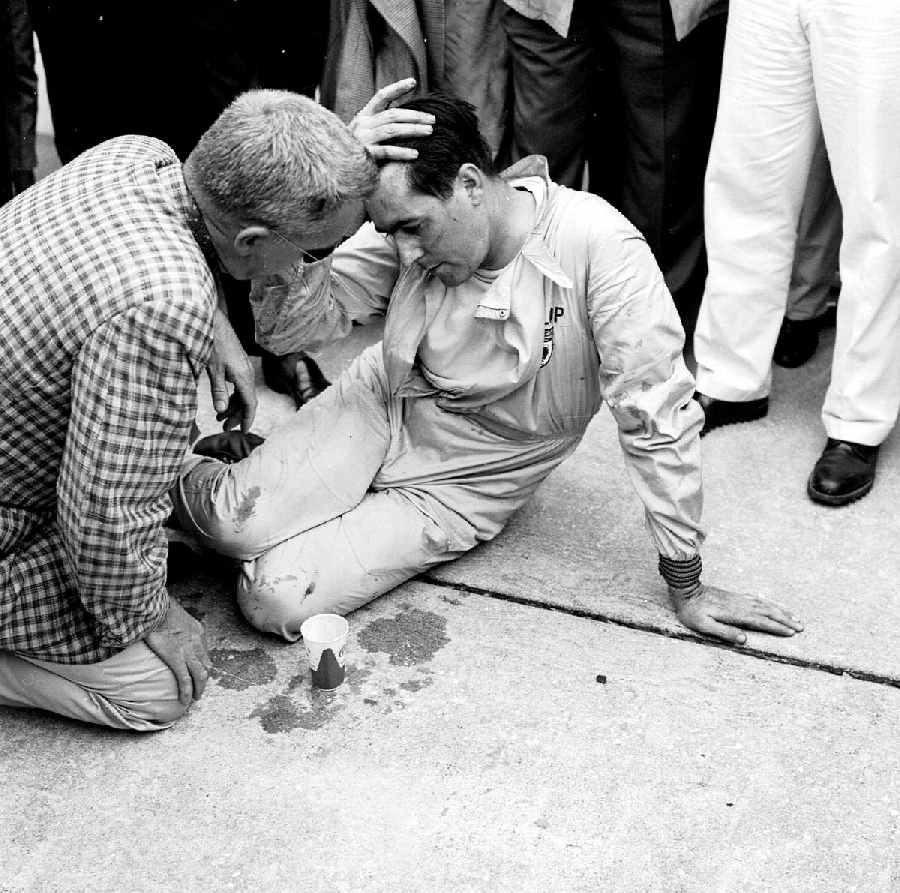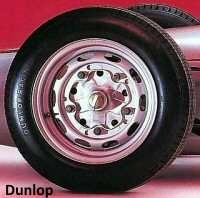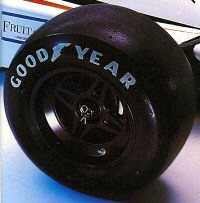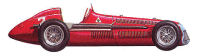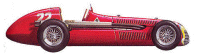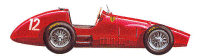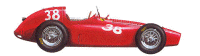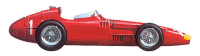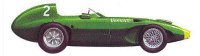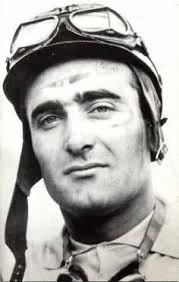|
|
 |

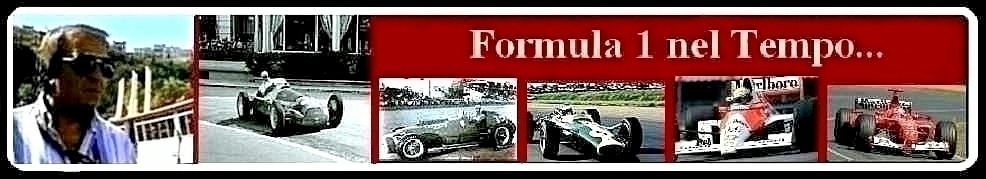
Nel 1949 vengono scelti
sette Gran Premi validi per l'assegnazione del trofeo.
La prima gara valida per
il campionato fu il Gran Premio di Gran Bretagna nel 1950.
Al titolo piloti
seguì un titolo per i costruttori nel 1958.Oltre ai campionati mondiali, si
disputarono
anche due campionati nazionali per vetture di Formula 1.
Il primo, denominato "Tasmanian Formula",
si disputò nel
Sudafrica e anche in Australia dal 1960 al 1975, e il suo dominatore
fu il
pilota rhodesiano John Love, vincitore di sei titoli. Il secondo, denominato
"Formula Aurora",
ebbe una durata più breve e si disputò in Inghilterra dal
1978 al 1980.
 |
|
Nasce il campionato mondiale.

|
La stagione 1950 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 è stata, nella storia della categoria, la prima ad assegnare il Campionato Piloti.
È iniziata il 13 maggio e terminata il 3 settembre, dopo 7 gare,
sei disputate in Europa e, in aggiunta, la 500 Miglia di Indianapolis,
corsa da piloti americani sotto il Regolamento della AAA e della USAC. Il titolo piloti venne vinto da Nino Farina.
Si disputarono inoltre sedici gare europee non valide per il mondiale –
dal 10 aprile al 29 ottobre, e inoltre undici gare sudamericane di Formula Libre – dall'8 gennaio al 24 dicembre – in Argentina, Brasile e Cile.
Si
è registrato un dominio totale della scuderia Alfa Romeo, che
piazzò in classifica ai primi tre posti con la vettura Alfa
Romeo 158 i suoi piloti di punta: oltre al vincitore Farina, si
distinguono Juan Manuel Fangio che vinse tre gare e perse il titolo
all'ultimo appuntamento, e il veterano Luigi Fagioli, più
costante dei compagni ma penalizzato dalla regola sullo scarto dei
risultati. Vengono infastiditi soltanto occasionalmente da Alberto
Ascari sulla Ferrari, che si classifica quinto, e dal francese Louis
Rosier sulla Talbot-Lago, giunto al quarto posto.
|
 |
SILVERSTONE - 13 MAGGIO 1950
PRIMO GRAN
PREMIO - F1
La
prima gara del primo Campionato del Mondo venne disputata di sabato. In Inghilterra
la domenica è, da sempre, la giornata dedicata al riposo e, tradizionalmente,
è il sabato il giorno della settimana riservato ai grandi appuntamenti
sportivi. I circuiti si alternano, ma per trent’anni, fino alla fine degli
anni Settanta, quando la televisione detterà legge anche in Formula 1,
il Gran Premio di Gran Bretagna sarà sempre corso nella giornata di sabato.
Il 13 maggio 1950 è una splendida giornata di sole. L’Autodromo
prescelto per la disputa della prima gara del nuovo Campionato del Mondo è
quello di Silverstone, qualche decina di miglia a nord-est di Oxford e a non
più di un’ora e mezza di automobile da Londra. Fra i tanti Autodromi
di cui pullula la magnifica campagna inglese, tutti rigorosamente allestiti
sui campi di aviazione usati dai piloti della Raf nel corso della Seconda Guerra
Mondiale, Silverstone si sta rapidamente avviando ad essere il più celebre.
Il tracciato è simile ad un pentagono, cui lato inferiore è leggermente
incurvato e i cui angoli sono smussati da curve velocissime. La prima fila dello
schieramento del Gran Premio di Gran Bretagna, che nell’occasione del
debutto del Campionato del Mondo di Formula 1 si fregia anche del Titolo di
Gran Premio d’Europa, è occupata interamente dalle quattro Alfa
Romeo inscritte alla gara. L’Alfa Romeo dispone del modello 158 che, ribattezzata
“Alfetta”, ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte nel dopoguerra.
La vettura è stata progettata da Gioacchino Colombo e da Enzo Ferrari
nel 1937 ma, come tutto il resto del materiale appartenuto alla Scuderia Ferrari,
era passata in forze all’Alfa Romeo quando il Commendator Ferrari aveva
cessato la propria attività sportiva poco prima della guerra.
|
Quando fu inaugurato il Campionato del Mondo ufficiale,
con il Gran Premio d’Europa (o Gran Premio di Gran Bretagna) a Silverstone,
l’Alfa Romeo era la vettura da battere, la Ferrari (seppur non presente)
era l’aspirante reginetta e la BRM la pretendente senza speranza.
Ma
quel giorno fece una dimostrazione di pochi giri per la Famiglia Reale.
Lo storico avvenimento fu patrocinato
da Re Giorgio VI d’Inghilterra e dalla Regina Isabella, e fu sottolineato il fatto che era la prima volta
che un monarca regnante assisteva ad un evento del genere.

La
scuderia Alfa Romeo si presentò nel circuito con quattro Alfetta
guidate da Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli e,
in segno di omaggio alla nazione ospitante, Reg Parnell;
le vetture si piazzarono ai primi quattro posti nelle qualifiche, occupando per intero la prima fila dello schieramento.
L'altra
casa automobilistica italiana presente fu la Maserati, che
schierò sei vetture portate in gara da tre scuderie diverse: la
Scuderia Ambrosiana con David Murray e David Hampshire, l'Officina
Alfieri Maserati con Louis Chiron di passaporto monegasco e Joe Fry,
per finire con la Enrico Platé dove si distinguevano due piloti
dotati di titoli nobiliari, Toulo de Graffenried e Prince Bira;
quest'ultimo occupò il quinto posto nella griglia di partenza.
Dei 22 iscritti Felice Bonetto della Scuderia Milano sarà
l'unico che non riuscirà a qualificarsi.
La
Ferrari, invece, preferì non prendere parte alla corsa con Enzo
Ferrari che si lamentò con la stampa del limitato ingaggio
offertogli dagli organizzatori. Le vetture inglesi erano le tre ERA e le due ALTA. I cinque francesi presenti invece gareggiarono con la Talbot-Lago
(con le migliori due vetture che occuparono la seconda fila di
partenza) e con due scuderie non manifatturiere. Parecchi corsero come
privati e Leslie Johnson si presentò col nome di una scuderia, la Taso Mathieson per la prima e ultima volta.
 |
Gran Premio di Gran Bretana 1950 |
 |
1º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 1 di 7 del Campionato 1950sabato 13 maggio 1950
70 giri x 4.649 km - 325.430 km
 |
|
Con ghirlande, Bande musicali e tutta la pompa di una Cerimonia di Stato,
i Reali britannici si divertirono assistendo alla grande prova dell’Alfa
Romeo di Giuseppe Farina, che vinse davanti a Luigi Fagioli e a Reg Parnell.
Più indietro, il veterano francese Yves Giraud-Cabantous ottenne
faticosamente il quarto posto con la sua Talbot Lago a 4,5 litri. Era
il tipo di predominio che si sarebbe visto molti anni dopo, con la Williams-Renault
e le McLaren-Honda, con la differenza che l’Alfa Romeo aveva una
superiorità ancora maggiore, in quanto affrontava una concorrenza
decisamente improvvisata. La mattina della gara, le Alfa erano state portate
a Silverstone per la strada che conduce a Banbury; ovviamente, ciò
era illegale, ma nessuno se ne curò. Le vetture riuscirono a non
rimanere bloccate nel traffico e arrivarono appena in tempo per l’entrata
dei monarchi britannici, che viaggiarono in treno fino alla stazione di
Brackley, da dove una Daimler della Casa Reale li portò al circuito.
Il Re e la Regina furono debitamente presentati ai piloti, fra cui gli
astri nascenti dell’Automobilismo britannico, i giovani Stirling
Moss e Peter Collins.
Tutti i dettagli del loro modo di comportarsi furono accuratamente descritti
da Williams Boddy, un giornalista della rivista “Motor Sport”,
che scrisse:
“Il conte Howe si sedette tra il Re e la Regina e,
quando al bandiera stava per dare il via, il Re guardò il programma
e scrutò la Griglia di Partenza. Quando le automobili partirono
a tutta velocità, sembrava molto interessato, ma il rumore e il
fumo colsero di sorpresa la Regina, come succede a quanti stanno vicino
alla pista nella partenza in massa di una Gara. La principessa Margherita
sembrava volersi concentrare solo su quanto stava succedendo, e considerava
la conversazione come qualcosa di secondario. Ma queste sono solo supposizioni”.
La cosa più curiosa, comunque, fu l’ingorgo di Silverstone,
sul quale “Motor Sport” si soffermò con dovizia di
particolari. Un fatto che oggi non sorprenderebbe nessuno, ma che nel
1950 destò un certo scalpore. “Noi siamo sicuri che coloro
che sono arrivati in ritardo a causa del traffico, coloro che hanno impiegato
quattro ore per uscire dai parcheggi o che hanno ricevuto pass sbagliati,
e i commissari onorari del Club, che la notte del venerdì sono
stati costretti a dormire in vecchi negozi di campagna perché le
pattuglie della RAC avevano esaurito i letti degli alberghi, saranno completamente
d’accordo con noi nel deplorare ciò che è accaduto”,
scrisse la rivista.
|
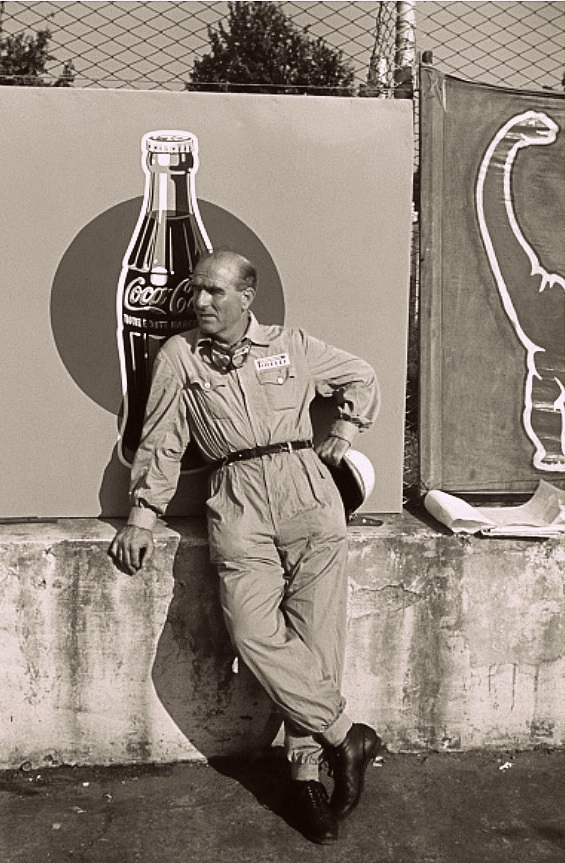
NINO FARINA
|
|
Il Gran Premio di Gran Bretagna del 1950 vinto da Nino Farina su Alfa Romeo, fu il primo round del Campionato Mondiale Piloti della stagione 1950 di Formula 1 e la quinta gara complessiva di quell'annata, dopo il Gran Premio di Pau e il Gran Premio di Sanremo, entrambe vinte da Juan Manuel Fangio, il Richmond Trophy, vinto da Reg Parnell e il Gran Premio di Parigi, vinto da Georges Grignard.
Disputato
il 13 maggio sul Circuito di Silverstone nella classica configurazione
del 1948, e inoltre designato anche come Gran Premio d'Europa per il
1950, questa prima gara valida per il Campionato Mondiale vede la
presenza sulle tribune del re Giorgio VI, la regina Elizabeth, la
principessa Margaret, Louis Mountbatten e Edwina Ashley.
La scuderia Alfa Romeo
si presentò nel circuito con quattro Alfetta guidate da Nino
Farina, Juan Manuel Fangio, Luigi Fagioli e, in segno di omaggio alla
nazione ospitante, Reg Parnell; le vetture si piazzarono ai primi
quattro posti nelle qualifiche, occupando per intero la prima fila
dello schieramento.
L'altra casa automobilistica italiana presente fu la Maserati, che
schierò sei vetture portate in gara da tre scuderie diverse: la
Scuderia Ambrosiana con David Murray e David Hampshire, l'Officina
Alfieri Maserati con Louis Chiron di passaporto monegasco e Joe Fry,
per finire con la Enrico Platé dove si distinguevano due piloti
dotati di titoli nobiliari, Toulo de Graffenried e Bira; quest'ultimo
occupò il quinto posto nella griglia di partenza.
Dei 22 iscritti Felice Bonetto della Scuderia Milano sarà l'unico che non riuscirà a qualificarsi.La
Ferrari, invece, preferì non prendere parte alla corsa con Enzo
Ferrari che si lamentò con la stampa del limitato ingaggio
offertogli dagli organizzatori. Le vetture inglesi erano le tre ERA e le due ALTA. I cinque francesi presenti invece gareggiarono con la Talbot-Lago
(con le migliori due vetture che occuparono la seconda fila di
partenza) e con due scuderie non manifatturiere. Parecchi corsero come
privati e Leslie Johnson si presentò col nome di una scuderia, la Taso Mathieson per la prima e ultima volta.
|
La FIA attraverso la CSI (Commissione
Sportiva Internazionale) mette ordine nel composito universo del Gran
Prix,
dando a sei di questi lo status di prova iridata ed organizzando
così il primo campionato del mondo.
Nel calendario
è inserito anche la 500 Miglia di Indianapolis, ma i piloti
europei
la disertano (e gli americani non vengono
a correre in Europa).
Il circuito è riservato alle Formula 1, vetture senza
limitazioni di peso con motore da 1500 cc
se sovralimentato e 4500 cc
se aspirato. Per battezzare l'evento, alla "prima" di Silvestone
si
presentano re Giorgio VI e la futura regina Elisabetta. Il campionato
si rivela una questione privata
tra Farina, Fangio e Fagioli, al
volante di altrettante Alfa Romeo 158, solo occasionalmente infastiditi
dalla Ferrari 125 di Alberto Ascari (figlio di Antonio, già
avversario di Nuvolari).
Il Mondiale si decide all'ultimo GP a Monza: Fangio è
tradito da cambio e motore, Farina vola a prendersi il titolo.
Regolamento sportivo: punti ai primi cinque (8-6-4-3-2), un punto
all'autore del giro più veloce in gara.
Validi i migliori
quattro risultati. Possibile l'avvicendamento di più piloti
su una stessa macchina (se a punti, questi vengono divisi tra i
componenti dell'equipaggio) e, per ogni pilota, il passaggio da una
macchina all'altra.
Regolamento tecnico: Motori 1500 cc con compressore, o 4500 cc senza.
|
|
LA RIVOLUZIONE DEL MOTORE POSTERIORE
Cooper-Climax T51

GP di Svizzera
Le Alfa di Giuseppe Farina (16), Luigi Fagioli (12),
e Juan Manuel Fangio (14) nel 1950.
|
Nel
1950, in risposta al Campionato Mondiale di Motociclismo introdotto
l'anno precedente, la FIA organizzò il primo vero Campionato
del Mondo Piloti utilizzando il Regolamento della Formula 1.
L’organizzazione del campionato vide scegliere sei dei
maggiori Gran Premi in Europa, più la 500 Miglia di
Indianapolis, ma questa fu una mera formalità per quanti
avevano partecipato alle gare durante gli anni precedenti. Furono tre
team italiani ad occupare le posizioni dominanti dei primi anni del
campionato, l’Alfa Romeo, quindi la Ferrari, e infine la
Maserati. Altre case manufattrici nazionali – come la
francese Talbot o la britannica BRM – competono, con successi
assai modesti. Un buon numero di vetture private prendevano parte alle gare.
L’Alfa Romeo dominò la concorrenza nella stagione
1950, vincendo tutte le gare di quel campionato con
l’"Alfetta" 158 costruita prima della guerra da Enzo Ferrari.
La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del campionato
ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente
gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai
importanza nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario
del campionato dopo il 1960.
Nino Farina vinse il campionato
inaugurale, Juan Manuel Fangio lo conquistò nel 1951 con la
Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I motori
dell’Alfetta erano estremamente potenti per la
capacità delle altre vetture dell’epoca.
|
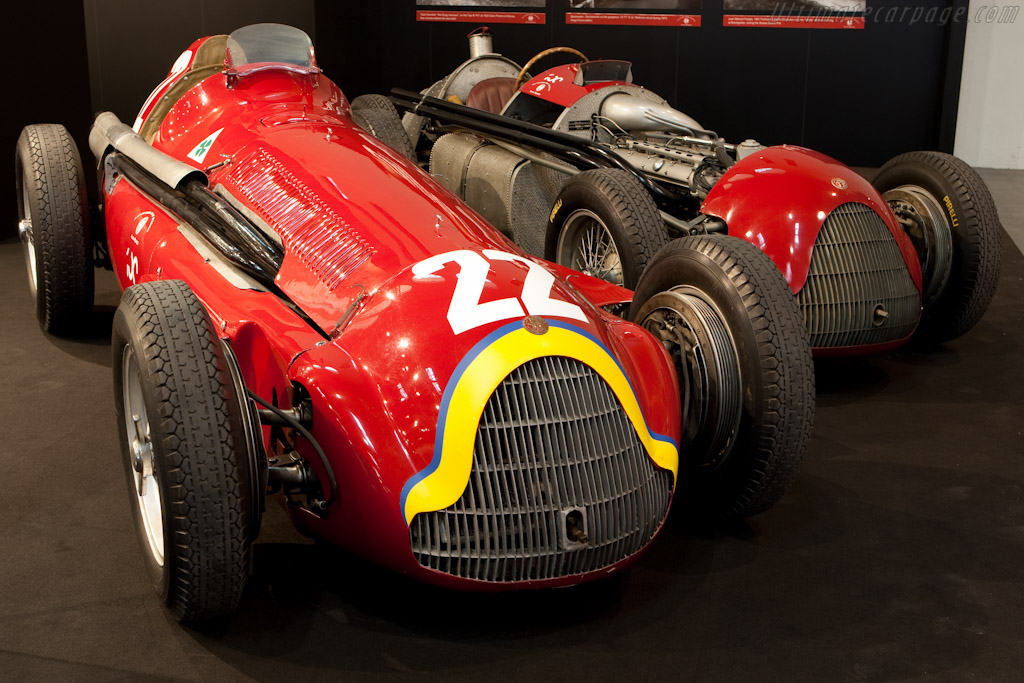
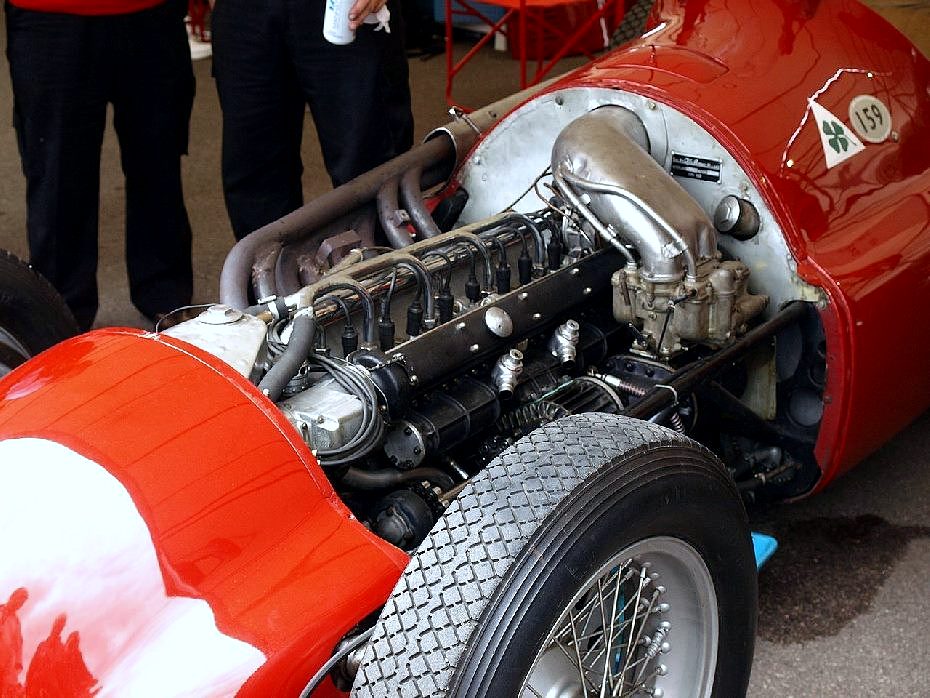
Nel 1951
il motore della 159 produceva attorno ai 420 cavalli di potenza, ma
questo comportava un prezzo da pagare nel consumo eccessivo di benzina,
che era stimato dai 125 ai 175 litri per percorrere 100 km. Enzo
Ferrari, che gareggiò con l’Alfa Romeo prima della
guerra (in pratica la Ferrari iniziò utilizzando ed
elaborando materiale Alfa Romeo), fu il primo a comprendere che lo
sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto a un punto
morto. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere lunghe
soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita di
tempo. |
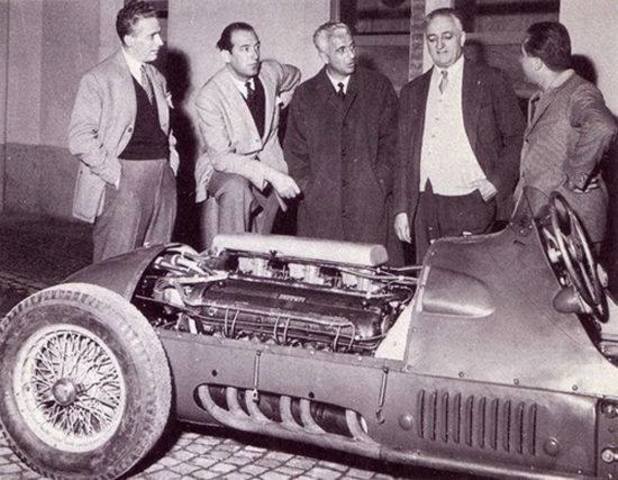 |
| Enzo Ferrari, Ugolini, Lampredi, Villoresi, Ascari, e la mitica 375 F1.1952 |
Per le ultime gare del 1950 Ferrari abbandonò il modello 125
da 1.5 litri con compressore, ormai da museo, e presentò il
nuovo modello 375 con motore V12 aspirato da 4.5 litri, cilindrata che
diventerà un "classico" della Casa modenese.
Con un consumo di benzina che si aggirava attorno ai 35 litri per 100
km le 375 offriromo fiera opposizione all’Alfetta fino al
termine della stagione 1951.
L’Alfa
Romeo, una compagnia finanziata dallo stato, decise di ritirarsi dopo
il rifiuto del governo italiano di concedere fondi per progettare la
nuova vettura. Sorprendentemente, l’Alfa Romeo
investì nelle corse budget molto limitati, utilizzando
ancora tanto materiale e tecnologie precedenti alla guerra durante
queste prime due stagioni. All’istante il team vinse i due
campionati usando solo nove motori costruiti negli anni ‘30.
Non fu comunque il ritiro dell’Alfa Romeo a rendere
invincibile la Ferrari. La FIA si trovò in una posizione
imbarazzante quando ammise che sul Regolamento della Formula 1
dell’epoca era previsto uno slittamento al 1954 del passaggio
al motore atmosferico da 2.5 litri. Le maggiori case costruttrici erano
in quel momento impegnate ad adattare le loro vetture per i nuovi
regolamenti, ma a quel punto si trovarono spiazzate in termini
puramente finanziari.

|
Spa 1952 - Terza edizione del Gp. Ascari su Ferrari taglia il traguardo al
comando
|
|
Alberto Ascari Campione del mondo 1952
Il primo titolo Mondiale
Fu chiaro a tutti che nessuno poteva pensare di
preparare una nuova macchina per affrontare le stagioni successive.
Soltanto la Ferrari era in grado di allestire vetture di Formula 1
competitive. La soluzione adottata fu quella di far disputare il
Campionato Mondiale Piloti con le vetture di Formula 2 per due
stagioni. Naturalmente il dominio Ferrari avvenne con la leggera e
potente 500 a 4 cilindri guidata dal leggendario pilota italiano
Alberto Ascari che fu il primo pilota a vincere due campionati
consecutivi nel 1952 e 1953. Le vetture Ferrari di Formula 1
continuarono a gareggiare nelle gare non valide per il campionato e in
quelle di Formula Libre corse durante quel periodo, soprattutto nel
Sudamerica – non a caso, "Libre" è il termine
spagnolo con cui si definisce "Libera" – dove queste corse
erano molto popolari. Ironicamente, durante quel biennio la sola gara
del Campionato del Mondo in cui le vetture di Formula 1 erano ammesse
era la 500 Miglia. Nel 1952 la Ferrari schierò quattro 375
di Formula 1 con Alberto Ascari come pilota guida, ma con scarso
successo: solo Ascari riuscì a qualificarsi (a
metà schieramento) e si ritirò ben presto in
gara. Non contando la gara di Indianapolis, il Campionato del Mondo si
svolse interamente in Europa fino al 1953, quando la stagione si
aprì in Argentina. Quella fu la prima corsa ufficiale di
Formula 1 a disputarsi fuori dall’Europa.
Come previsto, il Campionato del Mondo ritornò al
Regolamento di Formula 1 per la stagione 1954, adesso basato sui motori
atmosferici a 2.5 litri. Erano la Lancia e la Mercedes-Benz a
monopolizzare la serie, guidati dai migliori piloti
dell’epoca: Ascari per la Lancia, Fangio per la Mercedes.
Utilizzando valvole desmodromiche, iniettori a benzina, magnesio, ed
altre parti piuttosto esotiche come linee del telaio presentate con una
forma alquanto allungata e altre tecniche piuttosto avanzate, la nuova
Mercedes iniziò la stagione 1954 quando Fangio
partì dalla pole position nel Gran Premio di Francia svolto
sul circuito stradale di Reims-Gueux con il primo giro percorso a una
velocità di oltre 200 km/h – fu la prima volta
nella storia della Formula 1 – prima di vincere la corsa,
Fangio ingaggiò un duello con l’altro pilota della
Mercedes Karl Kling, giunto in seconda posizione.
 |
Gran premio d'Olanda 1955
46º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 5 di 7 del Campionato 1955
domenica 19 giugno 1955 - 100 giri x 4.193 km - 419.300 km
|
|
 |
|
Il Gran Premio d'Olanda 1955 fu
la quinta gara della stagione 1955 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 19 giugno sul Circuito di Zandvoort. La manifestazione
vide la vittoria di Juan Manuel Fangio su Mercedes,
seguito dal compagno di squadra Stirling Moss e dall'italiano Luigi
Musso su Maserati.
Il Gran Premio ebbe luogo una settimana dopo la tragedia di Le Mans.
|
Le vetture Mercedes affrontarono le due stagioni seguenti con Fangio
che si aggiudicò tutte le gare lasciando agli altri piloti
soltanto tre corse. Alla fine della stagione 1955 la Mercedes si
ritirò dalle gare nello stesso modo fulmineo
com’era entrata. Avevano provato la superiorità
della loro tecnologia, ma fu il terribile disastro di una delle sue
vetture sport, guidata da Pierre Levegh alla 24 Ore di Le Mans di
quell'anno, che provocò il decesso di 83 persone, a
comportare il ritiro dalle competizioni. La casa tedesca
resterà lontano dalla Formula 1 fino al termine della
stagione 1993. Dopo la tragedia di Le Mans, lo sport automobilistico ne
uscì totalmente sconvolto: tre Gran Premi ancora da
disputarsi vennero immediatamente cancellati e il governo svizzero
annunciò il bando totale alle corse automobilistiche
disputate sul suo territorio nazionale (tutt'ora in vigore. Il gran
premio di Svizzera del 1982 fu disputato in Francia,a Digione).

Lancia D50
Il Gran Premio di Montecarlo 1955 vide uno spettacolare incidente
quando Ascari e la sua Lancia, dopo aver mancato una chicane, si
schiantarono contro il molo. Ascari viene sbalzato fuori dalla vettura
e cadde in acqua, vivo e apparentemente senza danni. Vi furono varie
speculazioni attorno a una emorragia interna non riscontrata quando
appena quattro giorni dopo Ascari rimase ucciso a Monza mentre
effettuava alcuni test su una vettura Ferrari sport prestatagli
dall'amico Castellotti.
Dopo la morte di Ascari, la Lancia (alle prese con gravi problemi
finanziari) si ritirò definitivamente dalla categoria
cedendo motori, vetture, informazioni e tecnologia alla Ferrari (che
ricambierà il favore negli anni settanta fornendo il motore
per la creazione della mitica Stratos).
 |
| La partenza del GP con Collins al comando seguito da Castellotti e Fangio. |
|
Il Gran Premio di Francia 1956 fu la quinta gara della stagione 1956 del Campionato mondiale di Formula 1,
disputata il 1º luglio sul Circuito di Reims.
La corsa vide la seconda vittoria consecutiva di Peter
Collins su Ferrari,
seguito dal compagno di squadra Eugenio Castellotti e
dal francese Jean Behra su Maserati.
|
La
stagione 1956 vide Fangio fare buon uso della Ferrari – nata
in casa della Lancia – per vincere il suo quarto campionato.
Guidando una Maserati, coglie il quinto successo nella stagione 1957,
stabilendo un record che resterà imbattuto per 46 anni.
Nonostante la configurazione base della formula rimanga invariata per
il 1958, le gare furono accorciate dai circa 500 km / 300 miglia ai 300
km / 200 miglia e le macchine usarono un particolare tipo di benzina
composto da vari tipi di miscele il cui componente primario era il
metanolo.
 |
 |
Le 246 di Mike Hawrthon -Luigi Musso e Wolfgang von Trips
GP di Francia 1958 - La corsa vide l'ultima vittoria in carriera di Mike Hawthorn su Ferrari. |
 |
Con il ritiro di Fangio, Mike Hawthorn alla guida della Ferrari
conquistò il titolo piloti nella stagione 1958 diventando
così il primo pilota inglese a vincere il titolo. La
scuderia britannica Vanwall conquistò il primo titolo
riservato ai costruttori in quella stagione, ma non riuscì a
coronare le sue aspirazioni di portare un pilota inglese al titolo
iridato. Stirling Moss, nonostante avesse totalizzato un numero
maggiore di vittorie rispetto ad Hawthorn, perse il titolo per un solo
punto (Hawthorn sfruttò il regolamento dell'epoca che
premiava con un punto chi faceva il giro più veloce in
gara). Questa annata vide anche una donna guidare per la prima volta
una Formula 1 in una gara di campionato, la napoletana Maria Teresa de
Filippis che debuttò guidando da privata una Maserati nel
Gran Premio del Belgio.
|
 |
1959 - Jack Brabham - Cooper T51
| Il 1958 fu un anno cruciale per la Formula 1. Contro una piccola
pattuglia di Ferrari e Maserati (ritiratasi ufficialmente nella
stagione precedente), Stirling Moss vinse il
guidando una vettura a motore centrale Cooper per conto della scuderia
privata di Rob Walker, spinta da un motore 2 litri fornito dalla
Coventry Climax a 4 cilindri. Questa fu la prima vittoria per una
vettura col motore posizionato dietro al pilota in Formula 1. Il
successivo Gran Premio a Montecarlo venne vinto ugualmente dalla
Cooper, guidata questa volta da Maurice Trintignant. Spinte da motori
di minore cilindrata, le Cooper rimasero outsiders nel 1958, ma nel
momento in cui i nuovi motori da 2.5 litri della Coventry Climax furono
messi a disposizione, le piccole vetture britanniche passarono a
dominare la Formula 1. La stagione 1959 vide una competizione serrata
tra la scuderia Cooper dell’australiano Jack Brabham, e Moss
che correva per il team di Rob Walker su vettura Cooper.
L’uso della trasmissione della Citroën Traction
Avant modificata, rappresentò il tallone d’achille
per le Cooper, e Walker tornò a un progetto casalingo.
Sfortunatamente questo asse speciale era totalmente incompatibile con
le altre componenti della vettura e Brabham vinse il titolo, con Moss
piazzato secondo. |
| L’Alfa Romeo dispone del modello 158 che, ribattezzata
“Alfetta”, ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte nel dopoguerra.
La vettura è stata progettata da Gioacchino Colombo e da Enzo Ferrari
nel 1937 ma, come tutto il resto del materiale appartenuto alla Scuderia Ferrari, era passata in forze all’Alfa Romeo quando il Commendator Ferrari aveva
cessato la propria attività sportiva poco prima della guerra. |
Alfa Romeo 158
Aurelio Lampredi e Gioachino Colombo - Gioachino Colombo a Monza nel
1949
A fare grande la Casa milanese in F.1 furono gli
esordi del campionato del mondo, quando Farina e Fangio svettarono
nelle stagioni '50 e '51. Poi l'Alfa decise di ritirarsi dalle
competizioni della massima categoria, ripresentandosi in pista nel '76
come fornitore di motori per la Brabham prima di scendere in campo con
un proprio team. Ma più che successi, la squadra del
Biscione accumulò delusioni, fino a cedere il proprio
materiale all'Euroracing e i motori all'Osella: con la scuderia
piemontese, i motori Alfa «girarono» fino all'87.
Gli anni più gloriosi dell'Alfa Romeo sono legati alle prime
due stagioni del campionato del mondo di F.1, quando, per due anni di
seguito, Nino Farina prima e Juan Manuel Fangio poi, svettarono nei
mondiali '50 e '51. La prima stagione iridata fu caratterizzata dall'en
plein messo a segno dalla Casa milanese, che vinse tutti i Gran Premi
in calendario ad esclusione di Indianapolis, cui però i team
europei non partecipavano. L'arma formidabile che permise all'Alfa
l'exploit del '50, fu la «158», meglio nota come
«Alfetta», cui seguì la
«159» - naturale evoluzione della macchina campione
del mondo - con la quale la Casa del Portello disputò il
mondiale '51. Ma quello fu l'ultimo anno in F.1 dell'Alfa: paga dei
successi ottenuti, la Casa milanese decise infatti di abbandonare le
competizioni per capitalizzare i risultati ottenuti. Una decisione cui
contribuì l'evidente crescita che stava caratterizzando
un'altra scuderia: la Ferrari. Che dimostrò appunto il suo
potenziale vincendo il mondiale '52, e ripetendosi in quello successivo
con Ciccio Ascari.
|
|
|
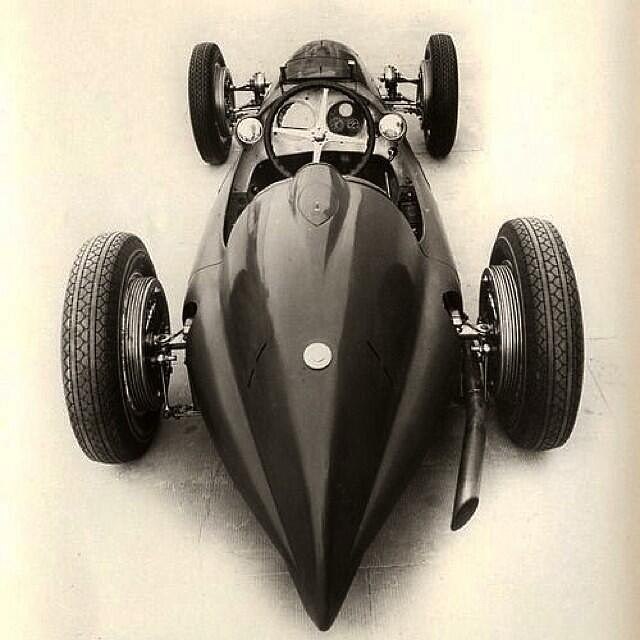 |
Nel
1950, in risposta al Campionato Mondiale di Motociclismo introdotto
l'anno precedente,
la FIA organizzò il primo vero Campionato del
Mondo Piloti utilizzando
il Regolamento della Formula 1.
L’organizzazione del campionato vide scegliere sei dei
maggiori Gran Premi in Europa, più la 500 Miglia di
Indianapolis,
ma questa fu una mera formalità per quanti
avevano partecipato alle gare durante gli anni precedenti.
Furono tre
team italiani ad occupare le posizioni dominanti dei primi anni del
campionato, l’Alfa Romeo,
quindi la Ferrari, e infine la
Maserati. Altre case manufattrici nazionali –
come la
francese Talbot o la britannica BRM – competono, con successi
assai modesti.
Un buon numero di vetture private prendevano parte alle gare.
Nel 1950 fu istituito il Campionato mondiale di Formula 1 e da allora il Gran Premio d’Italia ne ha sempre
fatto parte (foto sopra, Monza GP Italia 1950): nei primi anni era addirittura la gara conclusiva, in seguito
sono stati inseriti altri Gran Premi in date successive.
L’Alfa Romeo dominò la concorrenza nella stagione
1950, vincendo tutte le gare di quel campionato con
l’"Alfetta" 158 costruita prima della guerra da Enzo Ferrari.
La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del campionato
ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente
gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai
importanza nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario
del campionato dopo il 1960. Nino Farina vinse il campionato
inaugurale, Juan Manuel Fangio lo conquistò nel 1951 con la
Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I motori
dell’Alfetta erano estremamente potenti per la
capacità delle altre vetture dell’epoca.
Nel 1951
il motore della 159 produceva attorno ai 420 cavalli di potenza, ma
questo comportava un prezzo da pagare nel consumo eccessivo di benzina,
che era stimato dai 125 ai 175 litri per percorrere 100 km. Enzo
Ferrari, che gareggiò con l’Alfa Romeo prima della
guerra (in pratica la Ferrari iniziò utilizzando ed
elaborando materiale Alfa Romeo), fu il primo a comprendere che lo
sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto a un punto
morto. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere lunghe
soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita di
tempo.
L’Alfa Romeo dominò la concorrenza nella stagione
1950, vincendo tutte le gare di quel campionato con
l’"Alfetta" 158 costruita prima della guerra da Enzo Ferrari.
La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del campionato
ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente
gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai
importanza nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario
del campionato dopo il 1960. Nino Farina vinse il campionato
inaugurale, Juan Manuel Fangio lo conquistò nel 1951 con la
Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I motori
dell’Alfetta erano estremamente potenti per la
capacità delle altre vetture dell’epoca.
Nel 1951
il motore della 159 produceva attorno ai 420 cavalli di potenza, ma
questo comportava un prezzo da pagare nel consumo eccessivo di benzina,
che era stimato dai 125 ai 175 litri per percorrere 100 km. Enzo
Ferrari, che gareggiò con l’Alfa Romeo prima della
guerra (in pratica la Ferrari iniziò utilizzando ed
elaborando materiale Alfa Romeo), fu il primo a comprendere che lo
sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto a un punto
morto. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere lunghe
soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita di
tempo.
|
 |
Juan Manuel Fangio in mezzo ad Alberto Ascari (a sinistra) e a Nino Farina (a destra) in una foto del 1950
|
Per le ultime gare del 1950 Ferrari abbandonò il modello 125
da 1.5 litri con compressore, ormai da museo,
e presentò il
nuovo modello 375 con motore V12 aspirato da 4.5 litri, cilindrata che
diventerà
un "classico" della Casa modenese.
Gran Premio di Monaco 1950
21 maggio 1950
Percorso 3,180 Km - Distanza 100 giri 318,0 km |
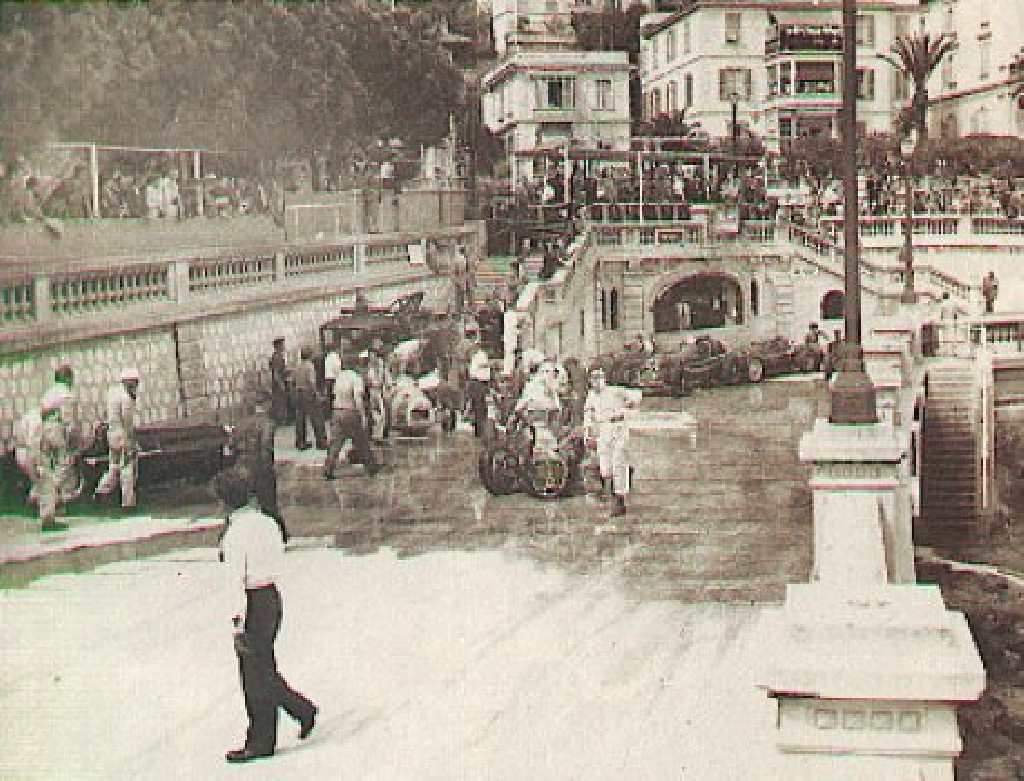 |
Al
via, dopo un paio di curve la classifica temporanea vede Fangio in
testa seguito da Villoresi Farina e Gonzales, reo di aver perso
posizioni a scapito dei due italiani.
Ma al primo giro si verifica un rovinoso incidente multiplo quando
un'ondata improvvisa invade la curva del Tabaccaio. Fangio, già
in testa, riesce ad evitarla mentre invece Giuseppe Farina si scontra
con la Maserati di González, che prende fuoco. L'argentino
riesce in breve tempo a uscire dalla vettura con qualche ustione.
Immediatamente, il personale di servizio agita ripetutamente la
bandiera gialla, ma i piloti non tengono conto della segnalazione.
Così, i concorrenti sopraggiunti, tentando di evitare le due
vetture, entrano in collisione tra loro: Luigi Fagioli, in quinta
posizione, sterza bruscamente andando in testacoda, e viene urtato dal
sopraggiungente Louis Rosier.Nella carambola si ritirano
complessivamente dieci piloti su diciannove partecipanti.
Un attimo prima, dalle tribune il pubblico aveva aguzzato lo sguardo
verso la curva di S. Devota, attendendo con impazienza il primo
passaggio. Un attimo dopo, tutta la gente presente tace, nel timore di
una catastrofe.
L'unico pilota per cui si pensa che vi siano state conseguenze gravi
è Rol, dato che si teme una frattura ad un braccio. Ma la
radiografia subito fatta sul percorso con l'impianto montato su vita
apposita autoambulanza permette di stabilire che non vi è nulla
di grave. Infatti, Rol riparte coraggiosamente in automobile per
Torino, guidando lui stesso, mentre la corsa è in fase di
svolgimento.
Nei box, le mogli dei piloti si torcono le mani per l'ansia dell'attesa.
Dopo pochi minuti, Fagioli giunge ai box a piedi, facendo grandi gesti.
Dalla sua mimica si capisce che è avvenuto uno scontro
collettivo e che le macchine si sono scontrate più volte tra
loro, mentre il comitato del Gran Premio informa, forse con
superficiale precipitazione, che la causa dell'incidente è stato
Farina.
Farina dice invece che è stato Gonzales a provocare l'incidente:
"Villoresi aveva passato da poco
l'argentino; anch'io stavo superando l'imbocco della curva; ad un
tratto ho sentito toccare nel fianco la mia macchina e questa si mise
di traverso, tanto è vero che una ruota di Gonzales porta ancora
tracce di vernice rosea, il colore cioè della mia Alfa".
Mentre i testimoni oculari dichiarano che la ruota destra posteriore della macchina di Farina avrebbe urtato contro un muro.
Le deposizioni sono infinite e discordanti, e vi è persino chi
parla di intenzionalità da parte di Gonzales, per mettere fuori
gara Farina, che è il più veloce concorrente di Fangio,
argentino come Gonzales.
Luigi Villoresi viene attardato in maniera irreparabile al secondo giro
dalla pista ostruita dalle vetture incidentate. Usciti subito di scena
due grandi protagonisti del Gran Premio di Gran Bretagna, Farina e
Fagioli, l'attenzione del pubblico è tutta per Villoresi, che
tenta una rimonta portandosi, al cinquantacinquesimo giro, a trentadue
secondi da Fangio, prima di arrendersi al sessantatreesimo giro per
problemi alla trasmissione.
Si spegne così l’unico reale motivo di interesse rimasto in gara.

L’ordine d’arrivo vede Fangio tagliare per primo il traguardo con un netto vantaggio su Ascari e Chiron.
Alla fine Juan Manuel Fangio, dopo avere doppiato tutti, e senza grandi
problemi, al termine di tre ore e tredici minuti di gara riesce a
conquistare la sua prima vittoria in Formula 1, tagliando per primo il
traguardo davanti ad Ascari e Chiron.
|
Ultimo appuntamento della stagione 1950, il
velocissimo circuito di Monza decreterà chi fra Fangio
(26
punti), Fagioli (24) e Farina (22) sarà il primo Campione
del Mondo di F1.
La partecipazione delle Ferrari rimane in forse fino a
martedì 29 agosto, giorno in cui scende
in pista la 4500
(modello 375) affidata ad Ascari. Debuttano anche due Alfa Romeo
modello 159 affidate
a Fangio e Farina, mentre a Fagioli viene lasciato
il modello 158.
In prova Fangio ottiene la pole con il tempo di
1’58’’6. Secondo è Ascari a
soli 2 decimi (1’58’’8),
terzo Farina
(2’00’’2). Chiude la prima fila
l’Alfa Romeo 158 di Sanesi
(2’01’’4) . Fagioli è solo
quinto
con un modesto 2’04’’0.
La gara si sviluppa in maniera incredibile.
Dal 1938 al 1940 vennero costruite 12 158 (per correre
nella categoria "Vetturette") mentre 4 saranno le 159.
Esteriormente si distingue dalla forma e disposizione degli scarichi e
dalla coda un pochino più arrotondata nella 159. |
Fangio prima rompe la sua
vettura poi quella di Taruffi ritirandosi definitivamente al
22°giro. Ascari
accusa un guasto al ponte e si ritira ma, al
48° giro, sale sulla vettura di Serafini terminando la gara
alle spalle di Farina vincitore indisturbato.
Al terzo posto si piazza Fagioli ,quarte e quinte rispettivamente le
due Tabot di Rosier e Etancelin. Farina,
Campione del Mondo
di F1 1950,
viene portato in trionfo dalla folla.
Gran Premio d'Italia 1951
14º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 7 di 8 del Campionato 1951
Monza - domenica 16 settembre 1951 - 80 giri x 6.300 km - 504.000 km
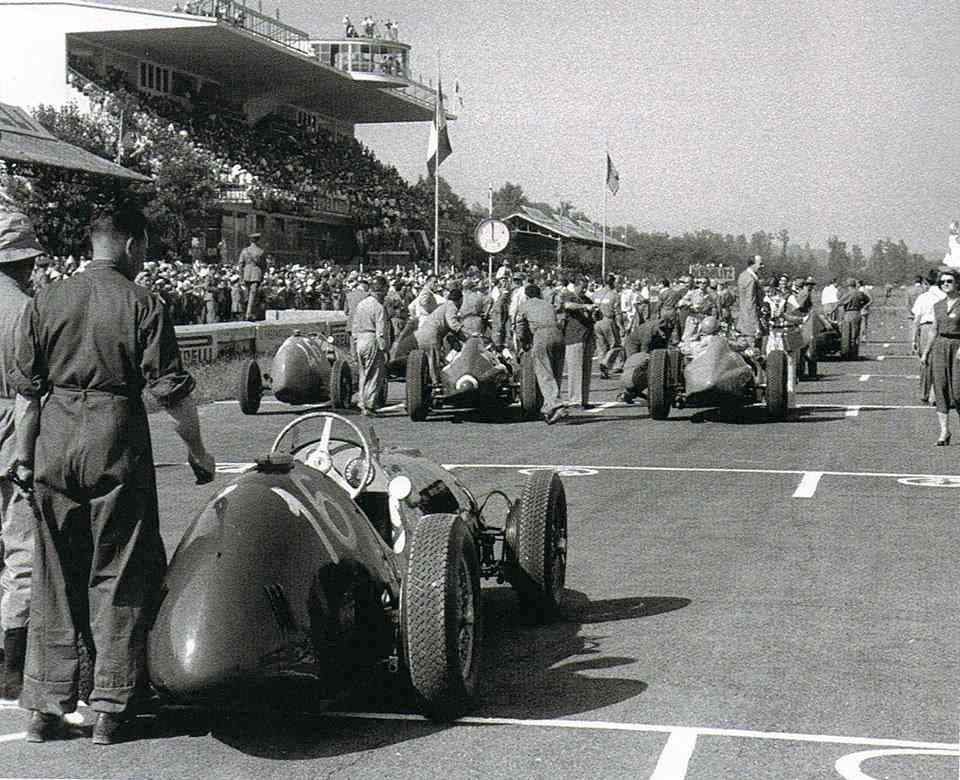
Il Gran Premio d'Italia 1951 si è svolto ad una settimana di distanza dal GP delle Nazioni di motociclismo che aveva occupato il circuito nella seconda domenica di settembre, data abituale per questa gara di Formula 1.
La gara fu vinta da Alberto Ascari su Ferrari, davanti al compagno di squadra José Froilán González; per la scuderia del cavallino si trattò inoltre della prima doppietta nella sua storia, oltre al primo successo sul circuito
brianzolo.
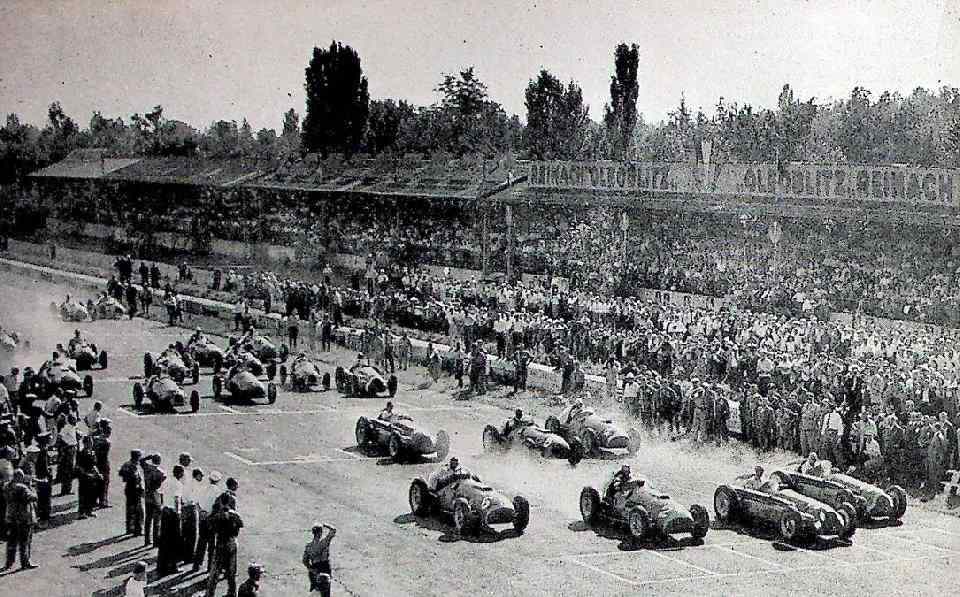
|
Dopo due vittorie della Ferrari nelle gare di Campionato, Juan-Manuel Fangio torna a vincere a Bari per l'Alfa Romeo
preannunciando una grande sfida a Monza tra le 2 scuderie italiane.
Alfa Romeo si presenta con Fangio, Nino Farina, Felice Bonetto e Toulo
de Graffenried mentre Ferrari porta sette vetture tra cui sono presenti
Alberto Ascari, Luigi Villoresi, José Froilán
González, Piero Taruffi e Chico Landi. Oltre alle consuete
Talbot-Lago sono presente la BRM, OSCA e Simca-Gordini.
La prima fila vede Fangio e Farina insieme ad Ascari e González
mentre Villoresi, Taruffi, Bonetto e Reg Parnell finiscono in seconda
fila. Le due BRM non partiranno per problemi alle loro vetture.
Alla partenza Fangio va in testa ma dopo pochi giri deve lasciar
passare Ascari. Ma l'argentino non molla e torna al comando poco prima
del cambio gomme.
Farina e de Graffenried si ritirano presto ma Farina torna in gara con
la vettura di Bonetto. Questo lascia González in seconda piazza. Fangio
prova a riprendere le due Ferrari ma il suo motore
va in fumo e Farina riesce ad arrivare terzo, passando Villoresi. La
sua Alfa è molto veloce ma il poco carburante lo costringe a fare 3 pit
stop.
Il risultato di Monza costringe tutti ad attendere l'ultima gara in Spagna per sapere chi sarà il Campione del Mondo.
|
|
Dopo due vittorie della Ferrari nelle gare di Campionato, Juan-Manuel Fangio
torna a vincere a Bari per l'Alfa Romeo preannunciando una grande sfida
a Monza tra le 2 scuderie italiane. Alfa Romeo si presenta con Fangio,
Nino Farina, Felice Bonetto e Toulo de Graffenried mentre Ferrari porta
sette vetture tra cui sono presenti Alberto Ascari, Luigi Villoresi,
José Froilán González, Piero Taruffi e Chico
Landi. Oltre alle consuete Talbot-Lago sono presente la BRM, OSCA e
Simca-Gordini.
La prima fila vede Fangio e Farina insieme ad Ascari e González
mentre Villoresi, Taruffi, Bonetto e Reg Parnell finiscono in seconda
fila. Le due BRM non partiranno per problemi alle loro vetture.
Alla partenza Fangio va in testa ma dopo pochi giri deve lasciar
passare Ascari. Ma l'argentino non molla e torna al comando poco prima
del cambio gomme.
Farina e de Graffenried si ritirano presto ma Farina torna in gara con
la vettura di Bonetto. Questo lascia González in seconda piazza. Fangio
prova a riprendere le due Ferrari ma il suo motore
va in fumo e Farina riesce ad arrivare terzo, passando Villoresi. La
sua Alfa è molto veloce ma il poco carburante lo costringe a fare 3 pit
stop.
Il risultato di Monza costringe tutti ad attendere l'ultima gara in Spagna per sapere chi sarà il Campione del Mondo.
|
|
BRM P15
|
 |
| Enzo Ferrari (a sinistra) ed Alberto Ascari sul muretto dell'Autodromo di Monza nel 1952. |
 |
Monza
La partenza del Gran Premio d'Italia1951 |
|
|
|
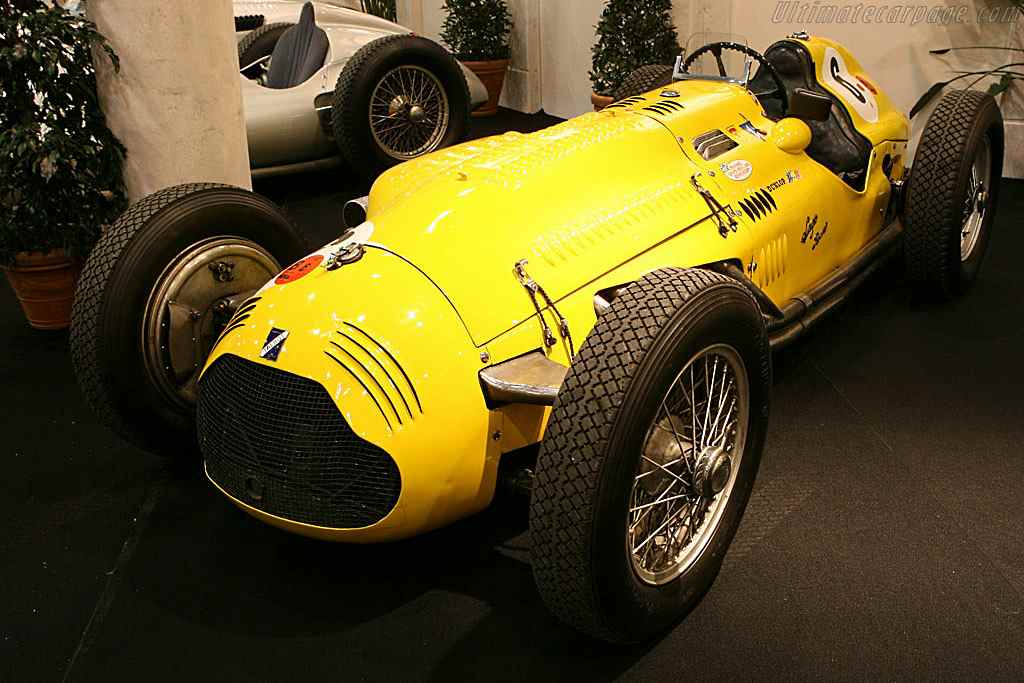
Il
costruttore francese ha partecipato con una propria squadra al
Campionato di Formula 1 negli anni 1950 e 1951 per un totale di 13 Gran
Premi, ottenendo come miglior risultati due terzi posti con Louis
Rosier.
Migliori
risultati furono ottenuti in quel periodo nella 24 Ore di Le Mans, in
particolare nell'edizione del 1950 dove una Talbot-Lago T26 trasformata
in biposto e dotata di parafanghi, vinse la gara guidata da Louis Rosier
e dal figlio Jean-Louis.
|
|
Alfa Romeo 159
Juan Manuel Fangio al volante
dell’”Alfetta 159” al Gran Premio della
Svizzera, al Bremgarten (Berna), nell’edizione del 1951,
che
andrà a vincere: in quell’anno il campione
argentino si aggiudica il primo dei suoi cinque allori mondiali.
Fangio
ricorderà sempre con profonda stima e riconoscenza
l’esperienza in Alfa Romeo, che lo ha lanciato
ai vertici
dell’automobilismo mondiale.
La mitica “Alfetta” è stata una
monoposto che ha chiuso un’epoca per l’Alfa Romeo:
la casa milanese si ritira imbattuta dalle
competizioni per dedicarsi
alla produzione in serie.
 |
1951 - Gran Premio di Francia
Reims
domenica 1 luglio 1951 - 77 giri x 7.816 km - 601.832 km
|
|
Il XXXVIII Gran Premio dell'Automobile Club di Francia, valido anche come XII Gran Premio d'Europa, fu l'edizione del 1951 del Gran Premio dell'Automobile Club di Francia (oggi chiamato "Gran Premio di Francia") e del Gran Premio d'Europa.
Il gran premio,
per vetture di Formula 1 e valido per il campionato del 1951, si
è disputato il 1º luglio 1951 sul Circuito di Reims.
Il GP di Francia fu la quarta prova del Mondiale 1951 e vide un quartetto di Alfa Romeo 159
contro tre Ferrari 375 e la Ferrari Thinwall Special. In aggiunta la
Gordini portò 4 vetture al GP di casa. Alfa Romeo riportò
in pista Luigi Fagioli mentre José Froilán
González guidò una Ferrari per la prima volta. In
qualifica Fangio e Farina su Alfa furono più veloci, con la
Rossa di Ascari terza a chiudere la prima fila. In partenza Ascari
andò in testa con Fangio dietro. Entrambi si ritirarono presto e
Villoresi ebbe dei problemi avvantaggiando Farina, autore di una
pessima partenza. González e Fagioli gli stavano dietro. Al suo
pit-stop Fagioli lasciò la vettura a Fangio e González fu
rimpiazzato da Ascari.
Questo non preoccupò Farina che rimase in testa fino al secondo
pit-stop, quando cominciò a soffrire di diversi problemi, lasciando così
la vittoria a Fangio, in coppia con Fagioli (unica vittoria in carriera
per il pilota italiano), con un minuto su Ascari che si aggiudicò il
secondo posto assieme al compagno di squadra González; Villoresi
concluse terzo a 3 giri. Parnell finì quarto riuscendo a piazzarsi
davanti allo sfortunato Farina.
|
Juan Manuel Fangio - José Froilàn Gonzàlez
Silverstone, 1951: 1ª vittoria Ferrari in
Formula 1
12º GP del Mondiale di Formula 1 - Gara 5 di 8 del Campionato 1951
Enzo Ferrari con Aurelio Lampredi
progettista del motore 4500 di cilindrata
 |
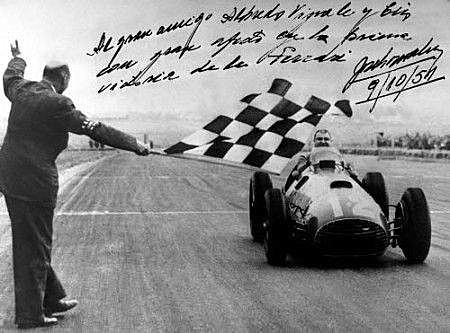 |
Ferrari 375 V 12 - 1951 Gonzalez |
Il primo successo
con un motore 4500 di cilindrata, montato sulla Tipo 375 F1 e portato
al successo a Silverstone
da Froilan Gonzalez, dopo avere progettato un
3300, quindi un 4100 ed infine lo storico 4500.
Sviluppa poi il
progetto del Tipo 500 F2 che porterà a Maranello due titoli
mondiali con Alberto Ascari nel 1952 e 1953.
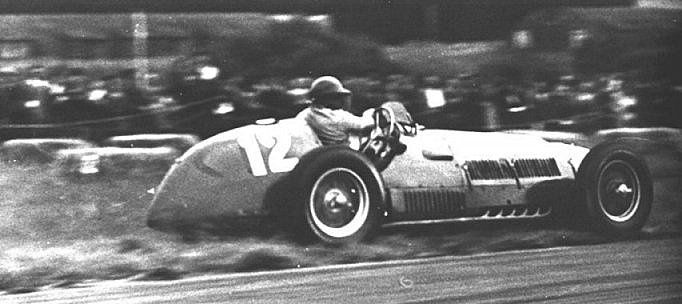 |
 |
Il weekend del Gran Premio d'Inghilterra si svolge alla metà di luglio 1951. I
piloti schierati dalla Ferrari sono Ascari, Villoresi e Gonzalez. Nel Libro
delle Corse del 1951 si legge che durante il "Primo Allenamento", corrispondente
alle attuali prove libere del venerdì, in questo caso il 12 luglio 1951, il
miglior tempo della giornata era stato segnato da Froilan Gonzalez, che aveva
girato in 1.43:4, seguito da Fangio e Farina su Alfa Romeo. Le prove del sabato
avevano invece visto lo scavalcamento dell'Alfa sulla Ferrari, con il miglior
tempo fatto segnare da Juan Manuel Fangio. La griglia di partenza vedeva in
prima fila Ascari (Ferrari), Farina (Alfa R.), Fangio (Alfa R.) e Gonzalez
(Ferrari), in seconda Bonetto (Alfa R.), Sanesi (Alfa R.) e Villoresi
(Ferrari).
Il Gran Premio d'Inghilterra, disputato il 14 luglio, prevedeva 90 giri e il
tracciato misurava 4,649 km, per un totale di 418.421 km. Alla partenza prendeva
la testa Bonetto; alla fine del primo giro è ancora in testa, seguito da
Gonzalez, Farina, Ascari, Fangio e Villoresi. Al secondo giro Gonzalez assume il
comando davanti a Bonetto e manteneva la testa fino alla 9a tornata. Al 10° giro
era in testa Fangio e Gonzalez è secondo, e questa situazione permaneva fino al
20esimo giro. Nel corso del 40esimo giro invece le posizioni erano Gonzalez,
Fangio, Farina, Ascari, Villoresi. Al 50esimo giro Gonzalez si trovava ancora in
testa e amministrava un vantaggio di 1.14 su Fangio, seguito da Ascari, Farina e
Villoresi, quinto. Villoresi si ritirava al 57° giro; al 60° Gonzalez si fermava
per il rifornimento di carburante (tempo di sosta: 15 secondi), e rientra
davanti a Fangio, indietro di 56 secondi. Il vantaggio su Fangio si allungava a
circa 1.20:000 e porta alla conclusione con l'ordine di arrivo: Gonzalez,
Fangio, Villoresi, Bonetto.
La vittoria della Ferrari in
F1 segnava simbolicamente il sorpasso della squadra corse di Maranello nei
confronti
della grande rivale, l'Alfa Romeo, dove Enzo Ferrari aveva
lavorato per vent'anni.
Enzo Ferrari ricevette la notizia per
telefono con molto ritardo, mentre si trovava solo nel suo ufficio; il giorno
dopo un telegramma del presidente di Alfa Romeo inorgogliva ancor di più Ferrari
per quella vittoria tanto agognata.
Con un consumo di benzina che si aggirava attorno ai 35 litri per 100
km le 375 offriromo fiera opposizione
all’Alfetta fino al
termine della stagione 1951.
|
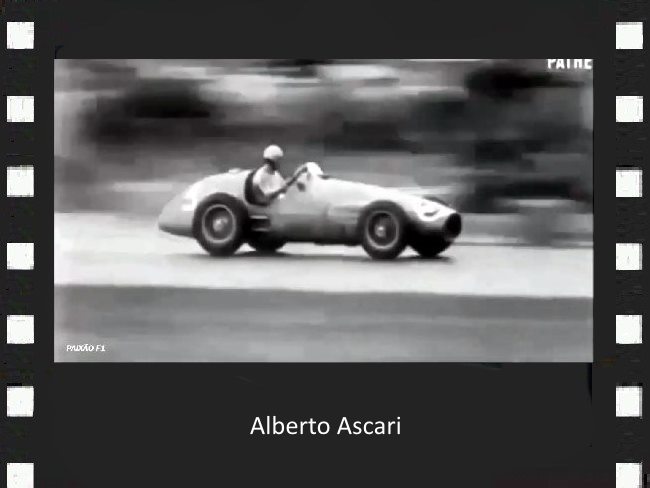
| L'avventura di Ascari a Indy |
|
La prima apparizione della 375 Indy avvenne al Gran Premio di Torino
del 1952 con alla guida Luigi Villoresi che si aggiudicò la gara. A
metà maggio circa la 375 Indy venne trasferita negli Stati Uniti
dove Ascari cominciò a prendere confidenza con il circuito e fu
costretto così a saltare il Gran Premio di Svizzera, primo appuntamento
della stagione di Formula 1.
In gara la Ferrari si presentò con quattro vetture: una gestita dalla NART
di Chinetti e guidata da Ascari e le altre tre affidate a team
americani. Una curiosità deriva dal fatto che la vettura di Ascari, non
sapendo se la squadra avrebbe partecipato in veste ufficiale, si
presentò alle qualifiche con il Cavallino Rampante nascosto sotto del
nastro adesivo per poi riapparire in gara.
Sin dalle qualifiche la 375 Indy palesò la sua inadeguatezza alla
gara americana e solo Ascari riuscì a qualificarsi conquistando il 19º
posto in griglia. Infatti, nonostante le vetture americane fossero più
rozze, erano perfettamente adattate a quel particolare tipo di gara. In
gara Ascari si dimostrò comunque all'altezza della situazione riuscendo a
guadagnare qualche posizione nei primi giri ma fu costretto al ritiro
al 40º passaggio a causa della rottura di un mozzo ruota.
Due anni dopo, alla 500 Miglia del 1954
lo statunitense Danny Oakes tenterà nuovamente senza successo di
qualificare la 375 e nel 1958 la NART iscrisse il pilota Harry Schell
alla 500 Chilometri di Monza senza però ben figurare.
 |
| Giovedì 5 giugno 1952 all'aeroporto di Malpensa la signora Maria Antonietta
Tavola in Ascari, detta Mietta, con i figli Tonino e Patrizia, assieme a vari
collaboratori del team Ferrari attendono Alberto Ascari, di ritorno dopo più di
un mese da Indianapolis. Dopo un viaggio durato 24 ore, il pilota scende
dall'aereo elegante e rilassato e racconta brevemente al giornalista Matuella
che cosa è avvenuto sul circuito: "La macchina si è puntata sulla ruota
posteriore destra e ha girato su se stessa. Poi mi sono sentito trasportare
all'indietro verso il prato all'interno della pista e lì mi sono arrestato". |
 |
|
Scheda
tecnica Ferrari 375 "Indy"
Costruttore Scuderia Ferrari - Categoria 500 Miglia di Indianapolis
Squadra NART-Ferrari - Progettata da Aurelio Lampredi
Motore anteriore longitudinale - 12 cilindri a V di
60° - Alesaggio e Corsa 80 x 74,5 - cilindrata totale 4493,73 cmc
rapp.compressione 13:1 -Distribuzione 2 valvole per cilindro
Alimentazione 3 carburatori doppio corpo Weber - Potenza 400 CV a 7500
giri
Trazione posteriore -Cambio longitudinale a 4 rapporti + RM in blocco
con differenziale autobloccante ZF
Sospensioni anteriore: a ruote indipendenti con bracci oscillanti e
balestra posteriore: Ponte De Dion con balestra trasversale
Gomme Firestone anteriori: da 16"posteriori da 18"
Freni a tamburo Dimensioni lunghezza: 3.937 mm larghezza: 1.428 mm Altezza: 960 mm Peso 829 kg
Esemplari prodotti 4
|
|
|
 |
Gran Premio di Svizzera 1952 |
 |
|
|
Bremgarten - domenica 18 maggio 1952 - 62 giri x 7.280 km - 451.360 km
 |
|
Il
primo Gran Premio della stagione 1952 è il Gp di Svizzera a
Bremgarten vicino Berna. Il pre-campionato aveva visto tentativi di
continuare con la precedente Formula 1, ma fu un flop perché
solo la Ferrari era davvero competitiva a causa del ritiro dell'Alfa
Romeo dalla corse. Alla fine si è deciso che il mondiale si
corre con le regole di Formula 2 e c'era una buona affluenza in
Svizzera.
La Ferrari ha 3 500
per Nino Farina, Piero Taruffi e André Simon, Alberto Ascari
è impegnato ad Indianapolis e Luigi Villoresi è fuori per
un grave incidente. Una macchina simile è guidata dalla Ecurie
Espadon per Rudolf Fischer e la Scuderia Rosier ha un'altra rossa per
Louis Rosier. C'era la possibilità che la Maserati portasse Juan-Manuel Fangio
e José Froilán González con la nuova A6GCM ma non
fu così. Gordini ha tre vetture per Jean Behra, Prince Bira e
Robert Manzon e la HWM è sostenuta da George Abecassis, Peter
Collins, Stirling Moss e Lance Macklin.
C'erano
due scuderie locali, con Hans Stuck per l'AFM e Toni Ulmen per la
Veritas-Meteor e un trio di motorizzate Bristol: Ken Wharton con la Frazer-Nash e due Cooper 20 per Eric Brandon e Alan Brown.
In prova Farina fa la pole con Taruffi e Manzon accanto a lui.
Dietro di loro Simon e Fischer con la terza fila capeggiata da Collins,
Behra ed Emanuel de Graffenried in una vecchia Maserati.
In gara Farina comandò la sua Ferrari fino a quando si ruppe.
Questo lasciò Taruffi comandare fino alla fine della corsa. Farina prese
la macchina di Simon ma si ruppe anche quella. Moss dopo una grande
gara fu costretto al ritiro lasciando Behra e Simon battagliare per il
secondo posto fino a quando Simon è stato richiamato. Alla fine sarà
Fischer a piazzarsi secondo davanti a Behra e Wharton.
|
|
|
Gran Premio di Gran Bretagna 1953
Silverstone - sabato 18 luglio 1953 - 90 giri x 4.711 km - 423.990 km
|

1953 Gran Premio di Gran Bretagna: Ascari - Gonzalez - Hawthorn - Fangio
|
- 12° vittoria per Alberto Ascari
- 10° podio per Juan Manuel Fangio
- 1º Gran Premio per Jack Fairman
- 1° e unico Gran Premio per Ian Stewart e Jimmy Stewart
- Ultimo Gran Premio per Duncan Hamilton e Tony Crook
- 15° vittoria per la Ferrari
- 40° podio per la Ferrari
- 10º giro più veloce per la Ferrari
- 15° vittoria per il motore Ferrari
- 10º giro più veloce per la Ferrari
|
 |
29o Gran Premio. VI RAC British Grand Prix.
 |
Il Gran Premio di Gran Bretagna 1953 fu la sesta gara della stagione 1953 del Campionato mondiale di Formula 1,
disputata il 18 luglio sul Circuito di Silverstone. La manifestazione vide la vittoria di Alberto Ascari su Ferrari,
seguito da Juan Manuel Fangio su Maserati e da Nino Farina su Ferrari. |
Alberto Ascari ha scritto pagine epiche della storia della Ferrari e della Formula Uno. Dopo aver vinto il primo titolo mondiale per la scuderia
del Cavallino Rampante nel 1952, seppe centrare il bis immediato nel 1953,
in un biennio nel quale non lasciò scampo a nessuno.
Dominante, senza
mezzi termini. In una epoca nella quale i piloti erano chiamati a
superarsi gara per gara, con il rischio della morte
che si nascondeva
veramente dietro ogni curva, e una passione che tracimava, dentro e
fuori la pista.
|
|
|
 |
VIDEO
1953 Monza Alberto Ascari Crash
Come descrivevano i giornalisti sportivi dell'epoca
e quelli più recenti i piloti, le vetture e i fatti dal
"mondo delle corse automobilistiche"?.
A volte articoli romanzati per raccontare le gesta eroiche degli
Ascari, dei Campari, Varzi e Nuvolari; a volte invece per raccontare
fatti che in uno sport non dovrebbero mai succedere: gli incidenti.
Anche le riviste d'epoca sono entrate a far parte con diritto del
collezionismo e leggendole sembra di rivivere "in loco" i fatti
narrati. Copertine che sembrano quadri d'autore, articoli, specialmente
quelli ante anni '50, che descrivono i fatti con licenza poetica. Vita,
corse e amori dei cavalieri del rischio, come amavano essere definiti i
piloti.
Scorriamo a ritroso nel tempo leggendone i grandi titoli di
richiamo che i maestri della carta stampata ci hanno
tramandato a
conferma di una passione che mai tramonterà: quella delle
corse automobilistiche.
|
|

L'unico
pilota italiano ad aver vinto il mondiale piloti con la
Ferrari, e anche il primo a portarlo alla casa di Maranello,
è stato Alberto
Ascari. L'impresa gli riuscì addirittura per due stagioni consecutive: 1952
e 1953.
L'Alfa Romeo, con le sue
mitiche "Alfetta" 158 e
159, si era ritirata dalle competizioni alla fine del 1951 dopo aver dominato
l'automobilismo per oltre un decennio. In quell'anno Ascari, vincendo al Nürburgring
e a Monza, aveva cominciato ad insidiare la supremazia di Fangio e della casa
del quadrifoglio. All'inizio del 1952 Fangio, passato alla Maserati, ebbe un
serio incidente in prova a Monza e fu costretto a saltare tutta la stagione.
Toltosi di mezzo l'avversario più pericoloso, per Ascari la vita f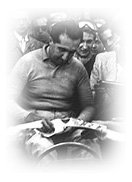 u
relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra
Piero Taruffi, e tentò l'avventura
nella 500 miglia di Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non
fu un grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si qualificò al
diciannovesimo posto, mentre in gara si ritirò dopo 40 giri. Comunque Ascari si
rifece ampiamente dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo
cinque pole position e cinque giri più veloci in gara. u
relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra
Piero Taruffi, e tentò l'avventura
nella 500 miglia di Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non
fu un grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si qualificò al
diciannovesimo posto, mentre in gara si ritirò dopo 40 giri. Comunque Ascari si
rifece ampiamente dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo
cinque pole position e cinque giri più veloci in gara.

Nel 1953 ritorna Fangio, ma la musica non cambia: Ascari vince
cinque gare su otto, è quarto in Francia, ottavo in Germania,
poi a Monza, nell'ultima prova dell'annata, mentre sta disputando la volata per il successo
con Fangio e Farina, è vittima di un incidente
all'ultima curva detta del
porfido, antenata della celeberrima parabolica. Poco male comunque: il milanese
si porta a casa il suo secondo titolo mondiale,
per sé e per la Ferrari, con la
quale in due anni aveva formato un binomio praticamente imbattibile.
L'unico pilota italiano ad aver vinto il mondiale
piloti con la Ferrari, e anche il primo a portarlo alla casa di
Maranello, è stato Alberto Ascari. L'impresa gli
riuscì addirittura per due stagioni consecutive: 1952 e
1953.
L'Alfa Romeo, con le sue mitiche "Alfetta" 158 e 159, si era ritirata
dalle competizioni alla fine del 1951 dopo aver dominato
l'automobilismo per oltre un decennio. In quell'anno Ascari, vincendo
al Nürburgring e a Monza, aveva cominciato ad insidiare la
supremazia di Fangio e della casa del quadrifoglio. All'inizio del 1952
Fangio, passato alla Maserati, ebbe un serio incidente in prova a Monza
e fu costretto a saltare tutta la stagione. Toltosi di mezzo
l'avversario più pericoloso, per Ascari la vita fu
relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della
stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra Piero
Taruffi, e tentò l'avventura nella 500 miglia di
Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non fu un
grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si
qualificò al diciannovesimo posto, mentre in gara si
ritirò dopo 40 giri.
Comunque Ascari si rifece ampiamente
dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo cinque pole
position e cinque giri più veloci in gara.
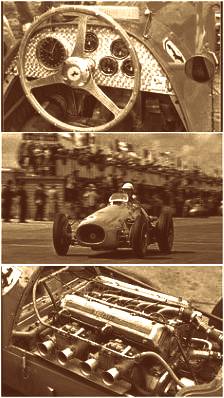 |
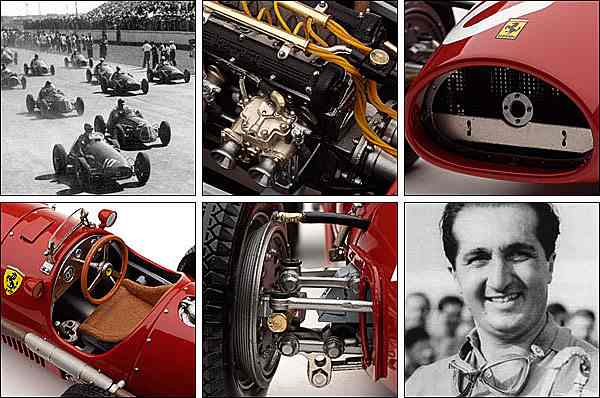 |
|
Nel 1953 ritorna Fangio, ma la musica non cambia: Ascari vince cinque
gare su otto, è quarto in Francia, ottavo in Germania, poi a
Monza, nell'ultima prova dell'annata, mentre sta disputando la volata
per il successo con Fangio e Farina, è vittima di un
incidente all'ultima curva detta del porfido, antenata della
celeberrima parabolica. Poco male comunque: il milanese si porta a casa
il suo secondo titolo mondiale, per sé e per la Ferrari, con
la quale in due anni aveva formato un binomio praticamente imbattibile. |
Reims - Gran Premio F1 1953
domenica 5 luglio 1953 - 60 giri x 8.347 km - 500.820 km
|
|
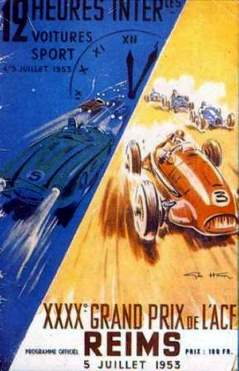
|

|
|
Sul tracciato di Reims un pilota inglese, Mike
Hawthorn, vince per la prima volta un gran premio di F1 valido per il
mondiale |
La prima fase della corsa è dominata da Gonzalez, con la sua
Maserati. L'argentino viene lanciato all'attacco con solo
metà serbatoio pieno di benzina: una tattica aggressiva che
serviva a mettere pressione alle Ferrari. Quando Gonzalez si ferma al
box per fare rifornimento, gli passano davanti Ascari, Fangio,
Hawthorn, Farina, Morimon e Villoresi. Da lì a breve, la lotta per la vittoria si restringe a
Hawthorn e Fangio, dopo che i due hanno passato Ascari. La sfda si svolge sui lunghi rettilinei nella campagna francese. I due
procedono ravvicinati, appaiati. Possono persino vedere l'espressione
sul viso dell'altro, la leggenda vuole che si siano scambiati dei
sorrisi, cavallereschi. All'ultima curva dell'ultimo l'inglese supera Fangio ed ottiene la
vittoria. |
|
|
Il Gran Premio di Germania 1953
fu la settima gara della stagione 1953 del Campionato mondiale di
Formula 1, disputata il 2 agosto sul Circuito del Nürburgring. La
manifestazione vide l'ultima vittoria in carriera di Nino Farina su
Ferrari, seguito da Juan Manuel Fangio su Maserati
e da Mike Hawthorn su Ferrari. È stato il Gran Premio di Formula 1 con il maggior
numero di piloti al via, ben 34.
Nonostante
il mancato piazzamento a punti, Alberto Ascari conquista in questo Gran
Premio il suo secondo e ultimo titolo mondiale,
con 2 gare di anticiposulla fine del Campionato.
|
|
|
 |
|
L'inizio
La
leggendaria Auto Union del '37
|
La
F1, rappresentando fin dagli esordi nei primi anni '50 la punta
di diamante delle competizioni automobilistiche mondiali, dette
modo ai progettisti di dare il meglio di sé in ogni settore. In
particolare l'aerodinamica assunse subito un ruolo abbastanza
importante (nonostante i limiti tecnologici dell'epoca), in
quanto, per definizione, le monoposto di F1 hanno il grosso
handicap delle ruote scoperte, che rappresentano un notevole
freno aerodinamico. Si presentava quindi il problema di trovare
una forma per i bolidi che garantisse la miglior penetrazione
nell'aria. I primi progettisti non dovettero sforzarsi più di
tanto nell'individuare tale forma, dato che era già presente in
natura: la goccia. |
|
La
Ferrari D50 (che era in origine un progetto Lancia) vinse il
mondiale di F1 nel '56 con Fangio
|
|
|
Seguendo
una moda che era già in voga nel periodo fra le due guerre, le
fusoliere venivano disegnate con la forma più affusolata
possibile, piazzando apposite bombature alle spalle del pilota o
nelle fiancate (vedi la D50) in modo da rendere il più
possibile laminare il movimento (relativo) dell'aria attorno al
corpo vettura e quindi da limitare le turbolenze. |
|
 |
|
Gianni Lancia con la Signora Lancia 20 febbraio 1954 Primo collaudo della D50 alla presenza di Gianni Lancia
Si può entrare nella storia delle corse
in solo un’anno e mezzo a partire dall’idea progettuale fino al ritiro? A
leggere la storia della Lancia
si penserebbe proprio di si. Non ci sono
vittorie, titoli o numeri altisonanti in questa storia, ma solo il
piacere (e anche un pò di nostalgia)
nel sapere che l’Italia a quel
tempo era la nazione più forte nel motorsport grazie ad Alfa Romeo,
Ferrari, Maserati e appunto Lancia.
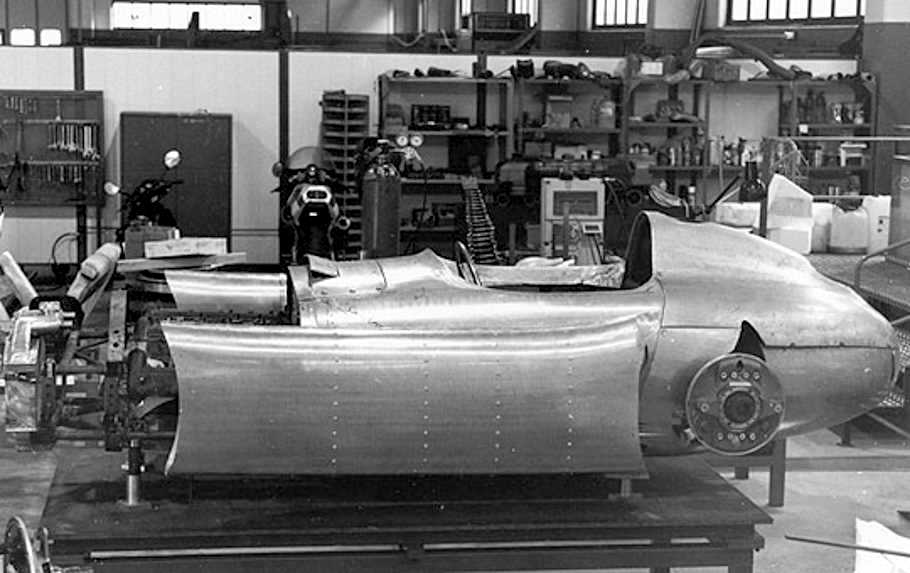
Il
debutto ufficiale nei Gran Premi è programmato per il Gp di Francia, ma
problemi strutturali spingonoa ritardare il debutto di qualche mese.
|
 |
Motore: 8 cilindri a V di
90° - Cilindrata: 2488 cm3 Potenza max: 260 CV - Velocità max: 300
km/h
Nell’estate
del 1953, Gianni Lancia è da 6 anni a capo della casa automobilistica
torinese omonima. Figlio del fondatore Vincenzo, Gianni Lancia ha già
dimostrato grande interesse per le corse, spendendo cifre astronomiche
per portare il marchio a correre nei prototipi. La Formula 1 è sempre
più un campionato crescente e a Gianni Lancia interessa eccome debuttare
anche li dove si sfidano: Ferrari, Maserati, Mercedes, Cooper, Gordini,
ecc.Così affida al suo progettista di fiducia, il leggendario Vittorio
Jano, lo studio e la progettazione di una nuova monoposto da Formula 1
da far debuttare nella stagione 1954.
Vittorio Jano sembra non attendesse
altro che l’ordine di poter mettere su carte le proprie idee e già in
Settembre il progetto è pronto e si può partire con la costruzione del
primo telaio. Gianni Lancia si incarica di seguire personalmente la
scelta dei piloti e di condurre le relative trattative. Lancia non si
accontentò di due nomi qualunque. L’idea era quella di entrare nel mondo
della Formula 1 come una bomba dinamitarda. Vincere. Solo quello
bisognava fare. La leggenda, mai verificata, narra che ci furono
contatti ben avviati anche con Fangio ma che la trattativa saltò per
l’opposizione Mercedes.
Alla fine Gianni Lancia riesce a
convincere niente poco di meno che il campione in carica Alberto Ascari e
il suo fido compagno non che suo amico fraterno Luigi “Gigi” Villoresi.
Il grande team Lancia pensa anche al futuro e a completare il trio di
piloti arriva Eugenio Castellotti, giovane 24enne promessa
dell’automobilismo italiano e considerato dai più erede naturale di
Ascari. A convincere il campione milanese pare sia stato un rapporto di
amicizia con Gianni Lancia che andava oltre quello professionale e si
espandeva alla mondanità. Leggenda vuole che a Giovanni Lancia sia
bastato mostrare ai 3 piloti il progetto della futura Lancia da Formula 1
per convincerli, ma la cosa più probabile è che dietro ci fosse una
vagonata di lire.
Il 21 gennaio 1954 avviene la firma dei
tre con la Lancia reparto corse e poco più di un mese dopo dovrebbe
avvenire la prima svezzata della Lancia D50, ovvero la prima Lancia da
Formula 1. La vettura fa la sua prima uscita il 20 febbraio e subito
appare rivoluzionaria. Le dimensioni sono nella media con le dirette
rivali, ma il peso è nettamente inferiore e ciò dovrebbe essere segno di
manegevolezza e praticità di guida. Inoltre i serbatoi sono in
posizione laterale al fianco del pilota, a dimostrazione che Vittorio ha
puntato tantissimo sulla praticità della macchina più che sulla potenza(comunque considerevole).
|
 |
Dopo un 1954 passato a rendere performante la monoposto, il debutto
ufficiale della Lancia D50 avviene all’ultima prova del mondiale in
Spagna. Ascari conquista una stratosferica pole position con Fangio e la
Mercedes (campioni del mondo) che nonostante un numero considerevole di
giri non riescono a impensierire l’alfiere Lancia. Ferrari e Maserati
inseguono ma, anche loro, lontanissime. Le Lancia, dunque, volano;
peccato che la loro gara dura 10 giri. Villoresi si ritira dopo due
tornate per problemi ai freni e al motore, mentre Ascari si deve
ritirare per guai alla frizione dovuti ad un difetto di progettazione.
Ascari, comunque, si toglie lo sfizio di far suo il giro più veloce che,
nonostante le poche tornate a disposizione, non verrà più battuto da
nessuno. Considerando che al momento del ritiro Ascari aveva 20 secondi
su Schell, si puà affermare che la Lancia D50 è velocissima come nessuno
ma anche troppo fragile |
|
Dopo un 1954 passato a rendere performante la monoposto, il debutto
ufficiale della Lancia D50 avviene all’ultima prova del mondiale in
Spagna. Ascari conquista una stratosferica pole position con Fangio e la
Mercedes (campioni del mondo) che nonostante un numero considerevole di
giri non riescono a impensierire l’alfiere Lancia. Ferrari e Maserati
inseguono ma, anche loro, lontanissime. Le Lancia, dunque, volano;
peccato che la loro gara dura 10 giri. Villoresi si ritira dopo due
tornate per problemi ai freni e al motore, mentre Ascari si deve
ritirare per guai alla frizione dovuti ad un difetto di progettazione.
Ascari, comunque, si toglie lo sfizio di far suo il giro più veloce che,
nonostante le poche tornate a disposizione, non verrà più battuto da
nessuno. Considerando che al momento del ritiro Ascari aveva 20 secondi
su Schell, si puà affermare che la Lancia D50 è velocissima come nessuno
ma anche troppo fragile
Per il 1955 le speranze sono tantissime
con Ascari in formissima (nel 1954 ha corso sporadicamente) e un
Villoresi pronto a farli da scudiero. In Argentina alla prima prova del
campionato (la gara con più avvicendamenti alla guida) Ascari si
qualifica secondo ma è costretto al ritiro per un incidente al 21esimo
passaggio. Villoresi eredita la D50 di Castellotti dopo che la sua si
dovette arrendere causa rottura del motore, ma si ritira per un
incidente al 36esimo passaggio. La competitività meccanica sembra più
vicini, ma ora a preoccupare sono le prestazioni al di sotto di quanto
visto qualche mese prima in Spagna. Nella seconda gara del campionato a
Montecarlo, Ascari è ottimo secondo con lo stesso tempo del poleman
Fangio. In gara dominano le Mercedes prima con Fangio poi col giovane
Moss, ma entrambe sono costrette al ritiro. In testa a 20 giri dalla
fine si trova Ascari ma è vittima di un incidente terribile. Alla
chicane del porto la Lancia vira improvvisamente verso l’esterno, sfiora
una tribuna con spettatori e cade in mare. Fortunatamente per lui un
sommozzatore si getta in acqua subito e Ascari è abile a divincolarsi
subito dalla vettura, ormai, destina a inabissarsi. L’unica
soddisfazione Lancia, la regala il giovane Castellotti secondo dietro a
Trintingnant..
|
|

|
Quattro
giorni più tardi, in seguito ad un test dove non doveva neanche essere
presente, Alberto Ascari perde la vita in un incidente alla curva del
vialone ancora oggi avvolto dal mistero. Questa tragedia segna la fine
della Lancia in Formula 1. Un comunicato stampa annuncia in simultanea
il ritiro dalle competizioni con effetto immediato, anche se a Villoresi
e Castellotti viene concesso il permesso di correre con le Lancia fino a
fine stagione. Con un triplice accordo Lancia-Fiat-Ferrari, tutte le 6
D50 prodotte, l’intero personale e tutto il materiale viene ceduto (con
una cerimonia in pompa magna il 26 luglio 1955) a prezzo politico alla
Ferrari, evitando così che tutto il patrimonio sportivo messo su dalla
Lancia finisca in mano ai tedeschi. Nel 1956 a Maranello arriva Fangio e
su una Lancia-Ferrari D50 si laureerà campione del mondo. |
 |
|
Modena, 2 agosto 1955 - Ferrari Farina e Jano gurdano Trintignant provare la nuova D50
Motore: anteriore/traz.posteriore - N/cilindri: v8
di 90° - Cilindrata: 2486 cc - Potenza/Giri: 265 Cv/8000
Alimentazione:
4 carburatori Solex 40 PII - Telaio: tubolare -
Produzione: 1956 - Carrozzeria: alluminio
Cambio: 5 rapporti -
Dimensioni: cm 385x144x96 - Peso: kg 64 -
Serbatoio: 190 litri
Piloti: Castellotti, Collins, De Portago, Fangio, Musso
|
Innovativa ed originale dal punto di vista meccanico (il telaio è realizzato in
cromomolibdeno) lo è anche per la disposizione di molti organi e per la
realizzazione di due serbatoi di carburante appoggiati lateralmente alla
struttura della vettura.
Grazie anche al motore inclinato in pianta di 8°
rispetto all'asse longitudinale, che consente all'albero di trasmissione di
passare a fianco del sedile di guida, la vettura vanta un baricentro molto
favorevole. Il telaio della vettura che vedete nelle immagini è il numero
5.
LE VITTORIE - Nel 1955 la D 50, pilotata da Alberto Ascari, vince a
Torino il Gran Premio del Valentino (sempre con la D 50 Gigi Villoresi è 3° ed
Eugenio Castellotti è 4°) e il Gran Premio di Napoli (3° Villoresi). Nello
stesso anno, nel Gran Premio di Monaco, Alberto Ascari, al comando della gara, a
pochi giri dal traguardo vola in mare senza gravi conseguenze.
La Lancia è entrata nella storia del
motorsport italiano pur senza vincere un Gran Premio e correndone
solamente 3 in veste ufficiale. Il progetto era buono e lo dimostra il
titolo arrivato l’anno dopo quando le D50 erano marcate Ferrari. La
Lancia si è guadagnata spazio nei rally; Stratos, 037, Delta S4 e Delta
Gruppo A hanno dominato nelle strade portando rivoluzioni tecniche che
hanno stravolto il mondo delle corse. La Delta S4 può essere vista un pò
come la figlia della D50. Rivoluzionaria, brutali, veloci, affascinanti
ma rovinate da due tragedie. Toivonen al Tour de Corse 86 e Ascari in
quel tragico test a Monza nel 55. Entrambe hanno anche un minimo comun
denominatore: se il destino non ci avesse messo lo zampino avrebbero,
probabilmente, disegnato alla loro maniera le corse della loro epoca.
|

|
 Rimessasi
in sesto dopo la fine della guerra, la Mercedes inizia a pianificare il
proprio ritorno sui circuiti. Neubauer si impegna molto nella ricerca
di macchine da corsa ancora funzionanti fra quelle rimaste nascoste
durante la guerra. I risultati ottenuti dalla Mercedes nel tentativo di
modificare queste vetture sono però piuttosto incerti. Di qui la
necessità di costruirne di nuove. Il modo più economico per farlo sembra
essere quello di convertire un'auto da granturismo in veicolo da
competizione e la macchina prescelta, realizzata con materiali di
recupero, è la 300 SL. Una delle sue caratteristiche più peculiari sono
le portiere. Il telaio tubolare dell'auto rende impossibile l'uso di
portiere tradizionali e, dopo attenti studi, viene adottato un si Rimessasi
in sesto dopo la fine della guerra, la Mercedes inizia a pianificare il
proprio ritorno sui circuiti. Neubauer si impegna molto nella ricerca
di macchine da corsa ancora funzionanti fra quelle rimaste nascoste
durante la guerra. I risultati ottenuti dalla Mercedes nel tentativo di
modificare queste vetture sono però piuttosto incerti. Di qui la
necessità di costruirne di nuove. Il modo più economico per farlo sembra
essere quello di convertire un'auto da granturismo in veicolo da
competizione e la macchina prescelta, realizzata con materiali di
recupero, è la 300 SL. Una delle sue caratteristiche più peculiari sono
le portiere. Il telaio tubolare dell'auto rende impossibile l'uso di
portiere tradizionali e, dopo attenti studi, viene adottato un si stema
di apertura verticale. Non appena le prime foto del nuovo modello
vengono pubblicate negli Stati Uniti i commentatori fanno notare che con
le portiere aperte l'auto ricorda un gabbiano, tanto da essere
battezzata "Gullwing" (ali di gabbiano).
Il debutto di queste nuove auto è la Mille Miglia. La Mercedes si
presenta con tre monoposto guidate da Kling, Lang e Caracciola. Kling,
il pilota di punta della Mercedes, finisce secondo. Caracciola, non del
tutto ristabilito dai postumi di un incidente a Indianapolis cinque anni
prima, si piazza eroicamente quarto, dopodiché guiderà un'ultima volta
prima di ritirarsi definitivamente dalle corse.
Caracciola, il pilota più famoso della Mercedes che Neubauer considera
il più grande di sempre, continuerà a lavorare per la Daimler-Benz fino
al 1959, anno della sua morte.
La gara successiva è il Gran Premio di Berna, una gara accessoria al
Gran Premio di Svizzera vero e proprio. Conquistando tutti i gradini del
podio, la Mercedes si prepara più agguerrita che mai alla 24 ore di Le
Mans.
Per l'occasione la Jaguar e la Ferrari presentano nuovi modelli da corsa
e la Mercedes risponde, com'è nel suo stile, con l'introduzione del
tettuccio frenante. Secondo la rivista specializzata Road & Track il
pilota si lancia con l'auto a tutta velocità, poi innesca il
dispositivo del tettuccio frenante che "scatta nel vento con un uop!"
facendo rallentare il bolide "come se la mano di un gigante l'afferrasse
d'improvviso" dai 240 ai 120 km/h, in pochissimi secondi. Il congegno
viene severamente testato ma non utilizzato in gara per motivi di
sicurezza.
La trovata del tettuccio frenante in verità ha il solo scopo di
vivacizzare la
vigilia della competizione e di disorientare la concorrenza. La gara ha
inizio
con le Mercedes particolarmente prudenti. Le Jaguar sono le prime a
dover
gettare la spugna. Nella seconda ora di gara tutte e tre le vetture
della
scuderia inglese sono fermate da problemi di surriscaldamento dei
motori. stema
di apertura verticale. Non appena le prime foto del nuovo modello
vengono pubblicate negli Stati Uniti i commentatori fanno notare che con
le portiere aperte l'auto ricorda un gabbiano, tanto da essere
battezzata "Gullwing" (ali di gabbiano).
Il debutto di queste nuove auto è la Mille Miglia. La Mercedes si
presenta con tre monoposto guidate da Kling, Lang e Caracciola. Kling,
il pilota di punta della Mercedes, finisce secondo. Caracciola, non del
tutto ristabilito dai postumi di un incidente a Indianapolis cinque anni
prima, si piazza eroicamente quarto, dopodiché guiderà un'ultima volta
prima di ritirarsi definitivamente dalle corse.
Caracciola, il pilota più famoso della Mercedes che Neubauer considera
il più grande di sempre, continuerà a lavorare per la Daimler-Benz fino
al 1959, anno della sua morte.
La gara successiva è il Gran Premio di Berna, una gara accessoria al
Gran Premio di Svizzera vero e proprio. Conquistando tutti i gradini del
podio, la Mercedes si prepara più agguerrita che mai alla 24 ore di Le
Mans.
Per l'occasione la Jaguar e la Ferrari presentano nuovi modelli da corsa
e la Mercedes risponde, com'è nel suo stile, con l'introduzione del
tettuccio frenante. Secondo la rivista specializzata Road & Track il
pilota si lancia con l'auto a tutta velocità, poi innesca il
dispositivo del tettuccio frenante che "scatta nel vento con un uop!"
facendo rallentare il bolide "come se la mano di un gigante l'afferrasse
d'improvviso" dai 240 ai 120 km/h, in pochissimi secondi. Il congegno
viene severamente testato ma non utilizzato in gara per motivi di
sicurezza.
La trovata del tettuccio frenante in verità ha il solo scopo di
vivacizzare la
vigilia della competizione e di disorientare la concorrenza. La gara ha
inizio
con le Mercedes particolarmente prudenti. Le Jaguar sono le prime a
dover
gettare la spugna. Nella seconda ora di gara tutte e tre le vetture
della
scuderia inglese sono fermate da problemi di surriscaldamento dei
motori.
 Anche
le vetture della Ferrari sono vittime di guasti meccanici vari. Così, del tutto
a sorpresa, si trova solo in testa Pierre Levegh, alla guida della sua Talbot.
Lo seguono due Mercedes che, nonostante il distacco di tre giri completi di
pista, non aumentano la velocità, mantenendosi sui 160 km/h. In breve, il
vantaggio di Levegh sale a 4 giri, ma le Mercedes insistono nel mantenere il
loro ritmo tranquillo. Neubauer non crede che Levegh possa portare a termine la
gara, sapendo che sta gareggiando senza squadra. A solo un'ora e 15 minuti dalla
fine Levegh sbaglia una marcia, rompe una biella ed è costretto al ritiro.
Neubauer aveva visto giusto e le Mercedes possono concludere in scioltezza al
primo e al secondo posto. Per quanto grandi siano queste auto, le 300SL sono
state impiegate solo come ripiego, in attesa di una vettura da Gran Premio vera
e propria. Le nuove norme applicate in Formula 1 nel 1954 determinano la
presentazione di molti nuovi modelli. Un modello di particolare interesse è la
Lancia D50, progettata dal rinomato ingegnere italiano Vittorio Jano. Il suo
motore offset V8 è parte integrante del telaio. La D50 è dotata di serbatoi
laterali esterni per mantenere la distribuzione del peso il più possibile
costante con il variare del carico di carburante. Il 1954 è anche l'anno che
vede l'annunciato ritorno di un modello Mercedes da Gran Premio. Le regole
attuali non obbligano all'uso di ruote scoperte e la W196, con le sue ruote
incluse nella sagoma della carrozzeria e linee affusolate, assomiglia molto ad
una vettura da Granturismo. Anche
le vetture della Ferrari sono vittime di guasti meccanici vari. Così, del tutto
a sorpresa, si trova solo in testa Pierre Levegh, alla guida della sua Talbot.
Lo seguono due Mercedes che, nonostante il distacco di tre giri completi di
pista, non aumentano la velocità, mantenendosi sui 160 km/h. In breve, il
vantaggio di Levegh sale a 4 giri, ma le Mercedes insistono nel mantenere il
loro ritmo tranquillo. Neubauer non crede che Levegh possa portare a termine la
gara, sapendo che sta gareggiando senza squadra. A solo un'ora e 15 minuti dalla
fine Levegh sbaglia una marcia, rompe una biella ed è costretto al ritiro.
Neubauer aveva visto giusto e le Mercedes possono concludere in scioltezza al
primo e al secondo posto. Per quanto grandi siano queste auto, le 300SL sono
state impiegate solo come ripiego, in attesa di una vettura da Gran Premio vera
e propria. Le nuove norme applicate in Formula 1 nel 1954 determinano la
presentazione di molti nuovi modelli. Un modello di particolare interesse è la
Lancia D50, progettata dal rinomato ingegnere italiano Vittorio Jano. Il suo
motore offset V8 è parte integrante del telaio. La D50 è dotata di serbatoi
laterali esterni per mantenere la distribuzione del peso il più possibile
costante con il variare del carico di carburante. Il 1954 è anche l'anno che
vede l'annunciato ritorno di un modello Mercedes da Gran Premio. Le regole
attuali non obbligano all'uso di ruote scoperte e la W196, con le sue ruote
incluse nella sagoma della carrozzeria e linee affusolate, assomiglia molto ad
una vettura da Granturismo. La W196 monta un motore a 8 cilindri inclinato di 25° rispetto la verticale,
ingegnoso espediente che consente ai progettisti di disegnare una carrozzeria
più affusolata e di abbassare il baricentro del mezzo. Il motore può inoltre
contare sui vantaggi dell'iniezione diretta e della valvola desmodromica. Le
Mercedes non sono pronte prima della terza gara della stagione, il Gran Premio
di Francia. La squadra è composta da Fangio, Karl Kling e Hans Herman. I loro
concorrenti più quotati sono Alberto Ascari, della scuderia Lancia ma
temporaneamente su una Maserati, Gonzalez su Ferrari e Moss alla guida di una
Maserati privata. Fangio e Kling si lanciano in testa alla corsa mentre l'auto
di Herman in quarta posizione accusa diversi problemi al motore. Gonzalez tenta
una rimonta ma i bolidi tedeschi sono assolutamente superiori e finiscono la
corsa con un convincente primo e secondo posto. Fangio, con le due vittorie
sulla Maserati presa in prestito a inizio stagione, è sul punto di diventare per
la seconda volta Campione del Mondo.
La W196 monta un motore a 8 cilindri inclinato di 25° rispetto la verticale,
ingegnoso espediente che consente ai progettisti di disegnare una carrozzeria
più affusolata e di abbassare il baricentro del mezzo. Il motore può inoltre
contare sui vantaggi dell'iniezione diretta e della valvola desmodromica. Le
Mercedes non sono pronte prima della terza gara della stagione, il Gran Premio
di Francia. La squadra è composta da Fangio, Karl Kling e Hans Herman. I loro
concorrenti più quotati sono Alberto Ascari, della scuderia Lancia ma
temporaneamente su una Maserati, Gonzalez su Ferrari e Moss alla guida di una
Maserati privata. Fangio e Kling si lanciano in testa alla corsa mentre l'auto
di Herman in quarta posizione accusa diversi problemi al motore. Gonzalez tenta
una rimonta ma i bolidi tedeschi sono assolutamente superiori e finiscono la
corsa con un convincente primo e secondo posto. Fangio, con le due vittorie
sulla Maserati presa in prestito a inizio stagione, è sul punto di diventare per
la seconda volta Campione del Mondo.
|
|
| Gran Premio di Spagna 1954 |
 |
|
|
Pedralbes - domenica 24 ottobre 1954 - 80 giri x 6.316 km - 505.280 km

|
| Lancia D50 di Alberto Ascari (34 ritiro frizione) e Luigi Villoresi (36 ritiro freni) |
La manifestazione vide la vittoria di Mike Hawthorn su Ferrari, seguito da Luigi Musso su Maserati
e Juan Manuel Fangio su Mercedes.
La
Lancia D50 di Alberto Ascari, al debutto nel mondiale, fa la pole
position in 2'18”1/10. Juan Manuel Fangio con la Mercedes W196
prova e riprova ma alla fine è di 1” più lento. La
Ferrari 53 di Mike Hawthorn e la Maserati 250F di Harry Schell segnano
lo stesso tempo, il terzo, ma sono staccate dalla Lancia di 2 secondi e
mezzo. Luigi Villoresi, con la seconda D50, è in seconda fila
con il quinto tempo. La prima fila vede dunque allineate quattro
macchine di quattro marche diverse, nell'ordine la Lancia D50 di
Ascari, la Mercedes W196 di Fangio, la Ferrari 553 di Hawthorn e la
Maserati 250F di Schell. Nomi altrettanto prestigiosi occupano la
seconda fila: Luigi Villoresi con la seconda delle Lancia D50 e le due
Maserati 250F di Stirling Moss e Luigi Musso.
Al
via scatta bene la Maserati di Schell, che si porta in testa, seguita
dalla Lancia di Ascari. Al termine del 2º giro, le posizioni sono:
Schell (Maserati), Ascari (Lancia), Hawthorn e Trintignant (Ferrari),
Fangio (Mercedes) e Moss (Maserati). Villoresi è attardato e
completa soltanto due giri per problemi ai freni, poi si ritira
(qualche fonte parla anche di problemi ai supporti di banco del
motore). Al 3º giro Ascari compie il giro più veloce della
giornata, sorpassa Schell e si porta al comando con autorità,
incrementando il vantaggio giro dopo giro. Al completamento della nona
tornata il margine della Lancia di Ascari sulla Maserati di Schell
è ormai di una ventina di secondi, ma nel corso del 10º
giro sulla D50 si manifestano gravi problemi alla frizione, dove si
verifica un trafilaggio di olio che costringe anche Ascari alla resa.
Si accerterà poi che il trafilaggio d'olio è
probabilmente derivato da un difetto di produzione della scatola della
trasmissione.
Dopo il ritiro della D50 di Ascari, in testa si alternano la
Maserati di Schell e la Ferrari di Trintignant, tallonati dalla Ferrari
di Hawthorn e, più a distanza, dalla Mercedes di Fangio. Poi Schell si
ritira, Trintignant è costretto a rallentare e al comando passa
Hawthorn, che è sempre seguito da Fangio; terzo Luigi Musso.
Nel finale, la Mercedes di Fangio accusa un notevole surriscaldamento
del motore (dovuto a fogli di giornale che hanno ostruito la presa
d'aria di raffreddamento) e deve rallentare notevolmente, cedendo il
posto d'onore proprio a Luigi Musso.
|
|
Gran Premio di Francia 1954
|
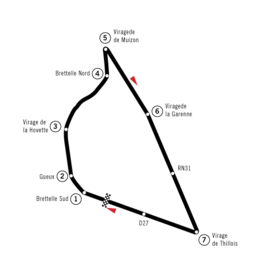
| Nome ufficiale |
XLI Grand Prix de l'A.C.F. |
| Circuito |
Circuito di Reims |
| Percorso |
8,302 km |
| Distanza |
61 giri, 506,422 km |
|
Quarta gara della stagione 1954 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 4 luglio sul Circuito di Reims.
|
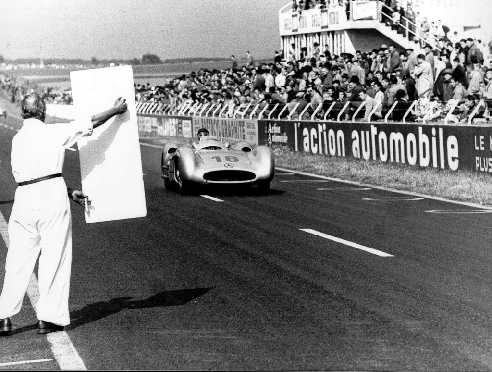
La gara segnò il
debutto in Formula 1 delle potentissime Mercedes-Benz W196 che
dominarono ampiamente la corsa con Fangio ed il debuttante Karl Kling,
classificatisi primo e secondo al termine della prova.
Chiuse il podio Robert Manzon su Ferrari.
Solamente sei piloti portarono a termine l'evento.
|
Gran Premio d'Italia 1954
domenica 5 settembre 1954 - 80 giri x 6.300 km - 504.000 km
Il Gran Premio d'Italia 1954 fu l'ottava gara della stagione 1954 delCampionato Mondiale di Formula 1,
disputata il 5 settembre all'Autodromo di Monza
Un momento della corsa:
la Ferrari di Ascari insegue la Mercedes carenata di Fangio
La manifestazione vide la vittoria di Juan Manuel Fangio su Mercedes,
seguito dai ferraristi Mike Hawthorn
e Josè
Froilàn
Gonzàlez, che sostituì durante la gara l'italiano Umberto
Maglioli.
|
|
 |
|
Gran Premio d'Argentina 1955
|
domenica 16 gennaio 1955 - 96 giri x 3.912 km - 375.552 km
|
|
Gran Premio d'Argentina 1955 prima gara della stagione 1955 del Campionato mondiale di Formula 1,
disputata il 16 gennaio sul Circuito di Buenos Aires.
La manifestazione fu vinta da Juan Manuel Fangio su Mercedes.
A causa del caldo torrido (circa
35 °C all'ombra e 55 °C in pista) molti piloti si
avvicendarono sulle vetture durante la gara creando situazioni curiose
nella classificazione finale: al secondo posto terminarono
González, Farina e Trintignant su Ferrari. Sul gradino
più basso del podio
di nuovo Farina e Trintignant insieme a
Maglioli sempre alla guida di una Ferrari.
Nelle
prove ufficiali, Alberto Ascari spreme ciò che può dalla
sua Lancia D50 ma la pole position va alla Ferrari di Froilán
González. Ascari segna un tempo di mezzo secondo superiore ed
è in seconda posizione, affiancato da Juan Manuel Fangio su
Mercedes, quarta la Maserati di Jean Behra.
La Mercedes di Juan Manuel Fangio è la più lesta al via e si
porta in testa, seguita dalla Ferrari di Gonzalez e dalla D50 di Ascari.
Al 3º giro inaugura la serie dei ritiri delle Lancia la D50 di
Villoresi, che accusa la rottura dei condotti del carburante.
Al termine del quarto giro, Gonzalez forza l'andatura e supera Fangio,
mantenendo il comando fino al 10º giro. In questa fase, anche Ascari
supera Fangio, cosicché al termine del 10º giro abbiamo questa
situazione: 1º Gonzalez (Ferrari), 2º Ascari (Lancia) a 1"9, 3º Fangio
(Mercedes) a 3"8 e 4º Moss
(Mercedes) a 9"9. Eugenio Castellotti prosegue attardatissimo, anche
perché sofferente a causa dell'elevata temperatura. All'11º giro, Ascari
supera Gonzalez e si porta al primo posto; frattanto, al 16º giro,
Eugenio Castellotti, vittima di una insolazione, non riesce a
proseguire, si ferma al box e cede la sua vettura all'appiedato
Villoresi. Non sarà che uno dei numerosissimi avvicendamenti di piloti
alla guida di una macchina: a causa del caldo, infatti, soltanto Juan
Manuel Fangio e Roberto Mieres
riusciranno stoicamente a completare il Gran Premio senza farsi dare
cambi. La D50 di Ascari riesce con un po' di fatica a mantenere la testa
e la situazione, al termine di 20 giri, lo vede al primo posto con
circa 2” di margine su Gonzalez e 13” su Fangio. Ma arriva il fatale 22º
giro, allorché Ascari finisce fuori di strada dopo un testa coda: la
vera ragione della piroetta non sarà mai accertata, dal momento che se
la versione semi-ufficiale parla di una macchia d'olio, molti propendono
a credere che la causa risieda nell'estrema instabilità della D50.
Villoresi
dopo aver rilevato la D50 attardatissima di Castellotti tenta
faticosamente un recupero, che viene però interrotto al 36º
giro, quando a sua volta esce di strada. A poco più di un terzo
di gara, ecco dunque che tutte e tre le Lancia sono fuori gioco. Il
Gran Premio prosegue con Fangio che percorre in testa l'ultima
metà di gara aggiudicandosi la corsa con 1 minuto e mezzo di
vantaggio sulla Ferrari di Gonzalez, condotta anche da Nino Farina e da
Maurice Trintignant,e addirittura due (o più) giri sugli altri
cinque equipaggi superstiti.
|
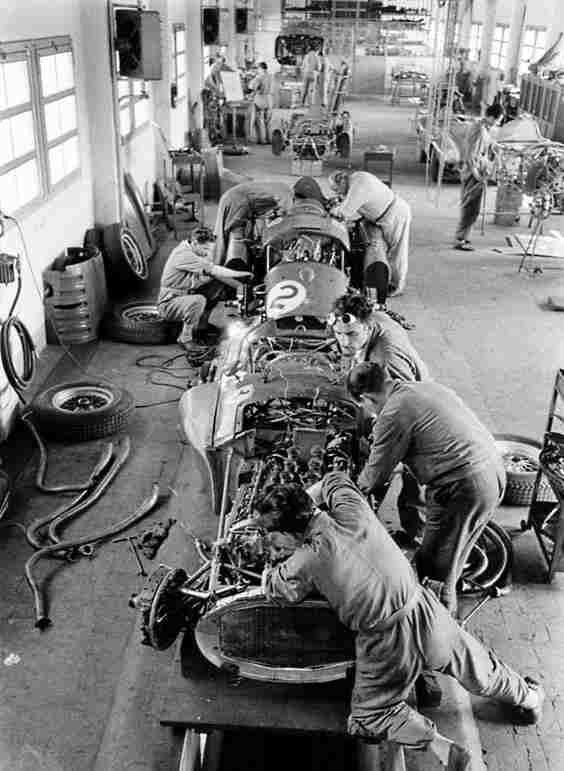
Maranello - Stabilimento Ferrari
|
Monza - 1955, le monoposto sfrecciano
sulla curva sopraelevata
|
| La Stagione da non dimenticare - 1955 |
|
1955. Alberto Ascari con la Lancia arriva
lungo alla chicane, sfonda la barriera di travi di legno e sacchi di
sabbia
e finisce in mare. Prima dell’arrivo dei mezzi di
soccorso raggiunge a nuoto la riva. E’ un annuncio di morte.
Ascari tre giorni dopo perirà in un incidente sul circuito
di Monza.
 |
Gran Premio di Monaco 1955
|
 |
|
|
domenica 22 maggio 1955 - 100 giri x 3.145 km - 314.500 km
Il Gran Premio di Monaco 1955 fu la seconda gara della stagione 1955 del Campionato mondiale di Formula 1,
disputata il 22 maggio sul Circuito di Monaco.
Stirling Moss, dopo aver firmato per la Mercedes per la prossima stagione, viene sostituito alla Maserati da Jean Behra.
Il pilota monegasco Louis Chiron
grazie alla presenza in questo Gran Premio diventa il pilota più
anziano ad aver preso parte ad un Gran Premio di Formula 1, record
ancora imbattuto nel 2016.
VIDEO
Principato di Monaco, 22 maggio 1955 Ascari vola in acqua,
"ripescato"
da un sommozzatore.
|
|
Ascari non è autore di una partenza azzeccata, ed al primo giro si
ritrova in quarta posizione, preceduto da Fangio, dal compagno di
squadra Castellotti e da Moss. Al 10º giro, dietro al leader Fangio,
troviamo Moss, poi Ascari che ha appena superato Castellotti, e la
Maserati di Behra. Quest'ultimo però rinviene fortissimo e ri-supera
prima Castellotti e poi anche Ascari, portandosi al terzo posto alle
spalle del duo Mercedes. Al 35º giro, Castellotti è costretto al box per
far controllare una ruota
ma anche per rabboccare il carburante. Al 40º giro la situazione è: 1°
Fangio, 2° Moss (molto vicino al compagno di marca), 3° Behra a 43” e 4°
Ascari a 50”, 5° il sorprendente Maurice Trintignant con la Ferrari
(staccato però di 1'20” da Fangio), 6° Mières e 7° Villoresi. Al 42º
giro, Behra si ferma lungamente al box per sistemare un raccordo della
tubazione dell'olio e viene doppiato. Alla Maserati si pensa di far
passare Behra alla guida della macchina di Cesare Perdisa
(in miglior posizione), mentre al bolognese non resta che sistemarsi al
volante della più attardata macchina di Behra. Poco prima di metà gara,
il primo vero colpo di scena di questo Gran Premio: Fangio si ritira
per la rottura del ponte. Passa così a condurre Moss, con 1'22” di
vantaggio sulla D50 di Ascari. Tutti gli altri sono già stati doppiati:
Trintignant è 3°, Mières è 4°.

Malgrado l'enorme vantaggio, Stirling Moss continua a tirare come
un ossesso, forse per giungere a doppiare anche Ascari, che è l'ultimo
concorrente a pieni giri. Ecco che quando mancano venti giri al termine
Moss è fermato da un guasto di motore e Ascari si trova in testa; i
numerosi italiani presenti si accingono a festeggiare il nuovo leader
della corsa, quando il milanese, alla “chicane” del porto, finisce in
mare.
Come riferito dallo stesso Ascari nelle ore successive, la causa del guaio sarebbe stata il bloccaggio del freno
anteriore destro, che avrebbe innescato una sbandata verso l'esterno,
incontrollabile: dovendo scegliere tra un muretto di sabbia, una piccola
tribuna affollata e l'acqua, il pilota finisce per scegliere
quest'ultima, considerandola il male minore. Una seconda ipotesi è
quella della sbandata sull'olio lasciato sul tracciato dal motore in
avaria della Mercedes di Stirling Moss, transitata poco prima. Alberto
comunque sguscia dalla macchina inabissata e risale a galla raggiungendo
il sommozzatore che già si è tuffato in suo soccorso. Anche se
ricoverato precauzionalmente all'ospedale di Monte Carlo, il pilota è
praticamente illeso.
Al comando del Gran Premio viene così a trovarsi il regolare
Trintignant con la Ferrari. Il solo ulteriore momento entusiasmante
della corsa è dato dall'inseguimento di Castellotti, che si porta a 15”
dal nuovo leader e riduce poi il distacco fino a soli 11”.
L'inseguimento però non ha successo, e nelle ultime tornate il lodigiano
della Lancia è costretto a ridurre il ritmo, tanto che alla fine il
distacco sale nuovamente a 20”. La corsa si conclude con la prima
vittoria in Formula 1 di Maurice Trintignant (coltivatore di viti in
quel di Nîmes e zio dell'attore Jean-Louis),
con il posto d'onore di Castellotti con la D50, con la terza piazza
della Maserati di Behra condotta anche dal giovane Cesare Perdisa.
|
|
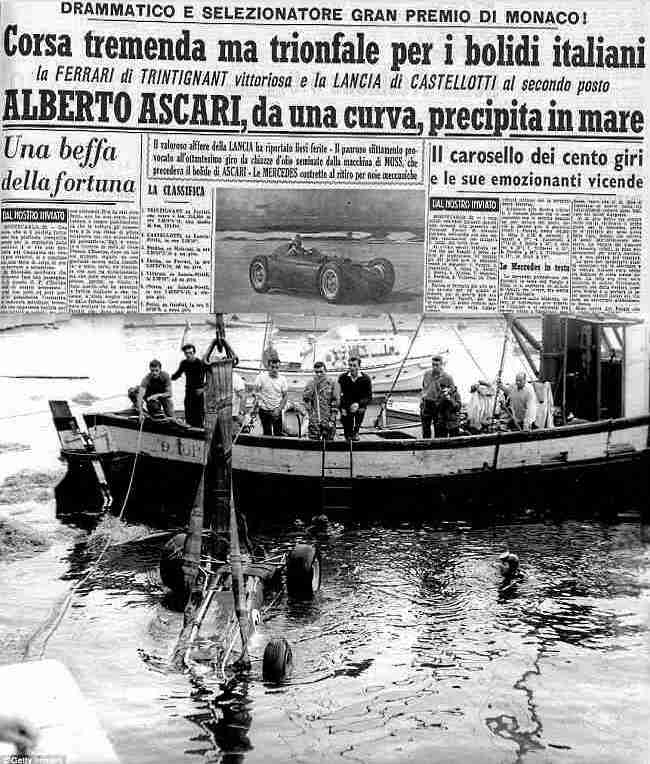 |
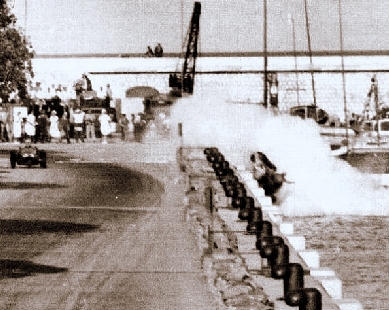 |
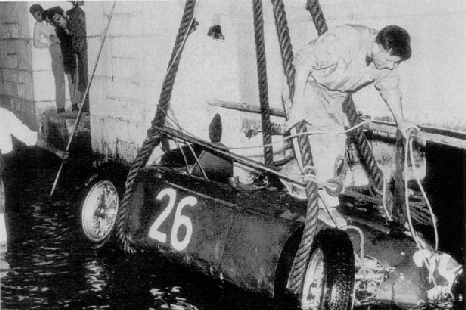 |
| Principato di Monaco, 22 maggio 1955 Ascari vola in acqua, "ripescato"
da un sommozzatore. |
GP Montecarlo 22 maggio 1955, il recupero dell'auto di
|
|

La gara venne poi vinta dal
francese Trintignant (detto, il "pilota gentile",
per i modi
particolarmente docili con cui riusciva a condurre le proprie
vetture), al primo successo in F. 1, su Ferrari.
|
|
MONZA
I resti della vettura con cui Alberto Ascari perì nel 1955
Alberto Ascari clinicamente non è
affatto in ottime condizioni, il suo fisico ha risentito comunque
dell'accaduto. Moralmente invece è al settimo cielo, sente
di poter lottare con Fangio ad armi pari, il campionato è
appena iniziato e nulla è ancora compromesso......ha solo
voglia di correre. La possibilità si presenta solo qualche giorno dopo, Alberto
passa dal circuito di Monza , al solo scopo di salutare gli amici,
quì trova Eugenio Castellotti (terzo pilota Lancia) intento
a testare una Ferrari Sport, Alberto sarebbe ben felice di farsi un
"giro" sul nuovo bolide... Castellotti dal suo canto non puo' che
esserne onorato... così il due volte campione del mondo
indossa casco e guanti e sale sulla vettura.
E' così... proprio così che il più
grande pilota italiano va incontro al più amaro e beffardo
destino: dopo un giro mentre affronta la famosa parabolica di Monza,
per motivi ancora da chiarire, la sua vettura esce di pista, Alberto
viene catapultato fuori dall'abitacolo, l'impatto è tremendo
per <<Ciccio>> così come lo
chiamavano gli amici non c'è nulla da fare. Si spegne
così il 26 Maggio 1955 alle ore 12.26 il più
grande pilota italiano di tutti i tempi.
Devastanti sono le conseguenze sul mondo della Formula Uno, l'Italia
è sconcertata.... Gianni Lancia, in lutto per la perdita del
suo pilota, sceglie la soluzione più drastica possibile: il
ritiro, la Lancia si ritira dopo solo tre gare dalla Formula Uno!! Dopo due settimane il "baraccone" della formula uno si sposta a
Zandvoort, anche se l'agonismo sembra aver assunto, per questa
stagione, un ruolo ormai irrilevante. In Belgio le Mercedes fanno il
vuoto, si aggiudicano praticamente tutto.
Ma il 1955 non ha finito di riservare cattive sorprese; infatti intanto
che la F1 tenta di dimenticare il terribile episodio di Ascari ecco che
una nuova tragedia si affaccia sul mondo dell'automobilismo, stavolta
riguarda la 500 miglia, un pilota americano: Bill Vukovich finisce sul
pubblico... è una strage muoiono circa cento spettatori.. il
mondo dell'automobilismo è travolto dalle critiche
pubbliche. A seguito di questo evento al calendario della stagione vengono
sottratte tre gare.... dunque delle dieci previste a inizio anno se ne
svolgeranno soltanto sette. Un mese dopo è la volta del Gp d'Olanda.... è
ancora dittatura Fangio, nel Gp d'Inghilterra, quindici giorni dopo,
Fangio continua a dominare, ma lascia la vittoria al suo compagno di
squadra il giovane Stirling Moss; la vittoria dell'inglese a
Silverstone è più che altro una strategia
politica; la F1 tenta di riconquistare il consenso nazionale. A Monza, ultima gara della stagione, Fangio continua a vincere e si
laurea dunque per la terza volta campione del mondo....... è
evidente che l'unico pilota ingrado di ostacolare concretamente
l'argentino sarebbe stato solo Ascari!!!
|
|
|
Gran Premio del Belgio 1955
Spa-Francorchamps - domenica 5 giugno 1955 - 36 giri x 14.120 km - 508.320 km

Gran Premio del Belgio 1955 quarta gara della stagione 1955
vinta da Juan Manuel Fangio
|
Malgrado
gli stati d'animo di Eugenio Castellotti, di Vittorio Jano e dei
meccanici non siano dei migliori per via della recente scomparsa di
Alberto Ascari, a cui è seguito il ritiro ufficiale della Lancia
dalla Formula 1, grazie anche all'ennesimo potenziamento del motore (si
parla di oltre 265, forse 270 HP), la Lancia D50 ottiene addirittura la
pole position davanti alle Mercedes di Fangio e di Moss, che risultano
staccati di 5/10 di secondo l'argentino, e di 1”e1/10 l'inglese.
A seguire, la Ferrari di Nino Farina, la Maserati di Jean Behra, la
terza Mercedes di Karl Kling, la Maserati di Luigi Musso e via via gli
altri.
Al segnale di via, Fangio assume autoritariamente il comando, che non
abbandonerà più fino al traguardo. Nella sua scia si lanciano Moss,
Castellotti e Farina. Al 10º giro (poco meno di 1/3 di gara) la
situazione è: 1° Fangio (Mercedes), 2° Moss (Mercedes) a 11”, 3°
Castellotti (Lancia) a 41”, 4° Farina (Ferrari) a 44” Il quartetto
marcia in quest'ordine fino al 16º giro, dopodiché la D50 di Castellotti
deve abbandonare la lotta per il cedimento della trasmissione
(probabilmente del cambio
in particolare), forse troppo sollecitata dalla aumentata potenza del
motore. Il Gran Premio prosegue senza troppi scossoni, con i primi tre
posti occupati stabilmente da Fangio, Moss e Farina.
|
 |
Stoccarda - Ottobre 1955
Unterturkheim. E' la riunione annuale per
festeggiare la stagione di corse e il secondo Campionato del Mondo
conseguito.
È pure l'occasione scelta dalla Direzione per
annunciare il ritiro della Mercedes dalle corse. |
|
 Da sinistra:
Scherenberg, terzo Neubauer, Nallinger, Uhlennaut, i piloti Kling,
Taruffi. Alle sue spalle W. I. Tak, Fangio, von Tripps, non
identificato, Moss, la rallista francese Gilberte Thirion.
Dietro di
lei John Fitch, Hermann, Peter Collins e, inginocchiato, il Ministro
dell'Economia del Baden-Wurttemberg Dr.Veit.
Da sinistra:
Scherenberg, terzo Neubauer, Nallinger, Uhlennaut, i piloti Kling,
Taruffi. Alle sue spalle W. I. Tak, Fangio, von Tripps, non
identificato, Moss, la rallista francese Gilberte Thirion.
Dietro di
lei John Fitch, Hermann, Peter Collins e, inginocchiato, il Ministro
dell'Economia del Baden-Wurttemberg Dr.Veit.
|
|
|

 |

Fangio - Musso - De Portago - Castellotti - Collins - Wolfgang von Trips: tutti su Lancia -Ferrari D50
La Lancia Ferrari D50 vince con Fangio il mondiale nel 1956
 Gran Premio di Francia 1956 Gran Premio di Francia 1956Dalla Lancia alla Ferrari, la D50 diventa la regina della Formula Uno
Nel 1956, Manuel Fangio conquista il suo quarto titolo mondiale con la Ferrari “8 CL” in pratica l’ex Lancia D50, l’ultima monoposto pilotata da Alberti Ascari.
Il dominio della Ferrari è notevole, Fangio, Musso, Collins sono i
piloti da battere, tutti al volante della rossa di Maranello, ma la
superiorità e la storia della vettura è frutto di una serie di
circostanze. Nel 1956, la Mercedes, dominatrice delle
due stagioni precedenti di Formula Uno con la W196, decide di
abbandonare la partita. Ufficialmente i dirigenti di Stoccarda sono
paghi dei successi e della superiorità dimostrata. Dietro ci sono
ragioni economiche: gli investimenti nello sport erano stati ampiamente
ricompensati dalla produzione di serie, stavano nascendo nuovi modelli
da strada che richiedevano un grande impegno, ed aleggiava ancora la
tragedia di Le Mans che era costata la vita ad 80 persone, causata dalla
Mercedes 300 SLR di Pierre Levegh. Anche in casa
Lancia giunge lo stop per le competizioni dopo la morte di Alberto
Ascari, ma soprattutto dalla drammatica situazione finanziaria della
fabbrica torinese. Da tutti questi presupposti inizia la stagione 1956,
di fatto si voltava pagina dopo i due anni targati Mercedes, con i due
top driver che prendevano strade diverse, ma entrambe italiane: Fangio approda a Maranello, Stirling Moss a Modena,
in via Ciro Menotti, alla Maserati. L’asso argentino trova in Ferrari
la ex Lancia D50, ed una squadra con giovani e veloci piloti come Collins, Musso, Castellotti ed il barone belga Gendebien. L’inglese a Modena farà squadra con Jean Berha e Cesare Perdisa.
La Lancia D50
La Ferrari è nata a Torino, in casa Lancia, due anni prima quando il giovane Gianni Lancia
decide di produrre auto, di nicchia, ma molto eleganti e ritornare nel
mondo delle corse, sfidando Mercedes e Ferrari, per rafforzare
l’immagine del marchio. Molte azioni della casa torinese sono tenute dal
gruppo Pesenti, ma Lancia, nonostante la fabbrica navighi in brutte
acque finanziarie ed i conti sono in rosso assume Vittorio Jano, il grande progettista delle Alfa Romeo della Scuderia Ferrari. Lo stipendio è da fuoriclasse, ma anche le vetture realizzate lo sono. Sotto la progettazione di Jano nascono le sport D23 e la D24 ed in seguito la monoposto D50 di Formula Uno.
Poi ci sono i piloti, ed in questo campo Gianni Lancia non si fa
mancare nulla, vuole solo i migliori, costi quel che costi. Con un
ingaggio sensazionale per l’epoca ingaggia Alberto Ascari, due volte
campione del mondo, il migliore tra tutti gli italiani, assieme a Gigi
Villoresi. Arriva anche Manuel Fangio, anche lui già campione del mondo
con l’Alfa Romeo. Fa qualche corsa di durata con la D24, ma che ben
presto emigra alla Mercedes, intuendo che la casa tedesca ha la macchina
con la migliore tecnologia, ed i soldi per svilupparla.
|

La progettazione della D50 ha una storia piuttosto lunga e
travagliata, ma quando viene presentata si capisce che Vittorio Jano è
ancora uno dei migliori progettisti sul mercato ed i soldi sono stati
ben spesi. Il problema però sono proprio i soldi: i Pesenti
hanno ormai molte azioni della fabbrica, l’azienda è vicina alla
bancarotta e vogliono fare quadrare i conti. La D50 è un gioiello di
tecnica per l’epoca, dotata di un brillante otto cilindri a V di 90°,
cilindrata 2.486cc per una potenza di 250cv a 8.000 giri, mentre Ferrari continua con il 4 cilindri in linea progettato da Lampredi.
La Lancia è dotata di serbatoi laterali per equilibrare le masse, la
trasmissione ha un sistema transaxle con il cambio posteriore e ponte De
Dion, tra le evoluzioni è già pronta una carrozzeria carenata per i
tracciati veloci come Reims e Monza. Il V8 è inclinato di 12° per
consentire il passaggio dell’albero di trasmissione alla sinistra del
pilota, il tutto per abbassare il telaio e quindi le masse sospese.
Intanto Gianni Lancia continua nella sua rivoluzione dell’immagine e fa
costruire un grattacielo a Torino, come sede dirigenziale, decorato da
Gio’ Ponti. Il grattacielo è realizzato proprio dal gruppo Pesenti che
diventa sempre più creditore della Lancia, ormai pesantemente indebitata
dalla gestione allegra del suo patron Gianni. La D50 debutta con Ascari
e Castellotti, a stagione inoltrata 1954, la messa a punto è piuttosto
laboriosa, ma la vettura sembra nata bene, molto maneggevole. La
stagione 1955 inizia nel peggiore dei modi: il 26 maggio del 1955 Alberto Ascari muore a Monza.
Tre giorni prima aveva corso a Montecarlo con la D50, mentre era in
testa è uscito di strada finendo in mare. I sommozzatori lo salvano, per
il milanese è uno shock e tre giorni dopo va a trovare l’amico
Castellotti che sta girando a Monza con la sua Ferrari 750 sport, chiede
al lodigiano di fare qualche giro, giusto per provare i riflessi. Sale
sulla sport del Cavallino in camicia e cravatta, parte veloce dai box,
dopo tre giri finisce fuori strada alla curva del Vialone, che verrà poi
intitolata proprio al campione milanese, perdendo la vita. Per Gianni
Lancia è il colpo da ko. Esce di scena dalle corse, e dopo due mesi
viene estromesso anche dalla sua fabbrica. I conti sono pesantemente in
rosso, deve cedere il 16% delle azioni ancora in suo possesso al Gruppo
Pesenti che chiede immediatamente il suo allontanamento dalla fabbrica.
La Mercedes si fa avanti per rilevare il reparto corse, ma in Italia
nasce un patto segreto tra ACI, Fiat e Ferrari ed il tutto viene donato
proprio alla scuderia di Maranello, mentre la Fiat si impegna a versare alla Ferrari un contributo di 50 milioni di lire per 5 anni per finanziare le corse con le ex macchine torinesi.
|
Dalla Lancia alla Ferrari
Il 26 luglio del 1955 mentre Gianni Lancia è scappato in esilio forzato in Brasile, i meccanici Ferrari accompagnati da Mino Amorotti e Luigi Bazzi entrano nel reparto corse di via Caraglio
a Torino caricando tutto il materiale del reparto corse e le sei
monoposto D50. Nell’accordo c’è anche la consulenza di Vittorio Jano che
torna a collaborare con Maranello scalzando Aurelio Lampredi dal ruolo
di direttore tecnico. Le D50, con i colori Ferrari vengono fatte correre
a Monza nel 1955 per testare le differenze di prestazioni con le
Ferrari e le Mercedes. Sono sei le Ferrari schierate a Monza,
tre 625 con il quattro cilindri di 2,5 litri e tre D50 per Castellotti,
Villoresi e Nino Farina. Le Mercedes di Fangio, Moss e Kling dominano
le prove e la gara, ma Castellotti e Farina sono subito dietro nelle
prove, mentre la prima 625, quella di Maglioli, è dodicesima. In gara
saranno le gomme a decidere la sorte delle D50, dopo pochi giri le
vetture vengono ritirate con i pneumatici a pezzi. La Ferrari, per
contratto, monta gomme Englebert al posto delle Pirelli utilizzate dalla
Lancia che non si adattano alle caratteristiche della monoposto
torinese.
|
La D50 mondiale con Fangio
In casa Ferrari iniziano le prime modifiche, i serbatoi vengono integrati nella carrozzeria e le Lancia-Ferrari vengono schierate per la stagione 1956.
Per Fangio, il caposquadra della scuderia di Maranello l’anno inizia
subito con molte difficoltà: in Argentina ha problemi al motore, ma
riesce a salire sulla macchina di Musso e vince dividendo i punti con il
pilota italiano. A Monaco c’è il grande duello tra l’argentino e
Stirling Moss fino a quando Fangio ha nuovamente problemi meccanici e si
ferma ai box. Collins gli cede la sua Ferrari, Fangio inizia una
furiosa rimonta che lo riporta alle spalle della Maserati di Moss, che
vince con sei secondi di vantaggio. A Spa arriva il primo successo di Peter Collins con la Ferrari,
mentre Fangio è di nuovo fermo per problemi alla trasmissione, ma anche
Moss è fermo per problemi alla sua Maserati.
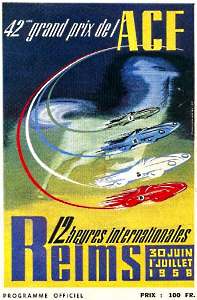 |
 |
In Francia l’inglese bissa
il successo con la Ferrari, precedendo il compagno Castellotti, Jean
Berha e Fangio che arriva quarto, Moss è nuovamente fermo per problemi
al cambio. Il campione argentino vince finalmente in Inghilterra a
Silverstone precedendo la coppia De Portago-Collins sulla D50. Nuovo
capolavoro di Fangio al Nurburgring che precede ben cinque Maserati, con
Moss che sale sul secondo gradino del podio. Ad una gara dal termine il
mondiale vede in testa Fangio con 30 punti, seguito da Collins e Berha con 22 e Moss con 19, l’ultimo
atto a Monza sarebbe stato quello decisivo per la conquista del titolo.
Il Gran Premio d’Italia si svolgeva sull’intero tracciato brinatolo,
quello di 10 km con stradale ed anello di alta velocità. La D50 di Fangio, dopo 20 giri, è ferma ai box con problemi al motore, trasmissione e sterzo,
ma c’è da vincere il mondiale, con le Maserati che vanno forte. Ai box
viene chiesto a Musso di cedere la vettura all’argentino, ma il romano
si rifiuta “se vuole corra con la sua macchina”. Sarà invece Peter Collins a fare il gesto che cambierà le sorti della gara e del mondiale. Cede la sua D50 all’argentino
“tanto sono giovane ed ho ancora tempo per vincere” sono le parole del
campione inglese, un gesto di cortesia, di rispetto verso la classe
dell’argentino, un favore che diventerà celebre. Fangio riparte con la
Ferrari di Collins, cercando di recuperare il tempo perso. Anche la D50
di Musso ha dei problemi ed il romano si ferma. Fangio è secondo alla spalle di Stirling Moss e conquista i punti necessari per il suo quarto titolo,
grazie soprattutto al gesto di Collins. Enzo Ferrari apprezzerà molto
il comportamento del pilota inglese: una vettura con il cavallino
rampante sul cofano è nuovamente mondiale. Da quel momento però le
strade tra il pilota argentino e Maranello si divideranno tra varie
polemiche. Fangio emigra a Modena, casa Maserati, Ferrari, per il
futuro, punta sui giovani piloti: Castellotti, Musso, Collins, ma
nessuno di loro riuscirà a conquistare l’alloro mondiale e tutti
perderanno la vita nell’arco di un paio di stagioni.
Nel 1957 la D50 viene modificata e diventa 801
La D50 viene modificata per la stagione 1957, i due serbatoi laterali
scompaiono e la benzina finisce alle spalle del pilota. la monoposto
viene ribattezzata 801 (8 cilindri, 01 Formula Uno), ma le modifiche
effettuate vengono subito criticate da Castellotti e Villoresi che
avevano contribuito allo sviluppo in Lancia. Scompaiono anche le
balestre trasversali sostituite da molle elicoidali. Viene rivista anche
la parte meccanica, il V8 ha una nuova cilindrata di 2.489cc con un
incremento di potenza che arriva a 275 cv a 8.200 giri. Il cambio, a 5
rapporti, è sempre in blocco con il differenziale. La 801 non riesce a
ripetere i risultati della D50, la Maserati 250 diventa la vettura da
battere e Fangio la fa volare verso il suo quinto titolo mondiale. Per
la 801 è l’unica stagione mondiale, per il 1968 verrà sostituita dalla
nuova 246 che riporterà il mondiale a Maranello.
|
|
Gordini T32
 |
 |

La Gordini T32, chiamata anche Gordini Type 32, è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia francese Gordini per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 1955 e 1956.
Progettata da Amédée Gordini, è stata l'ultima vettura della
Gordini in Formula 1. La vettura seguì lo schema
motoristico inaugurato
dalla Mercedes-Benz W196, con l'utilizzo di motore 8 cilindri in linea;
la vettura risultò però troppo pesante e grande e non si rivelò
competitiva.
|
L'IRIDE ROSSO DI FANGIO
Per la stagione 1956 Enzo Ferrari ingaggia il
miglior pilota del momento, Juan Manuel Fangio.
L'argentino si
è appena aggiudicato due titoli mondiali con la Mercedes
dopo quello del 1951 con l'Alfa Romeo; con le vetture del cavallino
cercherà quindi di conquistare il suo quarto iride. Fangio
riesce nell'intento, ma la sua è una vittoria molto
sofferta. Nei primi due Gran Premi, quello di casa sua e quello di
Montecarlo, ottiene un primo e un secondo posto ma soltanto grazie
alla
collaborazione dei suoi compagni di squadra Luigi Musso e Peter
Collins che gli cedono le proprie vetture, in quanto quella
dell'argentino in
entrambe le occasioni aveva ceduto per problemi meccanici. In
Belgio si
ritira senza appello, in Francia è quarto, poi trionfa in
Gran Bretagna e in Germania rilanciandosi
per la conquista del titolo. |
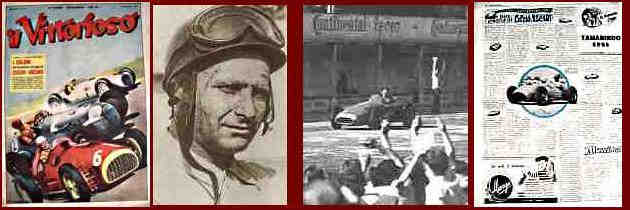 |
E' la volta della gara decisiva, quella di Monza. Sono tre i piloti
ancora in corsa per il mondiale: Fangio, Moss e Collins. Il pilota
inglese della Maserati domina e vince, ancora una volta Fangio
è costretto al ritiro dopo 20 giri per noie al motore, ma
dopo altri 15 giri Collins, che è secondo, si ferma ai box e
cede la macchina all'argentino che conclude così alle spalle
di Moss e si laurea ancora una volta campione del mondo. In quell'occasione Collins dimostrò uno spirito di
sacrificio ineguagliabile rinunciando alle sue chances per favorire
quelle del quarantacinquenne Fangio: l'inglese era convinto di poter
avere in futuro altre possibilità di vittoria iridata.
Purtroppo non sarà così:
due anni più
tardi il ventiseienne Collins morirà in un tragico incidente
sul mitico e terribile Nürburgring. |
 |
|
1956 - PRIMAVERA FERRARI
|
|
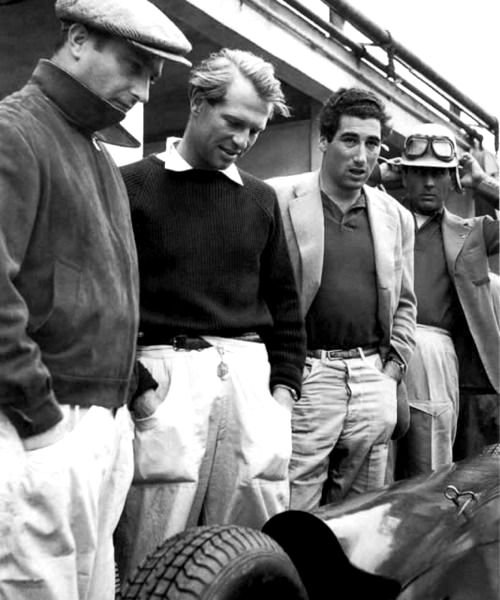 Accadde una volta e poi mai più: Ferrari, era il 1956, decise di
rinunciare al suo campione, Fangio, per puntare tutto sui giovani
talenti che scalpitavano alle sue spalle. Ma quella “Primavera” divenne
di colpo… un freddo inverno! Accadde una volta e poi mai più: Ferrari, era il 1956, decise di
rinunciare al suo campione, Fangio, per puntare tutto sui giovani
talenti che scalpitavano alle sue spalle. Ma quella “Primavera” divenne
di colpo… un freddo inverno! |
| Il 2 dicembre del 1956 Enzo Ferrari presentò alla stampa cinque nuovi
piloti sotto i trent’anni: Eugenio Castellotti, Luigi Musso, Peter
Collins, Mike Hawthorn e Alfonso Portago (che era marchese, nipote di
Alfonso XIII di Borbone). I cinque, ribattezzati "Ferrari Primavera" dal
cronista Gino Rancati, morirono tutti al volante nel giro di due anni.
Luca Delli Carri, nel libro "Gli indisciplinati", sostiene che i piloti
di allora «erano molto più scapestrati di quelli di oggi» e cita a
sostegno una serie di aneddoti. Alle gare, Portago, soprannominato "il
marchese senza bagagli" per l’abitudine di acquistar tutto sul posto,
giungeva sempre in compagnia di sua moglie Carroll McDaniel, dell’amante
ufficiale Linda Christian e di un’amante del giorno. Morì nella Mille
miglia del ’57 per lo scoppio di una gomma. Hawthorn non si presentava
mai due volte con la stessa donna; Musso, abbandonata la moglie per
l’attrice Fiamma Breschi, si giocò 45 milioni in una notte al Casinò di
Venezia e con l’eredità del padre (consulente legale in Cina) si comprò
una Ferrari con interni in cinghiale e pulsanti di tartaruga bionda. Nel
Gran Premio di Germania del ’58 Collins si schiantò contro gli alberi:
Ferrari diede la colpa dell’incidente al suo matrimonio con l’attrice
americana Louise Corder King. Il 14 marzo del ’57, sul circuito di
Modena, Castellotti urtò contro un cordolo e morì: stando alle cronache
del tempo, l’incidente fu causato da una notte di passione con la
soubrette Delia Scala. Appena diciannovenne, il pilota era già noto per
aver acquistato 50 abiti, 500 camicie, 100 paia di scarpe e una Ferrari. |
14 MARZO 1957 - AERAUTODROMO DI MODENA
Il 14 marzo 1957, moriva Eugenio Castellotti in un
incidente durante una seduta di prove all' aerautodromo di Modena.
Eugenio Castellotti con mamma Angela
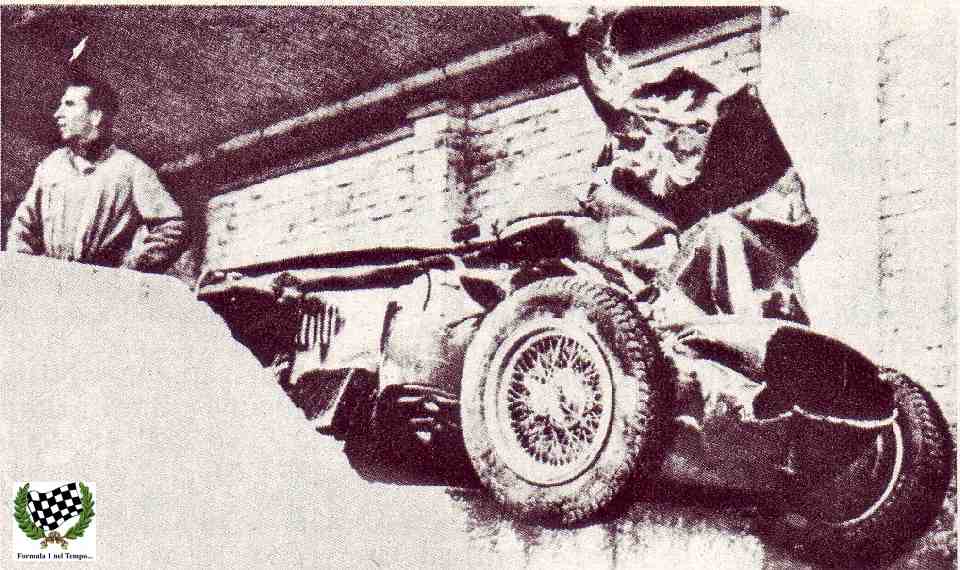
La vettura di Eugenio Castellotti dopo lo schianto a Modena.
Quella sera Delia Scala recita al teatro
Verdi di Firenze: lo spettacolo ha le sue regole inflessibili.
Gli inizi
Castellotti
proveniva da una famiglia di ricchi proprietari terrieri. Il padre era
appassionato di auto da corsa, ma non vedeva di buon occhio l'interesse
del figlio per le gare automobilistiche. La morte del genitore, nel
1950, consentì dunque a Castellotti di iniziare la propria
carriera, comprando una Ferrari 166 MM. Con questa vettura prese parte
a vari eventi nei due anni successivi, giungendo anche sesto alla Mille
Miglia del 1951. L'anno seguente cominciò a diversificare i suoi
impegni prendendo parte anche a gare a ruote scoperte di Formula 2 ed
ottenne le sue prime vittorie, tra cui la Coppa d'Oro di Sicilia
nell'edizione per vetture sport. Lo stesso anno conobbe a e il Gran
Premio del PortogalloMonza, durante il Gran Premio d'Italia, Alberto
Ascari che ebbe poi un ruolo fondamentale nel prosieguo della sua
carriera e di cui divenne grande amico Un secondo posto ottenuto alla
Mille Miglia, poi, gli permise di ottenere un contratto con la Lancia
per disputare la Carrera Panamericana del 1953. Nell'appuntamento
sudamericano il pilota italiano si mise in evidenza concludendo al
terzo posto, preceduto da Juan Manuel Fangio e Piero Taruffi, suoi
compagni di squadra.
Il passaggio alla Lancia e la morte di Ascari

Eugenio Castellotti Monza 1955
Visti
i buoni risultati Ascari riuscì a procurargli un contratto con
la Lancia, che lo inserì nel programma per debuttare in Formula
1 nella stagione 1954. La progettazione e la messa a punto della Lancia
D50 si rivelò, però, più lunga del previsto e il
debutto avvenne solo nel 1955. Ottenne quindi un secondo posto a
Monaco, ma la morte di Ascari, avvenuta meno di una settimana dopo,
portò la casa torinese alla decisione di ritirarsi dal mondiale.
A Castellotti venne concesso da Gianni Lancia di correre il Gran Premio
del Belgio con una delle D50 e l'italiano ottenne la sua unica pole
position in carriera su un circuito a lui sconosciuto. In gara fu
però costretto al ritiro mentre occupava la terza posizione
dietro le due Mercedes di Fangio e Moss. Dopo la gara di Spa
passò dunque alla Ferrari, con cui disputò gli ultimi
appuntamenti della stagione. Dopo un quinto posto in Olanda e un sesto
in Gran Bretagna, per la gara di Monza il team di Maranello
portò al debutto per la prima volta le D50 donate da Gianni
Lancia, ma le monoposto evidenziarono diversi problemi durante le
prove. Castellotti, pur di correre con le più potenti vetture
torinesi si dichiarò disposto a firmare una dichiarazione di
responsabilità, ma Enzo Ferrari glielo negò. Nonostante
ciò riuscì a raggiungere al terzo posto, dietro Fangio e
Taruffi e chiuse quindi il campionato piloti in terza posizione con
dodici punti ottenuti.
Gli anni in Ferrari
Per
il 1956 Castellotti ebbe l'occasione di dedicarsi sia a gare con
vetture sport, vincendo la Mille Miglia e la 12 Ore di Sebring, che
alla Formula 1. La stagione nella massima serie automobilistica,
nonostante le buone prestazioni fornite in prova, in gara fu spesso
costretto al ritiro. Al Gran Premio di Francia ebbe l'occasione di
vincere la gara, ma Eraldo Sculati,
direttore tecnico della squadra, gli impose di far passare Peter
Collins, meglio piazzato in classifica, costringendolo quindi a
concludere al secondo posto.
Nel
marzo 1957, mentre si trovava a Firenze, venne richiamato da Enzo
Ferrari per effettuare delle prove sull'Aerautodromo di Modena e
strappare a Jean Behra il record del circuito. Mentre Castellotti si
apprestava ad affrontare una curva presso il rettilineo delle
Tribunette, perse il controllo della vettura e si schiantò a
circa 200 km all'ora. Il pilota morì sul colpo, ma le cause
dell'incidente non furono mai completamente chiarite. Varie furono le
ipotesi formulate, tra cui la presunta stanchezza di Castellotti, che
viaggiava spesso tra Modena e Firenze, dove la fidanzata Delia Scala
teneva uno spettacolo teatrale, o un cedimento improvviso dell'albero
della trasmissione della sua monoposto.
La notizia venne accolta con grande sconforto nel mondo
dell'automobilismo e ai suoi funerali, svoltisi il 16 marzo,
parteciparono pressoché tutti i suoi colleghi.
Castellotti è stato inumato nella tomba di famiglia nel Cimitero Maggiore di Lodi.
|
|
|
 |
Enzo Ferrari ancora scosso dalla perdita del figlio
Dino avvenuta il 30 giugno 1956, decise di ricordarlo nella maniera a
lui più congeniale, dando il suo nome ad un motore che fino
agli ultimi giorni di vita, Dino Ferrari aveva voluto e partecipato
alla progettazione con grande passione, iniziata da Aurelio Lampredi e
terminata da Vittorio Jano, coadiuvati da Bellantani e
dall’Ing.Fraschetti. Nacque così un sei cilindri a
V di 65° di 1489,35 cc, che sviluppava 180 CV a 9000
giri/minuto, destinato alla F2 del 1957, che richiedeva una cilindrata
massima di 1500 cc. e che getta le basi per la futura Dino 246 F1 |
 Dino e Enzo Ferrari
Dino e Enzo Ferrari |

UNA GARA MEMORABILE
Gran Premio di Germania - 4 agosto 1957
Nürburgring - domenica 4 agosto 1957 - 22 giri x 22.810 km - 501.820 km
|
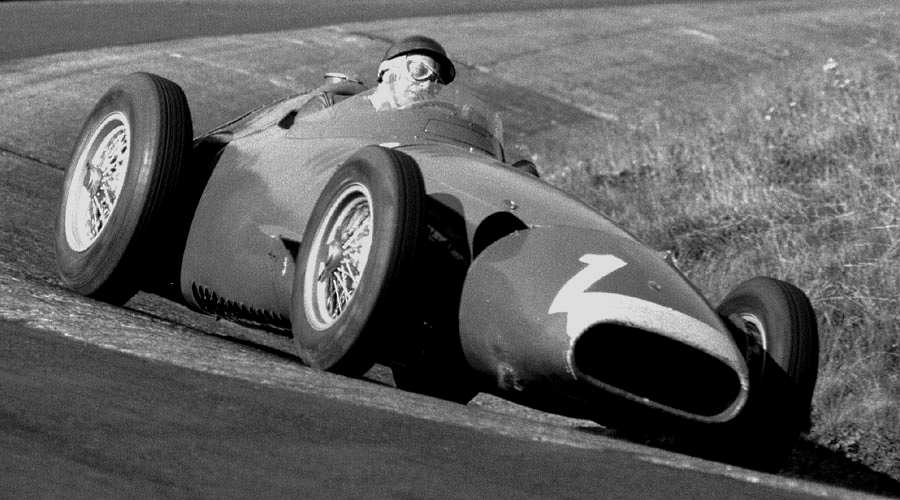 |
Fangio conquista il suo quinto titolo mondiale con la Maserati, ma per
l'epica impresa compiuta dal "Maestro" vale la pena di raccontarla,
anche se concorrente con una Maserati, la rivale modenese dell'epoca.
Per vedere la bandiera a scacchi si dovevano percorrere 22 giri di
22,722 mt. pari a 500,984 km, tra curve e saliscendi massacranti che
mettevano in evidenza doti e lacune di guida anche dei migliori piloti
dell'epoca. Manuel Fangio su Maserati 250F contrariamente ai piloti
Ferrari, monta gomme Pirelli, più tenere delle Englebert
usate dalla Casa di Maranello, montate appositamente per non dovere
effettuare soste ai box per il cambio gomme. La strategia di Fangio
è una gara tutta d'attacco, tanto avrebbe dovuto fermarsi a
sostituire gli pneumatici durante la corsa. Approfittando della maggior
leggerezza della sua vettura, dovuta al minor carburante nei serbatoi,
Fangio passa in testa al 3° giro e come concordato con i suoi
meccanici al 12° giro si ferma per rifornire la vettura. La
sosta studiata prima della gara doveva essere massimo di 30", tanto da
potere rientrare ed essere ancora davanti a Hawthorn e Collins su
Ferrari. Ma qualcosa non funziona e i 30" diventano tra sosta e
ripartenza più di un minuto, allontanandosi così
dalle due Ferrari che indisturbate conducono la corsa. Ma Fangio
è eccezionale! Dopo avere scaldato le gomme nel primo giro,
parte all'attacco dei due battistrada ferraristi. Lo sfrecciare a piena
velocità di Fangio allarma i box Ferrari che per comunicare
l'inizio della rimonta ai loro danni, sono costretti ad aspettare che
Hawthorn e Collins abbiano concluso il giro successivo di quasi 23
chilometri, durante il quale Fangio recupera ancora altri preziosi
secondi. Al penultimo giro parte il primo attacco a Collins che in
seconda posizione viene passato da Fangio, a sua volta ripassato da
Peter. Ma la seconda posizione di Collins durerà poco.
Fangio ormai è all'inseguimento di Hawthorn che
passerà vincendo la gara con tre secondi e mezzo di
vantaggio, approfittando di un errore dell'Inglese. Recuperare secondi
e posizioni sulla pista tedesca non è proprio da tutti,
è solo da Fangio!.
|
|
Gran Premio di Pescara 1957

Settima gara della stagione 1957 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 18 agosto
sul Circuito di Pescara.
|
|
 |
domenica 18 agosto 1957 - 18 giri x 25.579 km - 460.422 km
18 agosto 1957 le scuderie si presentano sul prestigioso
palcoscenico pescarese, i piloti partecipanti sono 16, Enzo Ferrari in
aperta polemica con la giustizia italiana che lo voleva sul banco degli
imputati per la tragedia alla Mille Miglia non inviò i piloti ufficiali,
presente la Ferrari privata di Luigi Musso, c’è un ultimo tentativo
dell’ANAS di annullare la gara per motivi di sicurezza sull’onda emotiva
della tragedia di Guidizzolo, ma alla fine anche questa resistenza cede
e il permesso viene accordato, la gara è valevole come 7ma prova del campionato mondiale di Formula Uno, in totale le gare sono otto, l’ultima è in programma a Monza l’8 settembre successivo.
Le prove del sabato vedono Fangio su Maserati assicurarsi la pole
position, Moss su Vanwall secondo è staccato di oltre 10 secondi, terzo
ancora più staccato Luigi Musso.
La gara prende il via in una calda giornata di agosto, oltre 200.000 spettatori si accalcano lungo il percorso, una folla immensa, 18 giri da completare per un totale di 460km!
Musso con la sua Ferrari infila Fangio e Moss al via e balza in testa, i
due lo inseguono sul polveroso stradone dritto, tallonati dall’altra
Vanwall di Brooks e dalle altre Maserati (10 vetture al via), le due
Cooper di Salvadori e Brabham chiudono il gruppo, e conclude uno
spericolato primo giro in testa.
Dietro di lui Moss a bordo della
sua potente ma poco affidabile Vanwall scalpita e nel corso del secondo
giro sorpassa Musso e si porta al comando, Fangio li insegue
controllando il distacco. Si ritirano due Maserati, Moss continua in
testa ad andatura elevatissima, fa segnare il record del giro in 9’44” e
6, l’inglese è scatenato. Al 10° giro un problema al serbatoio
dell’olio costringe Musso al ritiro, Fangio passa in seconda posizione e
controlla il battistrada sicuro che prima o poi lo vettura lo tradirà
ma non succede, la potente Vanwall resiste fino al termine e Stirling
Moss taglia il traguardo in solitudine vincendo l’unico Gran Premio di
Pescara corso nella storia della Formula Uno.
Fangio finisce secondo
aggiudicandosi i 6 punti che gli permettono di laurearsi campione del
mondo per la quinta volta consecutiva, regalando alla casa del tridente
il suo primo e unico titolo mondiale piloti. |
Circuito di Pescara – Italia, 18 Agosto 1957
Ordine di Arrivo:
1° Stirling Moss (GB) su Vanwall - 2° Manuel Fangio (Arg) su Maserati a 3’13” - 3° Harry Schell (USA) su Maserati a 6’46”
4° Masten Gregory (USA) su Maserati a 8’16” - 5° Stuart Lewis-Evans (GB) su Vanwall a 1 giro - 6° Giorgio Scaratti (Ita) su Maserati a 1 giro - 7° Jack Brabham (Aus) su Cooper a 3 giri.
|
Fu una gran bella pagina di storia dell’automobilismo, ma dall’anno
successivo i percorsi che si snodavano lungo strade ordinarie
furono
giudicati insicuri e tolti dal calendario e il glorioso Circuito di Pescara sparì dal calendario internazionale, degradato
a gare di formula 2 e 3 per le due stagioni successive e poi definitivamente abbandonato.
|
 |
|
Tutti gli appassionati di Formula
1 dovrebbero esser grati alla Lotus di ciò che ha saputo
dare all'automobilismo sportivo. Sei titoli mondiali Formula 1 (1963 e
1965: Clark; 1968: Graham Hill; 1970: Rindt; 1972: Emerson Fittipaldi;
1978: Mario Andretti), innovazioni tecniche epocali, vetture stupende,
due trionfi alla Indy 500 (1965-1966) con Clark e Hill. Ed inutile
nasconderlo. Ai più giovani il nome Lotus suona sconosciuto,
misterioso. Non dice niente. Male, malissimo. Non conoscere la storia e
le imprese di tale Marchio equivale ad ignorare il proprio nome,
cognome e gruppo sanguigno.
MARZO 1948
Da una Austin Seven nasce la Lotus Mk1 progettata x le gare di triaal
molto in voga quegli’anni in inghilterra |
|
GENNAIO 1951
Arriva la prima vettura da competizione x la formula 750, e la Lotus
Mk3 .
La Lotus Engineering è stata fondata nel 1952 da Colin
Chapman, trasformando in officina le scuderie attigue alla locanda del
padre, a Hornsey, a nord di Londra. Chapman, che aveva lavorava come
ingegnere alla British Aluminium, iniziò la produzione in
piccola serie di vetture sportive caratterizzate da un telaio
multitubolare in struttura ultraleggera; quella della leggerezza
resterà sempre il marchio di fabbrica della Lotus. |
|
GENNAIO 1954
Il primo modello da competizione progettato da Chapman e
dall’ingegnere Frank Costin, un esperto di aerodinamica
che
si era unito all’impresa, fu la Mk8.
1956 - Per la F2 Chapman costruisce la Lotus Mk 12, servira poi da base
x la Lotus Mk16 che correrà in F1
Lotus 12
|
|
MAGGIO 1958
Al Gp. di Montecarlo prima gara di debutto x la Lotus in F1 con il
modello mk16, i piloti sono Allison e Hill |
|
|
 |

|
|
|
 |
| Lotus 12 1958 - Motore Climax |
|
| Lotus 16 1958 - Motore Climax |
|
Gli Inizi
| Per apprezzare a pieno il ritorno delle monoposto
Lotus nel campionato F1 occorre conoscere le vicende agonistiche di una
squadra che segnato per oltre venti anni le fasi di sviluppo tecnico e
sperimentazione nel mondo della Formula 1, con trovate geniali,
soluzioni innovative e una serie di vetture spesso risultate vincenti.
Colin Chapman, giovane rivenditore di auto usate scopertosi nel 1948
appassionato di corse automobilistiche Trial nella campagna inglese e
costruttore di auto destinate a queste gare, si cimenta nei primi anni
Cinquanta nella realizzazione di monoposto di categorie minori e nel
1958 arriva la prima partecipazione a una gara iridata di Formula 1, il
GP di Monaco. La ricetta di Chapman per le sue monoposto è
semplice ed efficace al tempo stesso, un mix di scelte meccaniche
razionali, motore posteriore e costruzione leggera che diventa quasi un
marchio di fabbrica delle Lotus da corsa. |
|
Nel
1958 per la prima volta viene assegnata una coppa riservata ai
costruttori. Ad aggiudicarsela è un team inglese: la
Vanwall. I team inglesi, nel corso della loro storia saranno insultati
e guardati dall'alto in basso da un team che si è sempre
messo (un pò a ragione, un pò anche esagerando)
su un piedistallo, la Ferrari, che definirà i team inglesi
"garagisti" con molto disprezzo (e questo assolutamente a torto).
Eppure, i garagisti saranno assoluti protagonisti di un'era lunghissima
della f1, dagli anni 60 fino alla fine degli 90, e non è un
caso che proprio un team inglese abbia inaugurato la coppa costruttori,
nel 1958. A vincere il titolo piloti, quell'anno è
però Hawthorn su Ferrari.
Dopo il ritiro di Fangio, il pilota considerato più forte
è Moss. Moss corre per la Vanwall ma la prima gara egli la
disputa con la Cooper con motore posteriore. A sorpresa Moss fa sua
questa prima gara battendo Ferrari e Maserati. L'annata sarà
incentrata tutta sulla lotta tra Moss e Hawthorn che corre con la
Ferrari, ma anche ... su lutti e tragedie come la scomparsa di Musso e
Collins.
In sintesi Hawthorn ottiene il titolo mondiale solo per un punto grazie
alla sua grande regolarità mentre i due piloti Vanwall, Moss
e Brooks pagano la fragilità della loro vettura.
Di questa stagione vorremmo fissare l'attenzione su un episodio, che
dovrebbe ispirare tutti noi tifosi del motorismo di scuola inglese, una
filosofia dello sport che molti campioni della f1 dimostreranno di non
avere, arrivando a determinare i titoli mondiali con speronamenti e
mosse scorrette, fino addirittura a fare della "furbata" un uso
sistematico. L'episodio di correttezza e sportività
è il seguente: Hawthorn viene messo sotto inchiesta al gp
del Portogallo e rischia di vedersi levare i punti decisivi per il
mondiale: a scagionarlo dalle accuse sarà proprio il rivale
per il titolo, Moss, al quale avrebbe giovato vedere il collega
avversario perdere i punti della gara.
è dunque una stagione, quella del 1958, che dimostra una
certa forza della scuola inglese: titolo piloti ad un inglese (su
Ferrari, però) e titolo costruttori alla Vanwall, team
inglese per il quale corre Moss, il vicecampione del mondo e maestro di
sportività. In termini di sensibilità non fu da
meno neanche Hawthorn che, colpito dalla tragedia di Musso e Collins,
lascerà le competizioni ma morirà egli stesso
poco dopo in un ... incidente stradale.
|

Vanwall - Grand Prix
Lotus Climax 16

Vanwall - Grand Prix

BRM P48 1959 |
 |
|
 |
Il Gran Premio d'Italia 1958 fu la decima gara della
stagione 1958 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 7
settembre
all'Autodromo Nazionale di Monza. La corsa vide la vittoria di
Tony Brooks su Vanwall, seguito dalle Ferrari di Mike Hawthorn e Phil
Hill.
|
 |
 |
|
 |
La BRM venne fondata nel 1947 da Raymond
Mays e Peter Berthon in uno stabilimento a Bourne, nel Lincolnshire.
BRM sarebbe l’acronimo di British Racing Motors. Mays aveva già
esperienza nelle corse avendo posseduto la ERA e avendo corso nelle
gare in salita. Categoria alla quale aveva dato anche il proprio
contributo progettando svariate vetture. Inoltre, sempre con la ERA,
Mays iniziò a lavorare in F1 già nel 1950 fornendo vetture a Bob Gerard e
Cuth Gerard.Al Gran Premio di Gran Bretagna del 1951, la BRM debutta
ufficialmente in Formula 1 e correrà solamente due gare quell’anno. |
La
BRM P15 attira, però, molte attenzioni. Sull’anteriore è di fatto
montato un motore avveneristico: un V16 con bacate da 135°
sovralimentato da 1500 centimetri cubici e capace di erogare oltre 600
Cv. Grazie a questo poderoso V16, Reg Parnell giungerà 5° in Gran
Bretagna ma sopratutto attirerà le attenzioni di grandi piloti come
Fangio e Gonzalez che svolgeranno un test nel corso dell’inverno.
In un primo momento la BRM concentra le
proprie energie più sulla F2 che sulla F1 considerando la prima
categoria più nelle corde del team rispetto alla seconda. Tuttavia,
Fangio e Gonzalez, correranno alcune gare non valide per il mondiale, ma
saranno costretti al ritiro a causa di un V16 potente e rivoluzionario
ma anche fragile. Nel frattempo subentra l’industriale Sir Alfred Owen
che rileva la BRM, ma manterrà il nome originale della scuderia.
Dal 1956 la BRM comincia a correre
regolarmente in Formula 1. Alfred Owen ingaggia i promettenti Mike
Hawthorn e Peter Brooks e inizia a sviluppare la P25 equipaggiata da un
più classico motore a 4 cilindri. I primi veri risultati arrivano nel
1958 quando la BRM chiude 4° nel campionato costruttori davanti alla,
ormai, nobile decaduta Maserati e distante soli 13 punti dalla Cooper.
Nel 1959 arriva anche la prima vittoria con Jo Bonnier in Olanda e a
fine anno Flockhart vince a Snetterton una gara non valida per il
mondiale di Formula 1. Ora la BRM non è più una scuderia che corre
saltuariamente in F1, ma una solida realtà e una minaccia concreta per
tutti.
Nel 1960 arriva un giovane inglese, già
messosi in mostra in un’altra scuderia giovane ma in grande espansione
(Lotus): Graham Hill. La BRM abbandona progressivamente la P25 e
comincia a sviluppare la nuova P48. In una stagione dominata da Cooper e
Lotus, il trio composto da Bonnier, Gurney e Hill mette insieme solo 8,
di cui 4 presi in Olanda col podio di Hill, ed è sempre 4° nel
costruttori. Nonostante un’avvio promettente, la P48 si rivela una
vettura fragile e i risultati non sono molti. Nel 1961 la BRM prosegue
con la P48 ma inizia a sviluppare la nuova P57.
 |
Nel
1961 ad affiancare Hill arriva (anzi torna) Tony Brooks, ma i risultati
ancora sono scarsi.In Formula 1 le Ferrari dominano la stagione e alla
BRM non rimane che cogliere solo una vittoria, per di più col privato
Tony Marsh, al “Memorial Lewis-Evans” e la situazione interna al team è
sempre più difficile. Si Alfred Owen minaccia tutti, piloti compresi, di
chiudere la saracinesca della factory se non arriveranno risultati
concreti a partire dall’anno successivo.La nuova, e sviluppata, BRM P57
progettata da Tony Rudd inizia subito alla grande vincendo un paio di
gare fuori calendario e, una volta iniziato il mondiale, vince la prova
inaugurale in Olanda per poi replicarsi in Germania, Italia e Sud Africa
facendo suo il campionato all’ultima gara e vincendo il costruttori per
la prima volta nella storia della BRM. |
Nel
1961 ad affiancare Hill arriva (anzi torna) Tony Brooks, ma i risultati
ancora sono scarsi.In Formula 1 le Ferrari dominano la stagione e alla
BRM non rimane che cogliere solo una vittoria, per di più col privato
Tony Marsh, al “Memorial Lewis-Evans” e la situazione interna al team è
sempre più difficile. Si Alfred Owen minaccia tutti, piloti compresi, di
chiudere la saracinesca della factory se non arriveranno risultati
concreti a partire dall’anno successivo.La nuova, e sviluppata, BRM P57
progettata da Tony Rudd inizia subito alla grande vincendo un paio di
gare fuori calendario e, una volta iniziato il mondiale, vince la prova
inaugurale in Olanda per poi replicarsi in Germania, Italia e Sud Africa
facendo suo il campionato all’ultima gara e vincendo il costruttori per
la prima volta nella storia della BRM.
Il mondo della Formula 1 si accorge
della BRM. La casa di Bourne comincia a vendere telai anche a privati
concorrenti in F1 e non solo più a piloti occasionali in gare fuori
calendario. Scuderia Centro-Sud, Scuderia Filipinetti, BRP sono solo
alcune delle scuderie che busseranno alla porta di Sir Alfred Owen per
acquistare un telaio. Dopo un 1962 trionfale, la BRM non riesce a
replicarsi nel 1963 anche se Hill vincerà aMontecarlo e a Watkins Glen. A
fine anno la BRM chiuderà seconda sia nel piloti (Hill) che nel
costruttori dietro alla coppia-perfetta Clark-Lotus.
Nel 1964, Hill vince ancora a Montecarlo
e Watkins Glen e il mondiale viene perso all’ultima gara in Messico
nella maniera che tutti sappiamo. L’anno dopo debutta un giovane
scozzese destinato a scrivere la storia della Formula 1 negli anni
seguenti: Jackie Stewart. Il giovane futuro Sir Jackie va subito
fortissimo e chiude secondo il campionato dietro a Hill secondo per il
terzo anno di fila. Senza la regola degli scarti la BRM avrebbe vinto il
campionato costruttori davanti anche alla Lotus del volante Jim Clark.
Il 1966 è l’anno dell’aumento delle
cilindrate da 1.5cc a 3.0cc. La BRM progetta l H16 come motore e la P83
come telaio. Un motore competitivo su un telaio che, però, si rivela fin
da subito carico di problemi. Hill non vince neanche una gara, mentre
Stewart vince a Montecarlo con la vecchia P261 che si rivelerà migliore
dlla P83 lungo tutto l’arco della stagione.
 |
L’anno
successivo Hill lascia la BRM per accasarsi alla Lotus e viene
sostituito da Mike Spence con Stewart promosso al ruolo di prima guida.
Spence riesce ad andare a punti più volte, mentre Stewart deve
accontentarsi di soli 2 podi. Ormai il team sembra ben lontano dai
trionfi di pochi anni prima e comincia a decadere come motorista. La
Lotus, difatti, abbandona gli H16 per affidarsi ai neonati Ford DFV. Nel
1968 anche Stewart lascia la BRM e inizia a susseguirsi una girandola
di piloti e telai che fanno ben intuire lo stato di totale crisi in cui
la BRM si trova. Pedro Rodriguez porta a casa gli unici podi del team e
l’arrivo di Surtees e Oliver, ingaggiati con la speranza di risollevare
le sorti della squadra, non porterà alcun giovamento. |
Nel 1970 l’unica (e una delle ultime)
gioie della BRM arriva dalla vittoria di Rodriguez a Spa dopo una gara
da leone e una resistenza straordinaria agli attacchi di uno scatenato
Amon nel finale. La P153 è una macchina veloce, grazie a V12 P142, ma
altamente fragile e Rodriguez racconterà che temeva più di rompere
qualcosa all’ultimo giro che subire un sorpasso da Amon in quanto il
motore gli garantiva una maggior velocità di punta e quindi riusciva a
prendere più margine prima delle staccate.
Nel 1971, la BRM da segnali di ripresa
vincendo in due occasioni, Austria e Italia, con Siffert (poi morto a
fine anno a Brands Hatch e unico deceduto alla guida di una BRM) e Gethi
nell’arrivo più “cardiopalmatico” della storia della F1: Monza 1971.
Nel 1972 la BRM firma un importante accordo con la Marlboro per una
sponsorizzazione che coprirà interamente le livree del team e andrà
rilevare una netta quota a Alfred Owen. Jean-Pierre Beltoise vince a
Montecarlo l’ultima gara della storia della BRM. Curioso il fatto che il
francese fosse alla guida della P160B , una versione aggiornata della
P160 ultima vera e gloriosa BRM.
La P180 non è affatto una vettura
competitiva e la BRM riuscirà a vendere le ultime P160 fino al 1974.
Economicamente, ormai il team di Bourne è allo sfascio. La Marlboro
abbandona ben presto la BRM per concentrarsi sulla crescente Mclaren e
le altre sponsorizzazioni a stento coprono il budget stagionale. Alfred
Owen muore a fine 1974 e nello stesso periodo il team entra in
liquidazione. Louis Stanley rileva le quote del team e annuncia il
ritorno in pompa magna dopo 2 anni ma ormai il danno è fatto. La BRM non
riesce a riprendersi e dopo un tentativo andato a vuoto di rietro, nel
1979, sparisce definitivamente dalla Formula 1.
|
 |
GP Gran Bretagna 1958 : successo di Collins
|
|
|
|
| Al volante di una 246 F1, il pilota inglese colse la sua terza ed ultima
vittoria in Formula 1 proprio davanti al compagno di squadra, amico e
connazionale Mike Hawthorn. Quel successo arrivò dopo il tragico Gran
Premio di Francia del 6 luglio, quando perse la vita il ferrarista Luigi
Musso ma la morte non smise di esigere il suo tributo alla Formula 1.
Il 3 agosto successivo al Nürburgring, durante l’undicesimo dei 15 giri
del Gran Premio di Germania, toccò proprio a Collins pagare il prezzo
più alto possibile per la sua passione per le corse. |
Ferrari 246 F1
La “246 F1” è l’ultima monoposto Ferrari ad
essere spinta da un propulsore collocato anteriormente. Le brillanti
prestazioni sfoggiate dalle Cooper a motore posteriore costringeranno
infatti il Commendatore ad arrendersi all’evidente supremazia della
nuova architettura che, a suon di risultati, sfata il credo – a lui
tanto caro – che vuole i buoi da-vanti al carro. Il telaio di questo
bolide da Gran Premio, benché perfezionato da notevoli evoluzioni
costruttive, è a struttura tubolare, nel solco della migliore tradizione
di “famiglia”. Anche le sospensioni seguono il collaudato schema a
ruote indipendenti all’avantreno e a ponte De Dion al retrotreno; negli
step successivi pure queste ultime, tuttavia, diventeranno a ruote
indipendenti.
I freni sono a tamburo sulle quattro ruote ma, nel
corso dello sviluppo, verranno sperimentate (per la prima volta in
Ferrari) le efficaci unità anteriori a disco. Il cambio è a quattro
rapporti più retromarcia, installato posteriormente in senso trasversale
e posto in blocco col differenziale; la frizione è a dischi multipli.
Buono il dato relativo al peso, contenuto in appena 560 Kg, grazie
all’ampio impiego del leggero allumino. Questo facilita il compito del
motore destinato a spingere la monoposto, che è un 6 cilindri a doppia
bancata ad angolo interno di 65°, con alesaggio di 85 mm e corsa di 71
mm. La sua cilindrata è di 2417 cc e la potenza che riesce ad esprimere
si attesta sui 280 cv a 8500 giri al minuto. Due sono le valvole per
cilindro, con distribuzione di tipo bialbero a camme in testa azionata
da catena.
Si racconta che all’impostazione iniziale del
propulsore abbia collaborato Dino, il figlio del Commendatore
prematuramente scomparso. Ed è in suo onore che questo sei cilindri
vie-ne battezzato col suo nome. L’unica vittoria conseguita a Reims, nel
corso del Gran Pre-mio di Francia, assicura al driver inglese Mike
Hawthorn la conquista del Campionato del Mondo del 1958, alla guida di
una monoposto sana e affidabile, la “246 F1” appunto. Per la Casa di
Maranello questo successo è un’ulteriore alloro da aggiungere ad
un’ampia lista destinata a diventare sempre più lunga, creando nel tempo
un palmares d’eccellenza capace di elevare a mito la piccola azienda
fondata dal Grande Enzo Ferrari
|
|
|
Gran Premio di Francia - 6 luglio1958
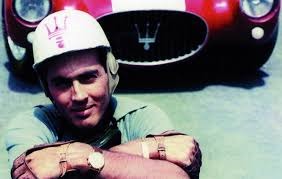 |
Luigi Musso
|
 |
Mike Hawthorn
|
 |
| Peter Collins |
|
I debiti di gioco e la coalizione inglese:
l’enigma della morte di Luigi Musso al Calvaire

|
La dinamica
dell’incidente non ce l’ha chiara nemmeno Enzo Ferrari. Che
scrive: “È difficile sapere con esattezza ciò che
accadde.
I pochi
testimoni e gli ufficiali di gara fecero un racconto in cui lo spavento
prevalse sulla fedeltà della cronaca”.
Gran Premio di Francia, 6 luglio del 1958, mentre lotta con Mike Hawthorn si schianta e muore Luigi Musso sulla Ferrari
alla curva del Calvaire di Reims.
“E finisce – sempre Ferrari che scrive – il bello stile italiano”.
Educato, acculturato, figlio di un diplomatico e bello come un divo,
eroe intrepido e dannato, corre per mestiere e corre pure – lo confessa
ad Antonio Ghirelli – perché ha bisogno “di guadagnare molto”, prova a farlo “attraverso un rischio calcolato”.
È una faccenda enigmatica, ci sono di mezzo i debiti di gioco. Musso
nel 1957 nel volo verso l’Argentina ha perso 12 milioni di lire a poker.
E allora le corse, il Gran Premio di Francia che assegna un premio
dieci volte più grande rispetto a tutte le altre tappe del mondiale.
Lui
è deciso a vincere.
Come Hawthorn e Collins che pure guidano la Ferrari
e secondo Fiamma Breschi, l’ultima compagna di Musso, hanno un patto
per ostacolarlo:
Chiunque dei due avesse vinto, avrebbe diviso i soldi con
l’altro. L’unione fa la forza. E loro erano in due contro Luigi che non
faceva parte dell’accordo. Era una rivalità che avrebbe anche favorito
Ferrari anziché danneggiarlo.
Più veloci andavano, più probabilità
c’erano di vincere.
Insomma Musso quando arriva al Calvaire si gioca tutto per tutto:
“Sono convinto – svela Ferrari – che la foga della gara gli fece tenere
il piede giù a fondo”. Come gli aveva detto Fangio, per guadagnare mezzo
secondo.
Fangio che dall’inizio del campionato già sta meditando il
ritiro e dopo la tragedia decide di smettere.
Luigi Musso

Luigi Musso nasce a Roma il 27 luglio 1924 e muore
a Reims, durante il Grand Prix, il 6 luglio 1958. Aveva iniziato la sua
carriera di pilota nel 1950 su vetture sport 750 cmc, ottenendo nel
primo triennio qualche buon piazzamento. Il 1953 è
l’anno dei primi risultati: vince il Giro
dell’Umbria, il Circuito di Avellino e la corsa in salita
Vermicino Rocca di Papa.
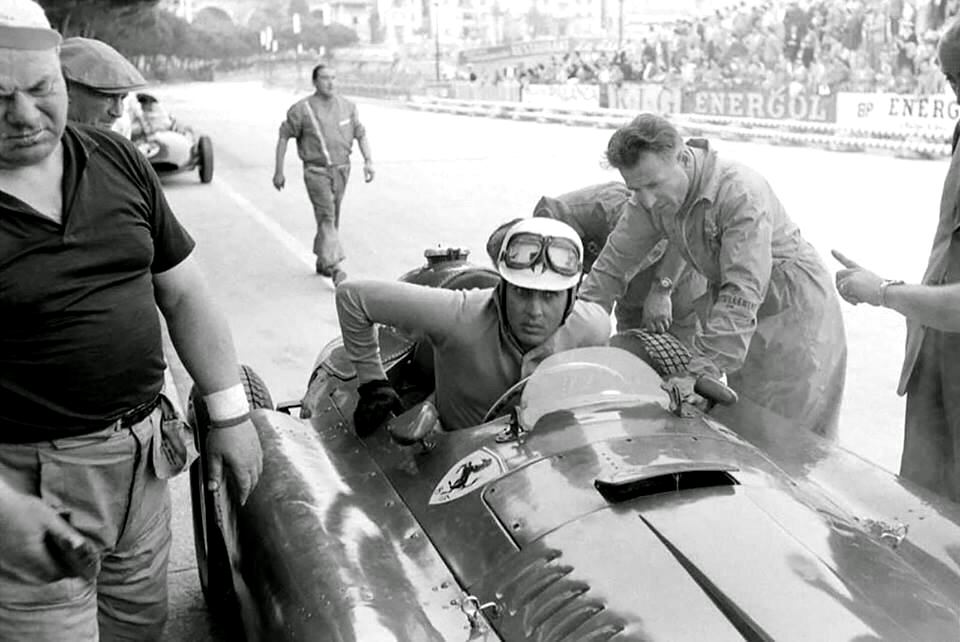
Luigi Musso Monaco, 1956
L’anno successivo affronta il mondo della Formula 1, e vince
subito, al Gran Premio di Napoli e al Gran Premio di Pescara, con una
Maserati; inoltre arriva secondo al Gran Premio di Spagna. Ma le sue
doti di pilota completo lo portano ad affrontare la Targa Florio, su
Maserati (secondo posto assoluto) e sempre su Maserati la Mille Miglia
(terzo posto assoluto). Entrato stabilmente a far parte della squadra
Maserati, continua a correre nel 1955 senza risultati eclatanti: molti
secondi posti o buoni piazzamenti, ma manca la vittoria trionfale. Nel
1956 cambia squadra ed entra alla Ferrari: ottiene la prima grande
affermazione internazionale nel Gran Premio d’Argentina in
coppia con Fangio, mentre con Schell si classifica secondo alla 12 Ore
di Sebring. L’anno della sua definitiva consacrazione tra i
grandi è però il 1957. Arriva primo al Gran
Premio di Reims, che gli sarà fatale l’anno
successivo, si piazza secondo sui circuiti di Francia, Gran Bretagna e
Modena, vince la 1000 km di Buenos Aires insieme a Castellotti e a
Gregory, al termine della stagione diventa Campione d’Italia.
E’ il 1958: Musso si piazza secondo al Gran Premio di
Argentina e al Gran Premio Città di Buenos Aires; ancora
secondo con Gendebien alla 12 Ore di Sebring, primo al G.P. di Siracusa
e alla Targa Florio. Arriva secondo al G.P. di Monaco. E giunge il
momento dell’ultima gara, a Reims, il 6 luglio.
 |
Nel corso del decimo giro sul circuito di Reims, all’inseguimento di
Hawthorn, col quale si gioca la prima posizione, Musso vola nel fossato
esterno alla curva Gueux, capottando.
Muore poche ore più tardi, in ospedale, a causa delle gravi ferite
riportate alla testa, lasciando a Hawthorn l’unica vittoria della
stagione e la conquista, amara, del titolo mondiale. Musso è il primo
pilota Ferrari a morire in gara. |
|

Fiamma Breschi Enzo Ferrari
|
CHI ERA FIAMMA BRESCHI
LA MUSA MISTERIOSA CHE COLORAVA LA VITA DI ENZO FERRARI
|
L'ultimo, straordinario, saluto firmato Giorgio Terruzzi a Fiamma
Breschi, la “bellissima signora” del Cavallino - Dopo la morte del
compagno Luigi Musso, pilota romano della Rossa, tentò il suicidio ma fu
salvata dalla donna di Fangio - Fu allora che Ferrari cominciò a
scriverle, a chiederle consigli: "Si affidò a me - disse lei - gli
inventai quello che poi è diventato il suo modo di vestire”...
|
|
|
Musso non sopravvisse alle ferite riportate nella celebre
Curva del Calvaire
del Circuito di Reims.
|
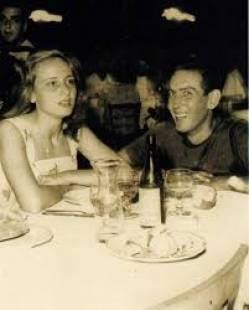 |
Fiamma Breschi - Luigi Musso
|
|
|
|
|
«L' ingegnere Mauro Forghieri e Gaetano Passarelli con dolore
partecipano alla scomparsa della signora Fiamma Breschi, ricordando con
tristezza e rammarico quando le gare si vivevano e vincevano con grande
spensieratezza e allegria e con la presenza ai box di signore
bellissime». Il necrologio è apparso ieri sul Corriere . Poche righe
delicate e romantiche che contengono una storia intensa e sommersa.
Protagonisti: Fiamma Breschi, la «bellissima signora», ed Enzo Ferrari.
Lei, ultraottantenne e malata, è scomparsa venerdì a Firenze. Lui,
signore e padrone della leggenda più straordinaria del motorismo, se n' è
andato il 14 agosto 1988. Si conobbero nel cuore degli anni Cinquanta.
Fiamma, giovane e attraente, era la compagna di Luigi
Musso, pilota romano del Cavallino, disposto a lasciare moglie e due
figli pur di averla accanto ogni giorno, sino all' ultimo, 6 luglio
1958, quando morì, a Reims, dopo l' ennesimo incidente di un' epoca da
stragi in pista. Appena lo seppe, Fiamma cercò di gettarsi dalla
finestra dell' hotel. Bloccata dalla compagna di Juan Manuel Fangio,
Beba, e dalla moglie di Maurice Trintignant, Lulù.
Fu
allora che Ferrari cominciò a scriverle, a frequentarla, a chiederle
consigli, preso da una docilità inattesa: «Si affidò a me, gli inventai
quello che poi è diventato il suo modo di vestire - disse in una rara
intervista -. Già nel 1962 mi voleva sposare, mi ha chiesto di sposarlo
sino a quando è morto». Si telefonavano. Ore ed ore di conversazioni.
Si scrivevano. Una lettera al giorno, secondo chi viveva vicino a
Ferrari. Si vedevano. A Firenze, forse altrove: «Veniva a mangiare a
casa mia. Fece coniare una coppa con il Cavallino dedicata a mia madre,
la cuoca più brava del mondo».
Abbastanza per far scattare pettegolezzi insistenti lungo quel crinale
delicato che fu la vita privata del Grande Vecchio di Maranello, sposato
con Laura, legatissimo a Lina, mamma di Piero. Del resto, Fiamma
Breschi cercò sempre di allontanare ogni ambiguità: «Eravamo amici, era
qualcosa di grande ma di platonico».
Questo disse e scrisse nel libro «Il mio Ferrari» (Mursia) del 1998. Una musa, dunque.
Intelligente al punto da farsi nominare dal capo, inviata speciale
alle corse: «Ferrari aveva sempre bisogno di controllare tutto e lei era
una donna piacevole, abile nel parlare e nel fare» racconta Forghieri,
il tecnico che ha accompagnato il decollo del mito di Maranello: «Capace
di convincerlo a presentare la prima Ferrari gialla, una 275 GTB 4 del
1966». Chissà, forse Fiamma, riuscì a sfiorare un lato debole e nascosto
di quell' uomo così geniale, così feroce, così difficile da trattare.
Del quale disse molto e disse molto poco,
conservando, insieme al casco giallo di Musso, ogni sua lettera, ogni
segreto, dentro una cassetta blindata. Ma ogni curiosità pare, adesso,
un' invadenza. Meglio lasciar correre l' immaginazione e una nostalgica
tenerezza.
Sentimenti nel vento, a
bordo di automobili preziose. Immagini di un uomo e una donna che volano
via, con i loro misteri,
dentro un tempo magnifico e perduto.
|
|

La stagione della Formula 1 del 1958
19 GENNAIO 1958
LA PRIMA VITTORIA DELLA COOPER
CON MOTORE POSTERIORE
|
Un evento di portata storica destinato a cambiare radicalmente la
tecnica delle vetture Grand Prix. In realtà, la Cooper T43
Climax non era una novità assoluta. Già a
metà degli anni trenta le favolose Auto Union con motore 16
cilindri posteriore progettate dal Prof. Porsche avevano dominato la
scena. Nel 1956 era apparsa al Gran Premio di Francia la Bugatti Tipo
251. La vettura progettata dall’Ing.Gioacchino Colombo, che
purtroppo non ha avuto più seguito, montava un motore
trasversale 8 cilindri posizionato davanti all’assale
posteriore.
 |
|
Così il successo ha giustamente premiato la
dedizione al motore posteriore di John Cooper, che aveva iniziato nei
primi anni cinquanta con le piccole monoposto della F3 motorizzate JAP,
per poi proseguire nelle sue applicazioni con le sport e le F2.
Partendo dalla F2 ha poi impostato il progetto della vettura Grand Prix
che, dopo i primi due tentativi nel Gran Premio di casa, ha schierato
stabilmente nel mondiale a partire dal 1957. A favore della Cooper
giocavano chiaramente il peso contenuto, appena 368 kg contro gli oltre
600 della concorrenza, e la maneggevolezza, anche se le sue forme erano
un po’…bruttine rispetto al trend delle macchine a
motore anteriore tipo la Vanwall. |
Al Gran Premio d’Argentina, tradizionale gara
d’apertura della stagione, la T43 schierata dal team di Rob
Walker, che affiancava la squadra ufficiale di Jack Brabham e Roy
Salvadori, poteva contare una tantum su Stirling Moss, libero dagli
impegni con la Vanwall. Fu una vittoria abbastanza fortunosa. A Luigi
Musso con la Ferrari non fu segnalato adeguatamente che stava
rimontando alla grande sul pilota di testa, abbastanza in
difficoltà. Moss vinse con poco meno di tre secondi sul
pilota romano mentre quarto, alle spalle dell’altra Ferrari
di Mike Hawthorn, si classificò Juan Manuel Fangio alla sua
ultima gara.
Cinque mesi più tardi, al Gran Premio di Monaco del 18
maggio, il bis della Cooper-Climax della Scuderia di Rob Walker,
questa
volta con Maurice Trintignant…
|
|
|
|
 |
Vista sulla curva Nord durante una gara del 1955
|
|
|
|
|
Il Gran Premio di Germania 1959
fu la sesta gara della stagione 1959 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 2 agosto
sul tracciato dell'AVUS. A causa delle
altissime velocità in pista l'evento fu diviso in due manche da
30 giri ciascuna. La classifica finale
data dalla somma dei tempi vide
un podio tutto Ferrari, con Tony Brooks vincitore, ed a seguire Dan
Gurney e Phil Hill.
Il
pilota francese Jean Behra morì in una gara di contorno al
volante di una Porsche RSK uscendo di pista alla curva sopraelevata.
|
Gran Premio di Francia : Reims, 5 luglio 1959
Tutte le macchine del team Ferrari sono allineate nel paddock prima delle prove.
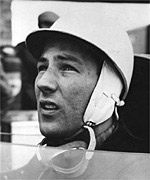 |
Il 27 maggio 1951 nel Gran
Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del
mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling
Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non
hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17
settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran
Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole
positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il
pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa
delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del
mondo |
La grande sfortuna di Moss è stata quella di incrociare la
propria carriera con quella del più grande pilota di ogni epoca a
livello di risultati, Juan Manuel Fangio, che dal '55 al '57
lo precedette nella classifica mondiale, mentre nel '58 fu battuto
di un solo punto dal connazionale Mike Hawthorn, pilota della
Ferrari che, pur avendo vinto un solo Gran Premio contro i quattro
di Stirling, si aggiudicò il titolo a causa di un regolamento
discutibile che premiava
di più i piazzamenti che le vittorie. Dopo
essersi piazzato terzo nella classifica dei campionati '59 '60 e '61
Moss si stava apprestando a dare l'ennesimo assalto
all'iride
per la stagione 1962 quando il lunedì di Pasqua in una gara fuori
campionato a Goodwood ebbe un terribile incidente che pose fine alla
sua carriera.
Tra le tante prestazioni memorabili del londinese va
ricordata quella del 19 gennaio 1958 a Buenos Aires quando con la
piccola Cooper-Climax a motore posteriore battè nettamente le ben
più potenti Ferrari e Maserati che parteciparono a quella gara;
inoltre fu il primo pilota a portare alla vittoria la gloriosa
scuderia della Lotus a Montecarlo nel 1960.
La gara di F1 con meno iscritti di sempre
Anno 1958. La F1 sbarcava in Argentina, circuito di Buenos Aires, per il primo Gran Premio della stagione.

|
|

La Cooper di Moss
|
La gara era in programma il 19 gennaio. Erano passati 4 mesi dall'ultima
gara di F1 a Monza, e durante l'inverno le varie scuderie avevano
sviluppato
nuovi modelli o migliorato gli esistenti.
Tuttavia, il regolamento tra le due stagioni era cambiato. Prima del GP
d'Argentina la composizione delle benzine era libera, ma per la stagione
1958
venne reso obbligatorio l'uso di carburanti standard avio, quindi
di derivazione aeronautica.
Vanwall e Brm si trovarono impreparati al cambiamento; di conseguenza
decisero di disertare l'appuntamento oltreoceano per concentrarsi
sul GP
successivo. Quello di Monaco, a maggio!
Arrivarono a Buenos Aires solo 10 vetture. Eccole: 3 Ferrari D246, 6
Maserati 250F e una Cooper-Climax T43 a motore posteriore del Rob Walker
Racing Team. Stirling Moss era alla guida dell'unica rappresentante del
Regno Unito, mentre per il Cavallino gareggiarono Musso, Hawthorn e
Collins. Le Maserati, schierate in forma privata a causa del ritiro del
team ufficiale per motivi economici, furono a disposizione di Fangio,
Behra, Godia, Gould, Menditeguy e Schell.

Moss festeggiato al traguardo
|
La gara fu avvicente. Moss la conquistò grazie a una accorta tattica,
mettendo a registro due record per la F1: la prima vittoria per la
Cooper e la prima per una vettura a motore posteriore. L'inglese non si
fermò ai box per cambiare pneumatici, riuscendo a gestire il suo
vantaggio su Luigi Musso. Hawthorn arrivò 3°, mentre Fangio giunse 4°
davanti a tutte le altre Maserati. Collins fu l'unico ritirato per via
della rottura dell'albero di trasmissione.
Moss negli ultimi giri fu costretto a rallentare a causa del consumo
delle gomme. Una sosta ai box, tuttavia, non gli avrebbe fatto
risparmiare tempo in quanto la sua Cooper non disponeva del fissaggio
centrale. Musso, da parte sua, potè solo recriminare sul risultato
finale; lui e il box Ferrari non si erano intesi bene
sull'interpretazione della strategia di Moss, lasciandogli prendere un
vantaggio incolmabile quando invece sarebbe stato meglio spingere
sull'acceleratore.
Era un'epoca romantica per l'automobilismo, e di quella gara rimangono
attuali solo le strategie suicide della Ferrari... Nella gara
successiva, quella di Montecarlo, si ristabilì lo scorrere naturale
degli eventi, con più di 30 iscritti (tra cui Bernie Ecclestone) e una
straordinaria varietà di team e modelli. |
Moss negli ultimi giri fu costretto a rallentare a causa del consumo
delle gomme. Una sosta ai box, tuttavia, non gli avrebbe fatto
risparmiare tempo in quanto la sua Cooper non disponeva del fissaggio
centrale. Musso, da parte sua, potè solo recriminare sul risultato
finale; lui e il box Ferrari non si erano intesi bene
sull'interpretazione della strategia di Moss, lasciandogli prendere un
vantaggio incolmabile quando invece sarebbe stato meglio spingere
sull'acceleratore.
Era un'epoca romantica per l'automobilismo, e di quella gara rimangono
attuali solo le strategie suicide della Ferrari... Nella gara
successiva, quella di Montecarlo, si ristabilì lo scorrere naturale
degli eventi, con più di 30 iscritti (tra cui Bernie Ecclestone) e una
straordinaria varietà di team e modelli.
|


|
Gran Premio degli Stati Uniti d'America 1959
|

|
La
corsa vide la vittoria di Bruce McLaren su Cooper-Climax, seguito dal
francese Maurice Trintignant, sempre su Cooper-Climax e dal britannico
Tony Brooks su Ferrari.
McLaren vinse il suo primo Gran Premio in Formula 1 all'età di
22 anni e 104 giorni. Il record verrà battuto solamente alGran
Premio d'Ungheria 2003 da Fernando Alonso, vincitore a 22 anni e 26
giorni.
Grazie al quarto posto in gara Jack Brabham,
che raggiunse il traguardo spingendo a braccia il suo veicolo senza più
carburante, si laureò Campione del Mondo con 4 punti di vantaggio su
Tony Brooks e 5,5 su Stirling Moss.
A
conquistare il mondiale costruttori del 1959 è la Cooper
Climax. Questo team introduce una rivoluzione fondamentale, qualcosa
che esiste ancora oggi. Una delle poche cose ad equiparare una f1 di
oggi ad una del passato è la posizione del motore:
alle
spalle del pilota, non davanti.
1959 F1 Monaco Cooper Climax 26 Masten Gregory 24 Jack Brabham 22 Bruce McLaren
La soluzione del motore centrale venne introdotta quattro anni prima
dalla Cooper e nel 1959 arriva il titolo mondiale, il primo per una
vettura con motore centrale. La Cooper Climax T51 campione del mondo
1959 ha il suo punto di forza nel minor peso e nella maggiore
manegevolezza della monoposto. Il motore collocato nella parte
centrale, cioè alle spalle del pilota ma davanti all'assale
posteriore, fa sì che il peso sia allocato maggiormente
sulla parte centrale anzichè davanti. L'avantreno risulta
così più leggero (rispetto alle vetture con
motore montato in posizione tradizionale, cioè in posizione
anteriore) soprattutto in accelerazione ed in curva.
Il minor peso sull'avantreno riduce, altresì l'usura dei
pneumatici. In effetti anche oggi il problema della distribuzione dei
pesi è essenziale soprattutto in relazione al consumo degli
pneumatici. Oggi la distribuzione dei pesi è connessa alla
distribuzione della zavorra all'interno della vettura. Tornando alla
Cooper Climax del 1959 e ai vantaggi del motore centrale, dobbiamo
anche dire che la collocazione centrale del motore garantisce anche un
miglior scaricamento dei cavalli al suolo, inoltre, non essendoci
albero di trasmissione il pilota può essere sistemato
più in basso nella vettura con benefici "aereodinamici".
L'innovazione del motore centrale è solo la prima di una
serie di innovazioni fondamentali
introdotte dai team inglesi di f1.
Il titolo piloti viene vinto da Brabham proprio sulla fantastica Cooper
Climax
|
|
|
|
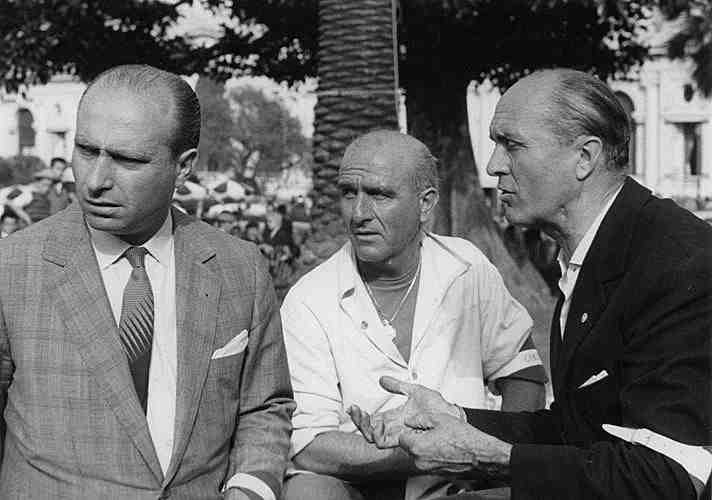 |
"The Boys" - Fangio - Giuseppe "Nino" Farina - Louis Chiron 1959
 |
 Jim Clark - John Surtees - Dan Gurney - Graham Hill Jim Clark - John Surtees - Dan Gurney - Graham Hill |
| Corre l'anno 1959 e il mondo dei Gran Premi
è cambiato radicalmente. Fangio, Hawthorn e Collins se ne
sono andati. Vanwall ha deciso di abbandonare la Formula 1 e Maserati,
Mercedes e Alfa Romeo sono ormai solo un pallido ricordo. Cooper, che
aveva contribuito al successo della Vanwall nella Formula Junior,
inaugura la stagione con un programma molto impegnativo. In
collaborazione con il pilota e ingegnere australiano Jack Brabham,
progetta un'auto a motore posteriore con propulsore Coventry-Climax
2500. I vantaggi determinanti del progetto sono di natura aerodinamica
e di peso. Infatti la T51 pesa solo 484 kg. contro i 673 kg. delle
contemporanee BRM a motore anteriore. Il motore Cooper-Climax apre
così improvvisamente nuove strade alle piccole scuderie che
ora possono impiegare motori modificati e gareggiare ai livelli di
quelle grandi. Questa evoluzione permetterà a squadre come
la Brabham, la MacLaren e la Surtees, giusto per fare qualche nome, di
gareggiare senza complessi di inferiorità. Con la
soppressione del Gran Premio di Argentina, la prima gara della stagione
viene spostata a Montecarlo. Vince Brabham anche grazie ai ritiri di
Behra su Ferrari e di Moss sulla Cooper Rob Walker. Zandvoort, il Gran
Premio seguente, vede vincere a sorpresa una BRM, al primo successo
dopo nove anni, guidata da Jo Bonnier. Le Ferrari dimostrano ancora
tutta la loro potenza sui circuiti veloci, piazzandosi al primo e al
secondo posto a Reims, con Brooks davanti a Phil Hill. La Cooper
ritorna ai vertici con il Gran Premio di Gran Bretagna ad Aintree
grazie a Brabham, alla sua seconda vittoria personale. Il suo giovane
compagno di squadra Bruce McLaren conclude terzo dietro Stirling Moss.
La Ferrari, a causa di uno sciopero generale in Italia, non riesce a
presentarsi alla competizione, assottigliando così le
speranze di Tony Brooks per la corsa al titolo. La gara sucessiva
è il Gran Premio di Germania che quest'anno si corre sul
circuito di Avus: si tratta di un tracciato molto veloce, ideale per le
Ferrari che infatti dominano e vincono con Tony Brooks. Moss, finora a
secco di vittorie, conquista il Gran Premio del Portogallo e
così la rosa dei concorrenti al titolo di Campione del Mondo
si riduce ai soli nomi di Moss, Brabham e Brooks. A Monza Moss vince
ancora mentre Brabham raccoglie punti preziosi giungendo terzo. Prima
del Gran Premio degli USA che si tiene a Sebring, il tracciato della
famosa 12 ore da Granturismo, c'è una pausa di tre mesi.
Questo Gran Premio è l'ultima possibilità che
rimane a Moss per aggiudicarsi il titolo finale. Con la conquista della
pole position l'impresa sembra riuscirgli, ma in gara il motore della
sua auto cede. Brabham allora passa in testa ma finisce la benzina
prima del tempo. Il pilota non si dà per vinto e
testardamente spinge a piedi la sua monoposto oltre il traguardo,
piazzandosi quarto e conquistando così il titolo. |
|
|
|
Monaco, sotto la pioggia, Moss alla guida di una Lotus privata si aggiudica una bella vittoria
La prima vittoria di Bruce McLaren
Nel
1959, oltre alla 500 miglia di Indianapolis, cui non prendevano parte i team
europei, si corse anche un secondo gp degli USA a Sebring, il tracciato più noto
per la 12 ore. Si trattava dell’ultima gara di quel campionato del mondo. 3 piloti arrivarono all’ultima sfida con la possibilità di diventare
campioni. Uno dei piloti in lotta per il titolo è Tony Brooks, pilota Ferrari.
Gli altri due contendenti alla corona iridata sono Moss e
Brabham, entrambi piloti Cooper. Moss guidava una Cooper schierata dal team
privato di Rob Walker.
|
|
In queste circostanze, era estremamente importante il ruolo occupato da Bruce
McLaren che era lo scudiero di Brabham. Moss scattava dalla pole. Dopo un’uscita
di pista Brooks sprofonda indietro e deve rimontare. Moss si deve ritirare per
un problema tecnico al 5° giro.
Brooks rimonta posizioni e alla
fine riesce a ottenere il 3° posto. Brabham, con il 4° posto finale si laurea
campione del mondo mentre la gara è vinta da Bruce McLaren. Bruce, è il più
giovane pilota ad aver vinto un GP, record conservato sino al 2003, quando con
il successo nel GP di Ungheria Alonso diventa il nuovo più giovane vincitore (a
sua volta ora battuto da Vettel).
|
|
Primo davanti alla bandiera a scacchi è
il ventiduenne neozelandese Bruce McLaren, il più giovane
pilota nella storia a vincere un Gran Premio. La Cooper vince la Coppa
Costruttori battendo la Ferrari per otto punti. Davide ha sconfitto
Golia e il mondo della Formula 1 da questo momento non sarà
più lo stesso. Nel 1960 tra i maggiori concorrenti, solo la
Ferrari impiega ancora auto con motore anteriore. Il giovane pilota
della Cooper, McLaren, vince il primo Gran Premio della stagione,
quello d'Argentina. A Monaco, sotto la pioggia, Moss alla guida di una
Lotus privata si aggiudica una bella vittoria. Le cinque vittorie
successive sono appannaggio di Brabham che si candida così
alla conquista del suo secondo Campionato del Mondo consecutivo. A
Monza prevalgono le Ferrari e l'ultima gara della stagione, il Gran
Premio degli USA, viene vinto da Moss. La Cooper fa ancora sua la Coppa
Costruttori con Brabham incoronato Campione del Mondo e un'altra auto
piazzata seconda in classifica generale. Questo è l'ultimo
anno in cui in Formula 1 vengono adottati i motori da 2 litri e mezzo,
che tanta storia hanno scritto. Le nuove norme per la stagione 1961
vietano del tutto la sovralimentazione e fissano per le auto un peso
minimo di 450 kg. e 1500 cc. di cilindrata. Le nuove regole vengono
accolte con disappunto. Molti si lamentano del fatto che le vetture,
così limitate, avrebbero perso potenza e quindi anche
l'interesse degli appassionati. Le scuderie britanniche sono le
più colpite, non avendo ancora a disposizione motori
conformi, mentre la Ferrari nell'immediato futuro ne risulta
avvantaggiata. Lo sviluppo di un nuovo motore Coventry-Climax 8V
procede a rilento e molte squadre inglesi sono costrette a ripiegare su
un vecchio motore a 4 cilindri. La Ferrari è la favorita di
quell'anno anche per essere finalmente passata al motore posteriore.
Alla guida delle rosse ci sono due piloti americani, Phil Hill e Richie
Ginther, ai quali si unisce il carismatico pilota tedesco Wolfgang Von
Trips. Stirling Moss si deve accontentare di una Lotus dell'anno
precedente, avendo scartato l'ultimo modello presentato dalla sua
scuderia. Nonostante questo, Moss a Monaco ottiene la vittoria
più grande della sua carriera. Moss ricorda: "Direi proprio
che quella è stata la gara più bella. Ho dovuto
girare piano per circa 11 dei 100 giri previsti. All'inizio ero felice
di fare l'andatura, ma quando gli altri hanno cominciato ad accelerare
ho capito che non dovevo mollare il gruppo. In altre circostanze non
avrei cominciato a lottare per il comando della corsa così
presto, ma in quel momento mi è sembrata l'unica cosa da
fare...". Prima Hill e poi Ginther, in attesa del minimo errore di
Moss, cercano di aprirsi un varco e passare. Ma all'ultimo giro Moss,
dopo essere stato pressato dalle Ferrari per tutta la gara,
è ancora miracolosamente in testa "Ho pensato.. adesso
è fatta, questo è il punto dove spingono al
massimo sull'acceleratore e mi raggiungono. Mi ero accorto che le
Ferrari stavano ricevendo l'ordine di "dare tutto" ma io mi sono
impegnato al massimo per non perdere il primo posto". Moss
così passa davanti alla bandiera a scacchi 3,6 secondi prima
di Ginther, a sua volta seguito dalle altre due Ferrari di Hill e di
Von Trips. Dopo Monaco le Ferrari non saranno più
ostacolate. Persino a Reims, dove tutta la squadra Ferrari cade vittima
di problemi meccanici, vince un concorrente privato, Giancarlo
Baghetti, su un'auto Ferrari. E così, solo la vittoria di
Moss al Nurburgring e la morte di Von Trips a Monza, rovinano una
grandissima stagione della scuderia italiana, con il Campionato nelle
mani di Phil Hill. Tony Brooks, l'ex studente di odontoiatria che aveva
lottato per il titolo mondiale contro Hawthorn e Moss, annuncia il
proprio ritiro. Questo pilota gentiluomo è, dopo Moss, il
più grande pilota britannico degli anni '50 e solo i
capricci del destino, come per il suo amico e rivale, lo privarono
della corona di campione.
Enzo Ferrari, capendo che le sue auto al momento non erano in grado di
competere con quelle delle squadre britanniche, decide di mettere sotto
contratto Stirling Moss, il migliore pilota inglese. Moss aveva
già in passato respinto le lusinghe del patriarca a causa di
una incomprensione: nel 1951, infatti, Ferrari gli aveva offerto un
posto in squadra per una gara a Bari. Quando Moss si
presentò per il primo giorno di prove chiedendo qual'era la
sua auto gli venne risposto che non c'era nessuna auto pronta per lui.
Ferrari aveva cambiato idea e aveva dato l'auto a Piero Taruffi. Moss
giurò quel giorno che non avrebbe mai più corso
su una rossa, ma all'ennesima offerta, il desiderio di correre con
un'auto veramente competitiva, lo spinge ad un ripensamento. Ferrari,
vedendo le scuderie inglesi nascere come funghi, cominciava a sentirsi
vulnerabile e confida a Moss: "Ho bisogno di te. Dimmi che tipo di auto
vuoi e sarà pronta in sei mesi. Prendi degli appunti e poi
fammeli vedere. Se accetti, tu puoi dirmi persino il lunedì
cosa non ti è piaciuto della tua auto il giorno prima in
corsa, e per il venerdì saranno approntati tutti i
cambiamenti che avrai chiesto... se accetti, io non avrò una
squadra, io avrò soltanto te e un pilota di riserva. Con te
non c'é bisogno di una squadra..." Moss però non
può abbandonare la Rob Walker e così propone di
guidare una Ferrari per i colori di Rob Walker. Incredibilmente Ferrari
accetta e l'auto di Moss viene debitamente verniciata di blu. Moss
però non arriverà mai a guidare quella Ferrari, a
causa di un incidente al Meeting del Lunedì di Pasqua a
Goodwood. Nello schianto Moss riporta ferite tali che lo obbligheranno
ad un ritiro permanente dalle corse. Graham Hill nel suo libro
intitolato 'Graham' scrive: "Stavo conducendo la gara senza affanno,
con Stirling ancora dietro di me in ritardo di due giri. Quando in
rimonta mi sorpassa è già fuori pista sull'erba.
Poi, apparentemente senza un motivo, sfila dritto contro una sponda. Mi
sembrava completamente fuori controllo e quello che è
successo nessuno potrà mai saperlo con certezza, ma io sono
sicuro che non si è trattato di un errore del pilota". Moss
rimane sospeso tra la vita e la morte e quando finalmente si sveglia
dal coma, rimane paralizzato per qualche tempo. Il primo maggio del
1963, più di un anno dopo l'incidente, Moss ritorna a
Goodwood per provare a guidare un'auto da corsa. Nonostante riesca
ancora a girare ad una velocità quasi da gara trova la cosa
faticosissima. Quello che era stato per lui del tutto naturale non lo
è più e poco dopo annuncia il suo ritiro
definitivo. Il legame con il passato è stato rotto e una
nuova generazione di piloti è pronta ad emergere. I loro
nomi sono Clark, Surtees, Gurney e Hill.
|
|
Campioni del Mondo Anni 50
FARINA - FANGIO - ASCARI - HAWTHORN - BRABHAM

 |
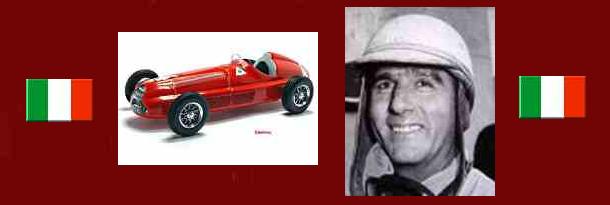

(1949) -1950 - Alfa Romeo 158
Giuseppe Farina
33 Gran Premi - 5 Vittorie - 20 Podi
|
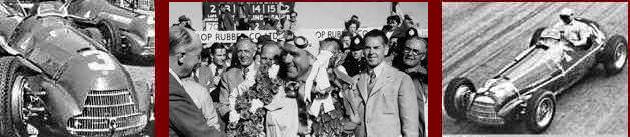 |
Riassunto della stagione
Nell'Alfa Romeo si decise di puntare tutte le carte su Juan Manuel Fangio,
il quale nei primi mesi si era già aggiudicato due gare in Europa, e
ribadirà nel finale di stagione il suo grande momento di forma vincendo
tre gare consecutive di Formula Libre. Oltre al coraggio e
all'incoscienza, indispensabili per gareggiare nei piloti di quella
generazione, Fangio possedeva una visione tattica superiore rispetto
alla concorrenza.[senza fonte]
Dal canto suo, Farina non demorde e si aggiudica il Gran Premio
inaugurale di Gran Bretagna a Silverstone con l'argentino tradito da una
perdita d'olio. A Montecarlo Fangio gli risponde una settimana dopo
dominando una corsa tormentata da un grave incidente nella sessione di
qualifica toccato ad Alfredo Pián,
argentino anche lui proveniente dalle gare sudamericane, che si
frattura una caviglia, e da una spettacolare carambola al primo giro che
elimina di colpo dieci concorrenti, provocata da un'improvvisa ondata
alla curva del "Tabaccaio". Il torinese vince sull'insidioso tracciato
svizzero del Bremgarten e l'argentino gli risponde per le rime a
Spa-Francorchamps. È un testa a testa entusiasmante e in Francia, sul
circuito stradale di Reims-Gueux, Fangio completa la sua rimonta
iridata, piazza il terzo sigillo e lascia a secco il rivale. Anche Luigi Fagioli
si comporta benissimo, piazzandosi secondo in ben quattro gare
disputate e racimolando 24 punti, ma con la regola degli scarti viene
privato in pratica di lottare per il titolo nell'ultima corsa valida, il
Gran Premio d'Italia.
Conquisterà 4 punti con il terzo posto ma non saranno comunque validi.
Passerà nella storia dell'automobilismo di Formula 1 come l'"eterno
secondo".
A Monza
è un affare privato tra Fangio e Farina, distanziati in classifica
soltanto di quattro punti (26 per Fangio e 22 per Farina, che oltretutto
è terzo). L'argentino già al sabato conquista la Pole position,
con Farina che si piazza terzo dietro alla Ferrari di Ascari. Fangio
conduce in testa i primi giri e piazza un punto mondiale segnando il
giro più veloce, ma al 24º giro deve ritirarsi ai box per noie al
cambio. Senza perdersi d'animo, sale sull'Alfa Romeo di riserva condotta
Piero Taruffi
che gli cede sportivamente il posto, ma compie appena dieci giri e dice
addio ai sogni di gloria, lasciando vittoria e titolo mondiale nelle
mani di Nino Farina, il primo italiano a laurearsi campione del mondo
con tre punti di vantaggio sull'argentino, 30 contro 27. Fagioli sarebbe
secondo con 28 punti, ma viene classificato al terzo posto con 24.
|
1950. Si comincia ed è
subito dominio Alfa Romeo
- 1950 -
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1950 |
Ita |
Farina N. |
Alfa Romeo |
158 |
30 |
3 |
|
|
Ufficialmente il primo campionato "mondiale" di
formula uno risale al 1950; prima di questa storica data, infatti,
troviamo solo delle vaghe competizioni che poco avevano a che fare con
la Formula uno.
L'iniziativa che forse più si avvicina al concetto di
mondiale di F1, è il campionato "marche" risalente al
più lontano 1925, è evidente, che in questo
evento si tende a dar priorità alle proprietà del
mezzo ed alle case costruttrici. Il punteggio che si adottava era
alquanto originale; infatti vinceva la casa costruttrice che alla fine
della stagione avesse accumulato meno punti, questa scelta è
dovuta al fatto che la ripartizione dei punti di una singola gara era
così strutturata: uno due e tre punti rispettivamente ai
primi tre piloti, quattr agli altri e sei a quelli che per vari motivi
non riuscissero a presiedere la competizione. A seguito di questo "mondiale" c'è solo il vuoto, infatti
storicamente gli anni avvenire sono tra i più tragici e
tristi che l'umanità abbia mai conosciuto. Nel 1950 la situazione cambia notevolmente, l'economia è in
piena ripresa, le automobili cominciano a diffondersi ed ecco che il 13
Maggio 1950 al circuito di Silverstone prende il via ufficialmente la
prima gara delle sette in programma della stagione di formula uno.
|
L'evento si svolge di sabato a prenderne parte sono vetture quali Alfa
Romeo, Maserati, Talbot, Era e Alta, ogni casa costruttrice dispone di
quattro o cinque vetture con altrettanti piloti, la vettura che
già dai primi giri si rivela essere più
efficiente è senza ombra di dubbio l'Alfa 158, meglio nota
come "Alfetta", affidata per l'occasione a piloti quali Nino Farina
(antenato di Pinin), Luigi Fagioli, Reginald Parnell, e ad un giovane
argentino (aveva già 39 anni) sconosciuto, un tale..... Juan
Manuel Fangio.
La prima gara è caratterizzata dal monopolio Alfa, le
quattro vetture infatti fanno il vuoto, il leader della gara
è Farina seguito a ruota da Fangio, Fagioli e Parnell;
l'argentino è costretto verso metà gara al ritiro
per noie tecniche dunque la casa italiana è costretta a
rinunciare al poker e ad "accontentarsi" dell'intero podio!!
Dato l'evidente gap presente tra le vetture Alfa Romeo e le altre,
l'intero campionato si preannuncia come un'inevitabile e noiosa
routine.... effettivamente i piloti alfa si aggiudicheranno tutte le
gare previste dal campionato, ma nonostante ciò la stagione
1950 riserva una grandissima sorpresa; infatti alla seconda gara, in
Francia, il 21 Maggio 1950, vengono ammesse in pista per la prima volta
tre vetture della SCUDERIA FERRARI, dirette da Enzo Ferrari: un uomo di
52 anni ex direttore tecnico dell'Alfa Romeo licenziato diversi anni
prima, proprio dalla grande casa costruttrice.
Il sig.Ferrari, come lo chiamavano a quei tempi, ritrovava in quella
competizione, non solo un'evento agonistico, ma qualcosa di molto
più grande, cercava vendetta....... voleva dimostrare alla
sua vecchia scuderia di valere ancora...... molto!!!!! |
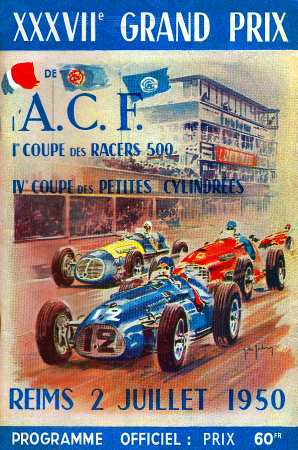 |
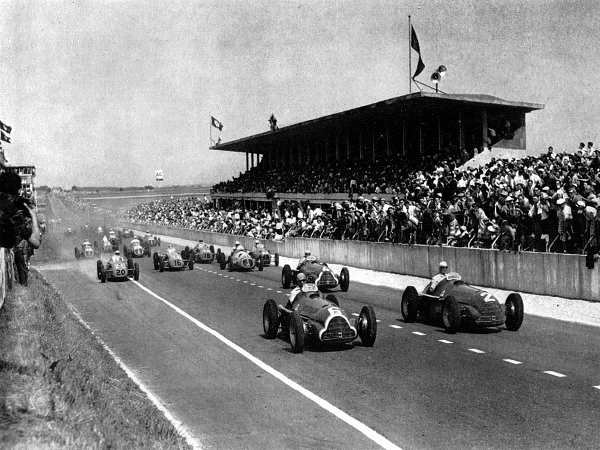 |
La Scuderia Ferrari schiera in pista ben tre
vetture affidate ad Alberto Ascari (figlio del celebre Antonio), Gigi
Villoresi e Raymond Sommer; la gara si preannuncia particolarmente
dura, anche se le ferrari riescono a mantenere bene il confronto con le
altre scuderie..... ma non riescono ad impensierire minimamente la
grande Alfetta. Solo, in Francia Ascari riesce a giungere secondo, questo è
solo un caso fortuito, si è infatti verificato un incidente
che ha tolto di mezzo ben tre alfette.
Le restanti gare, almeno agonisticamente parlando, danno origine ad un
vivace duello tra Farina e Fangio, duello che si risolverà
solo all'ultima gara:
Circuito di Monza, ultimo tracciato delle sette gare previste dalla
stagione, ai due pretendenti al titolo vengono assegnate le monoposto
più aggiornate, Farina è in pole mentre Fangio
occupa la seconda posizione, la gara si fa subito entusiasmante con
l'argentino che segue a ruota il leader della gara. Ma dopo pochi giri
Juan Manuel Fangio è costretto a rientrare ai box per un
cedimento meccanico, riprende la corsa più tardi, ma dopo
pochi giri è costretto a cambiare completamente vettura
(allora era permesso!!! da regolamento) per altre noie tecniche, al suo
rientro Farina è già lontano, tenta di
raggiungerlo, ma sottopone la vettura ad esagerate sollecitazioni, che
causano il suo definitivo ritiro.
Vince così il primo titolo mondiale di Formula Uno Nino
Farina su Alfa Romeo... l'Italia è in delirio!! |
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: IN
GRAN BRETAGNA INIZIA IL CAMPIONATO E TUTTI SONO DEBUTTANTI. RESTA COMUNQUE
L'ONORE ALL'ALFA ROMEO E A FARINA DI AVER VINTO PER PRIMI.
A MONTECARLO SI VERIFICA UN INCIDENTE CHE
COINVOLGE 10 VETTURE, UN RECORD CHE VERRÀ BATTUTO SOLO DOPO OLTRE VENT'ANNI.
L'ALFA ROMEO DIVENTA LA PRIMA CASA A
VINCERE IL MONDIALE PILOTI STANDO IN TESTA IN CLASSIFICA DALL'INIZIO ALLA FINE,
MA DOPO LA TERZA CORSA SI TROVA A PARI PUNTI CON LA KURTIS DI PARSONS.
ANZI, CASO INEDITO, IN TESTA ALLA
CLASSIFICA CI SONO TRE PILOTI: FARINA E FANGIO CON L'ALFA ROMEO-ALFA ROMEO E
PARSONS CON LA KURTIS-OFFENHAUSER.
LO SCHIERAMENTO DI PARTENZA DEL PRIMO GRAN
PREMIO PREVEDE UNA PRIMA FILA CON QUATTRO PILOTI. TALE CIRCOSTANZA SI RIPETERÀ
SOLO IN CIRCUITI MOLTO LARGHI, COME SILVERSTONE O IL NÜRBURGRING, TUTTAVIA GIÀ
DALLA SECONDA CORSA, A MONTECARLO, VIENE INTRODOTTO LO SCHIERAMENTO CON TRE
PILOTI IN PRIMA FILA.
DURANTE LE PROVE DEL GRAN PREMIO DEL BELGIO
SI VERIFICA UNA CIRCOSTANZA PARTICOLARE: DUE PILOTI REALIZZANO LO STESSO
IDENTICO MIGLIOR TEMPO. CIÒ È DOVUTO AL FATTO CHE L'APPROSSIMAZIONE DEI
CRONOMETRISTI DEL BELGIO SI FERMAVA AI SECONDI! I DUE PILOTI IN QUESTIONE ERANO:
FARINA E FANGIO, ENTRAMBI CON L'ALFA ROMEO. PER STABILIRE CHI DOVESSE PARTIRE
PER PRIMO I CRONOMETRISTI GUARDAVANO IL SECONDO MIGLIOR TEMPO REALIZZATO. OGGI
IL REGOLAMENTO È CAMBIATO E A PARITÀ DI TEMPO, PARTE IN MIGLIORE POSIZIONE CHI
LO HA STABILITO PRIMA.
IL SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO DIPENDEVA DAI
CIRCUITI. NELLA PRIMA CORSA L'APPROSSIMAZIONE ARRIVAVA AI DECIMI DI SECONDO. A
INDIANAPOLIS C'ERANO GIÀ I CENTESIMI DI SECONDO, MENTRE IN BELGIO CI SI FERMAVA
AI SECONDI (MA SOLO IN PROVA, IN GARA C'ERANO COMUNQUE I DECIMI).
A INDIANAPOLIS NUOVA SCHIERA DI DEBUTTANTI
DATA LA PARTICOLARITÀ DELLA CORSA E INOLTRE PRIMA CORSA AD ESSERE INTERROTTA E
PRIMA CORSA DISPUTATA SUL BAGNATO.
|
|
|
 |


Juan Manuel Fangio - 1951 - Alfa Romeo 159
|
 |
Riassunto della stagione
Il
1951 è un anno importante nella storia della Formula 1, sia dal
punto di vista sportivo, sia dal punto di vista tecnico. Vede, infatti,
Juan Manuel Fangio conquistare il suo 1º titolo mondiale, segna il
ritiro dalle corse della Alfa Romeo, dominatrice dei Grand Prix
dal dopo guerra ad oggi, ed assiste alla prima vittoria della Ferrari
in un Gran Premio di Formula 1, nel Gran Premio di Gran Bretagna, sul
Circuito di Silverstone, il 14 luglio del 1951. Proprio questo è
l'aspetto tecnico, oltre che sportivo, più interessante,
perché Enzo Ferrari, che aveva già intuito nell'anno
precedente che i motori compressi avevano già dato tutto quello
che potevano, schiera, in questa annata, una vettura aspirata da
4.500 cm³, che, si aggiudica 3 Gran Premi, e che solo
all'ultimo Gran Premio, quello di Spagna, del 28 ottobre 1951, deve
dare via libera all'Alfa Romeo 159,
a seguito di un errore nella scelta delle gomme. Ma la fine sportiva
dei motori compressi, è segnata, e se ne rende conto anche la Commissione Sportiva Internazionale,
che, nell'intento di ridare interesse ad una competizione che, dopo il
ritiro dell'Alfa Romeo rischiava di diventare un noioso monologo della
Ferrari, con una difficile quanto azzeccata decisione, decide che nel
biennio successivo (1952 e 1953) corrano, in Formula 1, le vetture di
Formula 2, che potranno montare, o un motore di 2.000 cm³
senza compressore, o un motore di 500 cm³ con compressore.
Perso
il titolo del 1950 all'ultima gara, Juan Manuel Fangio si "vendica" e
conquista il suo primo titolo mondiale. Nelle prime tre gare,
escludendo la 500 miglia di Indianapolis, vincono sempre le Alfa Romeo,
Fangio vince in Svizzera (prima gara stagionale), Farina nel Gran
Premio del Belgio mentre in Francia vince la coppia Fangio-Fagioli.
Dopo queste tre gare si assiste a un incredibile miglioramento delle
Ferrari. Inizia con José Froilán González
staccando Fangio di soli 51". È la prima vittoria per la Ferrari
in Formula 1. Vittoria Ferrari anche nella gara successiva, ma stavolta
con l'italiano Alberto Ascari, che si ripeterà anche nella gara
successiva a Monza, penultima gara di questo secondo campionato del
mondo di Formula 1. Si arriva quindi a Pedralbes, in Spagna, con Ascari
che ha buone probabilità di vincere il titolo mondiale,
soprattutto dopo aver conquistato la pole position. Purtroppo la
strategia si rivelerà sbagliata, colpa dell'eccessivo consumo
delle gomme, e Fangio coglie al volo l'occasione vincendo gara e
titolo. Da segnalare che in questa stagione avvenne il debutto di
Stirling Moss, pilota che si rivelerà molto forte in futuro.
|
|
| 1951. L'ultimo colpo dell'Alfa
Romeo |
 - 1951 - - 1951 -
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1951 |
Arg |
Fangio J.M |
Alfa Romeo |
159 |
37 |
3 |
La stagione 1950, seppure fosse stata completamente
dominata dall'Alfa Romeo aveva suscitato molti consensi tra il pubblico
più o meno appassionato, la formula uno funzionava, lo sport
cominciava a tirare a se tifosi di varie scuderie, e gli stessi
costruttori cominciavano a guardare la F1 con un certo interesse.
La stagione 1951 comincia, dunque, nel segno dell'espansione che si
manifesta da subito con l'aggiunta al campionato di una nuova gara: il
Gran Premio di Spagna. Come accadeva nel corso della precedente
stagione, la scuderia Alfa Romeo aveva, ancora una volta, tutte le
carte in regola per dominare il campionato, ma la concorrenza
cominciava a farsi sentire con maggiore intensità. Primo fra
tutti Enzo Ferrari che in collaborazione con l'ing. Aurelio Lampredi
aveva messo sùuna vettura... interessante, si tratta del
modello 375, guidata da Ascari, Villoresi e Taruffi; solo dopo qualche
gp si aggiungerà al trio l'argentino Froilan Gonzalez.
La stagione si apre con il Circuito di Berna, è Juan Manuel
Fangio a bordo della sua Alfetta 159, a vincerlo, l'argentino domina
comodamente l'intero Gran Premio, ma diversamente dal solito alle sue
spalle non c'è un'altra vettura della sua stessa scuderia,
bensì c'è un sorprendente Piero Taruffi.
Dopo la consueta pausa di Indianapolis (il gp era previsto in
calendario ma nessuno dei piloti ci partecipava per carenze di fondi...
l'America a quei tempi era davvero lontana) è la volta del
Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. Il duello Ferrari-Alfa
Romeo si ripete nuovamente ma ancora una volta il cavallino si deve
piegare allo strapotere Alfa. Stesso epilogo tocca anche al Gran Premio dell'Automobile Club di
Francia, vinto ancora una volta da Fangio... ma qualcosa sta cambiando,
la Ferrari sta crescendo a dismisura, l'Alfetta riesce a contenere la
375 a stento, e ad ogni gara i piloti Alfa fanno sempre più
fatica a tener testa alle vetture del cavallino.
Arriva
così il primo successo Ferrari,
il 14 Luglio 1951 sul circuito inglese di Silverstone, è la
prima volta da quando è stato introdotto il mondiale di F1,
che una vettura non appartenente alla casa dell'Alfa Romeo tagli per
prima il traguardo. La Ferrari trionfa con l'ultimo arrivato:
l'argentino Gonzalez costretto a duellare intensamente, gomito a gomito
(nel vero senso della parola) con il suo connazionale; ma la Ferrari
deve questo primo successo non solo all'abilità di Gonzalez,
o come tutti chiamavano <el Cabezòn> (a causa
della posizione molto particolare assunta durante la guida), ma anche
alla tecnologia del suo dodici cilindri che oltre ad essere
estremamente competitivo consuma quasi la metà dei motori
rivali, con sensibili vantaggi sui tempi impiegati per i pit-stop. La
Ferrari vince ed il suo fondatore si prende la rivincita sull'Alfa
Romeo,e a distanza di anni ammetterà: <è
come se avessi ucciso mia madre>, era infatti cresciuto
nell'ambiente Alfa e quando ebbe la meglio sulla stessa quasi un senso
di colpa lo affliggeva.
Ciò che rendeva felici gli uomini del cavallino, non era
soltanto la vittoria, ma l'insistente sensazione di crescita, la 375
cresceva di giorno in giorno mentre l'Alfetta 159 era ormai alla
deriva, a peggiorare notevolmente la condizione Alfa fu la decisione
del ritiro a fine stagione, per motivi economici.
Il gran premio successivo è quello di Germania, si torna a
correre in Germania dopo vent'anni su un circuito lungo 23 chilometri,
per la seconda volta consecutiva la Ferrari vince ma stavolta
è un trionfo tutto italiano, è infatti Ascari a
tagliare per primo il traguardo. La penultima gara del mondiale
è a Monza, ancora una volta Ascari fa il vuoto!!! Ultima gara del mondiale, si giocano il tutto per tutto Ascari e Fangio
in Spagna, l'italiano a seguito degli ultimi risultati ottenuti sembra
essere di gran lunga il favorito; ma stavolta la Ferrari ha la peggio,
tutto a causa di un errata scelta di gomme, infatti Enzo Ferrari non
segue il consiglio degli uomini Pirelli, quello di montare gomme di
diametro maggiorato, cosa che invece fanno gli uomini dell'Alfa.
Conseguenza di ciò è una elevatissima abrasione
delle gomme montate sulla 375 di Ascari, costretto a rientrare per ben
sei volte ai box.
Il successo tocca dunque a Juan Manuel Fangio, che regala.
|
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: A
INDIANAPOLIS SI CORRE FINALMENTE SULLA DISTANZA COMPLETA E INSIEME ALLE EDIZIONI
SUCCESSIVE DIVENTERÀ COSÌ LA CORSA DI FORMULA 1 DISPUTATA SULLA DISTANZA PIÙ
LUNGA, OLTRE 800 KM. INOLTRE PROPRIO IN QUESTA EDIZIONE SI DISPUTA LA CORSA
DURATA PIÙ TEMPO, QUASI 4 ORE DI GARA CONSECUTIVA.
IN FRANCIA VINCE FAGIOLI IN COPPIA CON
FANGIO. OLTRE A DIMOSTRARE UNA SUPERIORITÀ DELL'ALFA ROMEO, FAGIOLI DIVENTA IL
PIÙ ANZIANO VINCITORE DI UN GRAN PREMIO A 53 ANNI E 22 GIORNI.
DURANTE IL GRAN PREMIO DI SVIZZERA DEBUTTA
IL PILOTA ABECASSIS IN UNA SQUADRA FONDATA DA LUI STESSO: LA HWM CHE UTILIZZA IL
MOTORE ALTA. È IL PRIMO CASO DI PILOTA-FONDATORE DI UNA SQUADRA. L'HWM ERA
STATA FONDATA NEL DOPOGUERRA DA GEORGE ABECASSIS E DA JOHN HEATH. NELLO STESSO
GRAN PREMIO DEBUTTA ANCHE LA VERITAS-VERITAS FONDATA NEL 1948 DA ERNST LOOF, IL
QUALE PERÒ DEBUTTERÀ IN FORMULA 1 SOLO NEL 1953.
PICCOLE NOVITÀ SUL FRONTE DEI
CRONOMETRAGGI: IN SVIZZERA, NELLE PROVE LA PRECISIONE ERA AL DECIMO DI SECONDO,
MENTRE IN GARA SI ARRIVAVA AI CENTESIMI DI SECONDO (PRIMO GRAN PREMIO EUROPEO IN
CUI COMPAIONO I CENTESIMI). NEL GRAN PREMIO DI SPAGNA, INVECE, CI SONO I
CENTESIMI SIA IN PROVA CHE IN GARA.
|
|
|
 |
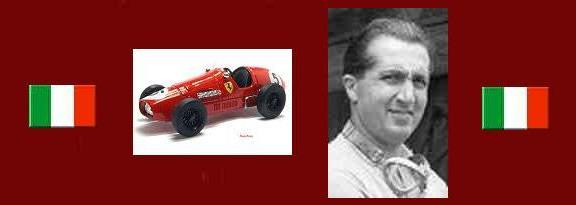

Ferrari 500 F2 - 1952 - Alberto Ascari
|
 |
Riassunto della stagione
La stagione 1952 del Campionato mondiale FIA Piloti (comunemente detto mondiale di Formula 1) è stata, nella storia della categoria, la 3a ad assegnare il Campionato Piloti. Il campionato però era assegnato su una serie di competizioni riservate alle vetture di Formula 2.
È
iniziata il 18 maggio ed è terminata il 7 settembre, dopo 8
gare. Il titolo mondiale piloti è stato vinto daAlberto Ascari.
Con
il ritiro delle Alfa Romeo e con l'incidente in una gara pre-mondiale a
Fangio che non gli permette di partecipare, Alberto Ascari vince
dominando il campionato del mondo. Salta la prima gara in Svizzera per
prepararsi alla 500 miglia di Indianapolis,
ma vince tutte le altre sei gare, ottenendo in 5 occasioni anche giro
più veloce (uno a pari merito con il suo ex-compagnoJosé
Froilán González). Considerando i migliori quattro
risultati, quelli validi per la classifica, Ascari ha fatto il massimo
dei punti (36), 12 in più del secondo classificato, Nino Farina.
Ascari diventa così per la prima volta campione del mondo, pur
essendo venuto meno il confronto con Fangio. Durante la stagione
è morto in un incidente Luigi Fagioli, tuttora il più
vecchio vincitore di un Gran Premio in Formula 1. Inoltre, in questa
stagione debuttò Mike Hawthorn, futuro campione del mondo.
|
|
|
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1952 |
Ita |
Ascari A. |
Ferrari |
500 |
52,5 |
6 |
 Un dominio tutto
all'italiana Un dominio tutto
all'italiana
 - 1952 - - 1952 -
|
La stagione 1952, è una stagione di
rilevo anzitutto dal punto di vista, per così dire politico,
infatti la federazione che gestisce la formula uno emette un rigoroso
regolamento che prevede delle notevoli limitazioni tecniche per le
vetture iscritte al mondiale.
La Ferrari si presenta con il modello 500, progettato, ancora una
volta, dall'ingegner Lampredi; è una vettura innovativa,
estremamente competitiva ed affidabile, indubbiamente la più
accreditata al titolo.
Si parte, nuovamente da Berna, in occassione del primo Gp mancano
all'appello i due grandi del momento: Fangio è in attessa di
un'adeguata offerta da un'altra scuderia, a seguito del ritiro dalle
corse dell'Alfa Romeo; mentre Ascari si accinge a partecipare alla
cinquecento miglia di Indianapolis; la presenza della Ferrari negli
Stati Uniti ha più che altro uno scopo promozionale, infatti
la Ferrari comincia a produrre auto sportive stradali, e il popolo
americano rappresenta un ottimo target di vendita. Dal punto di vista
sportivo è dunque, quasi, irrilevante la gara americana che
si conclude infatti con il ritiro di Ascari dopo un inizio decisamente
poco brillante.
Intanto a brillare è l'altra Ferrari quella guidata da
Taruffi che a Berna stravince.
Al rientro di Ascari le cose si rivelano essere
davvero molto semplici, Ascari è uno dei migliori piloti in
circolazione, la vettura è di gran lunga superiore a tutte
le altre.... la vittoria sembra essere la più facile
copnseguenza di tutto ciò; infatti sarà
così il modello 500 comincia a collezzionare vittorie a
ripetizione e senza alcuna difficolta. C'era solo un uomo davvero in grado di tener testa ad una furia come
Ascari, si tratta del campione del mondo Juan Manuel Fangio;
l'argentino purtroppo sarà coinvolto in un spaventoso
incidente stradale, che fortunatamente non metterà fine alla
sua carriera ma che sicuramente renderà impossibile la sua
presenza nella stagione corrente.
Per la Ferrari e per Ascari è davvero tutto molto semplice,
vincono anche con una gara d'anticipo e partecipano a Monza con la
certezza del titolo..... sembra più una parata che una gara.
Nel 1952, così la Ferrari vince per la prima volta un titolo
mondia... lo fa alla sua maniera, in grande stile, vincendo, con Ascari
sei gare su otto..... è solo l'inizio di una meravigliosa
favola!!!!! |
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: A
INDIANAPOLIS VINCE RUTTMAN CHE DIVENTA COSÌ IL PIÙ GIOVANE VINCITORE DI UN
GRAN PREMIO (E ANCHE DI INDIANAPOLIS) ALL'ETÀ DI 22 ANNI E 80 GIORNI.
ASCARI STABILISCE VARI PRIMATI CHE NON
VERRANNO MAI PIÙ BATTUTI: VITTORIE CONSECUTIVE (7), GIRI IN TESTA CONSECUTIVI
(304), HAT TRICK CONSECUTIVI (4), VITTORIE IN UNA STAGIONE RELATIVE AL NUMERO DI
GRAN PREMI (6 SU 8 CIOÈ IL 75%) ED ALTRI ANCORA.
LA FERRARI INOLTRE PIAZZA QUATTRO SUOI
PILOTI AI PRIMI QUATTRO POSTI DEL CAMPIONATO, GRAZIE ANCHE AL FATTO CHE IN CERTE
OCCASIONI ARRIVÒ A GAREGGIARE CON 9 VETTURE SULLA GRIGLIA DI PARTENZA.
LA CASA ITALIANA È INOLTRE LA PRIMA A
VINCERE IL TITOLO PILOTI STANDO IN TESTA IN CLASSIFICA DALL'INIZIO ALLA FINE DEL
CAMPIONATO, A PARI CON NESSUNO, PRIMA CON TARUFFI E DOPO CON ASCARI.
NEL GRAN PREMIO D'ITALIA SI VERIFICA PER LA
PRIMA VOLTA LA CIRCOSTANZA DI DUE PILOTI CHE REALIZZANO LO STESSO GPV.
L'APPROSSIMAZIONE DI QUEL TEMPO SI FERMAVA AI DECIMI DI SECONDO. I DUE PILOTI IN
QUESTIONE (AI QUALI PER REGOLAMENTO VA UN PUNTO DIVISO IN DUE) SONO: ASCARI CON
LA FERRARI E GONZALEZ CON LA MASERATI.
NEL G.P. DI GRAN BRETAGNA DEBUTTA IL MOTORE
BMW MA È NEL G.P. DI GERMANIA CHE ARRIVANO IN MASSA I TEDESCHI. DEBUTTA LA
SQUADRA BMW, FORNENDO INOLTRE IL PROPRIO MOTORE AD UN NUGOLO DI SQUADRE TEDESCHE
SENZA PERALTRO OTTENERE RISULTATI DI RILIEVO.
NEL GRAN PREMIO DI GERMANIA, ASCARI FA LA
POLE POSITION CON IL TEMPO DI 10 MINUTI, 4 SECONDI E 4 DECIMI CHE DIVENTA COSÌ
LA POLE POSITION CON IL TEMPO PIÙ LUNGO (L'UNICA TRA L'ALTRO OLTRE I 10
MINUTI).
DURANTE IL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA
DEBUTTA IL PILOTA WILLIAM ASTON, SULLA BUTTERWORTH DA LUI FONDATA E, CASO RARO,
LA VETTURA CON CUI CORRE È DA LUI PROGETTATA. ASTON È INFATTI ANCHE UN
PROGETTISTA, IL PRIMO A CORRERE SU UNA DELLE "SUE" VETTURE. NEL TEMPO
SI VERIFICHERANNO ALTRI RARI CASI DI PILOTI-PROGETTISTI. NELLA MAGGIORANZA DEI
CASI SI TRATTA DI PILOTI CON NOZIONI DI INGEGNERIA, CHE CORRONO CON VETTURE
AUTOCOSTRUITE O PRIVATE OPPURE GESTISCONO UNA SQUADRA (COME JACK BRABHAM, DE
KLERK, EMERY, JABOUILLE, MERZARIO, SERRURIER E SURTEES). MOLTO PIÙ RARO È IL
CASO DI PROGETTISTI CHE PER DILETTARSI DECIDONO DI CORRERE QUALCHE GRAN PREMIO
(COME CHAPMAN, DE TOMASO, HART, KLENK, KLODWIG E LOOF). ASTON, INFINE, È ANCHE
IL PRIMO PILOTA-FONDATORE DI UNA SQUADRA DI FORMULA 1 CHE SI AUTOCOSTRUISCE
ANCHE IL MOTORE.
SUL FRONTE DEI CRONOMETRAGGI SI ASSISTE AD
UN REGRESSO. IN GRAN BRETAGNA L'APPROSSIMAZIONE È NELL'ORDINE DEI SECONDI, SIA
IN PROVA CHE IN GARA.
SI VERIFICA IL PRIMO CASO DI DUE FRATELLI
PRESENTI NELLO STESSO GRAN PREMIO. ACCADE NEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA E I
DUE PROTAGONISTI SONO: GRAHAM E PETER WHITEHEAD, RISPETTIVAMENTE SU ALTA-ALTA E
SU FERRARI-FERRARI. ENTRAMBI TERMINANO LA CORSA, AL 12° E 10° POSTO. |
|
|
|
 |
 |
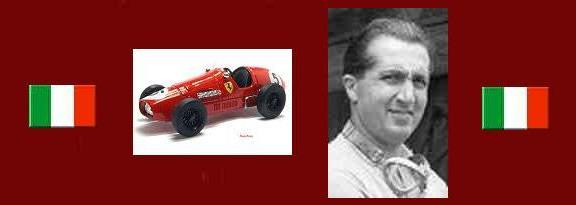

Ferrari 500 F2
1952 - 1953
Alberto Ascari
32 Gran Premi - 13 Vittorie - 17 Podi
|
 |
Riassunto della stagione
La stagione 1953 del Campionato mondiale FIA è stata, nella storia della categoria, la 4a ad assegnare il Campionato Piloti.
È iniziata il 18 gennaio ed è terminata il 13 settembre, dopo 9 gare.
Il titolo mondiale piloti è andato per la seconda volta all'italiano Alberto Ascari.
Come
nel 1952, il campionato fu riservato alle Formula 2, mentre le auto da
Formula 1 corsero solo gare non valide per il campionato, che
ufficialmente era il "Campionato del Mondo Piloti".
Unica eccezione, fu la 500 Miglia di Indianapolis, riservate alle
vetture secondo il regolamento tecnico specifico; inoltre, durante la
500 Miglia di Indianapolis, l'annata del mondiale si rivelò
tragica, in quanto in Formula 1 si verificarono i primi decessi in
pista da parte di Chet Miller durante le prove del 15 maggio e Carl
Scarborough durante la gara del 30 maggio.
La Ferrari dominò il campionato, vincendo sette gare su otto disputate con Ascari, Farina e Hawthorn.
|
|
Ascari e Ferrari un
binomio da record
 - 1953 - - 1953 -
|
 |
Enzo Ferrari con Alberto Ascari a Monza
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1953 |
Ita |
Ascari A. |
Ferrari |
500 |
46,5 |
5 |
 1953 - Ascari e Ferrari un
binomio da record 1953 - Ascari e Ferrari un
binomio da record |
La stagione 1953 comincia con un nuovo gran premio,
si corre infatti a Buonos Aires il Gran Premio d'Argentia, per la prima
volta in assoluto, quasi tutte le scuderie si apprestano a correre su
un circuito oltre oceano.
L'appuntamento è a Gennaio, in Argentina è piena
estate, il pubblico sudamericano accoglie l'evento con notevole
entusiasmo, giungono in massa da tutta la nazione per ammirare i loro
beniamini Fangio e Gonzalez.
La Ferrari affida le sue quattro vettura a Nino Farina, Villoresi,
Hawthorn (neo acquisto) ed al campione del mondo in carica Alberto
Ascari. L'ex campione del mondo argentino Fangio ed il suo connazionale
Gonzalez hanno invece trovato posto presso una scuderia emergente, si
tratta della Maserati.
Al via, come da copione, Alberto Ascari crea il vuoto, la sua Ferrari
500 è indubbiamente l'auto più competitiva in
assoluto, seppure abbia subito delle sostanziali modifiche, il telaio
è rimasto pressoché invariato.
Il passo che impone Ascari alla gara è impressionate nessuno
riesce a contenere l'asso italiano; agonisticamente si tratta dunque
dell'ennesima cavalcata solitaria Ferrari, ma purtroppo il primo Gp
d'Argentina non è solo questo: |
 |
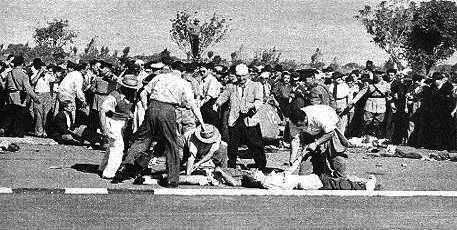 |
Il calore del pubblico, come
evidenziato precedentemente, è molto intenso, le norme di
sicurezza del circuito sono pressoché inesistenti, ecco
dunque che al trentaduesimo giro la tragedia si compie: Farina
nell'intento di schivare un bambino che attraversa la pista finisce sul
pubblico assiepato sul tracciato, il bilancio è
pesantissimo: innumerevoli feriti ed una dozzina di morti........
nonostante ciò la gara continua indisturbata...
Al traguardo il primo è Ascari seguito da Villoresi.
In Olanda e Belgio è ancora Ascari a dominare sbaragliando
decisamente la concorrenza.... in Francia invece è ancora
una Ferrari a vincere ma al volante, stavolta, non c'è
l'asso italiano, bensì l'ultimo arrivato la nuova promessa
della formula uno, l'inglese Mike Hawthorn.
Il gran premio dapprima sembra aver preso la solita e consueta "piega",
ma a circa trenta giri al termine Fangio e Hawthorn hanno la meglio su
Ascari, i due proseguono, sino al traguardo dando vita ad uno
spettacolare duello: l'inglese sembra essere più veloce ma
l'esperienza di Fangio lo ostacola nettamente, il sorpasso sembra non
essere possibile, ma a qualche giro dalla fine Hawthorn si accorge che
l'argentino non usa mai la prima marcia per affrontare le curve
più lente, è evidente che la sua Maserati abbia
un problema meccanico, Hawthorn sfrutta a suo favore questo fattore
tirando le curve più che può e costringendo
Fangio a frenare al limite, ovviamente nell'uscita di curva il pilota
Ferrari, a differenza, del pilota Maserati può ingranare
tranquillamente la prima marcia ed usufruire di un uscita molto
più veloce.... il sorpasso è fatto. Per la prima
volta a vincere un Gran Premio è un pilota inglese. |
 |
|
In Inghilterra e in Svizzera vince ancora Ascari
che si aggiudica con due Gran Premi d'anticipo sulla fine della
stagione il secondo tiotolo mondiale: La Ferrari è
così, accanto all'Alfa Romeo la scuderia con il maggior
numero di mondiali vinti..... e Ascari è il primo pilota
della storia ad aver vinto due titoli!!
I due Gran premi finali si svolgono in Germania ed in Italia, il primo
se lo aggiudicherà Farina (sarà la sua ultima
vittoria in carriera), mentre il secondo, sarà vinto da
Fangio, complice un incidente che toglie di mezzo tutte e quattro le
vetture del cavallino.
La stagione è ormai conclusa, il binomio Ferrari-Ascari
sembra imbattibile e consolidato, ma così non
è.......
Si affacciano sulla Formula uno altre grandi case costruttrici: la
Mercedes, l'Alfa Romeo (pensa ad un ritorno in grande stile) e la
Lancia, quest'ultima diretta da un audace Gianni Lancia. Da subito le
preoccupazioni di Ferrari riguardano, proprio la Lancia, l'azienda
italiana infatti oltre a disporre di personale altamente qualificato
può contare su un oneroso budget..... che spende, volentieri
per accaparrassi il miglior pilota in circolazione: il campione del
Mondo Alberto Ascari. Alberto fa presente a Ferrari l'offerta ricevuta ed ammette
esplicitamente di voler mantenere il suo posto in scuderia in cambio di
un piccolo ritocco contrattuale, ma il Drake è
inamovibile... dopo ore, giorni.. mesi di trattative a Dicembre.....
Ascari parla per l'ultima volta con Ferrari: esce dall'ufficio
dell'ingegnere saluta i compagni e scoppia in lacrime; dopo due giorni
è ufficiale: Ascari è il primo pilota Lancia.
Si scioglie così l'invincibile binomio che aveva dominato
nettamente la formula uno in quegli anni....
Alberto Ascari non
salirà mai più su una vettura del cavallino.
|
|
 Alberto Ascari era nato a Milano il 13 Luglio 1918. Suo padre Antonio era stato il
più grande pilota italiano dei suoi tempi e aveva l'abitudine di portare
spesso suo figlio con sé alle corse cui partecipava. Due settimane prima Alberto Ascari era nato a Milano il 13 Luglio 1918. Suo padre Antonio era stato il
più grande pilota italiano dei suoi tempi e aveva l'abitudine di portare
spesso suo figlio con sé alle corse cui partecipava. Due settimane prima
che Alberto compisse sette anni, Antonio Ascari rimase ucciso mentre stava
conducendo il Gran Premio di Francia a Montlehry.
Da quel momento il
desiderio di Alberto fu quello di diventare un pilota di macchine da corsa
proprio come il padre. Fu così preso
da questo suo sogno che scappò ben
due volte da scuola e appena poté si comprò una motocicletta. La sua prima
gara fu la Mille Miglia del 1940 e la macchina che guidò una Ferrari. Nel
1940 sposò una ragazza di Milano ed ebbero due bambini. Il maschio
venne
chiamato Antonio, in ricordo del nonno, e la femmina Patrizia. Ascari era
molto legato alla famiglia.
Alberto riprese a gareggiare nel 1947.
Comprò una Maserati 4CLT dai nuovi proprietari, la famiglia Orsi. Racimolò
tre milioni
di lire e il suo caro amico Gigi Villoresi lo aiutò dandogli
altri due milioni. Ascari e Villoresi corsero con successo sui circuiti
del Nord Italia, e la folla milanese soprannominò Alberto "Ciccio". Il
1948 si rivelò un altro anno di successi per la coppia di amici
alla guida
delle più evolute Maserati San Remo. Ascari gareggiò su un'Alfa 158,
finendo terzo nel Gran Premio di Francia a Reims, dietro ai compagni
di
squadra Wimille e Sanesi. Enzo Ferrari, che era stato un
grande amico e compagno di squadra del padre di Alberto, si era
appassionato ai successi
di Alberto e aveva messo sotto contratto Ascari e
Villoresi nel 1949. Quell'anno Ascari vinse sei volte, una delle quali a
Buenos Aires nel Gran Premio di Peron.
Ascari trionfatore a Monza nel 1952

Alberto Ascari - Il pilota del destino
|
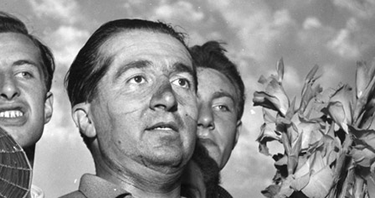
Nel 1950 ottenne nove vittorie
con la Ferrari e nel 1951 sei, nonostante la Ferrari rivestisse un ruolo
di secondo piano rispetto alle più rodate Alfa Romeo 158/159, ma fu il
1952 la sua stagione più ricca con addirittura 12 vittorie. |
|
La prima gara
alla quale non partecipò fu nel 1952, il Gran Premio di Svizzera, essendo
impegnato nelle qualificazioni di Indianapolis con la Ferrari 45OO, con la
quale forò una gomma nella 500 miglia, ma per quanto riguarda le altre
gare ebbe vita relativamente facile in quanto Fangio, della squadra rivale
Maserati, fu messo fuori gioco per gran parte della stagione in seguito ad
un incidente nel Gran Premio di Monza a Giugno. Ascari vinse tutte
le 6 gare a cui prese parte e il
Campionato del Mondo.Si ripete nel 1953
vincendo le prime 3 gare e stabilisce il record di vittorie consecutive:9.
Ascari era più tranquillo
quando si trovava in testa alla corsa e, diversamente da molti altri
piloti, sembrava non dare il suo meglio quando stava dietro. Come Enzo
Ferrari più tardi ricordò: "Quando guidava, non poteva essere sorpassato
tanto facilmente, anzi di fatto era impossibile farlo".
Non era un
pilota sereno. Con la sua smorfia e lo sguardo fisso sembrava frustasse la
sua auto e che le sue mani sensibili tormentassero il volante.
Quando aveva fretta
affrontava le curve con una serie di rischiose sterzate piuttosto che con
un unico fluido movimento. Avere Ascari alle spalle era un'esperienza
davvero snervante. La sua mente era ossessivamente impegnata a cercare il
sorpasso ad ogni costo.
Il 1954 era stato un anno molto deludente per il campione del mondo
del '52 e del '53. Ascari era uscito dalla Ferrari alla fine del 1953 e il
1° Gennaio del 1954 aveva firmato per l'ambiziosa azienda Lancia,
che aveva progettato e costruito la sua prima e alquanto innovativa
macchina da Gran Premio.
La messa a punto del mezzo però procedeva con
lentezza e il suo debutto in pista veniva continuamente rimandato. Nel
frattempo la Mercedes Benz annunciò che le Silver Arrows (le frecce
d'argento), dalla rivoluzionaria aerodinamica, sarebbero state pronte per
gareggiare nel Gran Premio di Francia a Luglio.Fu così che, per
fronteggiare la minaccia al primato italiano, la Lancia permise ad Alberto
e al suo amico e guida Luigi Villoresi di passare al volante delle
Maserati 250 F. Ma fu inutile.
Fangio e Kling sulle loro
W196 seminarono tutti gli avversari. Solo sei concorrenti su
ventuno terminarono la gara e Alberto, come molti altri, fuse il motore al
2° giro, nel tentativo di mantenere il passo delle Mercedes.
Dopo
alcune gare decisamente sfortunate con la Maserati, ad Ascari venne
generosamente prestata una Ferrari per correre il Gran Premio d'Italia.
Alberto riuscì a conquistare la prima fila della griglia di partenza e al
6° giro era in testa. La corsa finì per diventare una sfida tra Ascari e
Moss, sulla sua Maserati personale, ma al 49° giro Alberto fu costretto a
ritirarsi per noie al motore. Alla fine accadde proprio ciò che gli
italiani avevano più temuto: Fangio vinse alla guida della tedesca
Mercedes, ma solo dopo che la coppa dell'olio di Moss si fu spaccata.
|
Bisognava
fare qualcosa e così due Lancia rosso porpora nuove fiammanti furono
messe a punto in fretta e furia per debuttare nell'ultima gara del 1954,
il Gran Premio di Spagna, che si corse il 24 Ottobre nel circuito
Pedralbes.
Alberto partì alla grande e già all'8°giro aveva
accumulato un grosso vantaggio. Al nono giro però un gemito di
costernazione si sollevò non appena fu costretto a fermarsi per problemi
alla frizione.
Ascari corse un altro giro lentamente e poi si ritirò. Villoresi si era
già ritirato al quarto giro. Anche se la Ferrari di Hawthorn vinse la
competizione, fu Fangio a conquistare il Campionato del Mondo del 1954,
grazie alla Mercedes Benz W 196, ma anche grazie al fatto che la Lancia
ritardò la messa a punto della sua D50.
Benché tutte e tre le Lancia
si fossero ritirate nel Gran Premio di Argentina del 16 Gennaio del 1955,
le D50 vinsero due gare minori di F1 e con la formidabile squadra degli
italiani, Ascari, Gigi Villoresi e il giovane Eugenio Castellotti, la
Lancia era pronta a misurarsi con i tedeschi, finora trionfatori, e a
batterli.
E' il 22 Maggio del 1955 e il
Gran Premio di Monaco e d'Europa sta tenendo tutti col fiato
sospeso.
Alberto Ascari sulla sua Lancia D50 è autore di una rimonta
incredibile, per raggiungere in testa alla corsa la Mercedes Benz W196 di
Stirling Moss. E' il 77° giro di pista e sta recuperando due o tre secondi
per giro. Possiamo capire da un rapido calcolo che se Moss rallentasse la
velocità di un secondo per giro Ascari lo raggiungerebbe e lo
sorpasserebbe all'ultimo giro...
All'81°giro Moss finisce fuori pista con la Mercedes
fumante. I pistoni non hanno retto alle sollecitazioni della corsa.
Siccome Fangio si è già ritirato per la rottura di una trasmissione al 50°
giro le speranze dei tedeschi svaniscono definitivamente, lasciando il
campo libero alla Lancia e alla sua prima vittoria di Gran Premio.
Non
appena Ascari si avvicina al Casino, in quel fatidico 81° giro, gli
altoparlanti stanno informando gli spettatori di ciò che lui ancora non
può sapere, e cioè che Moss è uscito di pista e che i meccanici stanno
fissando impotenti il motore
|
|
Conducendo la sua Lancia nel dedalo di curve, proprio mentre
affronta la svolta del Casinò, Alberto all'altezza della stazione si
accorge che la folla sta cercando di richiamare la sua attenzione. Lui non
può immaginare che ciò che stanno cercando di dirgli è che non appena
raggiungerà gli spalti sarà lui il vincitore.
La sua ferma concentrazione,
tesa a mantenere il controllo della sua Lancia alla maggiore velocità
possibile, viene meno. Ha la sensazione che qualcosa non stia andando per
il verso giusto non appena infila la curva della stazione e imbocca la
Corniche. Guizza nel tunnel e poi fuori in pieno sole per trovarsi ancora
faccia a faccia con la folla esultante e in preda all'entusiasmo. Ciò
distoglie la sua attenzione proprio mentre deve affrontare la discesa che
porta alla chicane e la curva gli diventa impossibile. Sceglie quindi
l'unica via di fuga e si scaraventa in acqua oltre le barriere di
protezione. Nascosto tra le balle di fieno c'è un pilastro di ferro.
L'auto lo manca per soli trenta centimetri.
Il vapore prodotto dal motore
rovente mischiato alla polvere e ai frammenti della paglia si diffonde
nell'aria. Per tre lunghissimi secondi tutti smettono di respirare. Poi un
casco azzurro appare balenando sulla superficie dell'acqua. Ascari viene
tratto in salvo da una barca prima ancora che i sommozzatori possano
raggiungerlo.
Vince la gara su una Ferrari Trintignant che ha condotto
una corsa veloce ma regolare, assistendo alla progressiva uscita di scena
di tutti i piloti che aveva davanti a sé alla fine del 10° giro. Nel
frattempo Alberto giace in un letto d'ospedale con il naso rotto e sotto
shock. Un vero miracolo.
|

|
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: NEL
G.P. DI GERMANIA SI VERIFICA UN'AFFLUENZA RECORD DI VETTURE, 34.
AD INDIANAPOLIS SI REGISTRANO PURTROPPO I
PRIMI DUE INCIDENTI MORTALI: CHET MILLER DURANTE LE PROVE DI QUALIFICAZIONE,
CARL SCARBOROUGH DURANTE LA CORSA.
ASCARI È IL PRIMO PILOTA A VINCERE IL
SECONDO TITOLO MONDIALE (TRA L'ALTRO ANCHE DI SEGUITO). INOLTRE EGLI È ANCHE IL
PRIMO PILOTA CHE VINCE IL TITOLO STANDO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DALL'INIZIO
ALLA FINE (PERÒ DOPO LA SECONDA CORSA È A PARI PUNTI CON VUKOVICH).
CON IL G.P. D'ARGENTINA SI INAUGURA LA
SERIE DEI GRAN PREMI EXTRAEUROPEI (ESCLUSO INDIANAPOLIS). |
|
|
- 1954 -
|
Il Gran Premio di Francia 1954
fu la quarta gara della stagione 1954 del Campionato mondiale di
Formula 1, disputata il 4 luglio sul Circuito di Reims. La gara
segnò il debutto in Formula 1 delle potentissime
Mercedes-Benz W196 che dominarono ampiamente la corsa con Fangio ed il
debuttante Karl Kling, classificatisi primo e secondo al termine della
prova. Chiuse il podio Robert Manzon su Ferrari. Solamente sei piloti
portarono a termine l'evento.
|
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1954 |
Arg |
Fangio J.M. |
Maserati-Mrcedes |
250F- W196c |
57,1 |
6 |
1954 - Nascono le frecce d'argento
|
VIDEO
F1 - GP Germania: 75 anni di Frecce d'Argento |
|
Le regole nel 1954 non obbligano all'uso di ruote
scoperte e la W196 Streamliner, con le sue ruote incluse nella sagoma
della carrozzeria
e linee affusolate, assomiglia molto ad una vettura
da Granturismo.
|
|
La stagione 1954 riparte, nuovamente dal Gran
Premio d'Argentina; Ferrari, ormai orfano di Ascari schiera in pista
Farina, Gonzalez, Trintignant e la giovane promessa Hawthorn. Le case
costruttrici che prendono parte alla prima gara sono le stesse
dell'anno prima, infatti sia Mercedes che Lancia ritengono opportuno
rinviare l'esordio in pista delle loro vetture a mondiale avanzato;
infatti i progetti delle due grandi case costruttrici non sono ancora
conclusi.
Al via passa in testa Fangio, l'argentino pur essendo stato ingaggiato
dalla Mercedes corre temporaneamente per la Maserati, in attesa
dell'esordio in pista della vettura tedesca. La Maserati modello 250F
sembra aver subito notevoli miglioramenti, la vettura non è
velocissima ma è molto bilanciata e consente all'argentino
una guida agile e priva di correzioni; Fangio domina e vince la prima
gara della stagione.
Dopo la pausa di Indianapolis si corre in Belgio, Fangio è
ancora il più veloce sul circuito di Spa; la Ferrari modello
625 non sembra riuscire a mantenere il confronto con la casa del
tridente; Enzo Ferrari corre ai ripari cimentandosi nella realizzazione
di uno nuovo telaio.
4 Luglio, la Mercedes modello W196 è pronta per gareggiare,
la vettura affidata a Fangio, Kling e Herrmann è un
astronave, ha le ruote carenate e le forme sinuose, le prese d'aria ai
lati dell'abitacolo fanno sembrare la vettura un vero è
proprio prototipo da fantascienza.... la concorrenza è
allibita... se il motore della W196 fosse all'altezza del telaio non ci
sarebbe nulla per nessuno.... malgrado tutto e tutti le cose stanno
proprio in questi termini!!!
Fangio, Kling e Herrmann fanno gara a parte, dopo aver conquistato le
prime file volano via... nessuno, incluso le Ferrari, è in
grado di avvicinare le frecce d'argento.
Due settimane dopo si verifica, perà, la prima battuta
d'arresto per la casa di Stoccarda, infatti sul circuito di
Silverstone, la carenatura delle Mercedes è
controproducente, rallenta le vetture e le rende pericolosamente
instabili; le Ferrari riescono ad imporsi agevolmente... Enzo Ferrari
vedrà nel primo fallimento Mercedes, il fallimento
dell'intero progetto; suppone infatti che la W196 per quanto
affascinante ed innovativa possa essere ha comunque delle carenze di
base che la rendono inopportuna per gran parte dei circuiti stagionali;
l'ingegnere effettivamente non sbagliava nell'affermare ciò,
ma non aveva considerato l'abilità dei tecnici tedeschi e
del loro direttore sportivo Alfred Neubauer che seguendo i suggerimenti
del pilota argentino realizzano nell'arco di solo due settimane una
vettura identica alla precedente ma privata della vistosa carenatura;
il successo torna nuovamente ad essere tedesco: Gran Premio di Germania
le Mercedes si impongono ed il loro pilota di punta comincia a guardare
con un certo interesse a quello che potrebbe essere il suo secondo
titolo mondiale.Intanto proprio sul circuito del Nurburgring la
Formula uno vive uno dei giorni più tristi; infatti a causa
di un inevitabile incidente muore per la prima volta nella storia, un
pilota in pista; si tratta del promettente Marimon pupillo,
nonché connazionale di Fangio e Gonzalez.... i due argentini
risentiranno molto dell'accaduto |
 |

Monza
Mercedes con carrozzeria aerodinamica (Stromlinien)
|
In Svizzera e in Italia ad imporsi sarà ancora Fangio che
conquisterà così aritmeticamente, con una gara
d'anticipo sulla fine della stagione, il suo secondo titolo
mondiale!!!! Finalmente all'ultima gara prevista dalla stagione, il 24 ottobre, fa
il suo ingresso sulla pista spagnola, per la prima volta, la Lancia
modello D50 guidata dal leggendario Ascari. A differenza della Mercedes
e della Ferrari la Lancia ha una linea più aggressiva e
dimensioni ridotte; il suo motore a 8 cilindri a V la rende la vettura
più veloce del circus. In prova Ascari si impone rapidamente su tutti, tenta di ripetersi in
gara ma l'affidabilità della sua vettura non è
certamente all'altezza della competitività, infatti dopo
dieci giri percorsi in testa, la frizione tradisce le speranze della
terza squadra italiana. La gara sarà allora vinta da Hawthorn.
|
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: AD
INDIANAPOLIS VUKOVICH OTTIENE LA SECONDA VITTORIA (PURE CONSECUTIVA IN QUESTA
CORSA) E RIMARRÀ COSÌ L'UNICO PILOTA AD AVER VINTO PIÙ DI UNA VOLTA LA 500
MIGLIA DI INDIANAPOLIS NEL PERIODO IN CUI QUESTA GARA ERA VALIDA ANCHE PER LA
FORMULA 1.
SEMPRE AD INDIANAPOLIS SI VERIFICA UNA
COINCIDENZA ASSURDA: CON BEN 33 PARTECIPANTI DIVERSI, C'È UN SOLO MOTORE PER
TUTTI, L'OFFENHAUSER. SI TRATTA DELLA GARA CON IL MINOR NUMERO DI MARCHE DIVERSE
DI MOTORI PRESENTI. QUESTA CIRCOSTANZA SI RIPETERÀ NEL GRAN PREMIO
D'INDIANAPOLIS DEL 1955, 1959 E 1960, MENTRE NEGLI ANNI '70 CI SARANNO GARE CON
I SOLI MOTORI FORD E FERRARI OPPURE FORD E BRM.
AL GRAN PREMIO DI FRANCIA DEBUTTA LA
MERCEDES CHE VINCE E FA LA POLE CON FANGIO E FA IL GPV CON HERRMANN. SOLO ALTRE
TRE SQUADRE SONO RIUSCITE A VINCERE UN G.P. AL DEBUTTO (ALFA ROMEO, KURTIS E
WOLF). LA POLE POSITION AL DEBUTTO È INVECE APPANNAGGIO DI BEN 7 SQUADRE
DIVERSE. IL GPV AL DEBUTTO È REALIZZATO DA 5 SQUADRE DIVERSE E PER QUANTO
RIGUARDA L'HAT TRICK AL DEBUTTO SOLO L'ALFA ROMEO, LA KURTIS E LA MERCEDES CI
SONO RIUSCITE.
FANGIO DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO CON
L'AUSILIO DI DUE SQUADRE: MASERATI E MERCEDES, IL TITOLO PILOTI VIENE ASSEGNATO
AD ENTRAMBE, CASO UNICO NELLA STORIA DELLA FORMULA 1.
INOLTRE MOLTO RARO ANCHE IL FATTO CHE LA
MERCEDES VINCA IL TITOLO PILOTI AL DEBUTTO (SOLO L'ALFA ROMEO NEL 1950 ERA
RIUSCITA NELL'IMPRESA).
IN PIÙ LA MERCEDES REALIZZA PER PRIMA UNA
SORTA DI GRANDE SLAM AUTOMOBILISTICO, SIA COME SQUADRA CHE COME MOTORE, VINCENDO
LA 500 MIGLIA DI INDIANAPOLIS NEL 1915, LA 24 ORE DI LE MANS NEL 1952 E IL
CAMPIONATO DI FORMULA 1 NEL 1954 (PERÒ SOLO IL TITOLO PILOTI, QUELLO
COSTRUTTORI SARÀ ISTITUITO NEL 1958).
A SILVERSTONE LA FERRARI RAGGIUNGE QUOTA 4
VITTORIE IN 4 ANNI, A TUTT'OGGI È LA SERIE MIGLIORE DI VITTORIE CONSECUTIVE
NELLA STESSA PISTA (E NELLO STESSO G.P.) DELLA FERRARI NEL TEMPO.
PROPRIO A SILVERSTONE SI VERIFICA UN FATTO
CURIOSO: BEN SETTE PILOTI REALIZZANO LO STESSO IDENTICO GPV IN GARA, CIÒ È
DOVUTO PERÒ LARGAMENTE AL SISTEMA DI CRONOMETRAGGIO DELL'EPOCA, LA CUI
APPROSSIMAZIONE SI FERMAVA AI SECONDI.
NEL GRAN PREMIO DEL BELGIO SI VERIFICA IL
PRIMO CASO DI UNA VETTURA CONFORME AL REGOLAMENTO MA PARTECIPANTE FUORI
CLASSIFICA. ACCADE CHE IL PILOTA DE GRAFFENRIED CORRE CON UNA CINEPRESA MONTATA
SULLA SUA MASERATI PER LE RIPRESE DEL FILM "THE RACER". IL CASO DI DE
GRAFFENRIED CHE IN GARA SI RITIRA, PUÒ ESSERE CONSIDERATO IL PRIMO CASO DI
CAMERA CAR. UN EPISODIO SIMILE SI VERIFICHERÀ NEL 66 CON PHILIP HILL. |
|
|
 |
|
|
Fangio imbattibile, ma
adesso è tutto più facile.....
 - 1955 - - 1955 -
|
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1955 |
Arg |
Fangio J.M. |
Mercedes |
W196s |
41 |
4 |
 1955 - Fangio imbattibile, ma
adesso è tutto più facile..... 1955 - Fangio imbattibile, ma
adesso è tutto più facile..... |
|
La stagione 1955 prende il via oltre oceano con il
Gran Premio d'Argentina, sullo schieramento di partenza sono presenti
le vetture di tutte le scuderie, inclusa la Lancia del mitico Alberto
Ascari; la stagione si preannuncia molto avvincente, i due assi Fangio
e Ascari guidano due delle vetture più competitive
dell'intero circus...lo spettacolo sembra garantito.
A Buenos Aires, però, contro ogni aspettativa si assiste
nuovamente ad una solitaria cavalcata di Fangio su una Mercedes W196
che sembra aver dimostrato solo in parte il suo reale potenziale.....
in realtà la causa di questa "facile" vittoria non
è da attribuire alle caratteristiche del mezzo,
bensì al pilota; infatti il pilota argentino grazie alla sua
consueta e meticolosa preparazione atletica riesce a sopportare
egregiamente condizioni particolarmente insidiose come il caldo torrido
verificatosi a Buenos Aires.
Quindici giorni dopo a Monaco si assiste al vero spettacolo, le vetture
Lancia e Mercedes tecnicamente sembrano equipararsi, si assiste ad un
leggendario duello tra Ascari e Fangio; l'italiano ha la meglio (la
vettura di Fangio, infatti accusa problemi tecnici) ma quando
è solo al comando della gara, la sua Lancia diventa
imprevedibile da ciò consegue una quasi inevitabile uscita
di pista..... che rischia di finire in tragedia: A Monaco, infatti, nel
1955 non era presente alcuna barriera tra la pista ed il porticciolo
contiguo, di conseguenza nulla impedì alla vettura di Ascari
di cadere in mare, il pilota, per fortuna, riuscì ad uscire,
rapidamente, dall'abitacolo e a cavarsela semplicemente con la rottura
del setto nasale. La gara sarà vinta dalla Ferrari di
Trintignant.
Alberto Ascari clinicamente non è affatto in ottime
condizioni, il suo fisico ha risentito comunque dell'accaduto.
Moralmente invece è al settimo cielo, sente di poter lottare
con Fangio ad armi pari, il campionato è appena iniziato e
nulla è ancora compromesso......ha solo voglia di correre.
La possibilità si presenta solo qualche giorno dopo, Alberto
passa dal circuito di Monza , al solo scopo di salutare gli amici,
quì trova Eugenio Castellotti (terzo pilota Lancia) intento
a testare una Ferrari Sport, Alberto sarebbe ben felice di farsi un
"giro" sul nuovo bolide... Castellotti dal suo canto non puo' che
esserne onorato... così il due volte campione del mondo
indossa casco e guanti e sale sulla vettura.
E' così... proprio così che il più
grande pilota italiano va incontro al più amaro e beffardo
destino: dopo un giro mentre affronta la famosa parabolica di Monza,
per motivi ancora da chiarire, la sua vettura esce di pista, Alberto
viene catapultato fuori dall'abitacolo, l'impatto è tremendo
per <<Ciccio>> così come lo
chiamavano gli amici non c'è nulla da fare. Si spegne
così il 26 Maggio 1955 alle ore 12.26 il più
grande pilota italiano di tutti i tempi.
Devastanti sono le conseguenze sul mondo della Formula Uno, l'Italia
è sconcertata.... Gianni Lancia, in lutto per la perdita del
suo pilota, sceglie la soluzione più drastica possibile: il
ritiro, la Lancia si ritira dopo solo tre gare dalla Formula Uno!!
Dopo due settimane il "baraccone" della formula uno
si sposta a Zandvoort, anche se l'agonismo sembra aver assunto, per
questa stagione, un ruolo ormai irrilevante. In Belgio le Mercedes
fanno il vuoto, si aggiudicano praticamente tutto.
Ma il 1955 non ha finito di riservare cattive sorprese; infatti intanto
che la F1 tenta di dimenticare il terribile episodio di Ascari ecco che
una nuova tragedia si affaccia sul mondo dell'automobilismo, stavolta
riguarda la 500 miglia, un pilota americano: Bill Vukovich finisce sul
pubblico... è una strage muoiono circa cento spettatori.. il
mondo dell'automobilismo è travolto dalle critiche
pubbliche.
A seguito di questo evento al calendario della stagione vengono
sottratte tre gare.... dunque delle dieci previste a inizio anno se ne
svolgeranno soltanto sette. Un mese dopo è la volta del Gp d'Olanda.... è
ancora dittatura Fangio, nel Gp d'Inghilterra, quindici giorni dopo,
Fangio continua a dominare, ma lascia la vittoria al suo compagno di
squadra il giovane Stirling Moss; la vittoria dell'inglese a
Silverstone è più che altro una strategia
politica; la F1 tenta di riconquistare il consenso nazionale.
|
 |
| Sopraelevata di Monza - Gran Premio d'Italia 1955 - Fangio seguito da Moss - Mercedes |
A Monza, ultima gara della stagione, Fangio continua a vincere e si
laurea dunque per la terza volta campione del mondo.......
è
evidente che l'unico pilota ingrado di ostacolare concretamente
l'argentino sarebbe stato solo Ascari!!!
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: SI
DISPUTANO SOLO 7 GRAN PREMI VALIDI A CAUSA DELLE TRAGEDIE E QUESTA DIVENTA LA
STAGIONE PIÙ CORTA DI FORMULA 1 INSIEME AL 1950.
IL GRAN PREMIO DI MONACO TORNA NEL
CALENDARIO DI FORMULA 1 DOPO UNA PAUSA DI 4 ANNI. INVECE IL GRAN PREMIO DI
FRANCIA E DI GERMANIA NON VENGONO DISPUTATI (PER LA FRANCIA SARÀ L'UNICA
EDIZIONE PERSA, MENTRE LA GERMANIA ERA FUORI ANCHE NEL 1950).
NEL BIENNIO 1954-55 LA MERCEDES INTRODUCE
NOVITÀ TECNICHE INTERESSANTI: È LA PRIMA VETTURA DI FORMULA 1 A VINCERE
UTILIZZANDO UN CAMBIO A CINQUE MARCE; È LA PRIMA VETTURA CON FRENI A DISCO E
INOLTRE È LA PRIMA E UNICA VETTURA DI FORMULA 1 A RUOTE COPERTE, INFATTI LA
CONFIGURAZIONE BASE DELLA VETTURA ERA CON TUTTE E QUATTRO LE RUOTE COPERTE DA
UNA CARENATURA. ESISTEVA UN IDENTICO MODELLO MA A RUOTE SCOPERTE ADATTO PER I
CIRCUITI MENO VELOCI E PIÙ TORTUOSI COME MONTECARLO.
A FINE ANNO LASCIA ANCHE LA LANCIA, PER VIA
DELLA MORTE DI ASCARI, PILOTA UFFICIALE, E ANCHE PERCHÉ LA LANCIA È ENTRATA
NELL'ORBITA DELLA FIAT. TUTTO IL MATERIALE (TELAIO E MOTORI) VERRANNO CEDUTI
ALLA FERRARI, LA QUALE STAVA ATTRAVERSANDO UN PERIODO DI CRISI TECNICA DOVUTO AL
FATTO CHE ERANO PREPOTENTEMENTE TORNATE ALLA RIBALTA LE VERE VETTURE DI FORMULA
1. DOPO I DUE ANNI 52-53 DI TRANSIZIONE CON VETTURE DI FORMULA 2, LA FERRARI NON
ERA PIÙ RIUSCITA A COSTRUIRE VETTURE DI FORMULA 1 VINCENTI. CON IL MATERIALE
DELLA LANCIA, RIDENOMINATO FERRARI, LA CASA DI MARANELLO TORNÒ A VINCERE.
CON IL GRAN PREMIO D'ITALIA DEL 1955
TERMINA ANCHE LA CARRIERA DI FARINA (CAMPIONE NEL 1950) E COSÌ DALLA STAGIONE
SUCCESSIVA A TUTT'OGGI NON VI SARÀ PIÙ IN GARA UN PILOTA ITALIANO CAMPIONE DEL
MONDO DI FORMULA 1.
|
|
|
1956 - La Ferrari torna in vetta

 |
 |
| 1956 Gran Premio di Francia - Fangio du Ferrari D50 |
Gran premio di Argentina 1956 - Fangio di Ferrari D50 |
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1956 |
Arg |
Fangio J.M. |
Ferrari |
D50 |
33 |
3 |
|
Il 1956 è l'anno dei grandi assenti,
infatti dopo la Lancia anche la Mercedes ha scelto di non competere
più in F1, la casa di Stoccarda infatti riteneva ormai
raggiunti i suo i obiettavi, effettivamente in due anni avevano vinto
tutto e tutti... adesso era ora di pensare ad altro.
Così alla partenza del Gp d'Argentina, che inaugura la
stagione 1956, sono presenti solo due grandi case costruttrici la
Ferrari e l'intramontabile Maserati; la prima schiera come pilota di
punta, niente poco di meno, che il campione in carica Juan Manuel
Fangio; mentre la casa del tridente si affida all'astro nascente
Stirling Moss.
La scuderia di Maranello sulla carta sembra essere ancora una volta la
favorita, infatti oltre a disporre del miglior pilota in circolazione
ha realizzato una vettura estremamente affidabile e competitiva si
tratta della "Ferrari-Lancia D50"; proprio così per la prima
e unica volta nella sua storia gli uomini del cavallino non hanno
realizzato "tutto in casa" bensì si sono avvalsi della
collaborazione Lancia.
Fu proprio Gianni Lancia, in persona, a voler affidare vetture, ricambi
e personale alla squadra di Maranello... tanto li a Torino, a seguito
del ritiro, non sarebbero serviti a granché. E' importante
sottolineare questo ulteriore, e imprevisto apporto, infatti,
sarà determinante per la conquista del titolo.
A Buenos Aires dopo un ottimo avvio Fangio è costretto a
rientrare ai box per problemi tecnici; la sua vettura è
inutilizzabile si decide dunque di far rientrare l'altro ferrarista
Musso e consentire dunque al campione in carica, di concludere la gara
con l'altra Ferrari. Stesso copione per il secondo Gp della stagione,
quello di Montecarlo dove Fangio conclude la gara, sulla Ferrari di
Collins; ma questa volta l'argentino è secondo dietro
all'inglese Stirling Moss.
I due Gran Premi successivi (escludendo la pausa Indianapolis) sono
ancora targati Ferrari, ma stavolta a vincere è il
venticinquenne Collins pilota di grande maturità ed
esperienza; furono proprio le ultime due vittorie dell'inglese a
mandare su tutte le furie Fangio; l'argentino, infatti, sosteneva di
aver subito, proprio per mano dei suoi stessi meccanici, dei continui
sabotaggi...... infatti oltre a non esser riuscito a finire neanche una
gara con il proprio mezzo, il tre volte campione del mondo avanza dei
seri sospetti sulle cause che hanno provocato i cedimenti meccanici.
Fangio suppone che la Ferrari stia tentando di favorire il compagno:
Peter Collins, poichè questo potrebbe avere risvolti molto
positivi sull'immagine aziendale nel Ragno Unito.
A logorare ulteriormente i rapporti tra Fangio e gli uomini di
Maranello è il Gran Premio del Belgio, dove ancora una volta
il mezzo dell'argentino è tormentato da noie tecniche... non
riesce a far meglio del quarto posto.
Fangio è moralmente a pezzi, sente di
poter vincere ma allo stesso tempo, qualcosa di misterioso rende vano
ogni suo tentativo. Tenta di parlarne con l'ingegner Ferrari ma
quest'ultimo, sta vivendo il periodo più brutto della sua
vita, le condizioni di salute di suo figlio Dino (ventiquattrenne) sono
notevolmente peggiorate la distrofia muscolare sta avendo la meglio sul
suo corpo... il 30 giugno scomparirà.
Nei due Gran Premi successivi: Gran Bretagna e Germania, torna sul
gradino più alto del podio Juan Manuel Fangio, l'argentino
sembra aver superato la sua "crisi", inoltre la scuderia, onde evitare
spiacevoli malintesi ha assunto un meccanico al solo scopo di
sorvegliare la vettura dell'asso argentino.
L'ultimo Gran Premio si corre, in Italia, a Monza; Fangio è
il leder della classifica l'unico in grado di privarlo del titolo
è il suo compagno di scuderia Collins... Il Gran Premio si
mette subito bene per Jaun Manuel Fangio, ma poi dopo venti giri la sua
Ferrari risentendo dell'usura delle gomme esce di pista, riportando
irrimediabili danni al piantone dello sterzo.
Per il tre volte campione del mondo la gara potrebbe essere chiusa
definitivamente, infatti in pista è rimasta solo un'altra
Ferrari, quella di Collins.
A sorpresa di tutti Collins rientra e cede il mezzo al suo "capitano";
che puo' così aggiudicarsi il quarto titolo mondiale. Quando all'inglese sarà chiesto il motivo del suo gesto si
giustificherà dicendo:"lui è ormai a fine
carriera, per me, che ho venticinque anni, occasione per vincere ce ne
saranno ancora". Questo è stato il gesto più
nobile che un pilota abbia mai compiuto in tutta la storia della
Formula uno...
Collins era si un grande pilota ma era prima di tutto un
grande uomo!!! |
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: FANGIO
DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO CON SOLI 30 PUNTI VALIDI, COME FARINA NEL 1950, E SARÀ
IL CAMPIONE LAUREATOSI CON MENO PUNTI (NEL 56 PERÒ C'È UNA CORSA IN PIÙ
RISPETTO AL 50).
LA FERRARI VINCE IL SUO TERZO TITOLO
MONDIALE E DIVENTA COSÌ LA SQUADRA PIÙ VINCENTE.
NEL GRAN PREMIO D'ARGENTINA DI QUELL'ANNO E
ANCHE IN QUELLO DEL 57 SI PRESENTANO AL VIA SOLO DUE SQUADRE: FERRARI E
MASERATI. A SPUNTARLA SARÀ IN ENTRAMBE LE OCCASIONI LA SQUADRA MENO
RAPPRESENTATA: LA FERRARI NEL 56 (CON 5 VETTURE CONTRO 10 MASERATI) E LA
MASERATI NEL 57 (CON 7 VETTURE CONTRO 9 FERRARI). L'UNICO PUNTO IN COMUNE È CHE
A VINCERE È SEMPRE FANGIO.
FANGIO SEMPRE PIÙ LANCIATO CONQUISTA IL
SUO QUARTO TITOLO, IL TERZO CONSECUTIVO, ED A FINE ANNO CAMBIA NUOVAMENTE
SQUADRA.
NEL GRAN PREMIO D'ARGENTINA E NEL
SUCCESSIVO GRAN PREMIO DI MONACO SI REGISTRA UN DISTACCO RECORD PER QUANTO
RIGUARDA IL QUARTO, GIUNTO IN ENTRAMBE LE OCCASIONI AD OLTRE 6 GIRI.
DOPO LA PRIMA CORSA DELLA STAGIONE, IL GRAN
PREMIO D'ARGENTINA, IN TESTA AL CAMPIONATO NON SI TROVA IL VINCITORE BENSÌ IL
SECONDO CLASSIFICATO. ERA ACCADUTO CHE IL PRIMO, FANGIO, AVEVA VINTO IN COPPIA
CON MUSSO, E DIVIDENDO I PUNTI CON QUEST'ULTIMO NE AVEVA COSÌ TOTALIZZATI
QUATTRO, DIVENTATI CINQUE GRAZIE AL GPV. IL SECONDO CLASSIFICATO, JEAN BEHRA SU
MASERATI, NON DIVIDENDO LA SUA VETTURA CON NESSUNO AVEVA INTASCATO TUTTI I PUNTI
DEL SECONDO CLASSIFICATO: CIOÈ 6, RITROVANDOSI IN TESTA AL MONDIALE. BEHRA,
NELLA SUA CARRIERA, NON VINSE MAI UN GRAN PREMIO RIUSCENDO UGUALMENTE A PORTARSI
IN TESTA AL CAMPIONATO ED È L'UNICO PILOTA CHE SIA RIUSCITO NELL'IMPRESA.
NEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA, PER
L'ULTIMA VOLTA ACCADE CHE L'APPROSSIMAZIONE DEL CRONOMETRAGGIO SI FERMI AI
SECONDI (MA SOLO DURANTE LE PROVE). |
|
|
 |


Juan Manuel Fangio
1951 1954 1955 1956 1957
51 Gran Premi - 24 Vittorie - 35 Podi
|
 |
Riassunto della stagione
La stagione 1957 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 è stata, nella storia della categoria, l'8a ad assegnare il Campionato Piloti.
È iniziata il 13 gennaio ed è terminata l'8 settembre, dopo 8 gare. Il
titolo mondiale piloti è andato per la quinta volta al campione
argentino Juan Manuel Fangio.
Il
team Vanwall divenne molto competitivo durante la stagione, sebbene la
Connaught fu costretta al ritiro per mancanza di fondi e la BRM rimase
inaffidabile. Fangio conquistò il suo quinto ed ultimo Titolo Mondiale, e la Vanwall fu vittoriosa in tre gare. La gara di Fangio al Nürburgring,
dove sorpassò Hawthorn e Collins durante il penultimo giro dopo aver
preso quasi un minuto di distacco rimase un classico. Questa fu l'ultima
stagione nella quale furono possibili i cambi di pilota al volante
delle auto durante il Gran Premio.
|
|
|
Fangio entra nella
leggenda... è l'uomo dei Record
- 1957 -
1957 - Fangio vince il suo quinto titolo iridato con la sua Maserati 250F
Nurburgring 4 agosto 1957 - Fangio e Maserati 250F campioni del mondo F1
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1957 |
Arg |
Fangio J.M. |
Maserati |
250F |
46 |
4 |
 1957 - Fangio entra nella
leggenda... è l'uomo dei Record 1957 - Fangio entra nella
leggenda... è l'uomo dei Record
|
E' il 1957, la stagione di formula uno si appresta
ad iniziare, per la prima volta, in assoluto, il progetto della nuova
Ferrari non è stato ancora approntato...... infatti il drake
ha serie intenzioni di smettere.... la morte del figlio Dino ha creato
nel costruttore modenese un vuoto incolmabile; è stanco
vuole farla finita con tutto e con tutti. Per fortuna ad impedire
questo, sono proprio i dipendenti Ferrari, i famosi "ragazzi" amano il
loro lavoro e la scuderia che rappresentano, nonostante tutto e tutti
il cavallino deve continuare a correre.... come solo lui sa fare.
Il drake gli accontenta. Al primo Gran Premio stagionale sono schierate
in pista le stesse vetture del precedente anno, solo che Fangio non
è più al volante di una Ferrari bensì
è diventato l'uomo di punta, accanto a Stiriling Moss della
Maserati. la prima tappa della stagione se l'aggiudica, proprio
l'argentino che a Buenos Aires è di casa.
Si corre successivamente a Montecarlo Fangio è ancora il
favorito, ma da adesso in poi non potrà più
contare sull'apporto del compagno di scuderia; Moss infatti
è stato ingaggiato dalla scuderia inglese: Vanwall diretta
dal celebre Tony Vandervell, un facoltoso industriale britannico,
titolare di una fabbrica di bronzine che porta il suo stesso nome.
Vandervell dopo aver fornito per anni bronzine alle varie scuderie
decide di mettere su un proprio team.. la squadra è in piedi
da diversi anni ma i risultati stentano ad arrivare, nel 1957
c'è un notevole progresso, dovuto soprattutto ai
giovanissimi e audaci uomini che Vadervell è riuscito a
reclutare. La Vanwall tra le sue file schiera, infatti, tecnici del
calibro di Colin Chapman, Frank Costin e Harry Weslake.. uomini che
realizzeranno le monoposto più competitive del prossimo
decennio. In Francia, dopo la pausa di Indianapolis, a salire
sul gradino più alto sarà ancora una volta
Fangio, facilitato dall'assenza di Moss; l'inglese infatti è
a letto a causa di un'acuta sinusite. L'inglese si rifarà, quindici giorni dopo, vincendo prorpio
il Gran Premio di casa , seppure utilizzando la monoposto del compagno,
la sua infatti ha ceduto verso metà gara. |

Il Gran Premio di Germania 1957 fu la sesta gara della stagione 1957 del Campionato mondiale di Formula 1, disputata il 4 agosto al Nürburgring.
La corsa vide la vittoria di Juan Manuel Fangio su Maserati,
in una da molti considerata come tra le più belle vittorie nella storia
dell'automobilismo,
nonché l'ultima in carriera per il pilota
argentino.
|
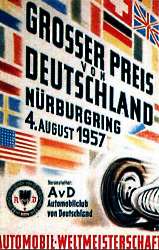 |
|
In Germania, non ce ne sarà per nessuno, infatti proprio
qui, quando pochi gran premi mancano alla conclusione ufficiale della
sua carriera, Juan Manuel Fangio corre la gara più bella
della sua vita: l'argentino guiderà senza compiere il
benché minimo errore, seppur svantaggiato da una sosta
più lunga del previsto Fangio non si lascia andare, ansi il
notevole distacco che lo separa dai piloti di testa lo sprona ad
insistere.. sfrutta tutta la pista, usa le marce più alte..
e corre rischi che solo lui puo' permettersi di correre... a fine gara
si ritrova primo con tre secondi di vantaggio sul secondo arrivato:
Hawthorn, quest'ultimo durante la gara aveva goduto di un gap di
superiore al minuto nei confronti dell'argentino.
Jaun Manuel Fangio agguanta così il record che
più a lungo resterà imbattuto, nella formula uno:si laurea per la quinta volta campione del mondo... è ormai
nella leggenda!!
|
 |
 |
Le due gare che mancano alla fine del campionato si corrono sul
circuito di Pescara (unica volta nella storia) e sul circuito di Monza.
Qui si impone, entrambe le volte, Stirling Moss, pilota ormai
considerato da tutti campione del domani.
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: DOPO
IL SUCCESSO DI FANGIO NEL 51 IN COPPIA CON FAGIOLI E QUELLO SEMPRE DI FANGIO NEL
56 IN COPPIA CON MUSSO, NEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA VINCE STIRLING MOSS SU
VANWALL IN COPPIA CON BROOKS. È QUESTO L'ULTIMO SUCCESSO OTTENUTO IN COPPIA IN
FORMULA 1.
FANGIO DIVENTA IL PRIMO PILOTA CAMPIONE DEL
MONDO, STANDO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DALL'INIZIO ALLA FINE, A PARI CON
NESSUNO.
NELLE ANNATE PRECEDENTI SI ERA ASSISTITO
ADDIRITTURA A 3 PILOTI CHE SI ERANO PASSATI LA STESSA VETTURA E GIUNTI IN ZONA
PUNTI, OPPURE A PILOTI GIUNTI IN ZONA PUNTI DUE VOLTE NELLO STESSO GRAN PREMIO
PERCHÈ OTTENUTI CON DUE VETTURE DIVERSE. GIUSTAMENTE LA FEDERAZIONE POSE UN
FRENO A QUESTE SITUAZIONI, STABILENDO CHE CHI AVESSE USUFRUITO DI TALI MEZZI NON
AVREBBE PRESO PUNTI QUALUNQUE FOSSE LA SUA POSIZIONE FINALE.
CON IL GRAN PREMIO DI PESCARA L'ITALIA
DIVENTA LA PRIMA NAZIONE AD OSPITARE DUE GRAN PREMI IRIDATI IN UNA STAGIONE
(BISOGNA RICORDARE CHE FINO ALLA FINE DEGLI ANNI 70 I GRAN PREMI DI FORMULA 1
NON VALIDI PER IL CAMPIONATO ERANO NUMEROSI, POI SCOMPARVERO CON IL
PROFESSIONISMO SEMPRE PIÙ ACCENTUATO). INOLTRE PROPRIO IL GRAN PREMIO DI
PESCARA UTILIZZA IL CIRCUITO DI PESCARA CHE RESTA IL PIÙ LUNGO UTILIZZATO IN
FORMULA 1: BEN 25 KM E 795 METRI.
NELLA MILLE MIGLIA DI QUELL'ANNO SI
VERIFICA UN GRAVE INCIDENTE IN CUI MUORE IL PILOTA DI FORMULA 1 ALFONSO DE
PORTAGO, UCCIDENDO INOLTRE UNA DECINA DI PERSONE. CIÒ AVRÀ RIPERCUSSIONI NON
SOLO SULLA GARA (CHE VERRÀ ABOLITA) MA ANCHE PER LA FERRARI (IL CUI PILOTA
SPAGNOLO ERA AL VOLANTE) CHE DOVRÀ SUBIRE UN DURO PROCESSO DA PARTE DELLA
STAMPA ITALIANA. |
|
|
 |
 |


1958 - Ferrari 246 - Motore Dino
Mike Hawthorn
45 Gran Premi - 3 Vittorie - 18 Podi
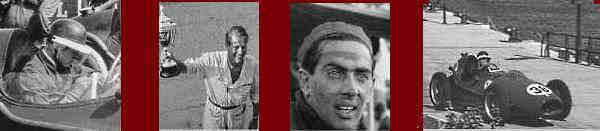
|
Riassunto della stagione
La stagione 1958 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 è stata, nella storia della categoria
9ª ad assegnare il Campionato Piloti e la 1ª ad assegnareil Campionato Costruttori.
È iniziata il 19 gennaio e terminata il 19 ottobre, dopo 11
gare. Il titolo mondiale piloti è andato
per la prima volta al
britannico Mike Hawthorn, mentre il Titolo Costruttori
è stato
conquistato dalla Vanwall.
Il
pilota della Kurtis Kraft Pat O'Connor, i piloti della scuderia Ferrari
Luigi Musso e Peter Collins e il pilota
della Vanwall Stuart
Lewis-Evanssono deceduti durante questo campionato.
|
|
La rossa torna a vincere
in un anno... nero
1958 - La rossa torna a vincere
in un anno... nero
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1958 |
GB |
Hawthorn M. |
Ferrari |
246 |
49 |
1 |
|

La nuova stagione comincia all'insegna
dell'innovazione umana e tecnologica: infatti fanno l'esordio in pista,
già dal primo Gran Premio, nuovi piloti, sicuramente molto
meno esperti dei precedenti, ma sicuramente estremamente più
giovani (la media degli anni di un pilota è passata dai 40
ai 25)... lo stesso Fangio, definito da tutti: un campione
intramontabile, sta pensando molto seriamente di appendere il caso al
chiodo... ma a inizio stagione la sua assenza è dovuta
prevalentemente alla mancanza di una scuderia. La Maserati, infatti,
dopo la conquista del titolo ha deciso di ritirarsi dalle
competizioni.. scelta da attribuire a carenze economiche da parte
dell'azienda modenese.
Quindi al primo Gran Premio, al fianco della Ferrari si schiera come
valida alternativa alla vincita del mondiale solo l'emergente Vanwall
che per l'occasione sperimenta per la prima volta un idea
rivoluzionaria: la vettura inglese prevede il montaggio del propulsore
alle spalle del pilota attribuendo quindi alla vettura trazione
posteriore...... la scoperta si rivelerà rivoluzionaria, a
breve tutti utilizzeranno la medesima tecnologia.
In Argentina la vittoria va a Moss il talento inglese guida una vettura
Vanwall acquistata dal team privato Cooper Climax al cui vertice figura
l'audace Rob Walker. Quindici giorni dopo al Gran Premio di Monaco
è ancora la Vanwall-Climax ad imporsi ma questa volta al
volante c'è l'esperto Trintignant. Dopo Montecarlo la
situazione in classifica generale ha del paradossale, infatti pur non
avendo conseguito alcuna vittoria, la testa della classifica appartiene
a Luigi Musso pilota Ferrari; il romano è l'unico pilota
italiano rimasto nel circus, infatti il suo ex compagno di squadra
Castellotti è scomparso a seguito di un incidente avvenuto
nel corso delle prove private all'autodromo di Modena.
In Olanda, però durante il successivo Gp, la leadership
della classifica generale viene strappata al romano, infatti Moss torna
a vincere alla guida di una vettura, che a seguito delle ultime
modifiche, sembra essere nettamente più competitiva della
Ferrari 246. La Vanwall si aggiudica anche il quarto gran premio
consecutivo, questa volta al volante della vettura c'è Tony
Brooks compagno di scuderia di Moss.
Quindici giorni dopo in Francia torna in pista, al volante di una
vecchia Maserati, il "maestro"; Juan Manuel Fangio è ancora
incerto sul prorpio futuro, avrebbe intenzione di smettere ma sia la
sua ragazza che il suo manager insistono affinché salga
nuovamente su una monoposto; probabilmente l'esito della gara
decreterebbe il da farsi. L'argentino pur arrivando soltanto in quarta
posizione guida in modo eccezionale, addirittura riesce a completare la
gara pur non disponendo della frizione, ceduta dopo pochi giri dal via,
cambiando le marce solo quando il suo istinto ed il suo orecchio gli
dicono che puo' farlo senza rompere il motore. Per Fangio questa comunque sarà l'ultima gara, si accorge
infatti che tutto sta cambiando, i piloti con cui corre hanno la
metà dei suoi anni; inoltre perchè continuare ??
Dopo cinque titoli cos'altro chiedere alla sua carriera... è
prorpio giunto il momento di tornare a casa..........
In Francia, Fangio non sarà l'unico a salutare
definitivamente la massima formula, infatti, seppure in un modo
maledettamente più amaro anche Luigi Musso
scomparirà dalle scene; l'unico pilota italiano rimasto in
circolazione, perderà la vita alla curva di Thillois nel
vano tentativo di raggiungere il suo compagno di squadra Hawthorn. Per
la cronaca sarà proprio l'inglese della Ferrari ad
aggiudicarsi il Gran Premio.
Il 19 luglio è in programma il Gran Premio d'Inghilterra,
nonostante l'ottima prestazione in prova di Moss a vincerlo
sarà una Ferrari quella di Collins, seguito dal compagno di
squadra Hawthorn.
Quindici giorni dopo si corre in Germania, sul
circuito tedesco si ripete una tragedia analoga a quella capitata pochi
mesi prima: Peter Collins nel tentativo di resistere a Tony Brooks,
entra in curva troppo velocemente, la sua Ferrari si impenna....
l'impatto con gli alberi è inevitabile... per Collins il
pilota gentile, l'uomo dall'animo umile, capace di sacrificarsi in nome
di sentimenti nobili.. è la fine!!!
Brooks, in una gara maledetta, taglia il traguardo per primo.
Restano tre gare alla fine del mondiale tre sono i piloti che
potrebbero aggiudicarsi il titolo Moss, Brooks e Hawthorn, il pilota
Ferrari, però, è moralmente a pezzi, ha perso
entrambi i suoi compagni... dopo Musso anche Collins si è
sacrificato........ è proprio la fine riservata a Peter che
più rammarica Hawthorn, i due infatti erano amici fraterni,
vivevano insieme, e rappresentavano insieme la nuova leva dei piloti
inglesi....... Mike sente di non farcela da solo ha deciso di
ritirarsi.. ma prima deve contribuire alla causa per cui i suoi due
compagni si sono sacrificati..... vincere.
Negli ultimi tre Gran Premi Hawthorn si aggiudica tre secondi
posti...... la regolarità delle sue prestazione si
è rilevata determinante, con un solo punto di vantaggio su
Moss, Mike Hawthorn è il campione del mondo!!!
Raggiunto l'obiettivo aspirato Mike Hawthorn si ritira ufficialmente
dalle competizioni.... ma, scherzi del destino, troverà la
morte cinque mesi dopo in un incidente stradale a bordo della sua
Jaguar. La sua vita era comunque segnata, Mike infatti godeva di una
salute precaria: il male che lo aveva colpito ha un rene gli avrebbe
soffiato la vita ...... comunque.
|
Hawthorn, con regolarità, nel 1958
|
 Il
titolo mondiale della Ferrari probabilmente più sorprendente fu quello
conquistato da Mike Hawthorn nel 1958. Il
titolo mondiale della Ferrari probabilmente più sorprendente fu quello
conquistato da Mike Hawthorn nel 1958.
In quella stagione la casa di Maranello è ancora una delle
vetture più forti, ma l'attacco delle marche inglesi comincia a farsi molto più
serio. Stirling Moss, il pilota più forte del mondo dopo il ritiro di
Juan Manuel Fangio, corre per la Vanwall, scuderia a quel tempo ai
vertici, ma solo per la prima gara in Argentina guida la piccola Cooper con
motore a posteriore Climax e, a sorpresa, riesce a battere le Ferrari e le
Maserati. Hawthorn è terzo dietro al compagno di squadra Musso. Il duello tra i
due piloti inglesi si protrarrà per tutto l'arco dell'annata.
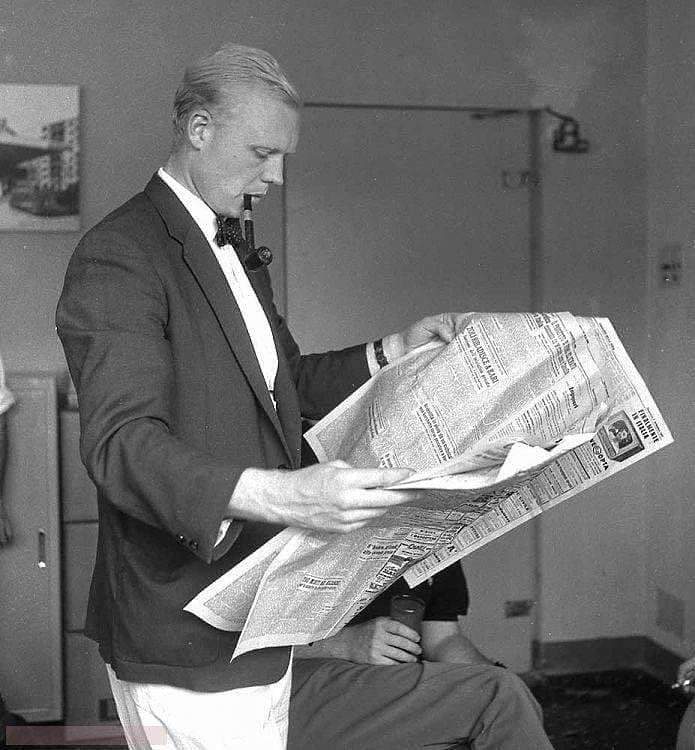
Mike Hawthorn, il primo campione inglese di F.1
|
A Montecarlo si ritirano entrambi, in Olanda nuova vittoria di Moss e
quinto posto di Hawthorn, piazza d'onore per il ferrarista dietro a Brooks
(Vanwall) a Spa con Moss ritirato. E' la volta del Gran Premio di Francia.
Hawthorn si aggiudica l'unica gara della stagione battendo proprio Moss, ma la
malasorte comincia a colpire la Ferrari. Infatti Musso muore in un
terribile incidente dopo 10 giri. In questa occasione Fangio disputa la
sua ultima gara.
Il colpo è durissimo per Mike che però è in piena corsa per il titolo:
a Silverstone si piazza dietro il suo connazionale e compagno di squadra Peter
Collins, ma quest'ultimo perde anch'egli la vita al Nürburgring dove
domina Brooks. Altro lutto gravissimo per la Ferrari che vede oltretutto
Hawthorn ritirarsi mentre la gara è vinta da Brooks. Nelle ultime tre gare Mike
arriva sempre secondo, in Portogallo e in Marocco dietro a Moss e a Monza
alle spalle di Brooks. Nella gara nordafricana, l'ultima, il ferrarista
acquisisce la certezza del titolo mondiale, aggiudicandoselo con un solo
punto di vantaggio su Moss.

L'iride è tutto sommato meritato per Hawthorn, autore di una stagione
dalla regolarità impressionante, ma anche di quattro pole position e cinque
giri più veloci in gara. Molta sfortuna però per Moss e Brooks, vincitori
rispettivamente di quattro e tre gare ma penalizzati dalla fragilità delle
loro Vanwall. Alla fine del campionato Hawthorn, colpito nel profondo
dalle morti di Musso e Collins, annuncia il suo ritiro dalle
competizioni, ma non avrà il tempo di godersi la vittoria mondiale. Tre mesi
dopo infatti il gentleman della Formula 1 perirà anch'egli in un incidente
stradale, a 30 anni non ancora compiuti.
|
|
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: SI
DISPUTANO 11 CORSE ED È LA PRIMA VOLTA CHE VIENE RAGGIUNTO (E ANCHE SUPERATO)
IL NUMERO DI DIECI CORSE IN CAMPIONATO. IL BILANCIO FINALE DELLA STAGIONE È
PESANTE: 4 PILOTI MORTI, UN RECORD CHE FORTUNATAMENTE NON VERRÀ PIÙ BATTUTO.
IL CAMPIONATO MONDIALE PILOTI VINTO DALLA
FERRARI È IL QUARTO E LA SQUADRA SI CONFERMA SEMPRE PIÙ SPECIALISTA NELLA
SERIE. QUESTO RESTERÀ COMUNQUE A TUTT'OGGI L'UNICO CASO IN CUI LA FERRARI VINCE
IL SOLO TITOLO PILOTI, DA QUANDO ESISTE ANCHE QUELLO PER I COSTRUTTORI.
INVECE LA VANWALL RESTA L'UNICA SQUADRA IN
FORMULA 1 AD AVER CONQUISTATO SOLO IL TITOLO MONDIALE COSTRUTTORI; ALLA FINE
DELL'ANNO SI RITIRERÀ. SARÀ PRESENTE NEL 1959 E NEL 1960 SOLO IN FORMA PRIVATA
CON UN UNICA VETTURA AL VIA DI UN SOLO GRAN PREMIO ALL'ANNO.
NEL GRAN PREMIO DI FRANCIA CORRE CON UNA
MASERATI TROY RUTTMAN, PILOTA STATUNITENSE CHE CORRE NELLA SERIE AMERICANA. È
UNO DEI RARI CASI DI PARTECIPAZIONE ALLE DUE SERIE CHE NON RIUSCIRONO MAI A
LEGARSI, NONOSTANTE IL TENTATIVO DI INDIANAPOLIS. I CASI DI PILOTI DI FORMULA 1,
CHE DISPUTANO ALMENO UNA GARA NELLA SERIE AMERICANA SONO ANCORA PIÙ RARI: SOLO
ASCARI NEL 1952, TRA L'ALTRO A INDIANAPOLIS, PER CUI ERA COMUNQUE IN UNA PROVA
DI FORMULA 1.
IL PILOTA AMERICANO SARÀ PRESENTE ANCHE
NEL GRAN PREMIO DI GERMANIA SEMPRE CON UNA MASERATI MA SENZA RIUSCIRE A PARTIRE.
IN TUTTI I CASI NESSUN "OSPITE"
RIUSCI AD OTTENERE RISULTATI DI RILIEVO. VA DETTO CHE MENTRE ASCARI UTILIZZÒ LA
SUA VETTURA UFFICIALE CON AL SEGUITO TUTTA LA SQUADRA, I PILOTI AMERICANI
TENDEVANO A UTILIZZARE VETTURE PRESENTI IN EUROPA, DOVENDO SCOPRIRE LA VETTURA
AL MOMENTO.
IL GRAN PREMIO D'ARGENTINA DIVENTA IL GRAN
PREMIO CON IL MINOR NUMERO DI PARTECIPANTI, SOLO 10 PILOTI SONO PRESENTI;
INOLTRE VERRÀ RICORDATO ANCHE PER LA PRIMA VITTORIA DI UNA VETTURA A MOTORE
POSTERIORE: LA COOPER-CLIMAX DI STIRLING MOSS. |
|
|
 |
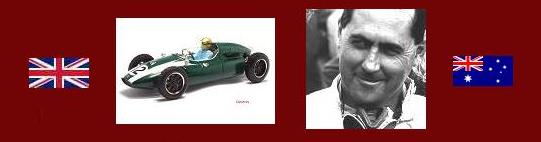

Jack Brabham - 1959 - Cooper Climax T51
|
 |
La stagione 1959 del Campionato mondiale FIA di Formula 1 è stata, nella storia della categoria, la 10a ad assegnare il Campionato Piloti
e la 2a ad assegnare il Campionato Costruttori. È iniziata il 10 maggio e terminata il 12 dicembre, dopo 9 gare.
Il titoli mondiali sono andati per la prima volta al pilota Jack Brabham ed al costruttore Cooper.
Prima della stagione
- Mike Hawthorn, campione del mondo in carica ritiratosi al termine della 1958, muore in incidente stradale il 22 gennaio 1959.
- Il team Vanwall, Campione Costruttori in
carica, si ritira ufficialmente dal Mondiale a causa delle condizioni
di salute del titolare Tony Vandervell,
- fortemente provato anche dalla scomparsa del giovane Lewis-Evans a fine
1958. Tony Brooks abbandona il team per passare alla Scuderia Ferrari.
|
Il colpaccio di Black Jack
|
| Anno |
Naz. |
Pilota |
Vettura |
Tipo |
P.ti |
Vitt. |
| 1959 |
Aus |
Brabham J. |
Cooper |
T51 |
34 |
2 |
|

|
Il 1959 si avvia orfano di due figure che durante
il precedente anno si erano massicciamente imposte nella massima
formula: il campione del mondo in carica Mike Hawthorn scomparso in un
incidente stradale e l'innovativo costruttore Tony Vandervell,
l'industriale britannico, infatti, comincia ad accusare gli effetti di
una devastante malattia.
Il 1959, sembra profilarsi dunque nel segno dell'unico pilota "esperto"
rimasto in circolazione Stirling Moss; l'inglese è sulla
cresta dell'onda da diversi anni ma sino ad ora non è mai
riuscito a consacrare la sua abilità con un titolo mondiale.
Si comincia con il Gran Premio di Montecarlo il super favorito Moss
corre per Rob Walker, il binomio britannico non si avvale comunque di
una vera e propria scuderia; bensì acquisteranno di gara in
gara la vettura di altri team, ovviamente cercando di accaparrassi il
mezzo ritenuto più adatto al circuito. Questa politica, in
fin dei conti, si rivelerà inproduttiva; poiché
non permetterà a Moss di stabilire un feeling con una
vettura, di scoprirne i difetti e sfruttarne i vantaggi... forse questo
sarà la causa che impedirà al pilota inglese di
esprimersi al meglio in questa stagione.
|

1959 Spa - Brabham alla curva rouge
|
|
1959 - Il colpaccio di Black Jack
|
Per quanto riguarda la scuderia Ferrari, la situazione è, a
dir poco, penosa.. la squadra non si puo' più avvalere dei
piloti del precedente anno, ingaggia cos Tony Brooks, ex compagno di
scuderia di Moss...... Tony dimostra comunque abili
capacità: è veloce e affidabile...... ma,
malgrado tutto, non fa miracoli.... proprio così, per
rendere competitiva la vettura progettata per la stagione in corso ci
vorrebbe "solo" un miracolo, è pesante e tecnologicamente
arretrata; per di più gli uomini di Maranello, a differenza
di tutte le altre scuderie, continuano a posizionare il motore sulla
parte anteriore.....quasi, ignorando i molteplici svantaggi a cui
questa soluzione da origine.
A Monaco la gara è vinta da un certo
Jack Brabham ribattezzato dagli amici <<Black
Jack>> l'australiano corre per la scuderia Cooper-Climax.
Dopo la pausa di Indianapolis è la volta del Gp d'Olanda,
questa volta a vincere, per la prima volta nella storia della
F1,è uno svedese: Joakim Bonnier pilota della BRM (Brithis
Racing Partnership) alle cui spalle distaccato di pochissimo
c'è ancora la Cooper di Brabham.
In Francia, la Ferrari di Brooks illude, infatti la vettura schierata
dal cavallino domina per l'intero week-end.... i tifosi della rossa
confidano in un exploit tecnico subito dalla Ferrari 246..
così non è.. il monopolio del cavallino durante
questo Gp è dovuto unicamente alla particolare conformazione
del circuito francese..... lunghi rettilinei collegati tra loro da
curve molto veloci; su una pista del genere più che la
maneggevolezza della vettura conta la potenza in questo la 246
è indubbiamente la migliore. In Inghilterra, quindici giorni
dopo, si torna alla "normalità" Brabham si impone, Brooks
salva il salvabile, Moss si ritira...... Gran Premio di Germania, il circuito del Nurburging è molto
simile a quello francese..... la Ferrari si impone nuovamente, ma
considerando i punti che la dividono dalla Cooper e considerando la
conformazione dei circuiti su cui bisogna ancora gareggiare.....
è evidente che il cavallino per questa stagione dovra
accontentarsi. A due degli ultimi tre gp in programma, si rivede sul gradino
più alto Stirling Moss, straziato da un mondiale
così avaro nei suoi confronti. |
Gran Premio degli Stati Uniti d'America 1959
|

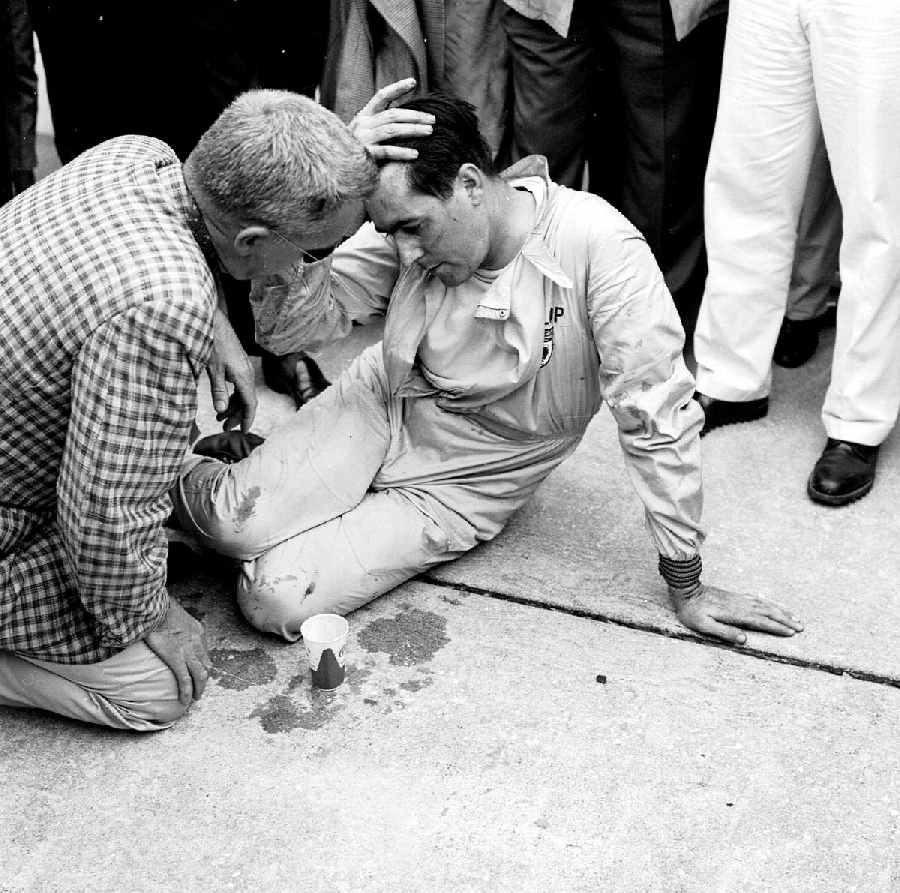
Sebring 1959 - Grazie al quarto posto in gara Jack Brabham,
che raggiunse il traguardo spingendo a braccia
il suo veicolo senza più
carburante, si laureò Campione del Mondo con 4 punti di vantaggio
su
Tony Brooks e 5,5 su Stirling Moss.
|
A Monza, invece, per l'ultimo Gp in programma, la vittoria
andrà al giovanissimo neozelandese Bruce Mclaren compagno di
squadra di Brabham,
quest'ultimo si accontenterà in
quest'occasione di piazzarsi in quarta posizione, i punti ottenuti sono
infatti sufficienti a decretarlo,
per la prima volta, campione del
mondo.
|
Storia dei fornitori di gomme
1950/1959:
Al via del primo campionato del mondo di
Formula 1, nel 1950, sono quattro i fornitori di gomme che si
presentano complessivamente in pista: oltre alla nostra Pirelli,
gareggiano la belga Englebert, la britannica Dunlop e l'americana
Firestone: quest'ultima però, pur risultando nelle statistiche, si
presenta in una sola occasione all'anno, ovvero la 500 miglia di
Indianapolis che agli albori del mondiale concorre al campionato del
mondo piloti di Formula 1 e nella quale tutti i piloti utilizzano le
gomme americane.
I primi quattro campionati vedono la
situazione inalterata, con Pirelli che domina nel numero di vittorie (28
su 32 Gran Premi), Firestone che raccoglie la vittoria nella 500
miglia, Englebert che conquista 4 Gran Premi e Dunlop che resta a zero.
Nel 1954 si aggiungono, ai quattro già
presenti, altri due fornitori di gomme: la tedesca Continental e la
britannica Avon. È il record imbattuto con sei gommisti complessivi
durante la stessa stagione. Pirelli trova un avversario ostico nel
produttore tedesco: sono infatti quattro le vittorie che ottengono
entrambi i produttori, con la costante Firestone per quanto riguarda
Indianapolis. Un anno dopo, nel 1955, Avon è assente, Pirelli resta a
zero insieme a Dunlop, mentre Continental conquista 5 Gran Premi su 7.
Gli altri due vanno rispettivamente a Firestone ed Englebert. I belgi,
nel 1956, fanno incetta di vittorie anche grazie all'assenza di
Continental: 5 su 8 GP. Pirelli si riprende con due vittorie prima di
dominare la scena nel 1957, con 8 centri su 9 appuntamenti. Situazione
ribaltata nel '58: Dunlop, dopo otto stagioni senza successi, ottiene
sette vittorie su 11 Gran Premi. Anche in questa stagione si vedono
complessivamente in pista 6 produttori di pneumatici. Pirelli chiude la
sua prima esperienza in Formula 1 con zero successi di stagione ma 41
complessivi nei primi 76 Gran Premi della storia della Formula 1. Quello
italiano non è l'unico produttore a lasciare: nel 1959 non ci sono più
nemmeno Englebert (12 successi su 66 partecipazioni) e Continental (10
su 13). Restano al via Dunlop, che conquista 8 GP su 9, Firestone con la
sua sola Indianapolis e Avon, che lascia al termine del decennio con
zero vittorie su 29 Gran Premi disputati.
|
|
CURIOSITÀ DELL'ANNATA: LA
COOPER-CLIMAX DIVENTA LA PRIMA SQUADRA IN FORMULA 1 A VINCERE UN TITOLO MONDIALE
UTILIZZANDO UN MOTORE PRODOTTO DA ALTRI.
INOLTRE LA CASA BRITANNICA DIVENTA LA PRIMA
SQUADRA A VINCERE IL TITOLO COSTRUTTORI E ANCHE IL TITOLO PILOTI E COSTRUTTORI
NELLO STESSO ANNO STANDO IN TESTA NELLE CLASSIFICHE DALL'INIZIO ALLA FINE DEL
CAMPIONATO, ANCHE SE A PARI PUNTI CON LA WATSON NELLA CLASSIFICA COSTRUTTORI
DOPO LA SECONDA CORSA.
BRUCE MCLAREN OLTRE A DIVENTARE IL PRIMO
PILOTA NEOZELANDESE VINCITORE DI UN GRAN PREMIO, DIVENTA IL SECONDO PIÙ GIOVANE
VINCITORE ALL'ETÀ DI 22 ANNI E 104 GIORNI (MANCA IL RECORD SOLO PER UN MESE DI
DIFFERENZA) MA DIVENTA IL PIÙ GIOVANE PILOTA AD EFFETTUARE IL GPV, CHE GLI
RIESCE NEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA (TRA L'ALTRO ALLA PARI CON STIRLING MOSS
CHE AVEVA REALIZZATO LO STESSO TEMPO E GPV ASSEGNATO AD ENTRAMBI) ALL'ETÀ DI 21
ANNI E 322 GIORNI, OLTRE AD ESSERE UNO DEI PIÙ GIOVANI PILOTI A SALIRE SUL
PODIO (SEMPRE IN GRAN BRETAGNA) E A PRENDERE PUNTI (NELLA SUA PRIMA CORSA SU UNA
VETTURA DI FORMULA 1 A MONTECARLO). PROPRIO PER L'ESTREMA GIOVINEZZA GLI
ORGANIZZATORI DEL GRAN PREMIO D'OLANDA NON GLI PERMETTONO DI PARTECIPARE ALLA
LORO CORSA.
IL GRAN PREMIO DI GERMANIA VIENE DISPUTATO
SUL CIRCUITO DELL'AVUS, UN TRACCIATO COSTITUITO DA DUE RETTILINEI AUTOSTRADALI
COLLEGATI DA DUE CURVE PARABOLICHE. PER L'ELEVATA MEDIA CHE SI RAGGIUNGE SU UNA
PISTA COSÌ, SI DECIDE DI DIVIDERE LA CORSA IN DUE MANCHE IDENTICHE CON
CLASSIFICA PER SOMMA DI TEMPI. OLTRE ALLA POSIZIONE PARTICOLARE DELLA PISTA (SI
TROVA A BERLINO IN PIENA GUERRA FREDDA CON IL MURO CHE VERRÀ COSTRUITO DUE ANNI
DOPO) È LO SVOLGIMENTO DELLA CORSA CHE RESTERÀ UNICO: INFATTI È L'UNICA CORSA
DI FORMULA 1 DIVISA IN DUE MANCHE A PRIORI, CIOÈ UNA CORSA CON UNA INTERRUZIONE
GIÀ PREVISTA PRIMA CHE COMINCI LA GARA. A VINCERE ENTRAMBE LE MANCHE E QUINDI
LA GARA È BROOKS SU FERRARI, ANCHE SE SONO PRATICAMENTE TUTTE LE POSIZIONI,
DELLA PRIMA MANCHE, CHE SI RIPETONO IDENTICHE NELLA SECONDA.
IL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA NON VIENE
DISPUTATO DALLA FERRARI PER MOTIVI POLITICI. È QUESTA UNA DELLE PRIME ASSENZE
DELLA FERRARI A SCOPO POLITICO. ENZO FERRARI SI RENDEVA CONTO CHE LE SQUADRE
INGLESI COMINCIAVANO A PRENDERE SEMPRE PIÙ POTERE E CON LE SUE ARMI A
DISPOSIZIONE CERCAVA DI METTERE UN FRENO A QUESTA SITUAZIONE, COSA CHE NON
SEMPRE GLI RIUSCÌ.
PROPRIO NELL'ULTIMA CORSA, SBARCA IN
FORMULA 1, RODGER WARD CON UNA KURTIS A MOTORE OFFENHAUSER. NONOSTANTE IL PILOTA
AMERICANO SIA ARRIVATO CON UNA VETTURA ED UN MOTORE DELLA SERIE AMERICANA NON
RIESCE AD OTTENERE NULLA, QUALIFICANDOSI ULTIMO AD OLTRE 40 SECONDI DAL PRIMO E
RITIRANDOSI NELLE PRIME FASI.
SI VERIFICA UN FATTO CURIOSO: NEL 1954
REGINALD PARNELL AVEVA DISPUTATO LA SUA ULTIMA CORSA, CON UNA FERRARI-FERRARI, E
QUI NEL 1959, SEMPRE IN GRAN BRETAGNA DEBUTTA SUO FIGLIO TIM PARNELL, CON UNA
COOPER-CLIMAX. PER POCO NON RIUSCIRONO AD ESSERE I PRIMI PADRE E FIGLIO A
CORRERE NELLA STESSA GARA, E COMUNQUE TIM PARNELL DIVENTA IL PRIMO PILOTA FIGLIO
D'ARTE CHE CORRE IN FORMULA 1. |
|
|
Campionato
Mondiale
Piloti
|
 |
Campionato
Mondiale
Costruttori
|
|
1950
|
Giuseppe Farina
|

|

|
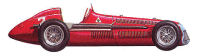
Alfa Romeo 158
|
|
Campionato Mondiale
Costruttori dal 1958 |
|
1951
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|
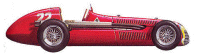
Alfa Romeo 159
|
|
|
|
1952
|
Alberto Ascari
|

|

|
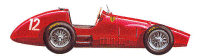
Ferrari 500 F2
|
|
|
|
1953
|
Alberto Ascari
|

|

|
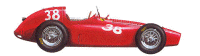
Ferrari 553 F2
|
|
|
|
1954
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|

Mercedes-Benz W 196
|
|
|
|
1955
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|

Mercedes-Benz W 196
|
|
|
|
1956
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|

Ferrari D 50
|
|
|
|
1957
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|
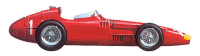
Maserati 250 F
|
|
|
|
1958
|
Mike Hawthorn
|

|

|
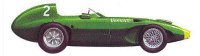
Vanwall
|
|
Vanwall
VW5 |
|
1959
|
Jack Brabham
|

|

|

Cooper-Climax
|
|
Cooper
Climax
T43 |
|
|
|
PERSONAGGI MITO
 |
 |
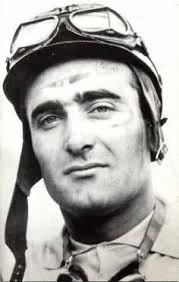 |
 |
| Ascari |
Fangio |
Castellotti |
Moss |
|
The History Of The Grand Prix Car
VIDEO
Accadeva nell'anno...
|
- 1950 -
NOVEMBRE
Il presidente degli Statui Uniti, Harry Truman, sopravvive
miracolosamente ad un attentato
|
 - 1951 - - 1951 -
LUGLIO
La più grave inondazione della storia degli Stati Uniti
provoca più di quaranta morti
e lascia duecento mila persone
senza tetto nel Kansas e nel Missuri
OTTOBRE
Viene presentato il primo sistema di servosterzo sulle berline
decappottabili Chrysler Crown Imperial
|
 - 1952 - - 1952 -
FEBBRAIO
Muore il Re d'inghilterra Giorgio VI dopo una lunga malattia
LUGLIO
Muore Eva Peron, moglie del dittatore argentino, Juan Peron
SETTEMBRE - 1952
Si producono negli Stati Uniti le prime cinture di sicurezza per le
automobili
|
 - 1953 - - 1953 -
GENNAIO
Le coste dell'Olanda e della Gran Bretagna sono flagellate da
inondazioni
che causano la morte di 2000 persone
MARZO
Esce la prima penna a sfera economica usa e getta, si chiama Bic,
dal nome del suo inventore
GIUGNO
Nelle elezioni del 7 giugno in Italia la coalizione centrista perde
la maggioranza assoluta
|
- 1954 -
MAGGIO
Roger Bannister infrange la barriera dei quttro minuti nella prova di
un miglio
LUGLIO
Il primo Boeing 707 compie il suo volo inaugurale da Seattle
Dopo quattordici anni finisce il razionamento del cibo in Gran Bretagna
|
 - 1955 - - 1955 -
APRILE
Muore lo scienziato Albert Einstein
GIUGNO
Ottantacinque spettatori e un pilota muoino per l'incidente di una
Mercedes Benz
nella 24 ore di Le-Mans
Si disputa per la prima volta la Coppa dei Campioni di Calcio
per squadre di club
|
- 1956 -
GIUGNO
L'attrice Marilyn Monroe sposa il commediografo Arthur Miller
NOVEMBRE
Viene rieletto nuovamente presidente degli Stati Uniti: Eisenhower
|
- 1957 -
GENNAIO
Muore l'attore americano Humphrey Bogart
OTTOBRE
L'Unione Sovietica lancia il satellite <Sputnik>
|
|
- 1958 -
FEBBRAIO
Otto giocatori del Manchester Utd. muoiono in un incidente aereo
AGOSTO
Nascono i cantanti americani Michael Jakson e Madonna
Un fabbricante danese di giocattoli lancia il gioco di costruzioni Lego
|
- 1959 -
FEBBRAIO
Il cantante americano Buddy Holly muore in un incidente aereo
MAGGIO
Iniziano i lavori per la galleria che congiungerà l'Italia e
Francia
attraverso
il Monte Bianco
LUGLIO
Un Overcraft compie, per la prima volta la traversata della Manica
|

|
Sito-Blog personale - Riproduzione vietata
|
|
|
|
|
 |

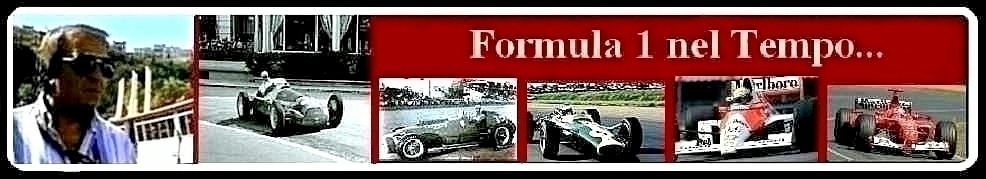









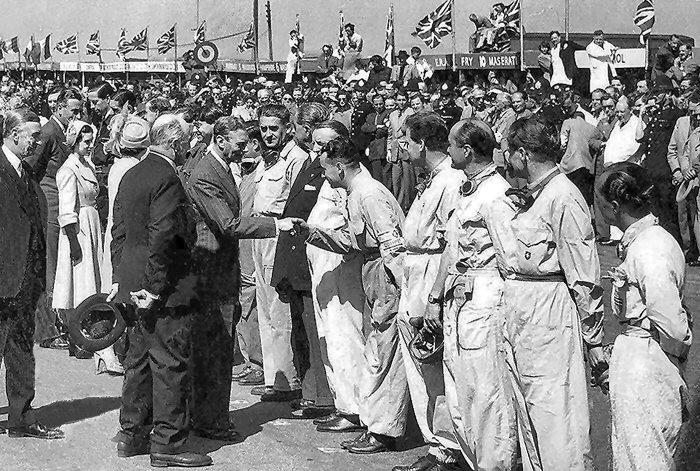
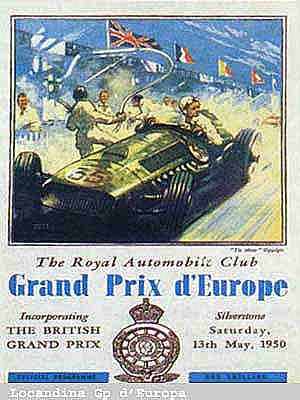






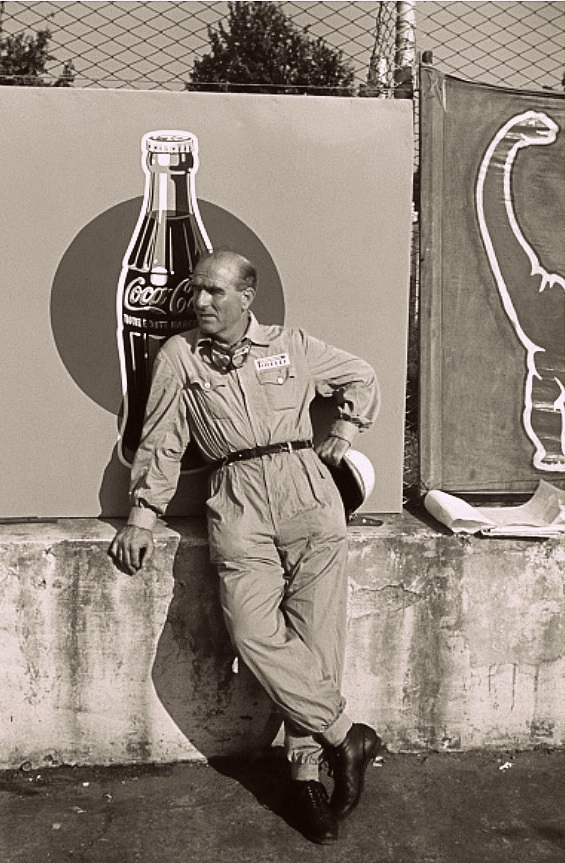

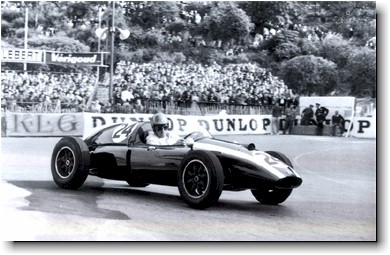
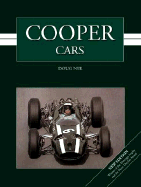


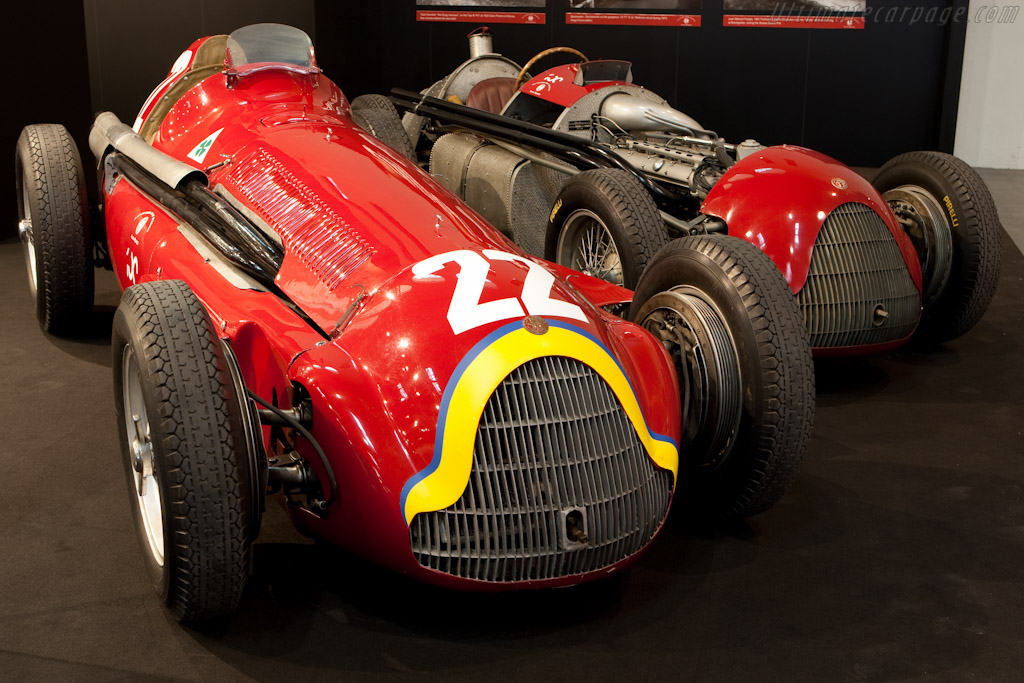
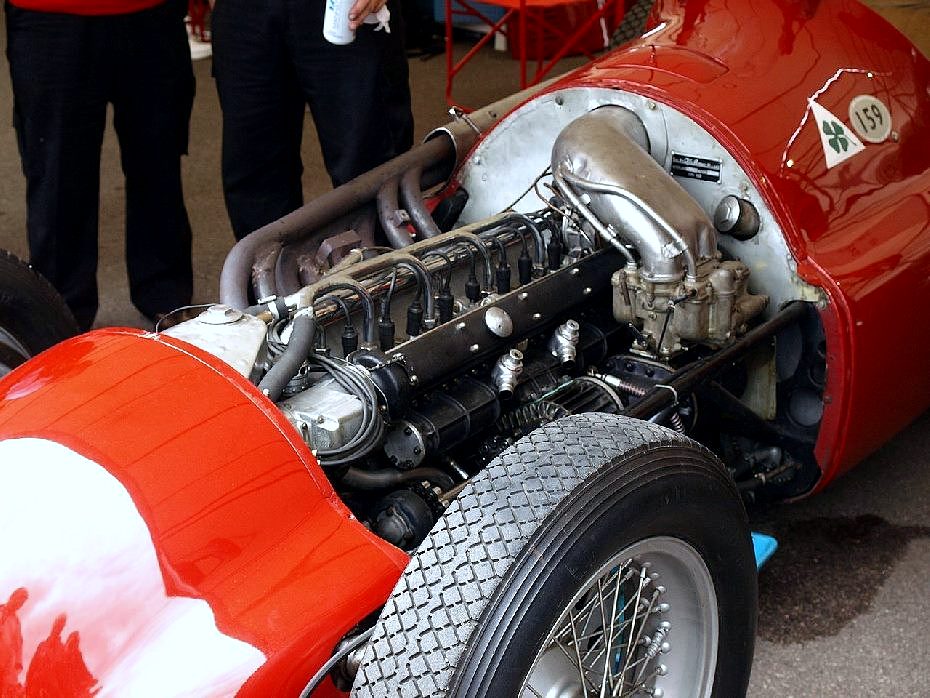
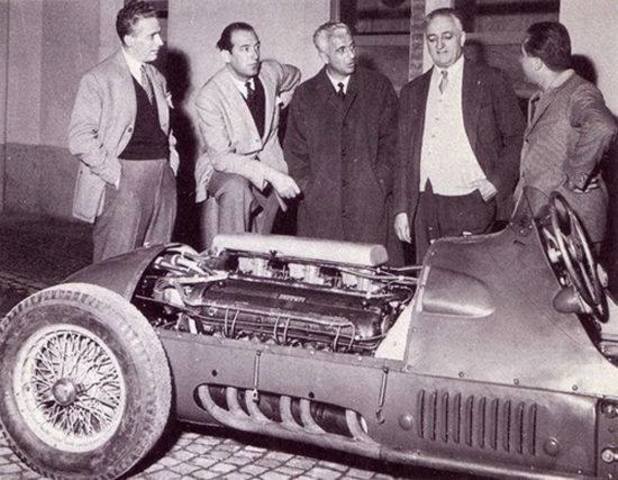










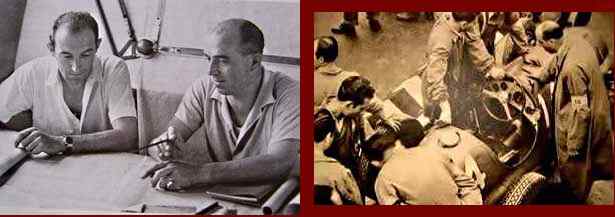
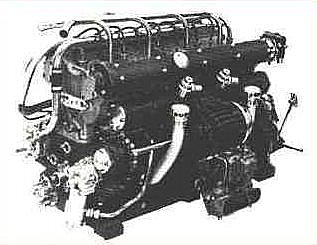

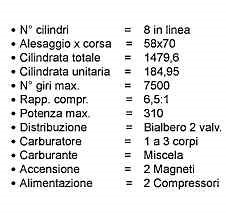
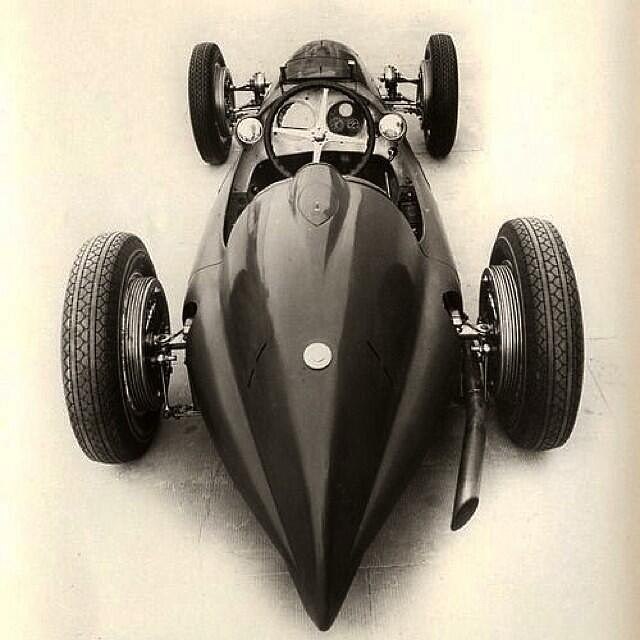
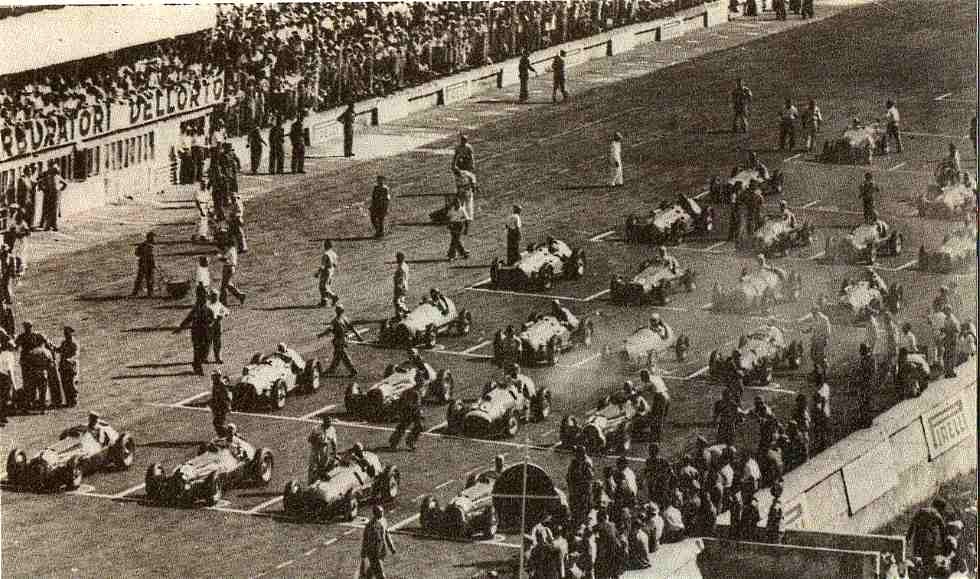

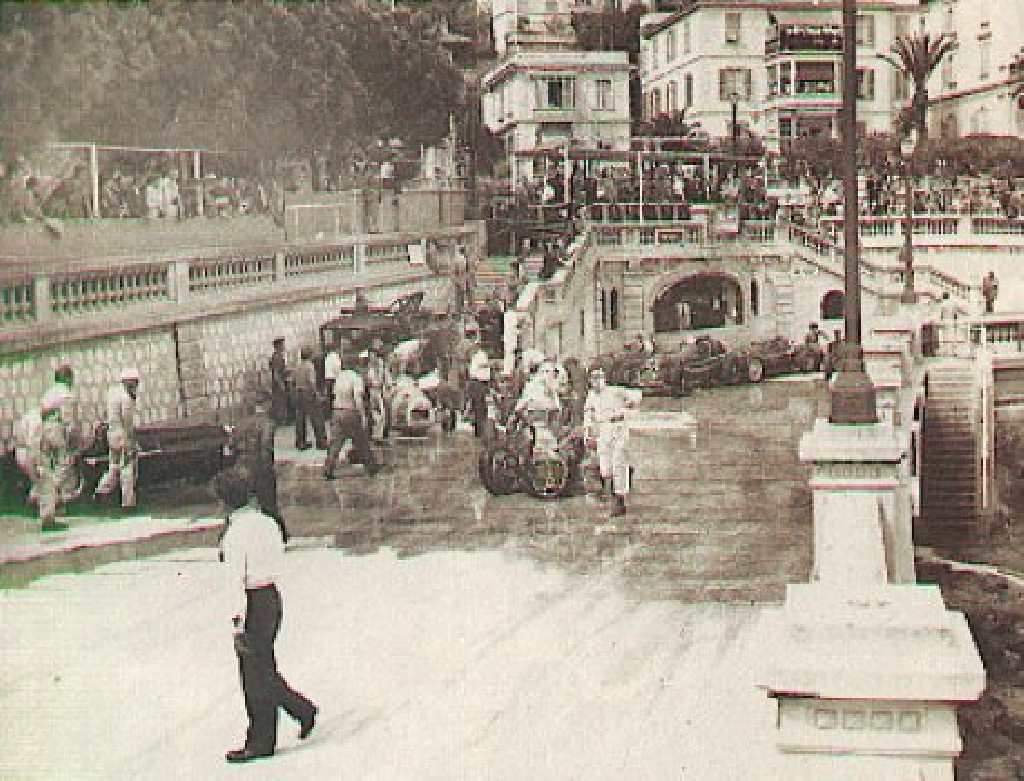




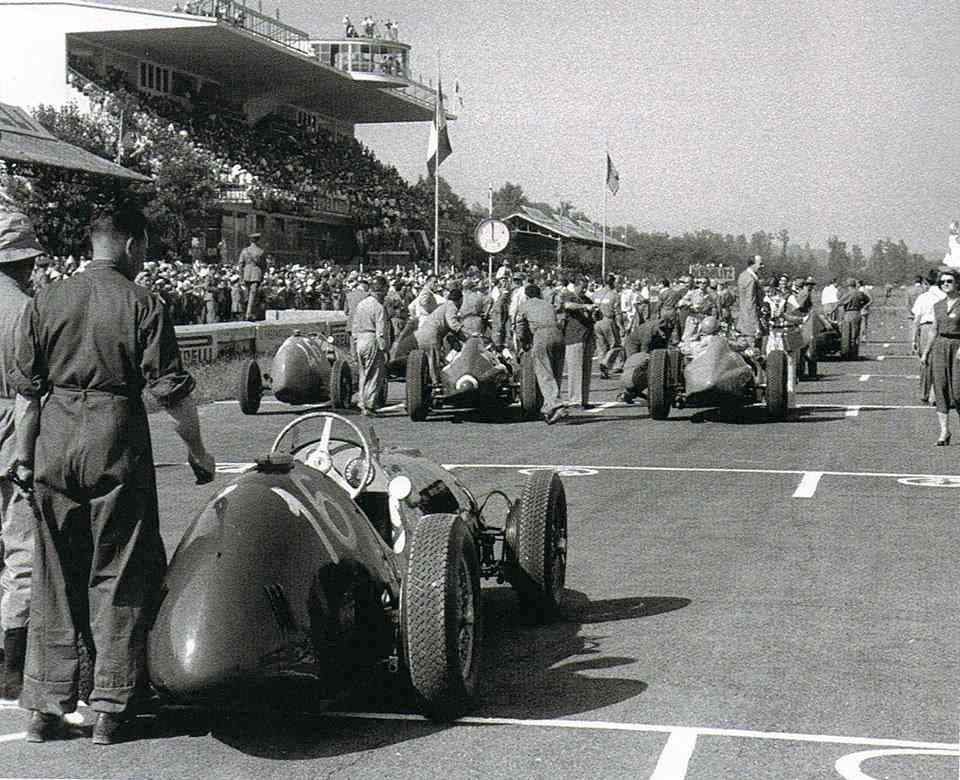
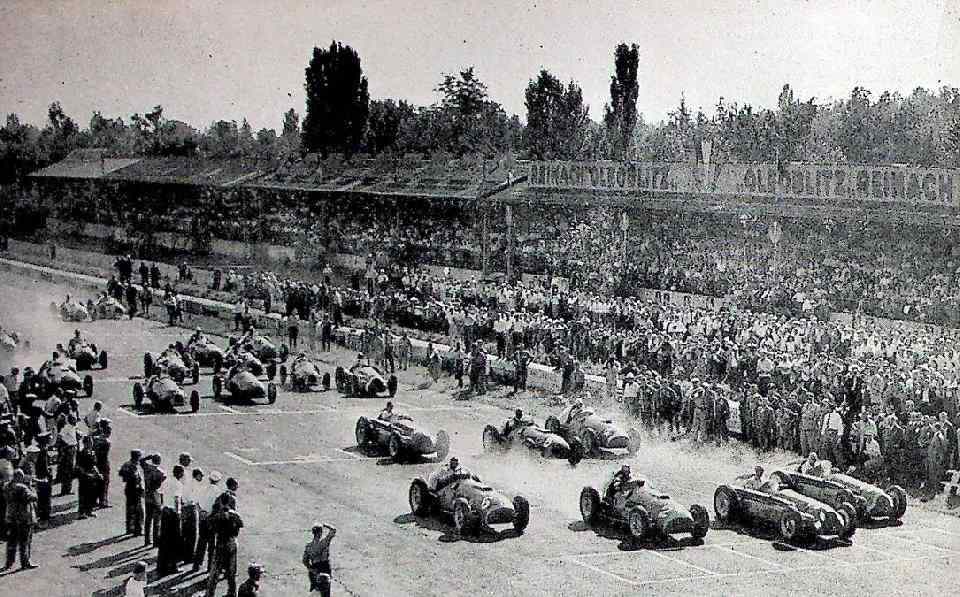
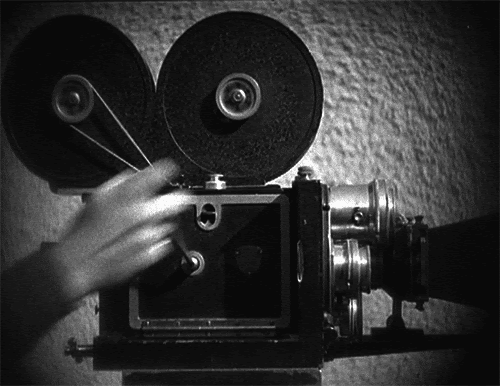

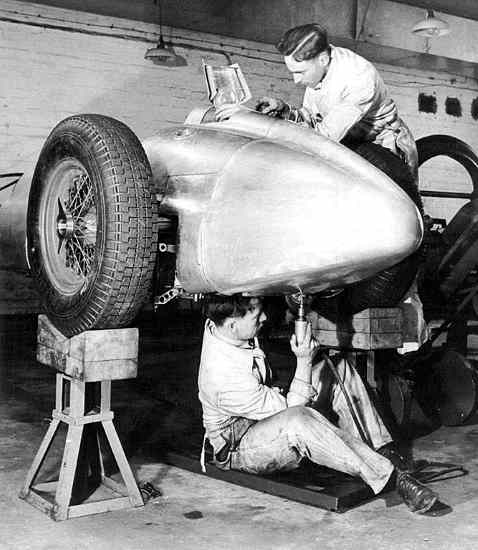


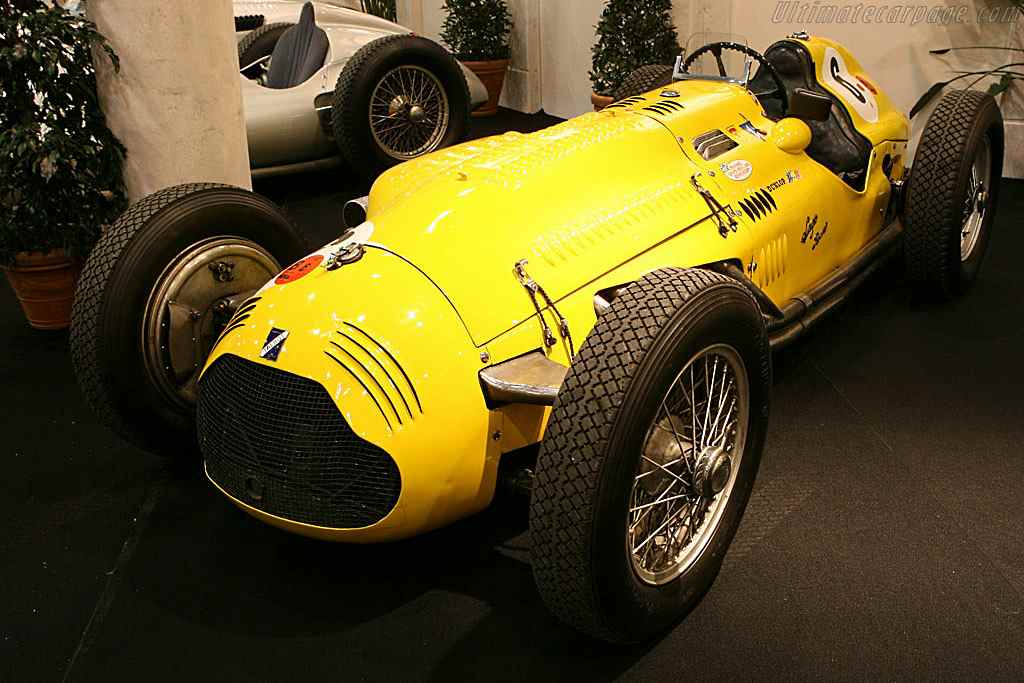


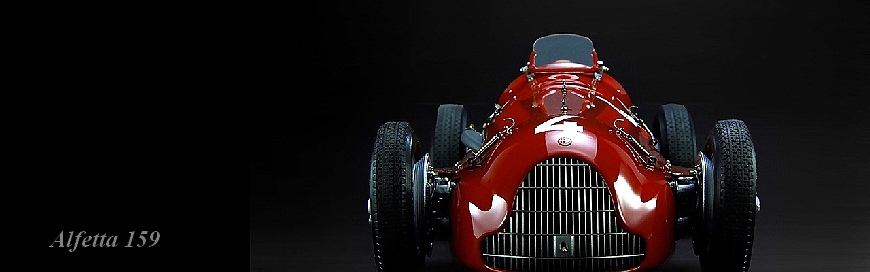


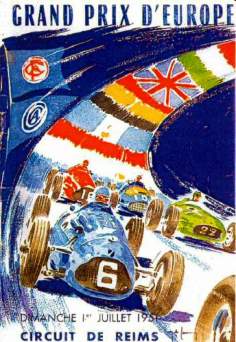




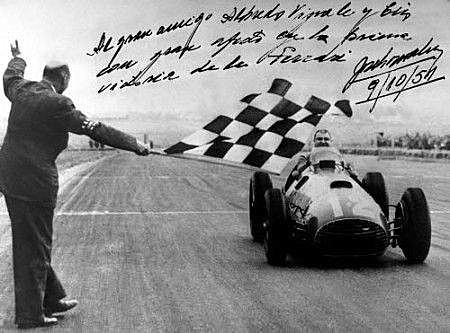
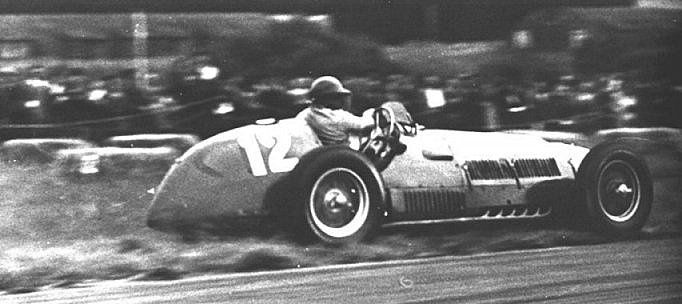

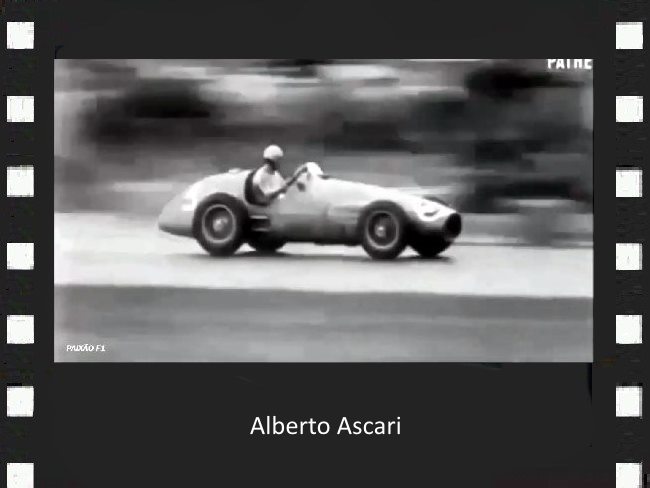















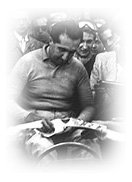 u
relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra
Piero Taruffi, e tentò l'avventura
nella 500 miglia di Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non
fu un grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si qualificò al
diciannovesimo posto, mentre in gara si ritirò dopo 40 giri. Comunque Ascari si
rifece ampiamente dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo
cinque pole position e cinque giri più veloci in gara.
u
relativamente semplice. Saltò il primo Gran Premio della stagione, quello di Svizzera, vinto dal compagno di squadra
Piero Taruffi, e tentò l'avventura
nella 500 miglia di Indianapolis, allora valida per il campionato del mondo. Non
fu un grande successo per il pilota milanese, anzi: in prova si qualificò al
diciannovesimo posto, mentre in gara si ritirò dopo 40 giri. Comunque Ascari si
rifece ampiamente dominando le rimanenti sei corse della stagione, stabilendo
cinque pole position e cinque giri più veloci in gara.



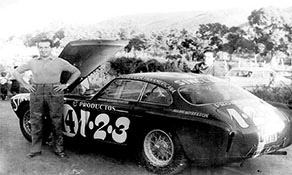








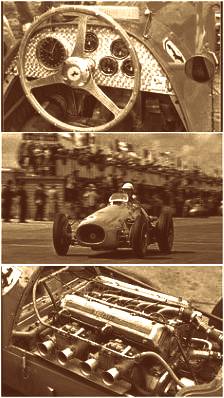
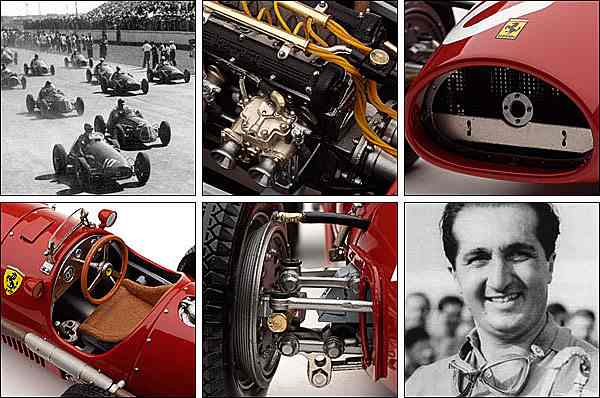
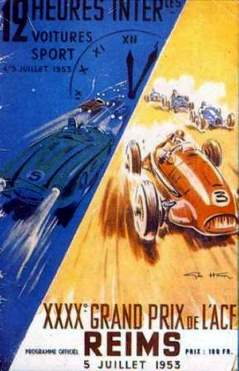

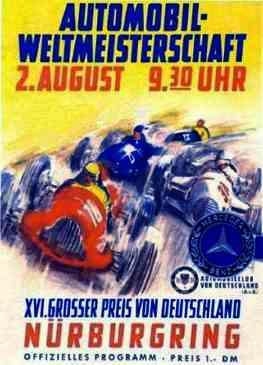


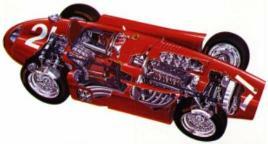

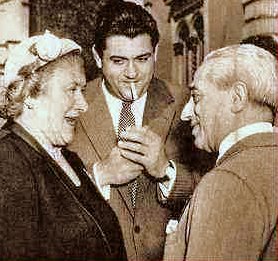


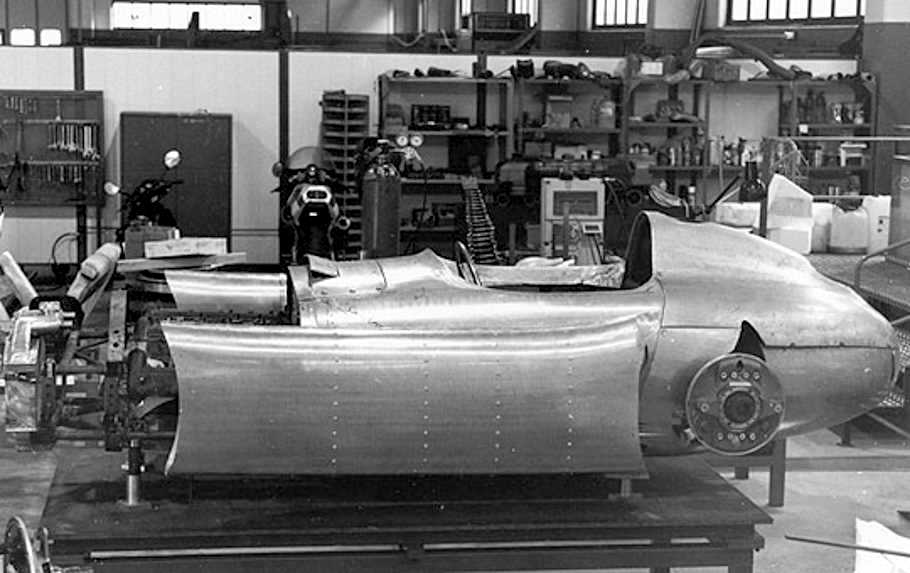






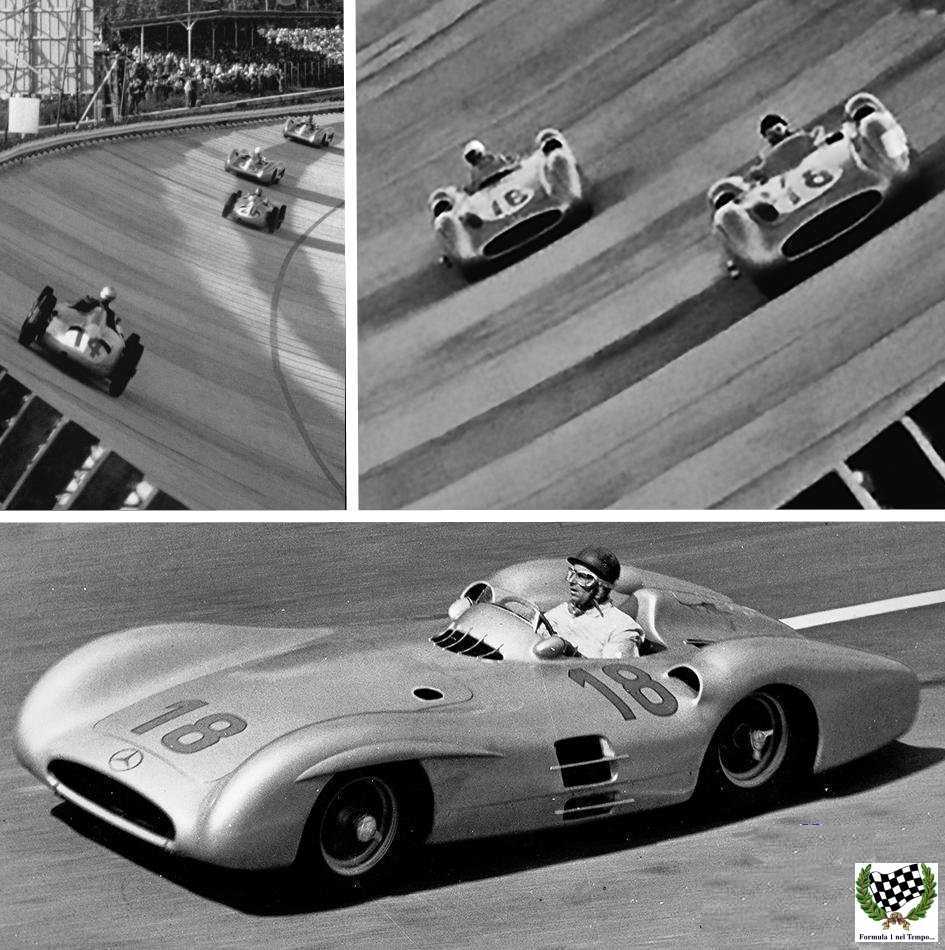
 Rimessasi
in sesto dopo la fine della guerra, la Mercedes inizia a pianificare il
proprio ritorno sui circuiti. Neubauer si impegna molto nella ricerca
di macchine da corsa ancora funzionanti fra quelle rimaste nascoste
durante la guerra. I risultati ottenuti dalla Mercedes nel tentativo di
modificare queste vetture sono però piuttosto incerti. Di qui la
necessità di costruirne di nuove. Il modo più economico per farlo sembra
essere quello di convertire un'auto da granturismo in veicolo da
competizione e la macchina prescelta, realizzata con materiali di
recupero, è la 300 SL. Una delle sue caratteristiche più peculiari sono
le portiere. Il telaio tubolare dell'auto rende impossibile l'uso di
portiere tradizionali e, dopo attenti studi, viene adottato un si
Rimessasi
in sesto dopo la fine della guerra, la Mercedes inizia a pianificare il
proprio ritorno sui circuiti. Neubauer si impegna molto nella ricerca
di macchine da corsa ancora funzionanti fra quelle rimaste nascoste
durante la guerra. I risultati ottenuti dalla Mercedes nel tentativo di
modificare queste vetture sono però piuttosto incerti. Di qui la
necessità di costruirne di nuove. Il modo più economico per farlo sembra
essere quello di convertire un'auto da granturismo in veicolo da
competizione e la macchina prescelta, realizzata con materiali di
recupero, è la 300 SL. Una delle sue caratteristiche più peculiari sono
le portiere. Il telaio tubolare dell'auto rende impossibile l'uso di
portiere tradizionali e, dopo attenti studi, viene adottato un si stema
di apertura verticale. Non appena le prime foto del nuovo modello
vengono pubblicate negli Stati Uniti i commentatori fanno notare che con
le portiere aperte l'auto ricorda un gabbiano, tanto da essere
battezzata "Gullwing" (ali di gabbiano).
Il debutto di queste nuove auto è la Mille Miglia. La Mercedes si
presenta con tre monoposto guidate da Kling, Lang e Caracciola. Kling,
il pilota di punta della Mercedes, finisce secondo. Caracciola, non del
tutto ristabilito dai postumi di un incidente a Indianapolis cinque anni
prima, si piazza eroicamente quarto, dopodiché guiderà un'ultima volta
prima di ritirarsi definitivamente dalle corse.
Caracciola, il pilota più famoso della Mercedes che Neubauer considera
il più grande di sempre, continuerà a lavorare per la Daimler-Benz fino
al 1959, anno della sua morte.
La gara successiva è il Gran Premio di Berna, una gara accessoria al
Gran Premio di Svizzera vero e proprio. Conquistando tutti i gradini del
podio, la Mercedes si prepara più agguerrita che mai alla 24 ore di Le
Mans.
Per l'occasione la Jaguar e la Ferrari presentano nuovi modelli da corsa
e la Mercedes risponde, com'è nel suo stile, con l'introduzione del
tettuccio frenante. Secondo la rivista specializzata Road & Track il
pilota si lancia con l'auto a tutta velocità, poi innesca il
dispositivo del tettuccio frenante che "scatta nel vento con un uop!"
facendo rallentare il bolide "come se la mano di un gigante l'afferrasse
d'improvviso" dai 240 ai 120 km/h, in pochissimi secondi. Il congegno
viene severamente testato ma non utilizzato in gara per motivi di
sicurezza.
La trovata del tettuccio frenante in verità ha il solo scopo di
vivacizzare la
vigilia della competizione e di disorientare la concorrenza. La gara ha
inizio
con le Mercedes particolarmente prudenti. Le Jaguar sono le prime a
dover
gettare la spugna. Nella seconda ora di gara tutte e tre le vetture
della
scuderia inglese sono fermate da problemi di surriscaldamento dei
motori.
stema
di apertura verticale. Non appena le prime foto del nuovo modello
vengono pubblicate negli Stati Uniti i commentatori fanno notare che con
le portiere aperte l'auto ricorda un gabbiano, tanto da essere
battezzata "Gullwing" (ali di gabbiano).
Il debutto di queste nuove auto è la Mille Miglia. La Mercedes si
presenta con tre monoposto guidate da Kling, Lang e Caracciola. Kling,
il pilota di punta della Mercedes, finisce secondo. Caracciola, non del
tutto ristabilito dai postumi di un incidente a Indianapolis cinque anni
prima, si piazza eroicamente quarto, dopodiché guiderà un'ultima volta
prima di ritirarsi definitivamente dalle corse.
Caracciola, il pilota più famoso della Mercedes che Neubauer considera
il più grande di sempre, continuerà a lavorare per la Daimler-Benz fino
al 1959, anno della sua morte.
La gara successiva è il Gran Premio di Berna, una gara accessoria al
Gran Premio di Svizzera vero e proprio. Conquistando tutti i gradini del
podio, la Mercedes si prepara più agguerrita che mai alla 24 ore di Le
Mans.
Per l'occasione la Jaguar e la Ferrari presentano nuovi modelli da corsa
e la Mercedes risponde, com'è nel suo stile, con l'introduzione del
tettuccio frenante. Secondo la rivista specializzata Road & Track il
pilota si lancia con l'auto a tutta velocità, poi innesca il
dispositivo del tettuccio frenante che "scatta nel vento con un uop!"
facendo rallentare il bolide "come se la mano di un gigante l'afferrasse
d'improvviso" dai 240 ai 120 km/h, in pochissimi secondi. Il congegno
viene severamente testato ma non utilizzato in gara per motivi di
sicurezza.
La trovata del tettuccio frenante in verità ha il solo scopo di
vivacizzare la
vigilia della competizione e di disorientare la concorrenza. La gara ha
inizio
con le Mercedes particolarmente prudenti. Le Jaguar sono le prime a
dover
gettare la spugna. Nella seconda ora di gara tutte e tre le vetture
della
scuderia inglese sono fermate da problemi di surriscaldamento dei
motori.
 Anche
le vetture della Ferrari sono vittime di guasti meccanici vari. Così, del tutto
a sorpresa, si trova solo in testa Pierre Levegh, alla guida della sua Talbot.
Lo seguono due Mercedes che, nonostante il distacco di tre giri completi di
pista, non aumentano la velocità, mantenendosi sui 160 km/h. In breve, il
vantaggio di Levegh sale a 4 giri, ma le Mercedes insistono nel mantenere il
loro ritmo tranquillo. Neubauer non crede che Levegh possa portare a termine la
gara, sapendo che sta gareggiando senza squadra. A solo un'ora e 15 minuti dalla
fine Levegh sbaglia una marcia, rompe una biella ed è costretto al ritiro.
Neubauer aveva visto giusto e le Mercedes possono concludere in scioltezza al
primo e al secondo posto. Per quanto grandi siano queste auto, le 300SL sono
state impiegate solo come ripiego, in attesa di una vettura da Gran Premio vera
e propria. Le nuove norme applicate in Formula 1 nel 1954 determinano la
presentazione di molti nuovi modelli. Un modello di particolare interesse è la
Lancia D50, progettata dal rinomato ingegnere italiano Vittorio Jano. Il suo
motore offset V8 è parte integrante del telaio. La D50 è dotata di serbatoi
laterali esterni per mantenere la distribuzione del peso il più possibile
costante con il variare del carico di carburante. Il 1954 è anche l'anno che
vede l'annunciato ritorno di un modello Mercedes da Gran Premio. Le regole
attuali non obbligano all'uso di ruote scoperte e la W196, con le sue ruote
incluse nella sagoma della carrozzeria e linee affusolate, assomiglia molto ad
una vettura da Granturismo.
Anche
le vetture della Ferrari sono vittime di guasti meccanici vari. Così, del tutto
a sorpresa, si trova solo in testa Pierre Levegh, alla guida della sua Talbot.
Lo seguono due Mercedes che, nonostante il distacco di tre giri completi di
pista, non aumentano la velocità, mantenendosi sui 160 km/h. In breve, il
vantaggio di Levegh sale a 4 giri, ma le Mercedes insistono nel mantenere il
loro ritmo tranquillo. Neubauer non crede che Levegh possa portare a termine la
gara, sapendo che sta gareggiando senza squadra. A solo un'ora e 15 minuti dalla
fine Levegh sbaglia una marcia, rompe una biella ed è costretto al ritiro.
Neubauer aveva visto giusto e le Mercedes possono concludere in scioltezza al
primo e al secondo posto. Per quanto grandi siano queste auto, le 300SL sono
state impiegate solo come ripiego, in attesa di una vettura da Gran Premio vera
e propria. Le nuove norme applicate in Formula 1 nel 1954 determinano la
presentazione di molti nuovi modelli. Un modello di particolare interesse è la
Lancia D50, progettata dal rinomato ingegnere italiano Vittorio Jano. Il suo
motore offset V8 è parte integrante del telaio. La D50 è dotata di serbatoi
laterali esterni per mantenere la distribuzione del peso il più possibile
costante con il variare del carico di carburante. Il 1954 è anche l'anno che
vede l'annunciato ritorno di un modello Mercedes da Gran Premio. Le regole
attuali non obbligano all'uso di ruote scoperte e la W196, con le sue ruote
incluse nella sagoma della carrozzeria e linee affusolate, assomiglia molto ad
una vettura da Granturismo. La W196 monta un motore a 8 cilindri inclinato di 25° rispetto la verticale,
ingegnoso espediente che consente ai progettisti di disegnare una carrozzeria
più affusolata e di abbassare il baricentro del mezzo. Il motore può inoltre
contare sui vantaggi dell'iniezione diretta e della valvola desmodromica. Le
Mercedes non sono pronte prima della terza gara della stagione, il Gran Premio
di Francia. La squadra è composta da Fangio, Karl Kling e Hans Herman. I loro
concorrenti più quotati sono Alberto Ascari, della scuderia Lancia ma
temporaneamente su una Maserati, Gonzalez su Ferrari e Moss alla guida di una
Maserati privata. Fangio e Kling si lanciano in testa alla corsa mentre l'auto
di Herman in quarta posizione accusa diversi problemi al motore. Gonzalez tenta
una rimonta ma i bolidi tedeschi sono assolutamente superiori e finiscono la
corsa con un convincente primo e secondo posto. Fangio, con le due vittorie
sulla Maserati presa in prestito a inizio stagione, è sul punto di diventare per
la seconda volta Campione del Mondo.
La W196 monta un motore a 8 cilindri inclinato di 25° rispetto la verticale,
ingegnoso espediente che consente ai progettisti di disegnare una carrozzeria
più affusolata e di abbassare il baricentro del mezzo. Il motore può inoltre
contare sui vantaggi dell'iniezione diretta e della valvola desmodromica. Le
Mercedes non sono pronte prima della terza gara della stagione, il Gran Premio
di Francia. La squadra è composta da Fangio, Karl Kling e Hans Herman. I loro
concorrenti più quotati sono Alberto Ascari, della scuderia Lancia ma
temporaneamente su una Maserati, Gonzalez su Ferrari e Moss alla guida di una
Maserati privata. Fangio e Kling si lanciano in testa alla corsa mentre l'auto
di Herman in quarta posizione accusa diversi problemi al motore. Gonzalez tenta
una rimonta ma i bolidi tedeschi sono assolutamente superiori e finiscono la
corsa con un convincente primo e secondo posto. Fangio, con le due vittorie
sulla Maserati presa in prestito a inizio stagione, è sul punto di diventare per
la seconda volta Campione del Mondo.





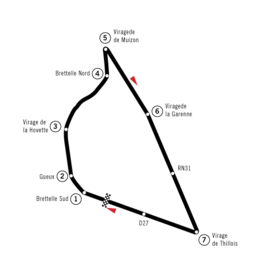
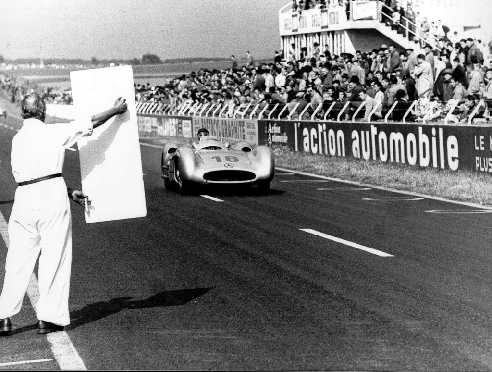
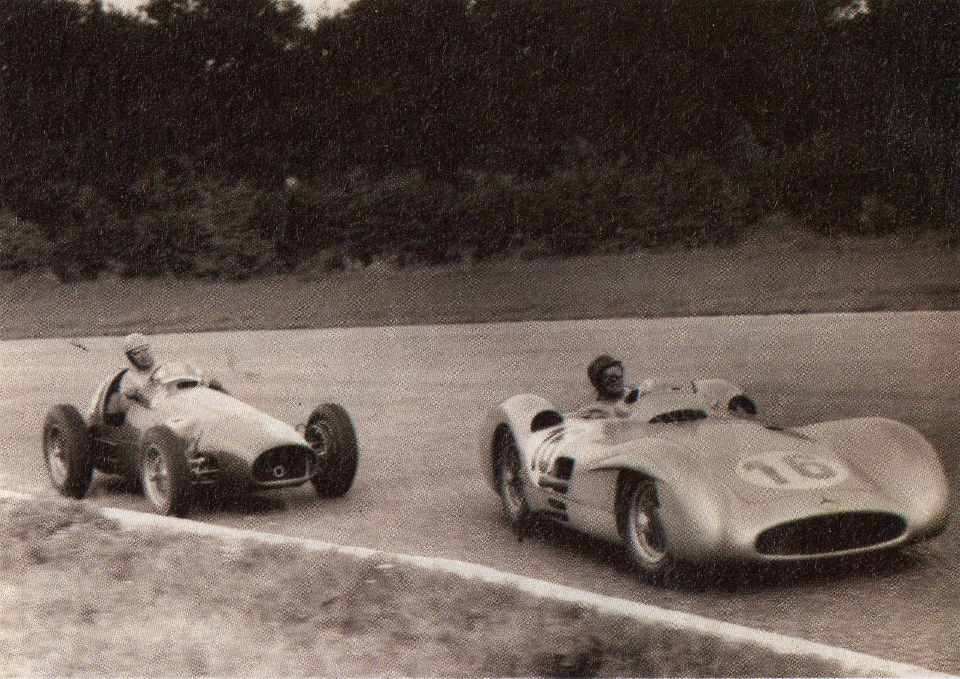

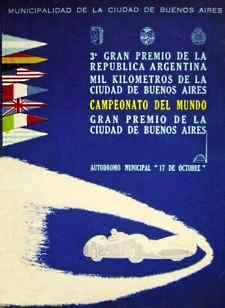
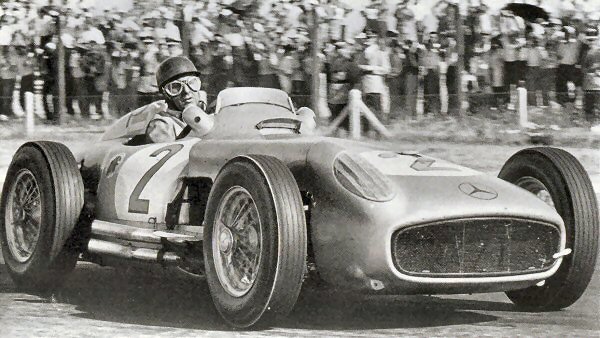

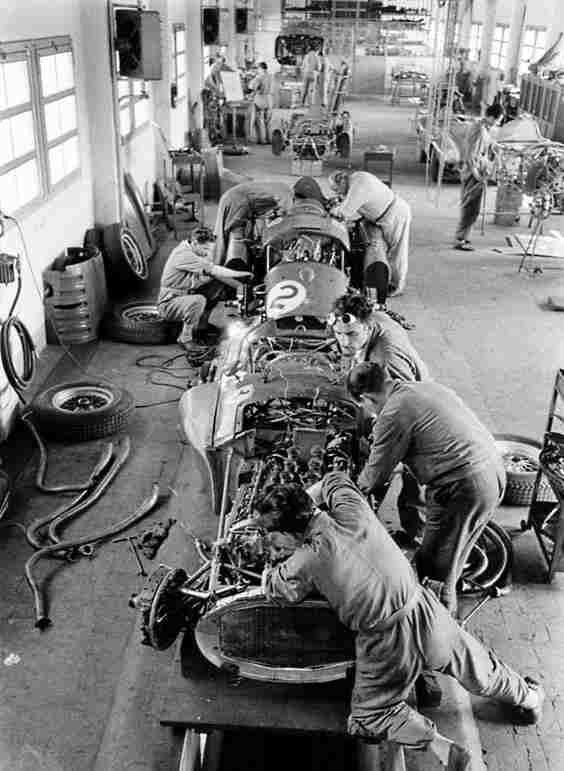

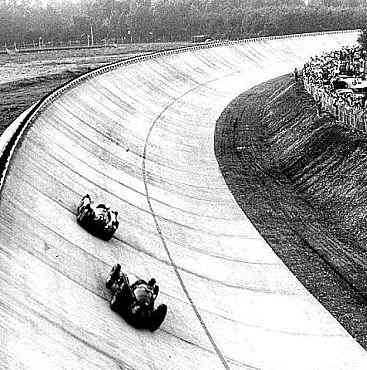






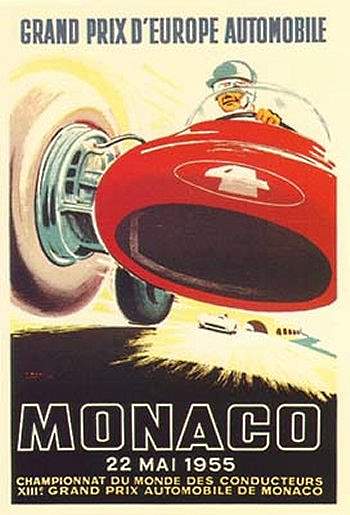

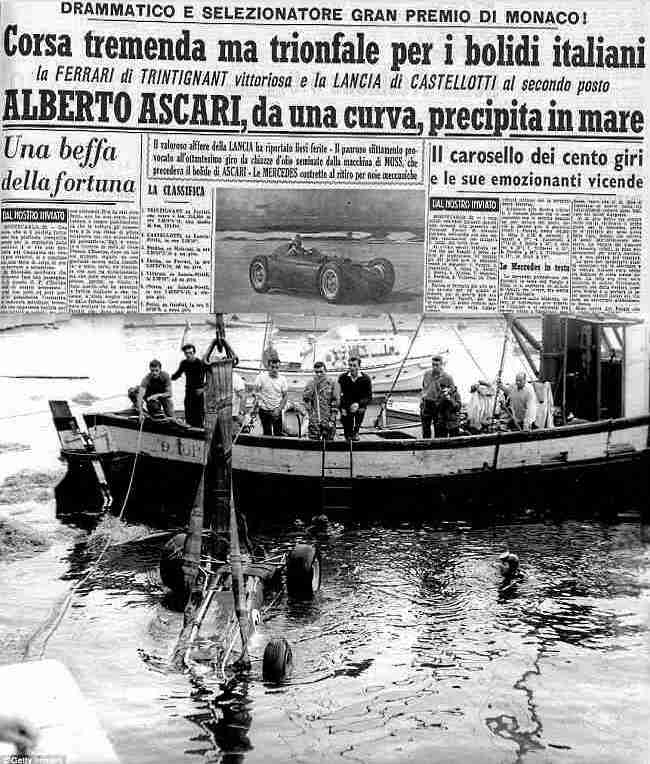
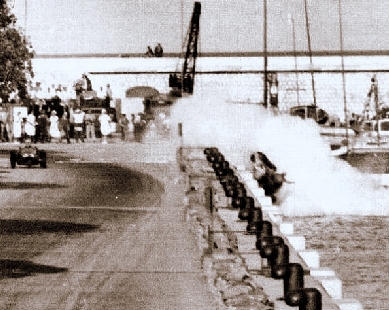
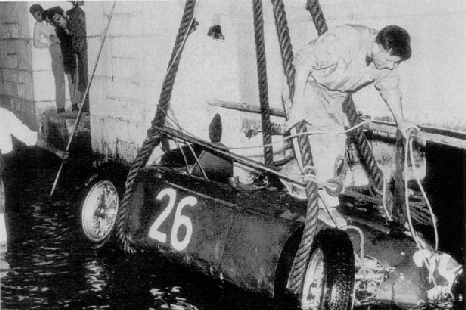






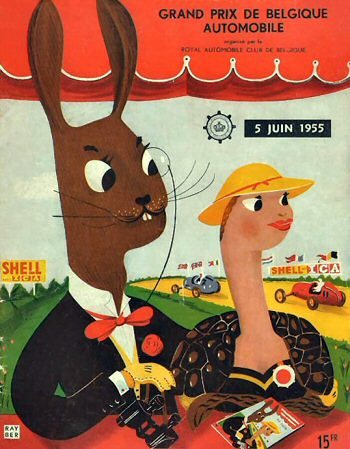













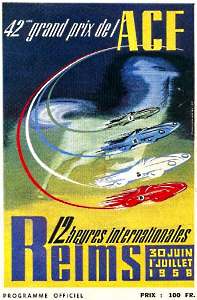






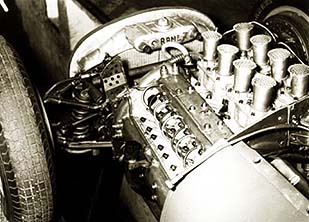





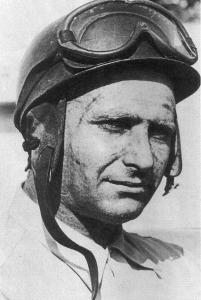


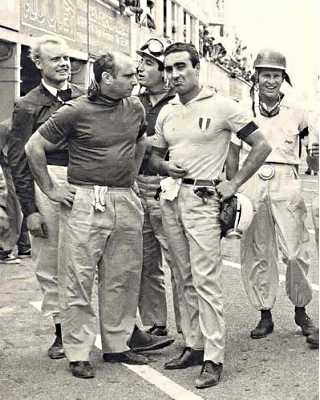
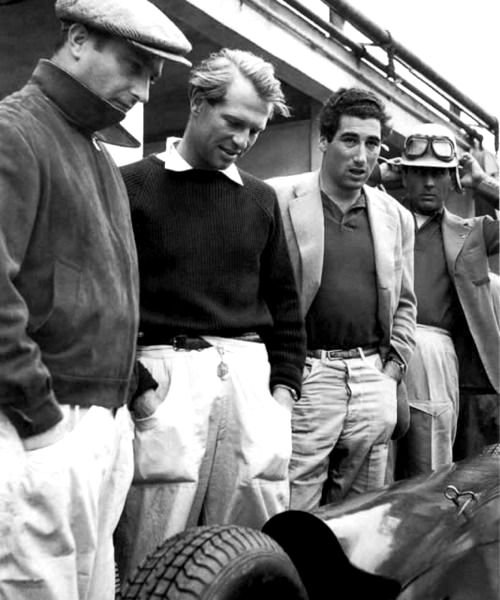 Accadde una volta e poi mai più: Ferrari, era il 1956, decise di
rinunciare al suo campione, Fangio, per puntare tutto sui giovani
talenti che scalpitavano alle sue spalle. Ma quella “Primavera” divenne
di colpo… un freddo inverno!
Accadde una volta e poi mai più: Ferrari, era il 1956, decise di
rinunciare al suo campione, Fangio, per puntare tutto sui giovani
talenti che scalpitavano alle sue spalle. Ma quella “Primavera” divenne
di colpo… un freddo inverno!


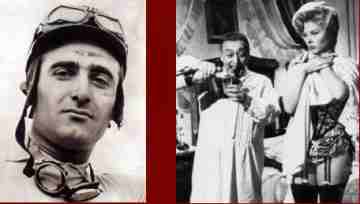

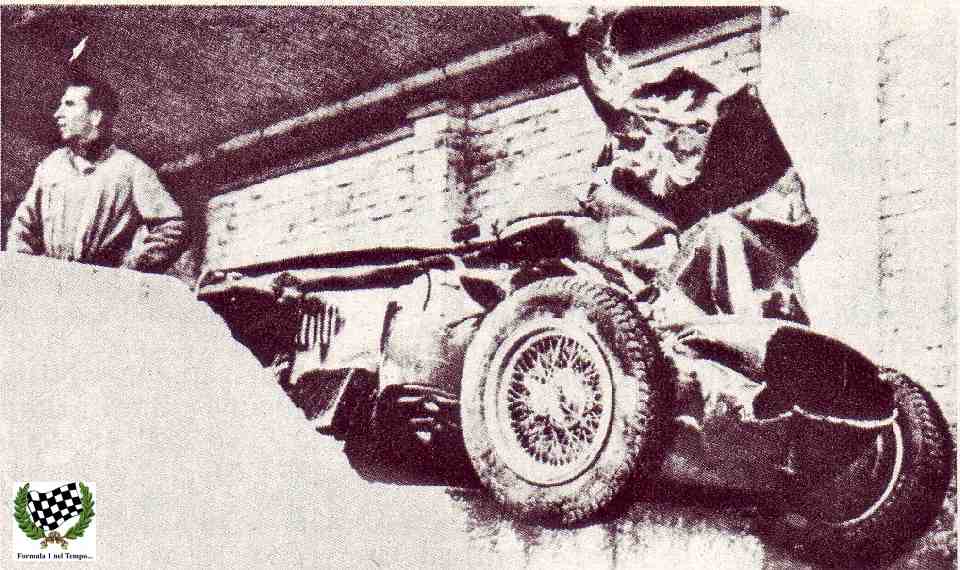





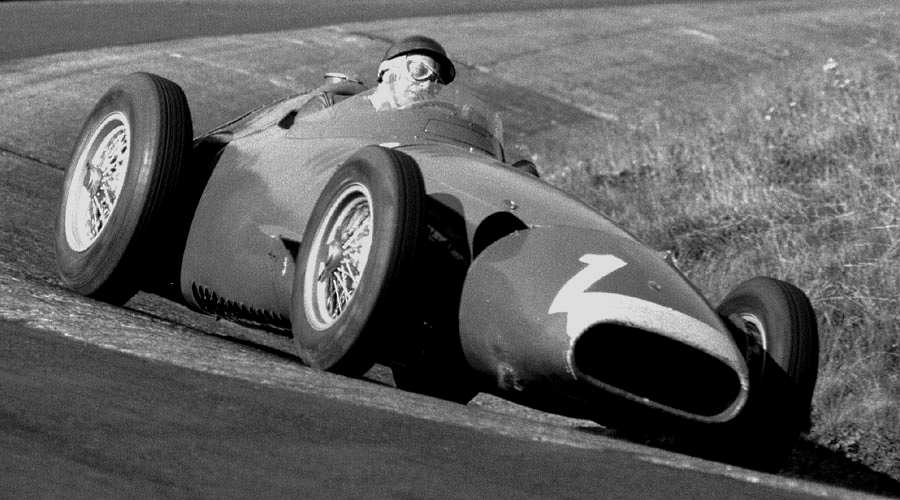



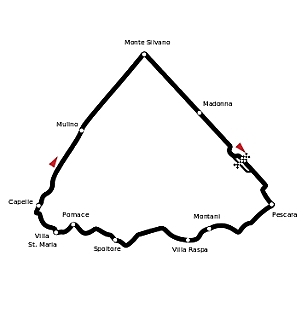
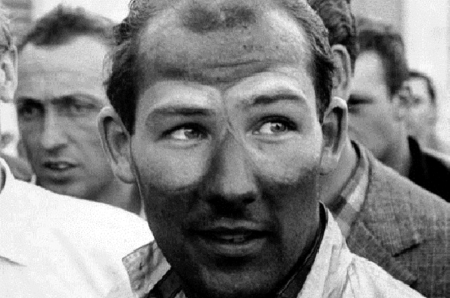

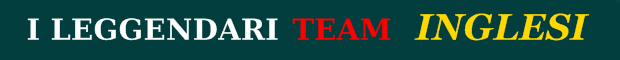
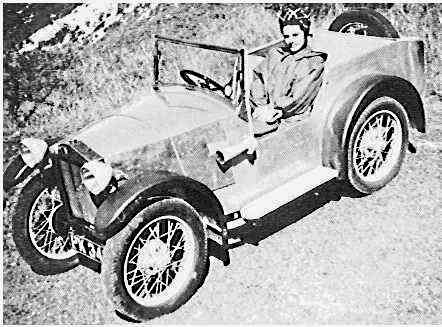





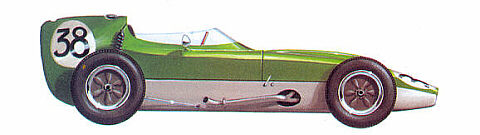












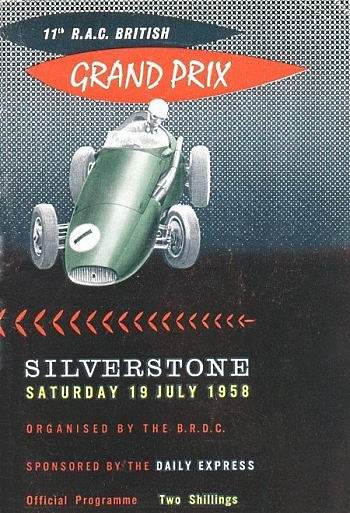

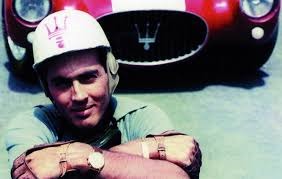




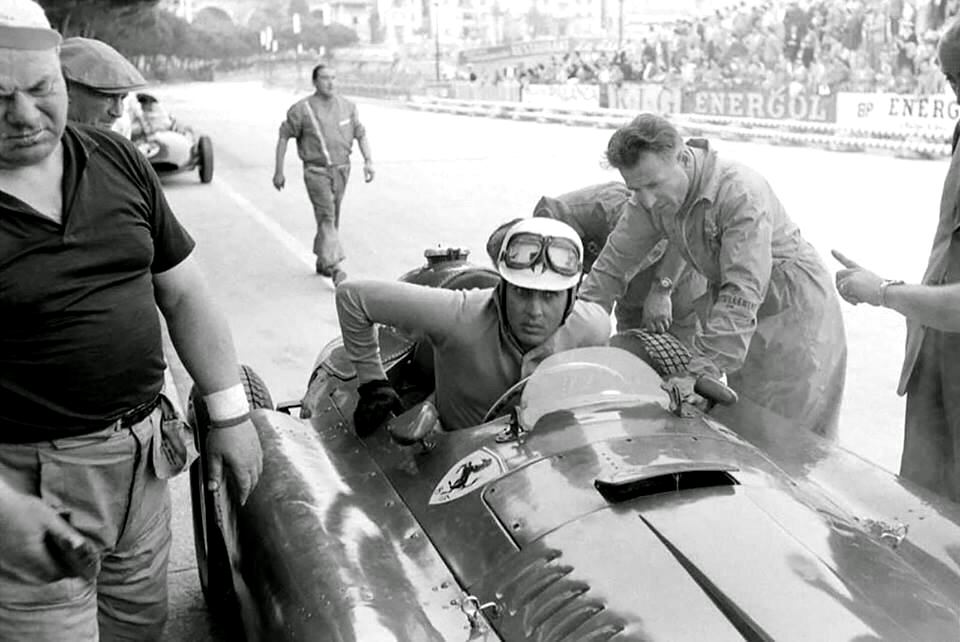



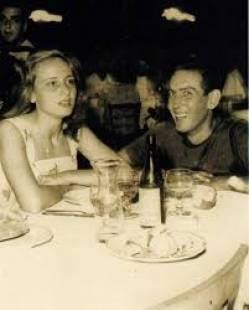
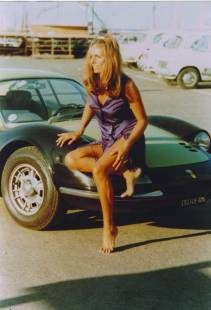






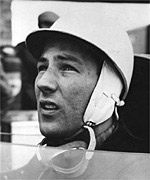











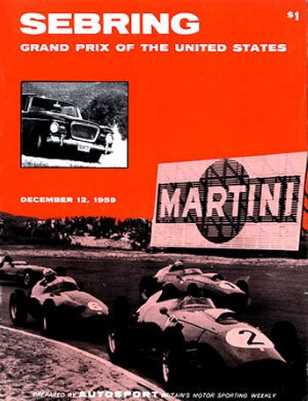





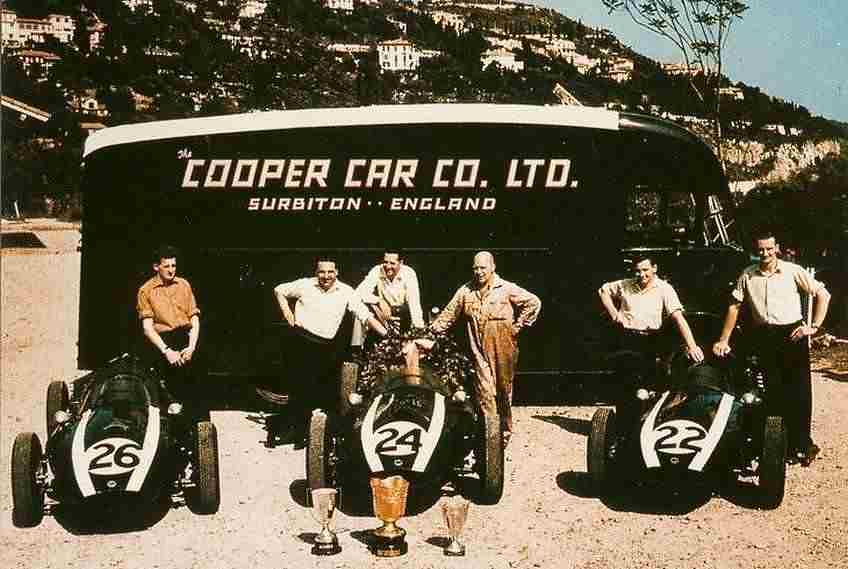
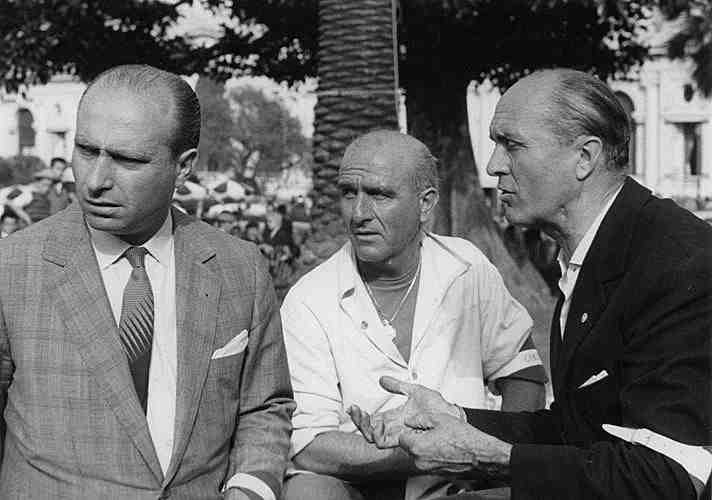

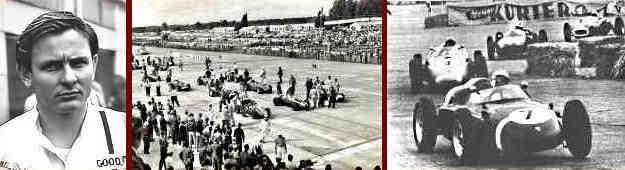


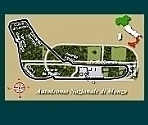
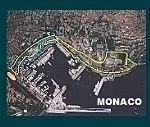

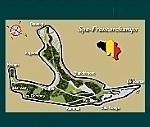




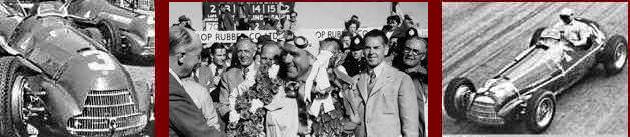






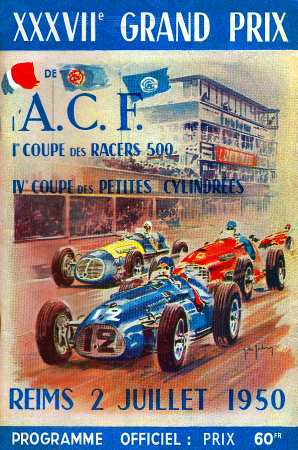
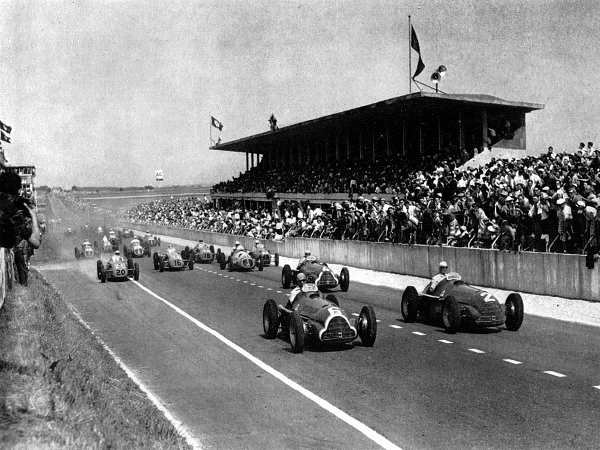


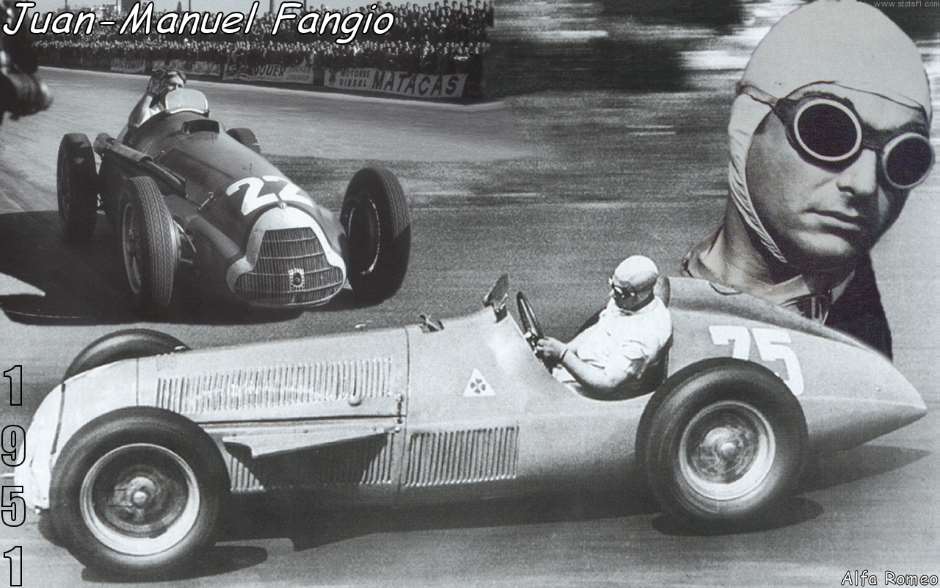




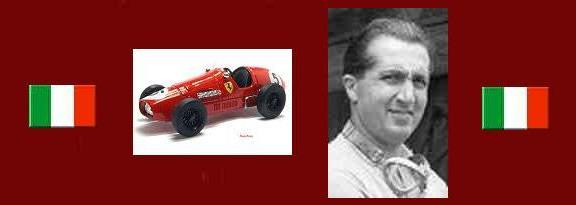









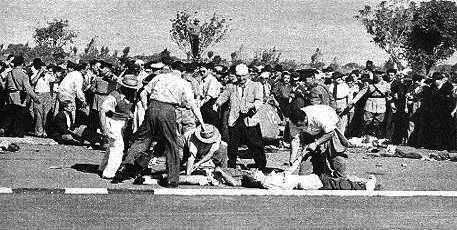



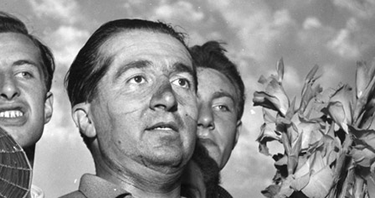
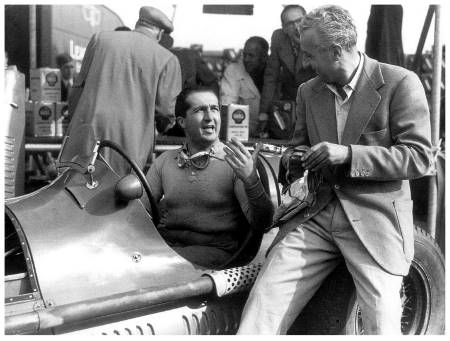
















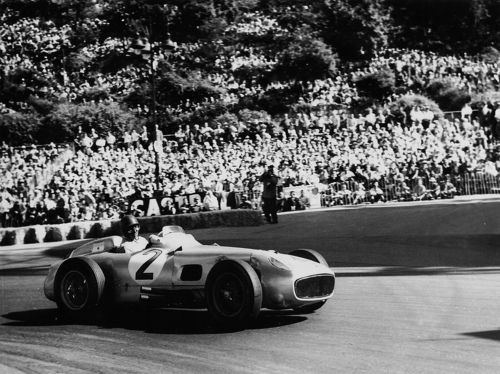

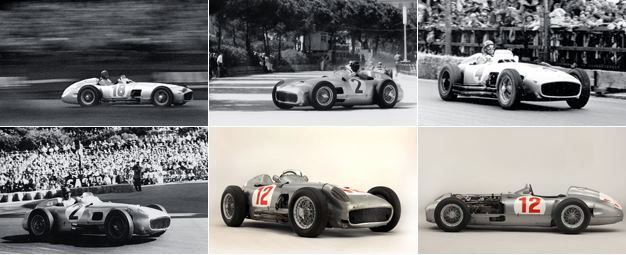








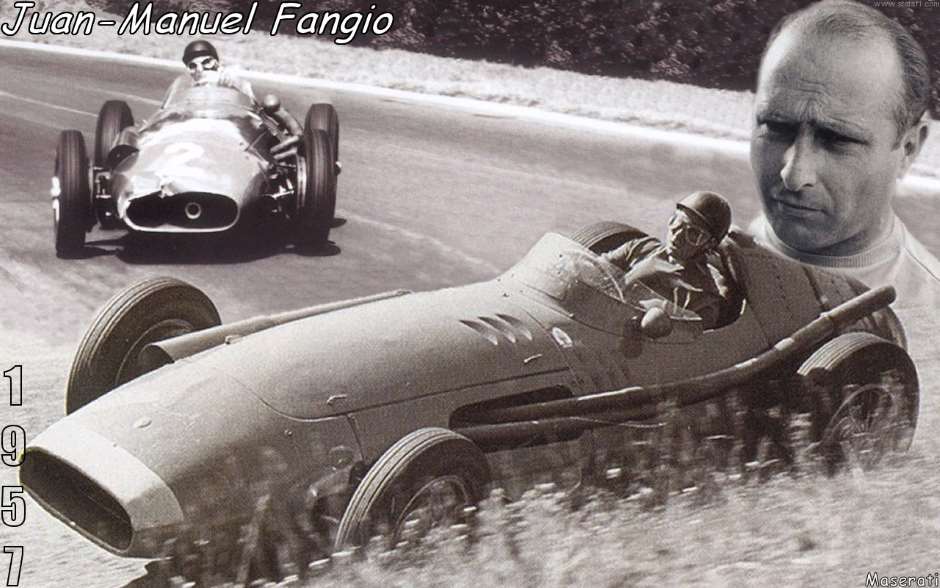




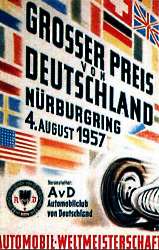



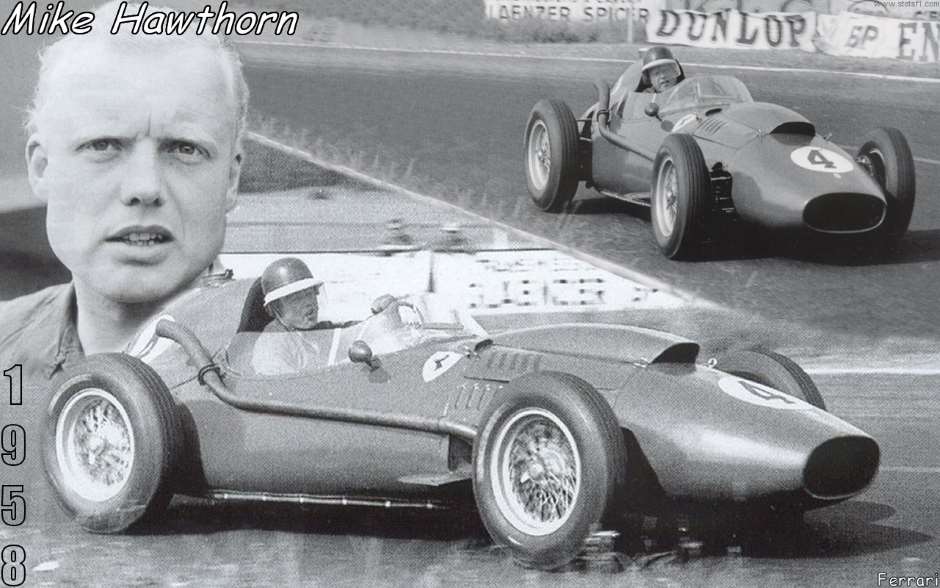






 Il
titolo mondiale della Ferrari probabilmente più sorprendente fu quello
conquistato da Mike Hawthorn nel 1958.
Il
titolo mondiale della Ferrari probabilmente più sorprendente fu quello
conquistato da Mike Hawthorn nel 1958.