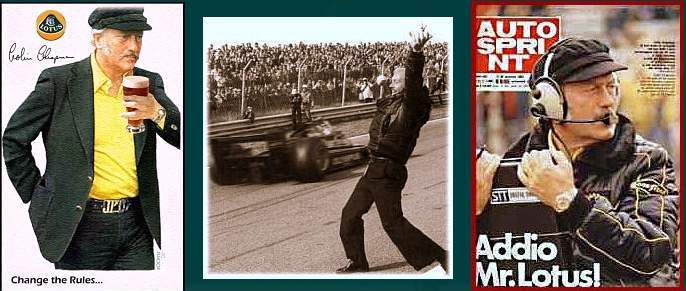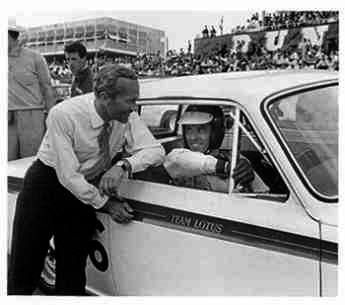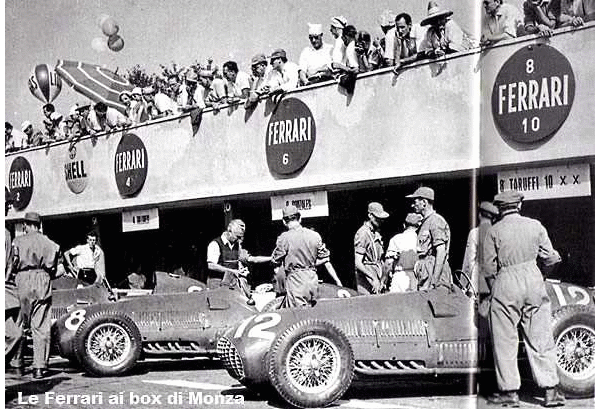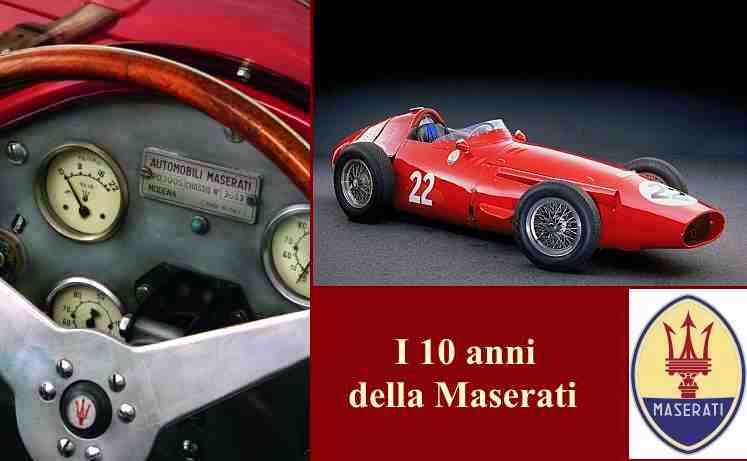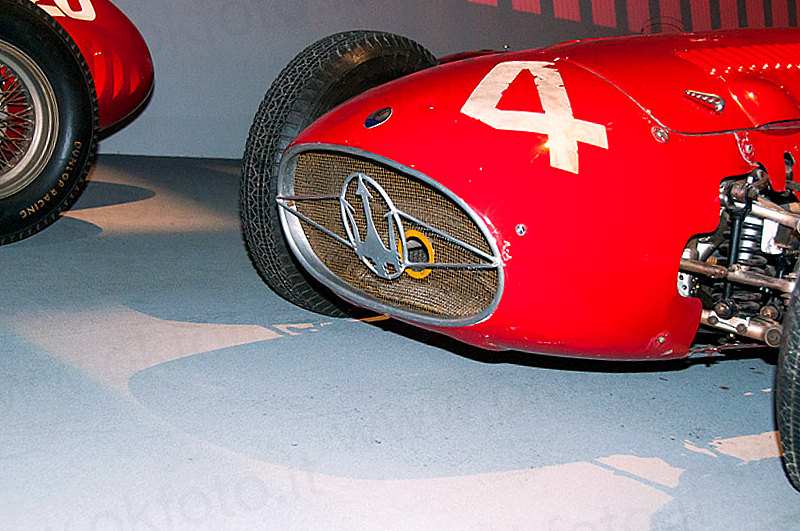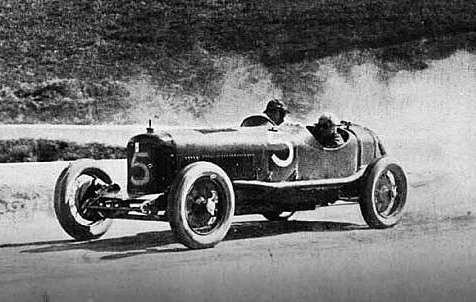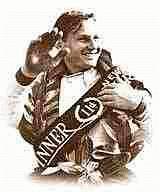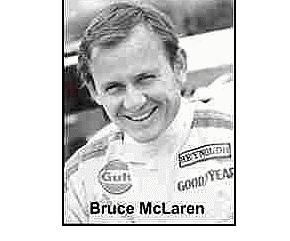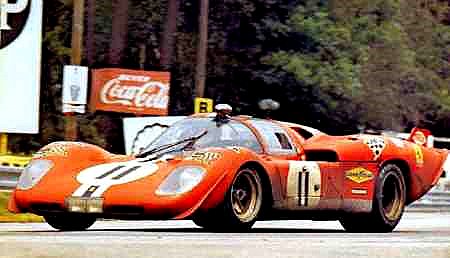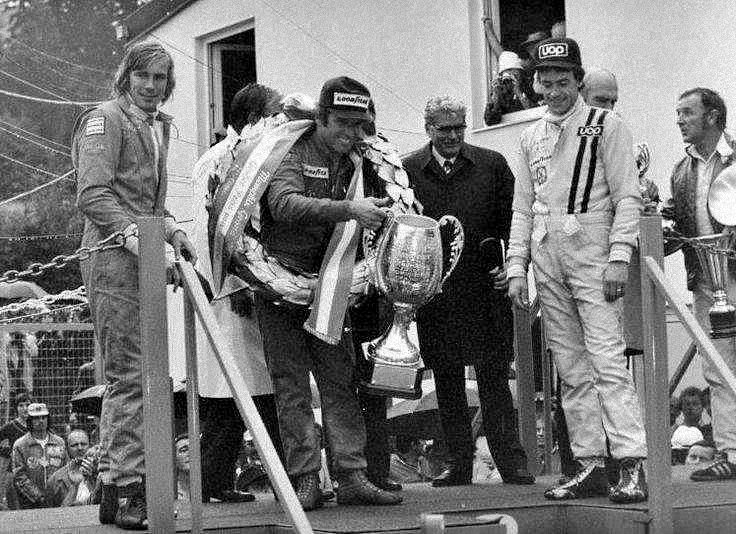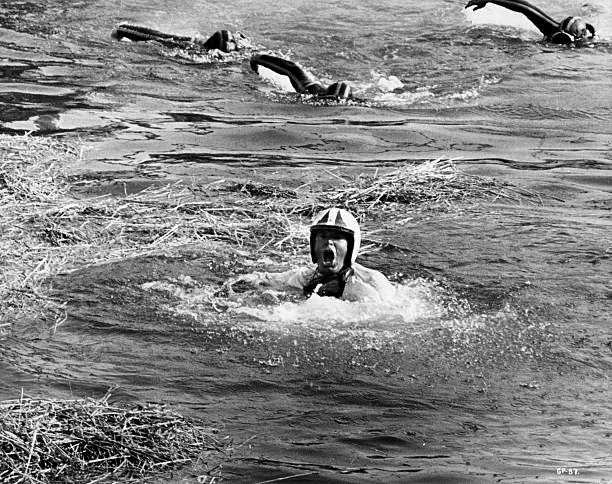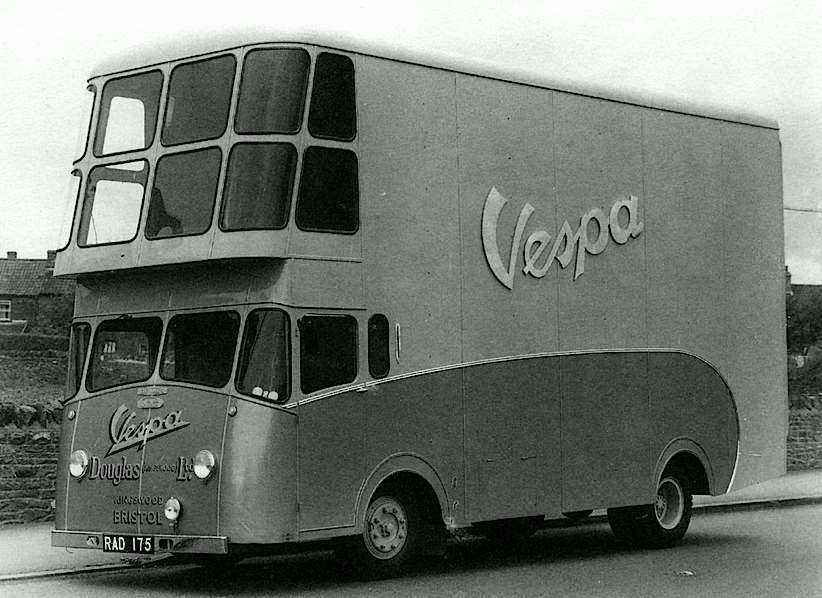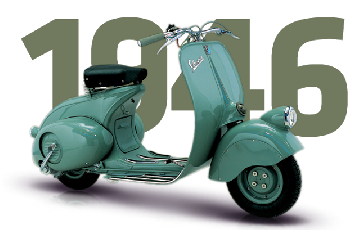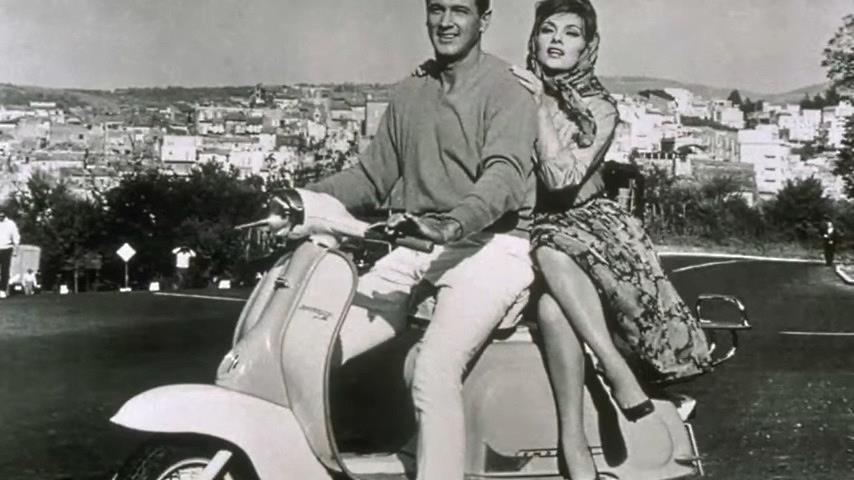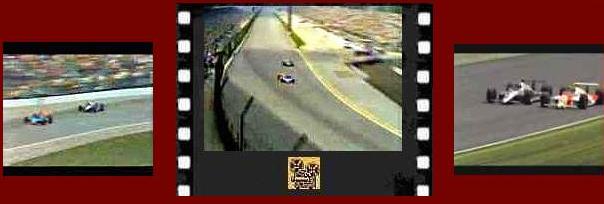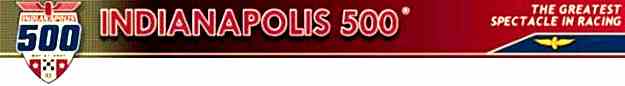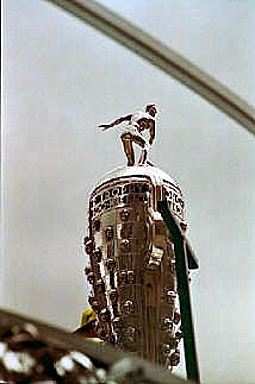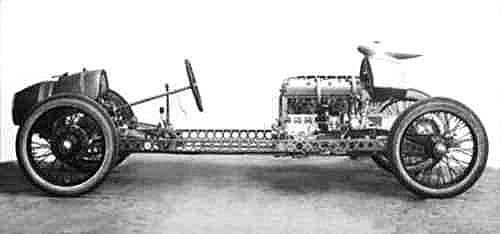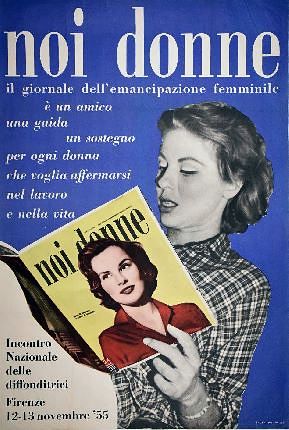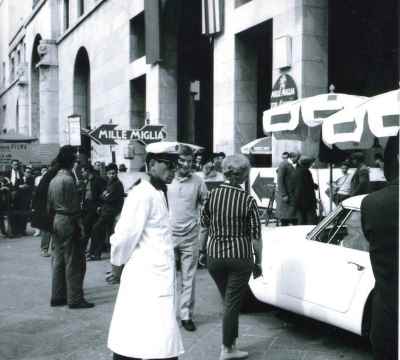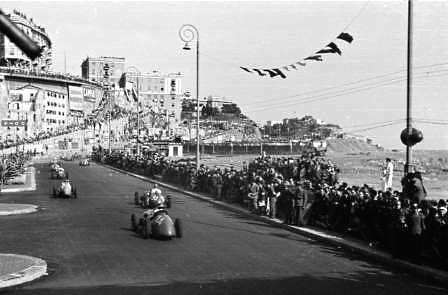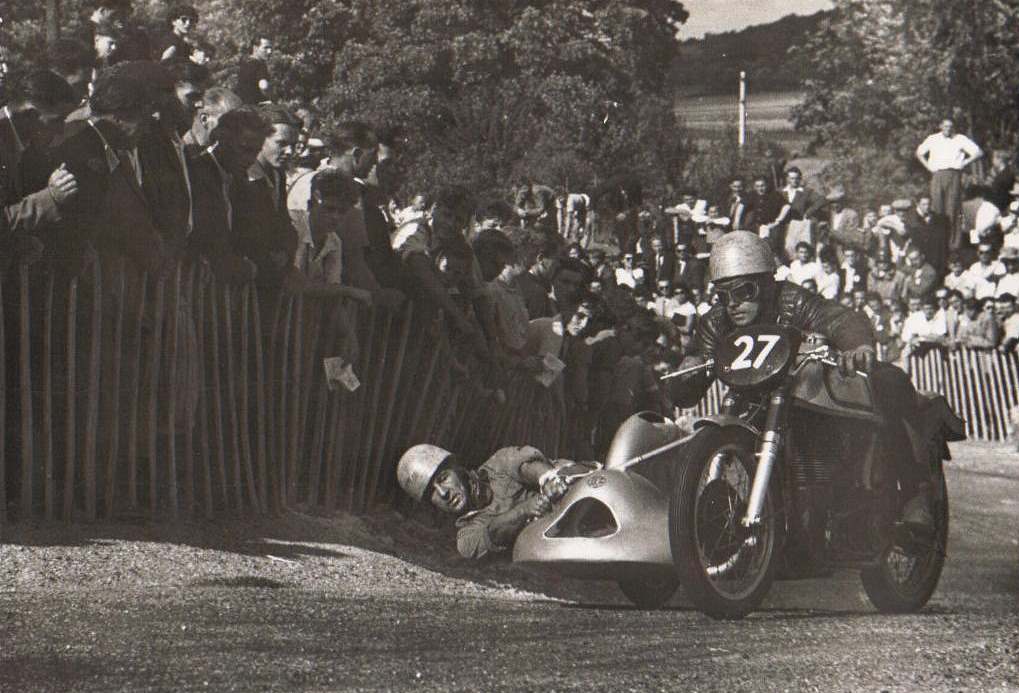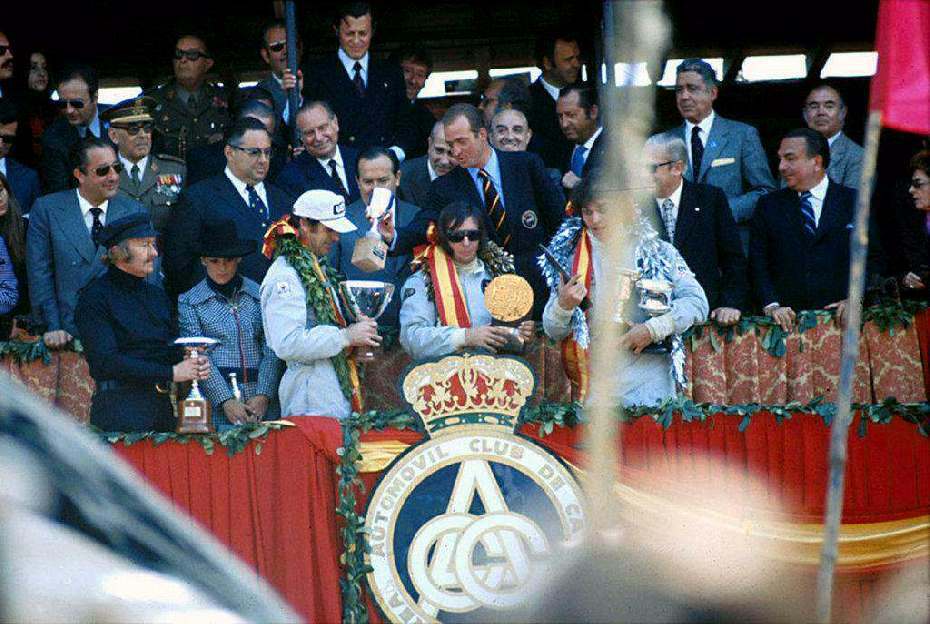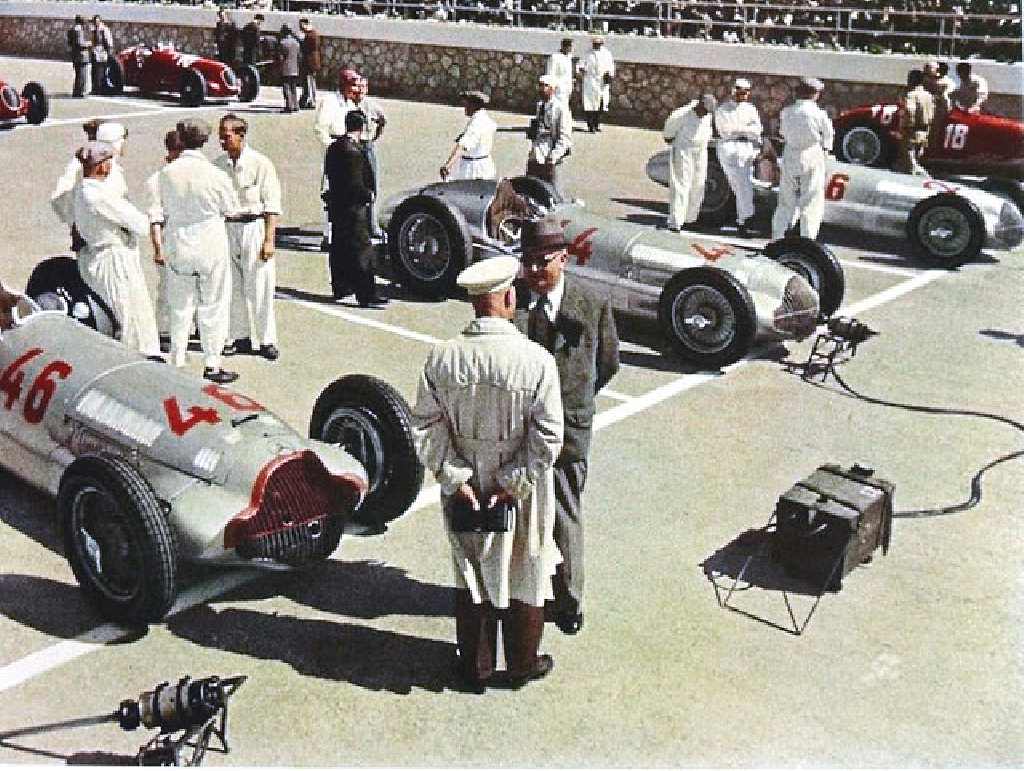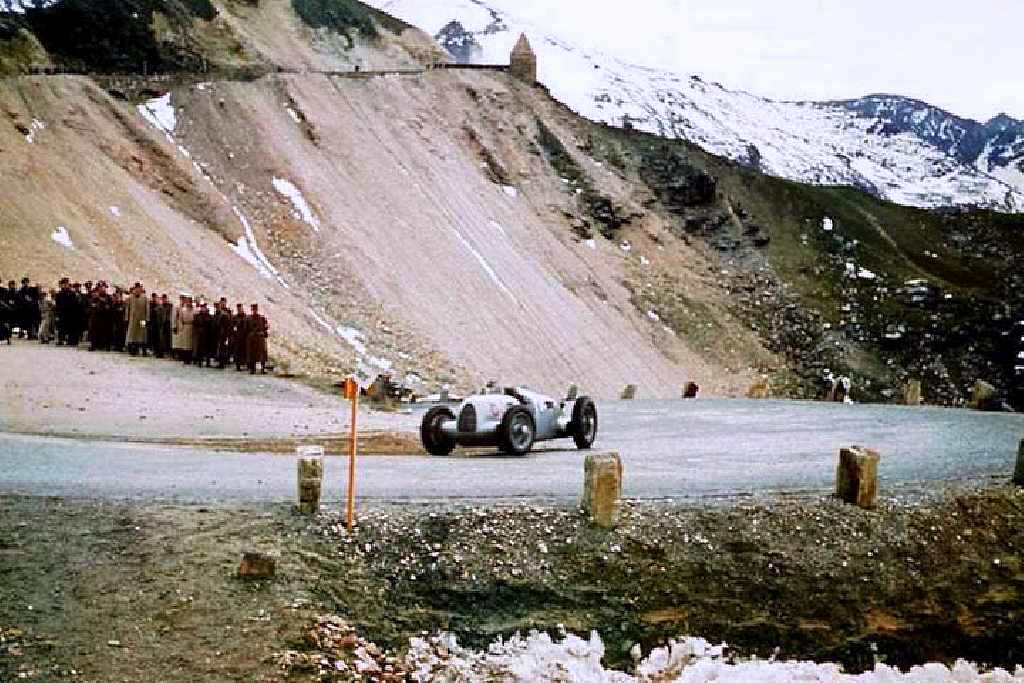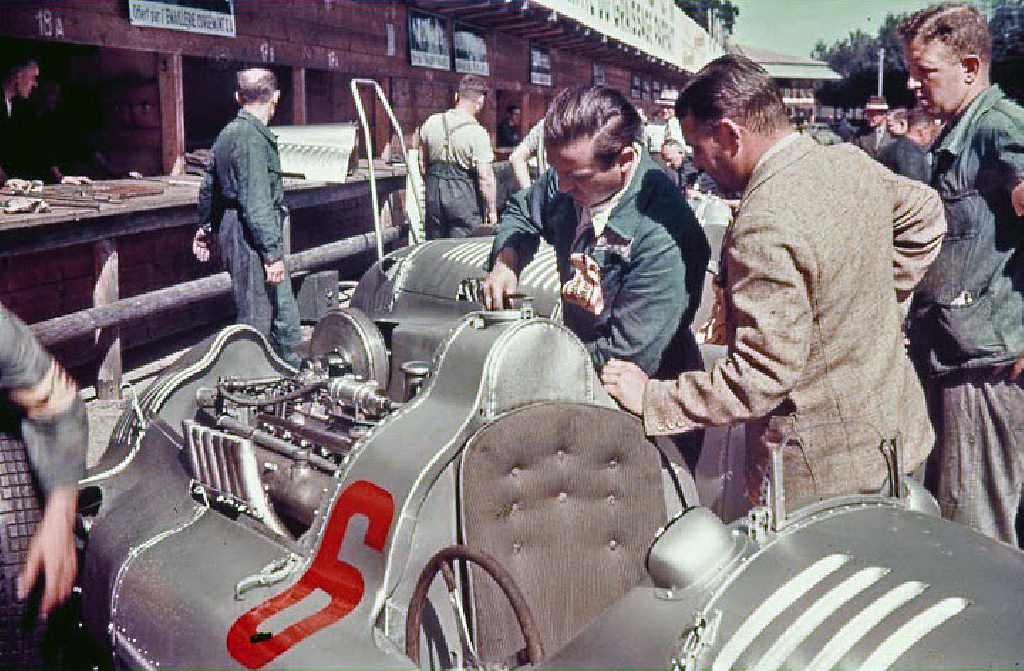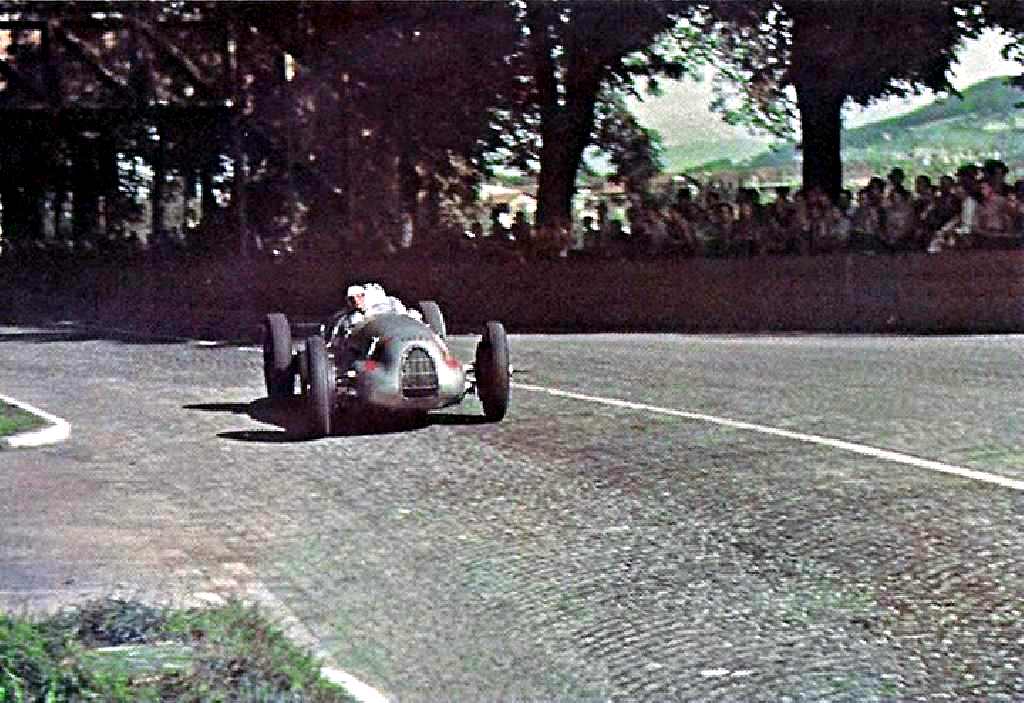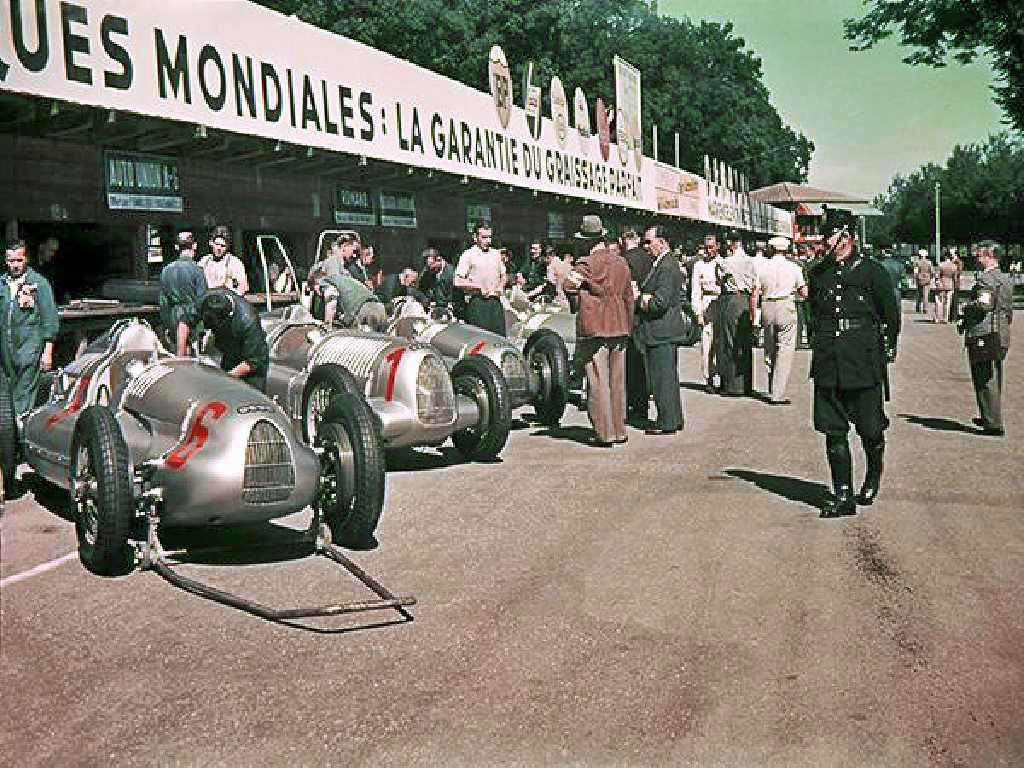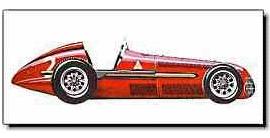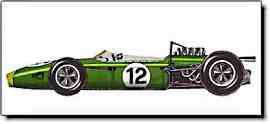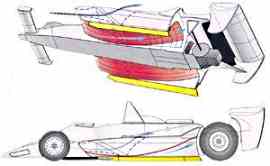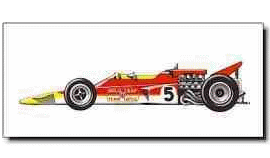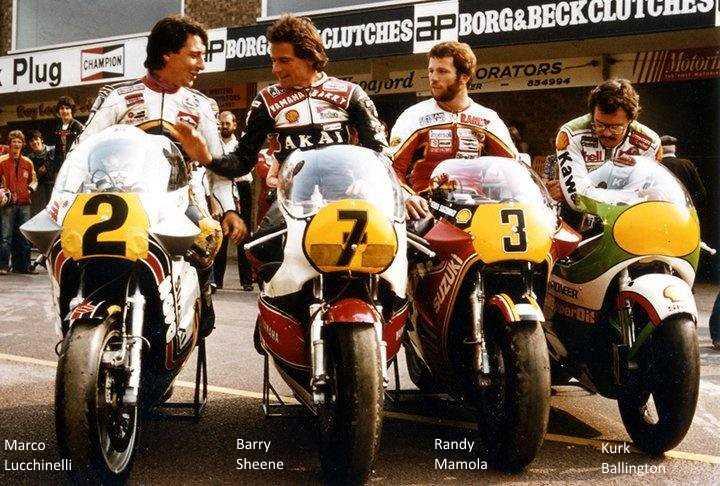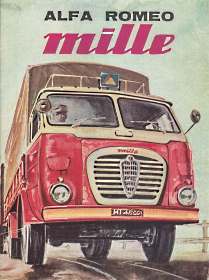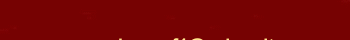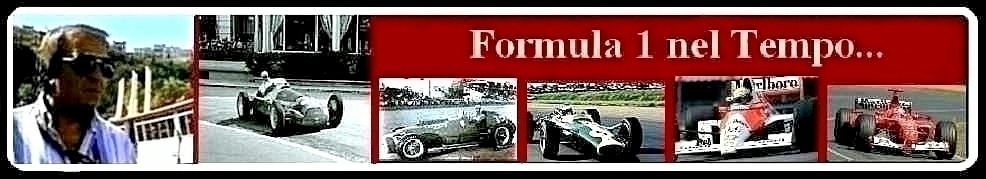
ALTRI ANNI
| Formula 1: I migliori di tutti i
tempi |
|
| Clark - Senna - Schumacher - Prost |
|
Qual è il miglior pilota di
Formula 1 di tutti i tempi?
Domanda difficile, epoche troppo
differenti, avversari diversi e un gusto personale che può
far cadere la scelta su tanti, troppi campioni.
Ma scegliere i migliori di tutti i tempi non dovrebbe essere
così difficile.
Il quotidiano inglese, infatti, ha pubblicato la classifica dei 50
migliori piloti di tutti i tempi. E le scelte lasciano, a dir poco,
basiti. Non discutiamo il podio, attribuito a Jim Clark, ma, come
detto, votare il migliore in assoluto è impossibile e sia
Clark sia Senna e Schumacher sarebbero candidati più che
validi al primo posto. Ma andiamo oltre.
Quarto si classifica Alain Prost. Il professore è stato
l’altro lato della medaglia del Sennismo tra gli anni
’80 e ’90. Ma basta ciò a farlo stare ai
piedi del podio? Fangio non è stato più forte,
più personaggio e più campione di lui? Dubbi che
sono quasi certezze. Ma è scendendo la classifica che i
giornalisti della perfida Albione danno il meglio di loro.
Solo undicesimo, infatti, l’italiano Ascari, uno dei pionieri
della Formula 1. Davanti a lui, incredibilmente, campioni sicuramente
meno importanti come Hakkinen o Alonso. E Niki Lauda? Solo
quattordicesimo, preceduto addirittura dal finlandese Kimi Raikkonen,
campione del mondo, sì, ma non certo un pilota che
verrà ricordato. Il ferrarista precede anche Nelson Piquet e
il grande
Gilles Villeneuve, solo diciannovesimo.
Villeneuve, uno dei piloti che hanno fatto innamorare milioni di
spettatori, è preceduto anche da Jenson Button. Ebbene
sì, il campione del mondo in carica, secondo il Times, vale
la sedicesima piazza. Da paracarro a campionissimo in una stagione?
Button ha meritato il titolo, ma ha vinto soprattutto perché
la Brawn Gp non ha avuto concorrenti.
Leggendo i nomi di Button, di Raikkonen, di Rindt, di Hakkinen o di
Mansell fa specie notare che, invece, sono diversi i campioni rimasti
fuori dalla Top 20. Chi? Per esempio Clay Regazzoni, Jackie Ickx
(preceduto anche da Rubens Barrichello!!!), Jody Scheckter, John
Surtees, Mario Andretti o Emerson Fittipaldi. Insomma, nomi che hanno
fatto veramente la storia di questo sport,
ma che per gli inglesi non esistono.
|
|
|
 |
|
Storia della Formula 1
I primi anni (1946-1949)

Torino 1° settembre 1946 - Parco del Valentino
Jean-Pierre Wimille su Alfa Romeo 158 n. 52 e Giuseppe Farina Alfa Romeo 158 n.8
Scorcio del viale di accesso al Borgo Medioevale del Parco del Valentino di Torino. Su un circuito
ricavato da queste strade, nel 1946 si disputò la prima gara assoluta per vetture di Formula 1
La Formula 1 venne creata nel 1946 dalla Commissione Sportiva Internazionale (CSI) della FIA,
antecedente della FISA, come la classe più alta di corse
automobilistiche per monoposto scoperte dell'automobilismo mondiale.
All'inizio era conosciuta come Formula A – denominazione usata attualmente per la categoria più alta del karting
– ma ne venne cambiato il nome dopo appena due anni. L'idea di
organizzare un campionato mondiale piloti venne formalizzata nel 1947,
ma già nel 1939 la vecchia AIACR, con il cambiamento del sistema di punteggio avvenuto nel Campionato Europeo Piloti, stava cominciando a pensare a questa soluzione. Lo scoppio del conflitto bloccò temporaneamente tutti i programmi.
Negli anni '30 il regolamento per le vetture da Grand Prix era
invece basato sul peso massimo della vettura, fissato a 750 kg. Non
c'erano limiti per quanto riguardava la cilindrata o il tipo di motore.
Si sfidavano dunque vetture con motori potentissimi, come nel 1936:
propulsori di 3.8 litri (Alfa Romeo), sia di 5.6 litri a V12 (Mercedes) e
infine quelli a 6.0 litri della Auto Union. Nel 1938 la cilindrata
venne limitata a 3.0 litri. Venne però istituita anche la categoria
"vetturette" con motore 1,5 sovralimentato. Tra queste vi era l'Alfa Romeo 158 che dominerà la scena sino al 1951.
Il nuovo regolamento del 1946 prevedeva un nuovo equilibrio per le vetture tra i motori supercompressi e aspirati. Vennero ammessi i tipi di motore aspirato da 4.5 litri, e quello supercompresso da 1.5 litri delle "Voiturette" d'anteguerra.
La prima corsa
disputata con questi nuovi regolamenti si disputò in Italia, e
precisamente a Torino il 1º settembre del 1946, il Gran Premio di
Torino, disputato sul Circuito del Valentino – il nome è
preso dal Parco del Valentino, dove le vetture correvano sui viali
adiacenti al Borgo Medioevale – e venne vinta da Achille Varzi
alla guida di una Alfa Romeo 158 detta Alfetta,
anche se in realtà le macchine non avevano subito grandi cambiamenti da
quelle che avevano corso le stagioni precedenti. Quella di Varzi era
stata progettata e costruita prima della guerra.
I Campionati per i Piloti e quello per i Costruttori non vennero
immediatamente reintrodotti. Nei primi anni si gareggiavano intorno alle
20 corse, tenute in Europa dalla tarda primavera ai primi di autunno, e
l'esempio del circuito cittadino di Torino venne seguito
immediatamente, oltre che in Inghilterra, da Milano, Bari, Sanremo,
Pescara, Siracusa, Napoli e Modena in Italia; Nizza, Marsiglia, Albi,
Pau, Comminges e Parigi in Francia; e infine dal circuito di Chimay in
Belgio dove si disputava il Grand Prix des Frontieres.
In particolare
il circuito cittadino di Ospedaletti, che ospitò dal 1948 al
1951 il Gran Premio di Sanremo per vetture di Formula 1 e in seguito
per altri tipi di vetture, fu l'ultimo dei circuiti stradali cittadini
di quel periodo a chiudere i battenti nel 1972. Le vetture più
competitive venivano dall'Italia, in particolare l'Alfa Romeo. Nel
periodo 1946–1949 si assisteva al tramonto della carriera dei
vecchi piloti anteguerra come lo stesso Varzi, Jean-Pierre Wimille e
Tazio Nuvolari, mentre piloti come Ascari e Fangio iniziavano a farsi
notare.
|
 |
Piloti che corrono oltre il limite
|
Ci sono piloti che corrono oltre il limite. Oltre
ciò che la meccanica può sopportare. Piloti che
spingono la propria vettura e sé stessi in una situazione
“precaria”, nella quale l’errore
è dietro l’angolo. Castellotti, Rosemeyer, Senna, Mansell, Gilles Villeneuve sono (esempi
di) piloti che hanno corso così, senza darsi dei limiti,
senza calcolare il limite del mezzo meccanico. Prendiamo Castellotti, uno degli “indisciplinati”,
di cui Delli Carri ci racconta magistralmente: durante la Targa Florio
del 1956 era in coppia con Collins. Il pilota di Lodi spinse
così forte nei primi giri che provocò un
cedimento meccanico. Fu così che Collins gli
raccomandò di essere più leggero col piede, la
prossima volta. Oppure a Monza, sempre quell’anno, quando nel
folle inseguimento a Musso distrusse le sue gomme e rischiò
grosso in un incidente. Castellotti si giustificò col fatto
che era stato Musso a scegliere quella folle tattica. Però
Lui gli era andato dietro, senza riflettere sul fatto che, con una
gestione più intelligente del mezzo, avrebbe potuto avere la
meglio. La sua spregiudicatezza, però, gli regala un
successo incredibile, quello alla Mille Miglia del 1956, vinta
percorrendo l’ultimo tratto sotto al diluvio, con
un’auto scoperta e gli occhiali rotti. Castellotti aveva
spinto tutta la gara, e continuò a spingere fino alla fine,
anche se nel finale si trovò a guidare quasi alla cieca per
colpa della pioggia.
 |
Oppure, prendiamo Bernd Rosemeyer, che nel 1935 regalò
spettacolo nelle corse da Gp. A Pescara, quell’anno, fece un
incidente incredibile, nel quale saltò un fosse infilandosi
tra un palo e il parapetto di un ponte. Bernd era un pilota veloce, ma
la sua aggressività nella guida non faceva i conti con la
necessità di salvare le gomme (sproporzionate, un
po’ come tutto sulle auto da Gp degli anni ’30,
rispetto alla potenza delle vetture stesse). Così, ad
esempio, accadde al Nurburgring nel 1935. Però solo un
pilota di questo genere poteva domare le incredibili Auto Union a
motore posteriore, così difficili da guidare.
Se sulle Cooper il motore centrale rientrava in una logica di
distribuzione del peso, sulle Auto Union, il motore collocato alle
spalle del pilota rendeva la guida impossibile. Tanto è vero
che quando Forghieri insisteva presso Ferrari perché
seguissero la scuola inglese e adottassero il motore centrale, il Drake
portava l’esempio delle inguidabili Auto Union, per
dimostrare che quella soluzione non era poi così buona.
Ma torniamo al buon Rosemeyer: un’altra impresa del tedesco
è la vittoria al Nurburgring (Gp dell'Eifelrennen) del 1936,
quando vince in condizioni di visibilità pessime, staccando
a memoria nelle curve. Un’impresa che sarà
ripetuta nel 1968 da Stewart, che vinse in condizioni simili. Stewart,
però, sapeva bene quali rischi si correvano al Nurburgring
(che definì l’inferno verde). Rosemeyer, invece,
ragionava meno sull’esistenza del rischio. |
Caracciola disse di Rosemeyer "Bernd non sapeva letteralmente cosa
fosse la paura e questo a volte non è una buona
cosa."Infatti, non fu una buona cosa, per Bernd, rischiare il record di
velocità sebbene Caracciola glielo avesse sconsigliato, per
via del forte vento. Rosemeyer, infatti, perse la vita durante quella
prova. Gilles Villeneuve è stato forse il pilota che meglio di
tutti ha incarnato il concetto dell’andare oltre. Non aveva
nessun rispetto per il mezzo meccanico; non conosceva limiti. Il famoso
giro su tre ruote (a Zandvoort nel 1979) è
l’emblema della capacità di Gilles di correre
oltre ai limiti.
Non per nulla Gilles è stato uno dei grandi della corsa di
Montecarlo (dove il limite tra correre forte e sbagliare è
più sottile che in qualunque altro posto). Si racconta che
Gilles avesse fatto una scommessa con un fotografo: questi avrebbe
dovuto piazzare un fiammifero nel guardrail all’esterno del
Tabac, perpendicolarmente al senso di marcia. Gilles scommise di essere
capace di rimuoverlo con la posteriore destra senza toccare la
barriera. Ovviamente, la scommessa fu vinta di Villeneuve. Di un pilota
del genere, come di tutti questi "irruenti del volante", non
è stato dato un giudizio univoco. Gilles, c'è
stato chi lo ha adorato, chi ha considerato la sua pura sconsideratezza
fuori luogo. La morte, forse, ha spento qualche voce critica.
è rimasto il mito: chi lo sa se è un bene o un
male. Un altro pilota che possiamo ricondurre a questa categoria, dei piloti
che guidano oltre il limite, è Ayrton Senna.
Senna rischiava le corse in doppiaggi eseguiti in modo folle. Ayrton
era uno che spremeva tutto dalla macchina. A volte, Ayrton non
ragionava sul vantaggio che aveva, ma spingeva solo
sull’acceleratore, rischiando l’errore. A Monaco
nel 1988 perse una gara, che stava dominando, per un errore di guida.
Se avesse gestito il suo vantaggio, questo non sarebbe accaduto.
Prost era il suo opposto. Sapeva gestire la vettura in modo fenomenale.
Pare che, dopo un gp, i suoi freni fossero così poco
consumati da poter essere impiegati nuovamente. Sembrerebbe, quindi, che Prost rappresenti il modo positivo di
affrontare una corsa e Senna quello negativo. In realtà non
è così. Senna è entrato, al pari di
Prost nella leggenda. Piuttosto, bisogna dire che Ayrton, dopo Monaco 1988, capì
che per correre senza calcoli, sempre al massimo, era necessario
allenare la propria mente. In definitiva, possiamo chiederci se questo correre oltre al limite sia
un fatto positivo o negativo. La mia risposta è che questo
modo di correre, di per sé, non rappresenta né un
fatto positivo, né uno negativo. Credo che l’essenza delle corse sia rappresentata dalla
famosa frase di Chapman, secondo cui una buona auto da corsa
è quella che si rompe un metro dopo il traguardo (non una
che finita la corsa ne può sopportare un’altra o
una che si rompe prima che la corsa sia finita ). Significa che nella
corsa bisogna dare tutto, però che la corsa deve essere
completata. Non per nulla, questi piloti aggressivi sono stati "Dei" quando la loro
corsa forsennata ha portato risultati. Viceversa, sono caduti nel
fango, quando hanno fallito. Oggi, il rappresentante di questa categoria, di piloti che corrono
senza calcoli, all'attacco, è senza dubbio Hamilton. |
|
|

Forghieri Racconta: 12 domande imperdibili - Intervista di Davide Cironi (SUBS)
Mauro Forghieri: una vita per la Ferrari

L'ingegnere modenese capace di portare al Cavallino sedici Mondiali
|
 |
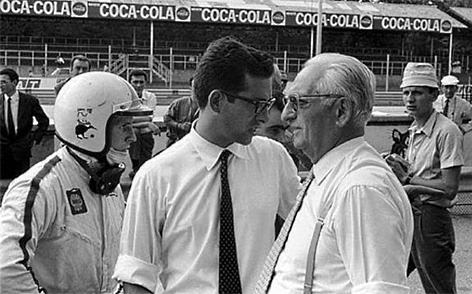 |
In una classifica dei personaggi più importanti della storia Ferrari Mauro Forghieri
meriterebbe di occupare una delle prime dieci posizioni della
graduatoria. Per quasi 30 anni l'ingegnere modenese è stato responsabile
tecnico del reparto corse di Maranello e le auto da lui progettate
hanno portato a casa ben sedici titoli Mondiali: 11 in F1 e 5 nell'endurance. Scopriamo insieme la storia del tecnico emiliano.
Mauro Forghieri: la storia
Mauro Forghieri nasce il 13 gennaio 1935 a Modena. Figlio di un meccanico del reparto corse Ferrari, si laurea in ingegneria meccanica nel 1959 all'Università di Bologna e poco dopo viene assunto nell'ufficio tecnico del Cavallino, all'epoca diretto da Carlo Chiti.
La svolta nella carriera di Forghieri arriva nel 1961 quando Chiti lascia la Ferrari insieme a Romolo Tavoni e ad altri tecnici e progettisti per fondare la ATS.
Mauro, a soli 26 anni, viene nominato responsabile tecnico del reparto
corse del Cavallino (che in quegli anni è focalizzato sulla F1 e sui prototipi).
Inizialmente Mauro Forghieri si occupa di motori
ma col passare del tempo interviene anche su altri aspetti meccanici: è
lui, ad esempio, che migliora la stabilità nei curvoni veloci della
mitica 250 GTO intervenendo sul ponte posteriore.
Le prime vittorie
Il 1963 è l'anno in cui arrivano i primi successi per la Ferrari sotto la direzione Forghieri: il britannico John Surtees si aggiudica il GP di Germania di F1, i nostri Ludovico Scarfiotti e Lorenzo Bandini portano a casa la 24 Ore di Le Mans al volante della 250P e arriva anche il titolo Mondiale Sportprototipi.L'anno seguente Mauro Forghieri festeggia il suo primo Mondiale F1
(doppietta: Costruttori e Surtees tra i Piloti) e il secondo campionato
del mondo sportprototipi. Senza dimenticare il gradino più alto del
podio di Le Mans conquistato dalla 275P guidata dal francese Jean Guichet e dal nostro Nino Vaccarella.
Dominio nell'endurance
La supremazia Ferrari nella categoria endurance continua nel 1965 con il terzo campionato del mondo: la 275 P2 vince la 1000 km di Monza (con l'inglese Mike Parkes affiancato da Guichet) e la Targa Florio (Vaccarella/Bandini) mentre la 330 P2 si aggiudica la 1000 km del Nürburgring con Surtees/Scarfiotti.
Il quarto Mondiale Sportprototipi per Mauro Forghieri arriva nel 1967 grazie soprattutto a Bandini e al neozelandese Chris Amon,
vincitori alla 24 Ore di Daytona (gara contraddistinta da una
memorabile tripletta del Cavallino) e alla 1000 km di Monza. L'anno
successivo le idee dell'ingegnere modenese iniziano a dare i loro frutti
anche in F1: in occasione del GP di Spagna viene montato per la prima volta su una monoposto l'alettone posteriore, una rivoluzione tecnica destinata a rivoluzionare il mondo del motorsport.
Gli anni '70
Nel 1972 la Ferrari conquista il suo ultimo Mondiale Sportprototipi di sempre dominando la stagione: lo svedese Ronnie Peterson e l'australiano Tim Schenken primi alla 1000 km di Buenos Aires e alla 1000 km del Nürburgring, lo statunitense Mario Andretti e il belga Jacky Ickx
davanti a tutti alla 6 Ore di Daytona, alla 12 Ore di Sebring, alla
1000 km di Brands Hatch e alla 6 Ore di Watkins Glen, il trionfo tutto
italiano di Arturo Merzario e Sandro Munari alla Targa Florio e il britannico Brian Redman insieme a Ickx sul gradino più alto del podio all'Österreichring.
La crisi e la rinascita
La crisi della Ferrari in F1 porta all'estromissione temporanea di Mauro Forghieri al termine della stagione 1972. Dopo pochi mesi – però - in seguito al fallimento della monoposto 312B3
del 1973 il tecnico emiliano ritorna al comando del reparto corse e
inizia una lunga striscia di vittorie nel Circus.Nel 1975 doppio titolo
(Piloti con l'austriaco Niki Lauda e Costruttori), nel 1976 Mondiale Costruttori e doppietta nel 1977 (con Lauda) e nel 1979 (con il sudafricano Jody Scheckter).
Gli ultimi Mondiali e l'addio alla Ferrari
Gli anni '80 di Mauro Forghieri si aprono con lo sviluppo della Ferrari 126CK, una monoposto di F1 dotata di un motore 1.5 V6 turbo da 570 CV. Le evoluzioni di questo modello conquistano due Mondiali Costruttori consecutivi nel 1982 e nel 1983.
Nel 1984, per via di alcuni dissidi con la dirigenza Fiat, Forghieri lascia il reparto corse Ferrari e si sposta all'ufficio ricerche per diventare nel 1986 direttore generale di Ferrari Engineering. Il suo progetto più importante è senza dubbio la 408 4RM, un prototipo realizzato in due esemplari dotato di trazione integrale.
Nuove avventure
Nel 1987, dopo quasi di 30 anni di carriera in Ferrari, Mauro Forghieri lascia Maranello e diventa direttore tecnico di Lamborghini Engineering. Per la Casa di Sant'Agata Bolognese progetta un motore 3.5 V12 aspirato da F1 che viene adottato nel 1989 dalla Lola e l'anno successivo anche dalla Lotus.
Il 1991 è l'anno in cui la Lamborghini debutta come costruttore in F1 (solo sei GP disputati senza conquistare punti) ma già nel 1992 Mauro viene chiamato dalla Bugatti per ricoprire il ruolo di direttore tecnico.
Mauro Forghieri fonda nel 1995 la Oral Engineering, azienda ancora oggi attiva nella progettazione, nell'assemblaggio e nei servizi di collaudo di motori a due e a quattro tempi per i settori racing e produzione.
|
|

Trasferimento vintage...
 |
|
Storia della Formula 1

Campionato del Mondo Piloti (1950-1957)
Nel 1950, in
risposta al Campionato Mondiale di Motociclismo introdotto l'anno
precedente, la FIA organizzò il primo vero Campionato del Mondo
Piloti.
L'organizzazione del
campionato vide scegliere sei dei maggiori Gran Premi in Europa,
più la 500 Miglia di Indianapolis, ma pochissimi piloti europei
vi presero parte, anche a causa del diverso regolamento tecnico.
In effetti la denominazione "Campionato del mondo Piloti di
Formula 1" fu adottata solo nel 1981 e sino al 1960 vi furono, almeno in
via teorica, nel calendario gare con diversi regolamenti tecnici, per i
Gran Premi e per Indianapolis. Addirittura nel 1952-53 il campionato
piloti si disputò con vetture di Formula 2 (Indianapolis esclusa),
mentre le vetture della F.1 ne furono escluse.
Furono tre team
italiani ad occupare le posizioni dominanti dei primi anni del
campionato, l'Alfa Romeo, quindi la Ferrari, e infine la Maserati.
Altre case manufattrici nazionali – come la francese Talbot o la
britannica BRM – competono, con successi assai modesti. Un buon
numero di vetture private prendevano parte alle gare.
L'Alfa Romeo
dominò la concorrenza nella stagione 1950, vincendo tutte le
gare di quel campionato con l'"Alfetta" 158 costruita prima della
guerra da Enzo Ferrari.
La sola eccezione fu per la 500 Miglia, che faceva parte del
campionato ma non correva con le regole della Formula 1 ed era raramente
gareggiata dai piloti europei. La corsa non acquisterà mai importanza
nel mondo della Formula 1 e uscì dal calendario del campionato dopo il
1960. Nino Farina vinse il campionato inaugurale, Juan Manuel Fangio
lo conquistò nel 1951 con la Alfa Romeo 159, un'evoluzione della 158. I
motori dell'Alfetta erano estremamente potenti per la capacità delle
altre vetture dell'epoca. Nel 1951 il motore della 159 produceva attorno
ai 420 cavalli di potenza, ma questo comportava un prezzo da pagare nel
consumo eccessivo di benzina, che era stimato dai 125 ai 175 litri per
percorrere 100 km[2]. Enzo Ferrari,
che gareggiò con l'Alfa Romeo prima della guerra (in pratica la Ferrari
era la scuderia ufficiale dell'Alfa Romeo), fu il primo a comprendere
che lo sviluppo dei motori con compressore da 1.5 litri era giunto ai
suoi limiti. Ogni ulteriore incremento di potenza obbligava a compiere
lunghe soste per fare rifornimento di benzina, con conseguente perdita
di tempo. Per le ultime gare del 1950 Ferrari abbandonò il modello 125
da 1.5 litri con compressore, ormai da museo, e presentò il nuovo
modello 375 con motore V12 aspirato da 4.5 litri. Con un consumo di
benzina che si aggirava attorno ai 35 litri per 100 km le 375 offriromo
fiera opposizione all'Alfetta fino al termine della stagione 1951.
L'Alfa Romeo, una compagnia stata, decise di ritirarsi dopo il rifiuto
del governo italiano di concedere fondi per progettare la nuova vettura.
Sorprendentemente, l'Alfa Romeo investì nelle corse budget molto
limitati, utilizzando ancora tanto materiale e tecnologie precedenti
alla guerra durante queste prime due stagioni. All'istante il team vinse
i due campionati usando solo nove motori costruiti negli anni ‘30.
Non fu comunque il ritiro dell'Alfa Romeo a rendere invincibile la Ferrari.
Infatti originariamente era prevista per il 1952 il passaggio ad
una sola cilindrata di 2,5 litri senza sovralimentazione, ma fu rinviato
al 1954. Poiché però sola la Ferrari era pronta a gareggiare
ufficialmente con le vecchie vetture con motori da 4.5 litri, La FIA si
trovò in una posizione imbarazzante.
Soltanto la Ferrari
era in grado di allestire vetture di Formula 1 competitive. La
soluzione adottata fu quella di far disputare il Campionato Mondiale
Piloti con le vetture di Formula 2 per due stagioni. Il dominio Ferrari
si delineò con la leggera e potente 500 a 4 cilindri guidata dal
leggendario pilota italiano Alberto Ascari che fu il primo pilota a
vincere due campionati consecutivi nel 1952 e 1953. Le vetture Ferrari
di Formula 1 continuarono a gareggiare nelle gare non valide per il
campionato e in quelle di Formula Libre corse durante quel periodo, soprattutto nel Sudamerica
– non a caso, "Libre" è il termine spagnolo con cui si
definisce "Libera" – dove queste corse erano molto popolari.
Ironicamente,
durante quel biennio la sola gara del Campionato del Mondo in cui le
vetture di Formula 1 erano ammesse era la 500 Miglia. Nel 1952 la
Ferrari schierò quattro 375 di Formula 1 con Alberto Ascari come
pilota guida, ma con scarso successo: solo Ascari riuscì a
qualificarsi (a metà schieramento) e si ritirò ben presto
in gara. Non contando la gara di Indianapolis, il Campionato del Mondo
si svolse interamente in Europa fino al 1953, quando la stagione si
aprì in Argentina. Quella fu la prima corsa ufficiale di Formula
1 a disputarsi fuori dall'Europa.
Va detto che nel 1951, comunque si disputarono molte gare di Formula 1, ma tutte fuori campionato, come il Gran Premio Autodomo di Monza 1951 nel quale Juan Manuel Fangio ebbe un grave incidente.
Come previsto, il
Campionato del Mondo a ritornò al Regolamento di Formula 1 per
la stagione 1954, adesso basato sui motori atmosferici a 2.5 litri.
Dopo un dominio iniziale della Maserati, l'ingresso della Mercedes-Benz
portò ad un dominio assoluto suo e di Fangio (che aveva corso le
prime gare del 1954 con la Maserati). A cercare di limitare il dominio
erano la Ferrari e la Lancia guidata da Alberto Ascari per la Lancia.
Utilizzando valvole desmodromiche, iniezione diretta a benzina,
magnesio, ed altre parti piuttosto esotiche come linee del telaio
presentate con una forma alquanto allungata e altre tecniche piuttosto
avanzate, la nuova Mercedes iniziò la stagione 1954 quando
Fangio partì dalla pole position nel Gran Premio di Francia
svolto sul circuito stradale di Reims-Gueux con il primo giro percorso
a una velocità di oltre 200 km/h – fu la prima volta
nella storia della Formula 1 – prima di vincere la corsa, Fangio
ingaggiò un duello con l'altro pilota della Mercedes Karl Kling,
giunto in seconda posizione.
|

|
Le vetture Mercedes affrontarono le due stagioni seguenti con
Fangio che si aggiudicò tutte le gare lasciando agli altri piloti
soltanto tre corse. Alla fine della stagione 1955
la Mercedes si ritirò dalle gare nello stesso modo fulmineo com'era
entrata.
Avevano provato la superiorità della loro tecnologia, ma fu il
terribile disastro di una delle sue vetture sport, guidata da Pierre Levegh alla 24 Ore di Le Mans
di quell'anno, che provocò il decesso di 83 persone, a comportare il
ritiro dalle competizioni. La casa tedesca resterà lontano dalla Formula
1 fino al termine della stagione 1993
Dopo la tragedia di Le Mans, lo sport automobilistico ne uscì
totalmente sconvolto: tre Gran Premi ancora da disputarsi vennero
immediatamente cancellati e il governo svizzero annunciò il bando totale
alle corse automobilistiche disputate sul suo territorio nazionale
(tuttora in vigore. Il gran premio di Svizzera del 1982 fu disputato in
Francia, a Digione).
|
Il Gran Premio di Montecarlo 1955 vide uno spettacolare incidente
quando Ascari e la sua Lancia, dopo aver mancato una chicane, si
schiantarono contro il molo. Ascari viene sbalzato fuori dalla vettura e
cadde in acqua, vivo e apparentemente senza danni. Vi furono varie
speculazioni attorno a una emorragia interna non riscontrata quando
appena quattro giorni dopo Ascari rimase ucciso a Monza mentre
effettuava alcuni test su una vettura Ferrari sport affidatagli
dall'amico Eugenio Castellotti.
Dopo la morte di Ascari, la Lancia (alle prese con gravi problemi
finanziari) si ritirò definitivamente dalla categoria cedendo motori,
vetture, informazioni e tecnologia alla Ferrari, compreso il
progettitsta Vittorio Jano, che con Ferrari aveva lavoirato negli anni
'30 con L'Alfa Romeo.
Così nel 1956 la Ferrari si schierò con la "D50" Lancia, chiamata
"Lancia-Ferrari" in un connubio che si ripresenterà, negli anni 70-80
quando le due aziende finiranno nell'orbita FIAT con la Lancia Stratos con motore Ferrari e la Lancia LC2 nel mondiale sport.
La stagione 1956
vide Fangio fare buon uso della Ferrari – nata in casa della Lancia –
per vincere il suo quarto campionato. Lasciata la Ferrari, colse il
quinto guidando una Maserati, nel stagione 1957, stabilendo un record che resterà imbattuto per 46 anni.
|
|
 |
|
Negli anni settanta e precisamente nel
1971, edizione in cui per la prima volta si è passati dalla
classica partenza con le auto parcheggiate sulla destra del tracciato,
a quella denominata Indianapolis, dalla storica corsa americana. Una
partenza lanciata, con le auto alle spalle di una pace car per tutto il
giro di ricognizione. Una procedura sicuramente meno spettacolare, ma
necessaria per evitare brutti incidenti e salvaguardare così
la sicurezza dei piloti.
|
Un formidabile allineamento di
versioni speciali
per la 24 Ore di Le Mans, i nuovi mostri

ALFA ROMEO 33.3L 1970 - PORSCHE 908L 1969
- FERRARI 512S/L 1970
PORSCHE 917L 1971 - FERRARI 312 PB/L 1973
|
Le parole di Henri Pescarolo, vincitore di quella edizione, confermano
la necessità di un simile cambiamento: "Abbiamo deciso di
passare alla partenza lanciata. E’ più sicura,
anche se è meno interessante e spettacolare, però
tutte le gare di durata ora usano questo tipo di partenza. Quindi tutti
stanno dietro alla pace car, che dopo il giro di riscaldamento, entra
nei box e a quel punto chi è in pole deve decidere quando
accelerare e dare il via alla gara. E’una partenza meno
caratteristica con meno intensità, ma bisogna dare
più importanza alla sicurezza”.
|
Nel 1972 e nel 1973 Henri Pescarolo ottiene altre due vittorie in
coppia con il due volte mondiale di F1, Graham Hill, che
morirà 3 anni dopo in un incidente aereo. Un fantastico Tris
del team francese Matra, che riporta un successo in Francia dal 1950.
"Era stata la prima vittoria con il team Matra e con Graham Hill, dopo
una notte di pioggia. Una grande vittoria con un leggendario pilota
come compagno. E’ stato un premio per tutto il lavoro fatto
dalla squadra negli anni passati. Finalmente avevamo vinto.”
|
La terra d'America ha sempre portato fortuna a chi
la fortuna l'ha cercata con tutto sé stesso, non regalandosi
nulla, ma costruendo giorno per giorno il proprio destino,
sintetizzando il pensiero che Enzo Ferrari fece suo e che si racchiude
in queste poche parole: "Non esiste fortuna o sfortuna, ma solo quanto
noi abbiamo saputo prevedere e quanto abbiamo fatto per incrementarla o
evitarla".
Luigi Chinetti è uno di questi.
Un uomo che come Ferrari, ha lavorato sodo per diventare in un paese
"non suo", l'importatore principale di tutta la produzione Ferrari nel
nord degli Stati Uniti.
Nato a Milano il 17 luglio 1901 e quindi contemporaneo a tutti gli
effetti di Enzo Ferrari, Chinetti cominciò a lavorare a 14
anni nell'officina paterna, entrando poi in Alfa Romeo, dove come
meccanico, prestava la sua opera al Reparto Esperienze della Casa di
Arese.
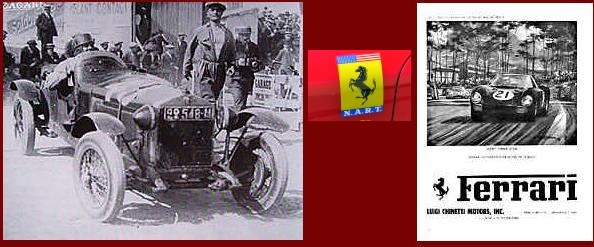
A destra, un giovane Chinetti meccanico nel 1928
|
Trasferitosi in Francia per assistere Antonio
Ascari nella gara di Montlèry del 1925, vi restò
poi come meccanico per assistere le Alfa Romeo vendute dal conte di
Carrobio. In seguito aprìrono un'officina meccanica atta
alla vendita ed assistenza delle vetture e dei motori sportivi e da
corsa del Portello. Quindi Chinetti passò alla vendita delle
vetture in prima persona, attività che negli anni, sarebbe
diventata la sua attività principale. L'epopea "corsaiola"
anteguerra di Luigi Chinetti comincia nel 1925 con una sei ore a
Parigi. Ma è nel 1932, con la vittoria alla 24 Ore di Le
Mans in coppia con Raymond Sommer, che si prende il lusso di battere la
squadra ufficiale Alfa Romeo. Nel 1933 giunge secondo alle spalle di
Nuvolari e ancora nel 1934, in coppia con "Phiphi" Etancelin, rivince
la classica gara, salendo agli onori della cronaca sportiva. Prima
dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Chinetti lasciò
Parigi per partecipare a Indianapolis come manager dell'Equipe di
Madame Schell. Ritorna nel vecchio continente soltanto nel 1949 e
approda a Maranello per acquistare una vettura da Enzo Ferrari, persona
con gli stessi interessi e probabilmente le stesse vedute nel campo
automobilistico. Ferrari fu ben lieto di vendere all'ormai quasi
cinquantenne Chinetti una 166 MM berlinetta, sapendo i fini
dell'acquisto: correre ancora a Le Mans. La Ferrari era nata come casa
costruttrice di autovetture da appena due anni e il fiuto rinomato di
Ferrari, capì al volo l'importanza della vendita e la
popolarità che avrebbe avuto la sua Azienda in caso di
affermazione a livello internazionale. Il 26 giugno 1949 alla media di
132,42 chilometri orari, la rossa berlinetta Ferrari tagliava il
traguardo a Le Mans, regalando a Chinetti e Ferrari una
pubblicità internazionale enorme.
Lord Seldson, copilota della Ferrari n° 21, si
accontentò di guidare la sua vettura per una sola ora,
lasciando al focoso Chinetti la guida per le altre 23 ore. Due
settimane dopo, il 9 e 10 luglio alla 24 Ore di Spa, Chinetti questa
volta in coppia con Jean Lucas, fece il bis con la stessa vettura. Il
nome della Ferrari cominciava a circolare negli ambienti
automobilistici sportivi mondiali. Ancora una volta Ferrari aveva visto
giusto.
Nel 1951 Chinetti ritorna alle corse partecipando alla Carrera
Panamericana con una Ferrari 212 Export della Scuderia milanese
Guastalla di Franco Cornacchia, in coppia con Piero Taruffi. Dopo sei
giorni di massacrante corsa e 3068 km percorsi su strade sterrate, la
Ferrari n° 34 taglia il traguardo di Ciudad Juarez davanti alla
Ferrari di Ascari-Villoresi. Dopo quella vittoria, nel 1954 Ferrari si
convinse ad affidare a Luigi Chinetti le vendite delle sue vetture
negli Stati Uniti, conferendogli la "nomina" di Agente Ferrari per il
Nord America. Partendo da questi presupposti, Chinetti negli anni 50
fonda la Luigi Chinetti Motors, Inc, patrocinando l'esordio
automobilistico di giovani promesse del volante.
Nel 1958 affiancato da George Arents, Jan de Vroom
e Margaret Strong, crea la North American Racing Team, seconda
esperienza di Scuderia dopo quella creata nel 1937, chiamata "Ecurie
Bleue", fondata con Madame Schell. madre del pilota Harry Schell.
Chinetti stesso ricorda che fu la scritta su di un telone di un camion:
"North American Van Lines" a suggerire l'idea di chiamare la neonata
Scuderia North American Racing Team, scegliendo il cavallino rampante
nero, simbolo della Ferrari come logo e inserendo nella parte superiore
una striscia azzurra con otto stelle bianche in campo blu e nella parte
inferiore la scritta North American Racing Team, che su consiglio dello
stesso Ferrari venne trasformata più avanti nell'acronimo
corrisponente, appunto N.A.R.T.
Il battesimo con la pista la N.A.R.T. l'ebbe il 23 marzo 1958 in
occasione della 12 Ore di Sebring.
L'equipaggio: O'Shea - Kessler - Cunningham, portarono la 250 GT al
6° posto assoluto. Bisognerà attendere fino al 22
ottobre 1961 per vedere una vettura della N.A.R.T. sul gradino
più alto del podio. L'occasione fu a Monthléry
per la 1000 km di Parigi, dove i fratelli Rodriguez conquistarono il
1° posto.
L'avventura sulle piste della North American Racing
Team durò fino al 1982, partecipando a più di 200
gare e facendo gareggiare oltre 100 piloti.
Jim Hall, Stirling Moss, Graham Hill, Giancarlo Baghetti, Umberto
Maglioli, Nino Vaccarella, Mario Andretti, sono alcuni nomi di questi
piloti che sotto i colori americani, hanno corso e vinto per la
Ferrari.

L'onore e l'onere forse più importante la N.A.R.T. l'ebbe in
occasione dei gran premi degli Stati Uniti e del Messico del 1964, dopo
che Ferrari, per i noti contrasti con le Autorità Sportive
per la mancata omologazione della 250 LM, iscrisse nelle ultime due
gare di campionato le vetture di Surtees e Bandini con i colori
dell'amico Chinetti, dopo avere restituito la licenza italiana. La
N.A.R.T. ebbe appunto l'onore di tenere a battesimo il neo Campione del
Mondo per l'anno 1964.
Alla 24 Ore di Le Mans del 1965, la coppia Gregory-Rindt con la vettura
"rinnegata" l'anno prima, la 250 LM, scrivono ancora una volta il nome
della Ferrari nell'Albo d'Oro della classica francese. Altro grande
successo la N.A.R.T. lo conseguì con la 24 Ore di Daytona
del 1967 con l' arrivo in parata ideato dall'allora D.S. Franco Lini. |
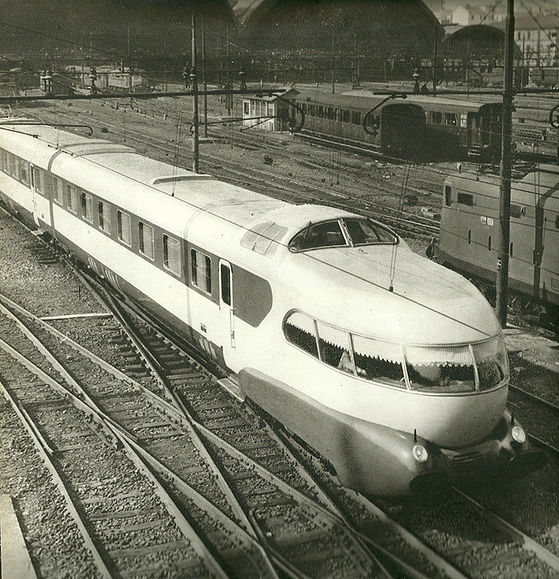 |
| Un capolavoro della tecnica : il superelettrotreno |
r |
Tour de France,1952: lo storico passaggio della borraccia tra Fausto Coppi e Gino Bartali
|
Alfa Romeo 1750 GTC Cabriolet Royal
Presente in due versioni. Quella azzurra era stata carrozzata nel 1931
dalla Touring, mentre era presente anche una versione carrozzata da Sala
risalente al 1932. L'Alfa Romeo 1750GTC era stata prodotta in
numerosissime versioni e rappresentava l'auto sportiva italiana per
eccellenza nella sua epoca. La versione 6C 1750 GS (Gran Sport) era un
sei cilindri, da 1750 cc appunto, che nel 1929 correva la Mille Miglia e
venne prodotta in 2579 esemplari. In quel periodo l'Alfa Romeo
realizzava molti modelli con una frequenza di innovazioni ed
aggiornamenti sorprendente. La 1750 GS derivava dalla precedente 1500 e
da essa nacque la 8C 2300 semplicemente aggiungendo due cilindri al
vecchio motore elevandolo di cilindrata.
|
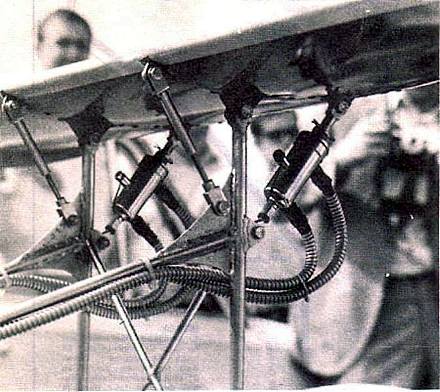 |
|
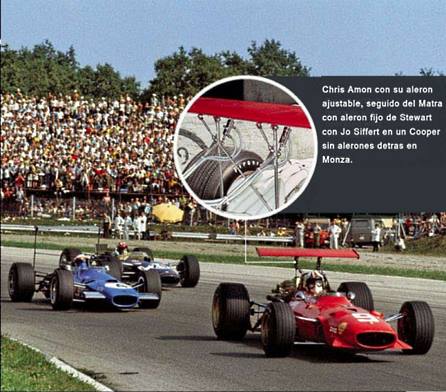 |
La velocità in curva di una macchina di Formula 1 è determinata
principalmente dalle forze aerodinamiche che spingono la vettura verso
il basso, aumentando così la tenuta delle gomme e l'aderenza al suolo.
Le auto sono leggere, ma gli alettoni con l'aumentare della velocità
conferiscono a esse un peso aggiuntivo che però non ha inerzia, e che
cresce con l'aumentare della velocità, sfruttando il principio opposto a
quello che fa volare gli aerei (“schiacciando” così l'automobile al
suolo: si veda il Principio di Bernoulli,
e si consideri che le ali di una monoposto sono rovesciate rispetto a
quelle di un aereo, schiacciando la vettura al suolo a tutto vantaggio
della guidabilità). A 160 km/h, la forza generata verso il basso è
uguale al peso della vettura; ma quando si viaggia alla massima
velocità, essa può essere pari a 2,5 volte il peso della vettura.
Inoltre, in curva si genera una forza trasversale che può arrivare a 4,5
g (= 4 volte e mezzo la forza di gravità; mentre in una normale vettura
stradale essa è di circa 0,85/1,00 g)
|
 |
|
Storia della Formula 1

La rivoluzione del motore posteriore (1958-1961)
Nonostante la configurazione base della formula rimanga invariata per il 1958, le gare furono accorciate dai circa 500 km / 300 miglia
ai 300 km / 200 miglia e le macchine usarono un particolare tipo
di benzina composto da vari tipi di miscele il cui componente primario
era il metanolo.
Con il declino di
Fangio (che si ritirerà durante l'anno), Mike Hawthorn alla
guida della Ferrari conquistò il titolo piloti nella stagione
1958 diventando così il primo pilota inglese a vincere il
titolo. La scuderia britannica Vanwall conquistò il primo titolo
riservato ai costruttori in quella stagione, ma non riuscì a
coronare le sue aspirazioni di portare un pilota inglese al titolo
iridato. Stirling Moss, nonostante avesse totalizzato un numero
maggiore di vittorie rispetto ad Hawthorn, perse il titolo per un solo
punto (Hawthorn sfruttò il regolamento dell'epoca che premiava
con un punto chi faceva il giro più veloce in gara). Questa
annata vide anche una donna guidare per la prima volta una Formula 1 in
una gara di campionato, Maria Teresa de Filippis che debuttò
guidando da privata una Maserati nel Gran Premio del Belgio..
Il 1958 fu un anno
cruciale per la Formula 1. Contro una piccola pattuglia di Ferrari e
Maserati (ritiratasi ufficialmente nella stagione precedente), Stirling
Moss vinse il Gran Premio d'Argentina guidando una vettura a motore
centrale Cooper per conto della scuderia privata di Rob Walker,
spinta da un motore 2 litri fornito dalla Coventry Climax a 4 cilindri.
Questa fu la prima vittoria per una vettura col motore posizionato
dietro al pilota in Formula 1. Il successivo Gran Premio a Montecarlo
venne vinto ugualmente dalla Cooper, guidata questa volta da Maurice
Trintignant. Spinte da motori di minore cilindrata, le Cooper rimasero
outsiders nel 1958, ma nel 1959, arrivarono i nuovi motori da 2.5 litri
della Coventry Climax e le piccole vetture britanniche passarono a
dominare la Formula 1. La stagione 1959 vide una competizione serrata
tra la scuderia Cooper dell'australiano Jack Brabham, e Moss che
correva per il team di Rob Walker sempre su Cooper. L'uso della
trasmissione della Citroën Traction Avant modificata,
rappresentò il tallone d'achille per le Cooper, e Walker
tornò a un progetto casalingo che però risultò
totalmente incompatibile con le altre componenti della vettura e
Brabham vinse il titolo, con Moss piazzato secondo.
Il stagione 1960
vide Enzo Ferrari adottare il più collaudato schema a motore anteriore,
in base al principio "i cavalli stanno davanti al carro, non dietro", mentre Lotus e BRM
introdussero le macchine a motore centrale. Il team di Rob Walker passò
al telaio della Lotus 18. Moss portò la Lotus alla sua prima vittoria
in Formula 1 a Monaco, ma la sua stagione venne rovinata da un incidente
e Brabham conquistò il suo secondo titolo con la Cooper.
La rivoluzione del motore centrale rese obsolete altre potenziali
vetture dal progetto rivoluzionario. Un particolare sistema di trazione
che agiva in contemporanea sulle quattro ruote motrici denominato "4WD"
(four wheels drive) venne impiantato sulla Ferguson P99 a motore
anteriore fornito dalla Coventry Climax per la disputa del Gran Premio
di Gran Bretagna del 1961, vincendo inoltre la Oulton Park Gold Cup, gara non valida per il campionato[, ma era troppo pesante e complessa per essere comparata alla nuova generazione delle vetture a motore centrale.
Nel 1961, nel
tentativo di diminuire le velocità, per le macchine di Formula 1
la cilindrata fu ridotta da 2.5 a 1.5 litri, non sovralimentati
(essenzialmente le allora vigenti regole per la Formula 2), una formula
che rimarrà invariata nei successivi cinque anni. Ferrari aveva
iniziato la stagione con le collaudate vetture V6 a 65º di Formula
2 con motore centrale, schierando poi nel corso della stagione un V6 a
120º ad iniezione diretta. Questo segnò segnò il
dominio della Ferrari nella stagione 1961 quando i team britannici
furono sconfitti dalla maggior potenza del motore italiano. Phil Hill
divenne il primo pilota statunitense ad aggiudicarsi il titolo
mondiale.
I primi due decenni,
negli anni cinquanta e sessanta il Campionato del Mondo di Formula 1
era solo all'inizio, la punta di un iceberg se consideriamo tutte le
gare disputate successivamente sotto il Regolamento di Formula 1. Il
numero totale di corse non valide non era variato dall'introduzione del
campionato mondiale. Molte gare celebri, come i Gran Premi di Pau e di
Siracusa, il BRDC International Trophy di Silverstone, la Race of
Champions di Brands Hatch e la citata Oulton Park Gold Cup,
continuano a non far parte del Campionato del Mondo, ma furono per
molti anni terreno di competizione per molti piloti e scuderie di gran
nome.
|
 |

ISOLA DI MAN 1969 - BOB E JENNY BEALES SULLA TRIUMPH SIDECAR 750 c.c. TT
|

Le immagini delle 15 edizioni che si sono svolte tra il 1921 ed il
1966 |
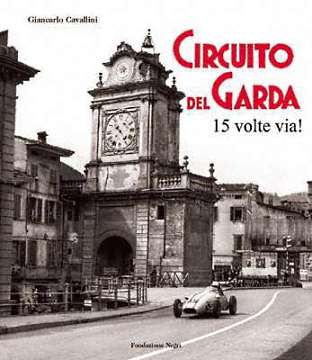 |

Il golfo di Salò fa da sfondo ai passaggi
lungo i tornanti delle Zette: da dietro i muretti gli spettatori osservano ed
incitano i centauri
|
|
|
Le immagini delle 15 edizioni che si sono svolte tra il 1921 ed il
1966 |
|
 |
 |
 |
|
Il
grande fotoreporter Tita Franzosi ci regala questa stupenda visuale dei box poco
prima della partenza; tutto è pronto per il grande spettacolo.
|
Un immagine di un tempo che non c'è più: David Piper
spinge la sua Lotus sulla griglia per la partenza della seconda
batteria.
|
Il Conte Bruno
Sterzi alla guida della sua Ferrari privata: ancora pochi giri ed uscirà di
strada tra
le località di Tormini e Villa distruggendo la
macchina
|
|
La Fiat 508 Balilla è una vettura prodotta dalla FIAT negli anni trenta grazie
a cui ebbe inizio la motorizzazione di massa in Italia.
|
 |
| Il progetto fu attuato da diverse celebri figure dell'automobilismo di quegli anni: Tranquillo Zerbi, Antonio Fessia, Bartolomeo Nebbia
e Dante Giacosa che costruirono una vettura dalle prestazioni di
classe, ma dai costi relativamente contenuti. Il modello viene
presentato alla Fiera di Milano il 12 aprile del 1932 in occasione del
Salone dell'automobile e si caratterizzava soprattutto per il prezzo
base di sole 10.800 lire. |
Circuito stradale del Mugello
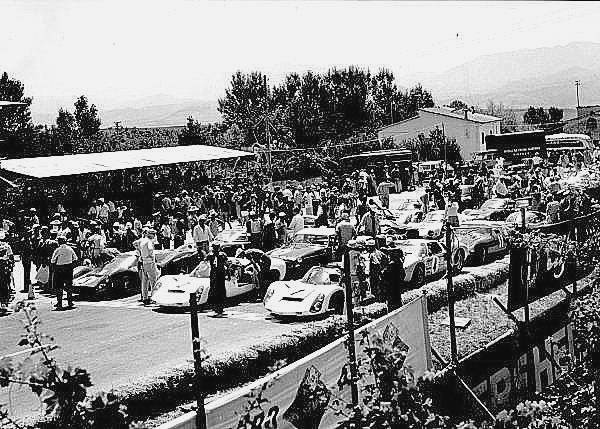 |
La
partenza originariamente e fino al 1965 (quando fu starter d'eccezione niente
meno che Juan Manuel Fangio) avveniva da S.Piero a Sieve, poi, dal '66 fino
all'ultima edizione, da Scarperia, ed il tracciato si sviluppava sulla strada
statale del Giogo (SS503), in un primo settore fino al passo appenninico (del
Giogo, appunto) che si presentava come una corsa in salita, circa 10 Km di
tornanti e brevi allunghi.
Seguiva poi il tratto più pericoloso con la
discesa fino a Firenzuola (12 Km) con un alternarsi continuo di curve
impegnative e tratti con brusche accelerazioni, un incubo in caso di
pioggia.
Da Firenzuola il tracciato saliva, fino a congiungersi a La Casetta
con la Statale del Passo della Futa (SS65) che seguiva poi fino al passo in un
tratto misto veloce di circa 15 Km per poi tuffarsi verso la pianura in pratica
continuando a percorrere in senso contrario il classico tracciato della Mille
Miglia che aveva imboccato proprio a La Casetta. |
|
|
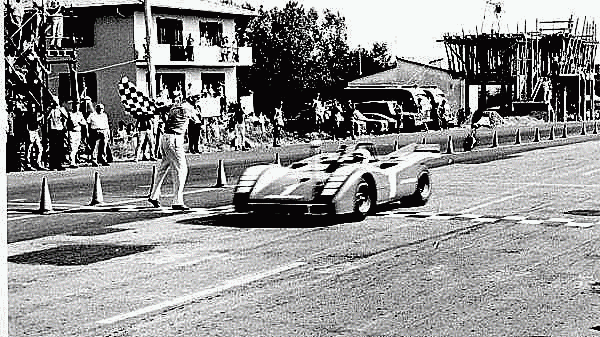 |
Una caratteristica del "Mugello stradale" era senz'altro il fatto
che i piloti si allenavano sulle strade aperte al pubblico e non era infrequente
per gli automobilisti impegnati a salire verso il Giogo o a scendere dalla Futa
vedersi superare da una bianca Porsche 911 targata Stoccarda o da una GTA col
quadrifoglio dell'Autodelta.
Altra caratteristica, a
parte alcune edizioni "bagnate", era il caldo terribile, in particolare le
edizioni corse nel '68, '69 e '70 si disputarono sotto un autentico solleone e
non furono pochi i piloti che lamentarono problemi di disidratazione e alcuni si
fermarono anche lungo il percorso per dissetarsi alla meglio.
Nel '68 Siffert
fu costretto, dall'inadeguatezza del suo compagno Steinemann, a correre sei giri
su otto, ma dopo il primo cambio era talmente esausto ed accaldato che svenne
nei box.
Ancora peggio era nelle edizioni storiche anteguerra, quando al
caldo (si è sempre corso in piena estate) si aggiungeva il tormento della
polvere delle strade sterrate.
Questo era il Mugello, queste erano le
corse anni '60. |
|
13 maggio 1950, a Silverstone la prima gara di Formula 1
|
 Nel 1950 viene introdotto un campionato piloti, la cui classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti in sette gare: Nel 1950 viene introdotto un campionato piloti, la cui classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti in sette gare:
Gran Bretagna, Svizzera, Monaco, Belgio, Francia, Italia e la 500 miglia di Indianapolis.
L'inclusione di quest'ultima gara viene fatta nel tentativo di
promuovere la Formula 1 anche negli Stati Uniti ma la cosa, come si sa,
non ebbe molto successo. L'Alfa Romeo si iscrive a questo campionato con
un team composto da tre grandissimi piloti dell'ante guerra, Giuseppe
Farina, Luigi Fagioli e Juan Manuel Fangio e, tranne per quest'ultimo, i
primi due hanno ormai un'età nella quale, contro le giovani leve delle
altre scuderie, possono far valere più che altro la loro grande
esperienza. La scuderia che dà loro più filo da torcere è la Ferrari che
però manca ancora di affidabilità e, alla fine, il campionato diventa
una sfida tra i tre piloti dell'Alfa. La gara finale, a Monza,
incoronerà il primo Campione del Mondo di Formula 1. Al via Fangio
scatta subito in testa ma per essere poi costretto al ritiro da una
rottura del cambio, dando così via libera a Farina che vince la gara ed
il mondiale.

SILVERSTONE 1950 - ALFA ROMEO ALFETTA 158
|
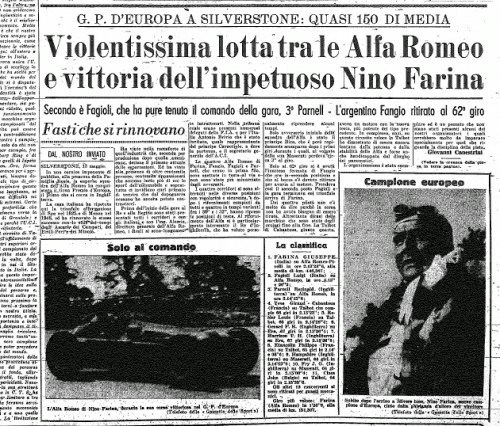 |
Il campionato del 1951 pare iniziare allo stesso punto in cui si era
interrotto quello del 1950, con l'Alfa ancora superiore alle altre
scuderie, ma questa volta la Ferrari affianca, al suo pilota Froilan
Gonzales, Alberto Ascari e Luigi Villoresi, famosi per le loro
grandissime capacità!
Fangio vince subito la gara di apertura in Svizzera ma il Gran Premio di
Germania, reinserito quell'anno nel mondiale, vede Ascari primo sul
traguardo. L'ultima gara a Pedrables in Spagna, parte con Fangio a 28
punti di vantaggio su Ascari e, con la possibilità di guadagnarne 25,
l'esito del mondiale appare già scontato. Alberto Ascari conquista
comunque la pole position ma in gara è costretto al ritiro a causa di
problemi ai pneumatici. Fangio domina la gara ed agguanta il suo primo
titolo iridato.
 Sebbene la Ferrari abbia perso ancora, il loro distacco dall'Alfa va
sempre più assottigliandosi. Da parte sua l'Alfa Romeo, a causa di
motivi finanziari, non è in grado di sviluppare ulteriormente le
monoposto e quindi di difendere il titolo: da qui la decisione di
abbandonare. Nessuno si potrà immaginare che, fino agli anni 80, questa
grandissima scuderia non riuscirà più a rientrare nel circus iridato.
La stagione del 1952 si corre con vetture di Formula 2 che prevedono
cilindrate di 500cc per i motori sovralimentati e di 2000cc per gli
altri. La Ferrari domina questo campionato ed il successivo vincendo 30
delle 33 gare principali, ma Fangio non è in grado di difendere il
titolo a causa di un incidente in una gara extra campionato che gli
causa la rottura del collo. In sua assenza Ascari vince tutte le gare
alle quali partecipa, conquistando il titolo mondiale. In quello stesso
anno fa il suo debutto il team inglese Cooper-Bristol che ha scelto Mike
Hawthorn come pilota di punta.
Il 1953 è ancora dominato dalla Ferrari che vede come unico rivale
Fangio, passato alla Maserati. Mike Hawthorn viene ingaggiato dalla
Ferrari e si ritrova in squadra con due campioni del mondo, Ascari e
Farina, e con un veterano d'eccezione, Villoresi; tre personaggi molto
scomodi e determinati a mantenere il controllo della squadra.
Ci riusciranno solo fino alla gara di Reims.
Sebbene la Ferrari abbia perso ancora, il loro distacco dall'Alfa va
sempre più assottigliandosi. Da parte sua l'Alfa Romeo, a causa di
motivi finanziari, non è in grado di sviluppare ulteriormente le
monoposto e quindi di difendere il titolo: da qui la decisione di
abbandonare. Nessuno si potrà immaginare che, fino agli anni 80, questa
grandissima scuderia non riuscirà più a rientrare nel circus iridato.
La stagione del 1952 si corre con vetture di Formula 2 che prevedono
cilindrate di 500cc per i motori sovralimentati e di 2000cc per gli
altri. La Ferrari domina questo campionato ed il successivo vincendo 30
delle 33 gare principali, ma Fangio non è in grado di difendere il
titolo a causa di un incidente in una gara extra campionato che gli
causa la rottura del collo. In sua assenza Ascari vince tutte le gare
alle quali partecipa, conquistando il titolo mondiale. In quello stesso
anno fa il suo debutto il team inglese Cooper-Bristol che ha scelto Mike
Hawthorn come pilota di punta.
Il 1953 è ancora dominato dalla Ferrari che vede come unico rivale
Fangio, passato alla Maserati. Mike Hawthorn viene ingaggiato dalla
Ferrari e si ritrova in squadra con due campioni del mondo, Ascari e
Farina, e con un veterano d'eccezione, Villoresi; tre personaggi molto
scomodi e determinati a mantenere il controllo della squadra.
Ci riusciranno solo fino alla gara di Reims.
|
|
BINOMI VINCENTI FORMULA 1

Ing. Mauro Forghieri  - Enzo Ferrari - Enzo Ferrari |
|
|
MOTORE PORTANTE
La prima F1 a motore
portante fu la Lotus 49, del 1967.
In pratica, il motore risultava
elemento strutturale capace di sostenere il resto della scocca, le
sospensioni e il cambio.
La soluzione, in realtà, fu provata già col
motore H16 BRM nella Lotus 43 del 1966 ma venne, effettivamente,
introdotta da Chapman con il modello 49.
Tuttavia, sorge un dubbio sul fatto che la Lotus 49 sia stata
realmente la prima vettura ad introdurre il concetto.
Secondo Forghieri,
infatti, la "sua" Ferrari 512 F1 del 1964/1965 introduceva quella
soluzione.
Infatti, secondo Forghieri il telaio (che non era tubolare ma
una semplice monoscocca composta da pannelli) ricopriva una semplice
funzione di rinforzo, mentre era effettivamente il motore l'elemento
portante.
Sul punto, poi, si introducono ulteriori complicazioni.
Ad
esempio, si scopre, tornando ancora più indietro, che il concetto di
motore che sostiene alcuni elementi è già presente
sulla Ferrari 158 F1
del 1964.
Quindi per certi aspetti "portante".
Probabilmente, la soluzione del problema consiste nella differenza tra motore completamente portante
e motore parzialmente sostenuto da un telaio.

Monza - La Ferrari 158 F1 di John Sutees prima della partenza della gara nel 1964
|

1964
- La nuova 158 debuttò nella seconda gara della stagione, il Gran
Premio d'Olanda, dove John Surtees conquistò
il secondo posto. Nel resto
della stagione, John Surtees conquistò due vittorie, il GP di Germania e
il GP d'Italia,
due secondi posti e un terzo posto che, nonostante
quattro ritiri, gli consentirono di vincere il mondiale piloti
con un solo punto di vantaggio su Graham
Hill.
Surtees Wins Grand Prix (1964)
1964 - Ferrari 158 F1
Telaio Monoscocca con pannelli in alluminio rivettati alla struttura tubolare
Sospensioni Ant. Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, ammortizzatori idraulici
Sospensioni Post. Ruote indipendenti, quadrilateri deformabili, molle elicoidali, 2 puntoni, ammortizzatori coassiali
Gran Premio d'Italia 1964
1 John Surtees Ferrari 158 78 2:10:51.8 1 9
2 Bruce McLaren Cooper T73-Climax 78 + 1:06.0 5 6 - 3 Lorenzo Bandini Ferrari 158 77 + 1 giro
|
|
 |
Le partenze erano con 4 macchine in prima fila, 3
in seconda fila, 4 in terza fila
e cosi fino al completamento della
griglia di partenza
BINOMI VINCENTI FORMULA 1
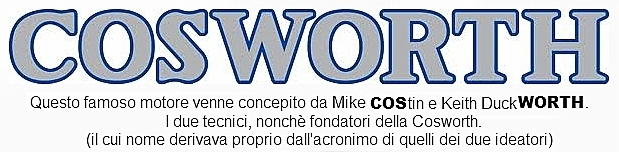
La
Ford finanziò il progetto con 100.000 sterline.
Per realizzare il DFV
si partì da un altro motore da corsa, l’FVA, anch’esso prodotto da Ford,
già impiegato in Formula 2
e a sua volta derivato dal motore della Ford
Cortina Lotus.
Mike
Costin e Keith Duckworth vennero chiamati in causa dai vertici Ford e
Lotus all’inizio del 1966 per lo sviluppo di un motore studiato
appositamente per correre in Formula 1. Una netta differenza con il
passato dove accadeva che la maggior parte
dei motori derivavano direttamente dalla serie.
Il loro compito era molto importante, perché sino a quel periodo i
costruttori di auto inglesi godevano di una certa supremazia nel campo
dello sviluppo telaistico e aerodinamico, mentre le case italiane, e
particolarmente la Ferrari, erano molto abili soprattutto nella
costruzione dei propulsori.
In un’epoca in cui le configurazioni aerodinamiche non erano esasperate come oggi, poter disporre di un motore potente
era basilare per poter lottare contro gli avversari, così lo scopo principale era quello
di riuscire almeno ad eguagliare la concorrenza.Il
propulsore era costruito totalmente in lega leggera d’alluminio, mentre
il suo peso era di 163 kg.La distribuzione era a quattro valvole per
cilindro, che venivano comandate da quattro alberi a camme in testa e
azionati da una cascata di ingranaggi.
La potenza erogata nella prima versione del 1967 era di circa 400
cv a 9.000 giri/min, mentre nelle ultime versioni del 1982-1983,
si arrivò ad incrementarla di circa 100 cv.Il
propulsore era costruito totalmente in lega leggera d’alluminio, mentre
il suo peso era di 163 kg. La distribuzione era a quattro valvole per
cilindro, che venivano comandate da quattro alberi a camme in testa e
azionati da una cascata di ingranaggi.
La potenza erogata nella prima versione del 1967 era di circa 400
cv a 9.000 giri/min, mentre nelle ultime versioni del 1982-1983,
si arrivò ad incrementarla di circa 100 cv.
|
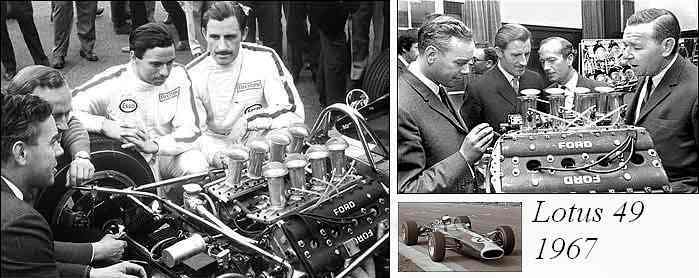 |
|
Nel
1967 la Lotus introdusse la Lotus 49, spinta dal Ford-Cosworth DFV V8,
motore che dominò la Formula 1 per i successivi 15 anni. Come il Repco,
il Cosworth era leggero e compatto ma era un autentico motore da corsa
con l’uso di 4 valvole per cilindro
e testate bialbero e garantiva molta più potenza. La Cosworth aveva
puntato ai 400 cavalli di potenza che il motore aveva addirittura
dimostrato di superare nelle prime prove. Il motore DFV era stato
progettato per essere portante
(una idea pionieristica la ebbe la Lancia con il modello D50). Questo
permise a Chapman di progettare una monoscocca che terminava subito
dopo il sedile del pilota mentre la Brabham usava una struttura tubolare
molto classica che sosteneva motore, la scatola del cambio e le
sospensioni posteriori. |
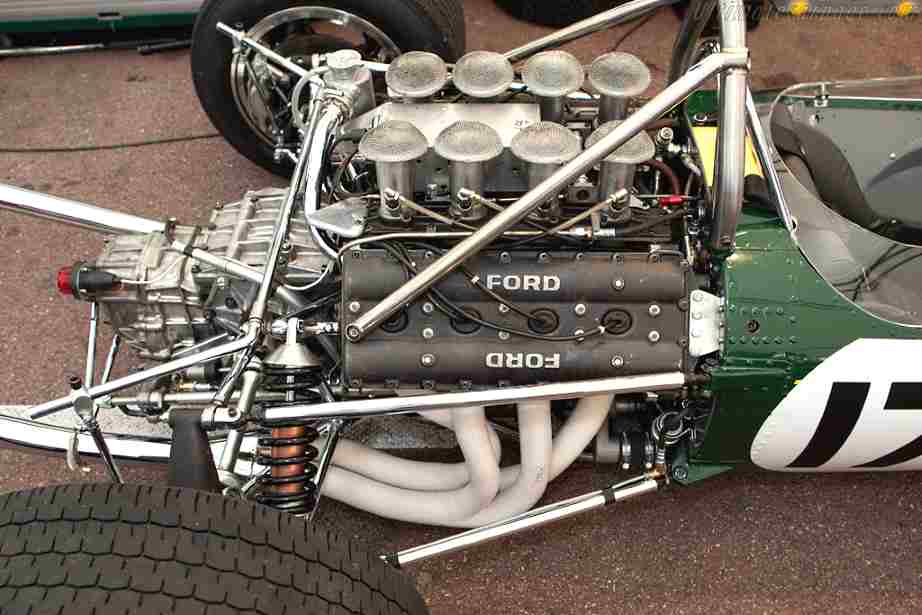
|
|

Il
primo pilota ad avere vinto una gara col DFV è stato Jim Clark con la
Lotus 49 nel 1967 (Gp d’Olanda),
mentre l’ultimo Michele Alboreto nel
1983 con la Tyrrell, ( Gp Usa-Est).
Nel
1967, anno della sua presentazione, la Lotus 49 esibiva la livrea
classica della Lotus: verde British con striscia gialla centrale.
Nei 16
mesi successivi la si poteva osservare fregiarsi di sponsor e dei nomi
dei piloti sopra lo schema base.
Graham
Hill è stato il primo a vincere il mondiale col DFV, nel
’68 sempre con la Lotus, mentre Keke Rosberg
con la Williams,
è stato l’ultimo ad ottenere il mondiale con questo motore nel 1982.

La fine del millennio ha portato con sé una
serie di lutti. Dopo la triste notizia della morte
di John Cooper alla vigilia
di Natale, mercoledì 26/2000 è morto Walter Hayes all'età di 76 anni
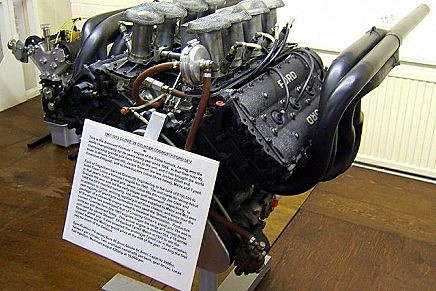 |
|
Inventore del motore Cosworth DFV (Double
Four Valve)), Walter Hayes aveva dato alla luce il motore che avrebbe ottenuto
il più grande numero di vittorie di tutta la storia della Formula 1.
Walter Hayes era entrato alla Ford nel 1962, e
presto si è ritrovato ai comandi di grandi progetti sportivi per la compagnia
americana, negli anni '60 e '70. La sua carriera lo ha portato fino alla
vice-presidenza della Ford Europe, e Walter Hayes è così diventato un'autorità
nel suo campo.
 |
Si era ritirato dal suo impiego a metà degli anni '80, lasciando
dietro di lui il ricordo di un uomo dalle decisioni sagge ed efficienti. Rimarrà
nelle memorie come colui che ha incoraggiato il finanziamento e la produzione
del motore più premiato della F1, il famoso Cosworth DFV. Il successo del DFV non è affatto dovuto al
caso. La sua nascita viene dalla congiunzione, negli anni '60, di talenti fuori
norma nella storia degli sport automobilistici. Il celeberrimo Colin Chapman è all'origine del
progetto. Un pò stanco e scoraggiato di veder sempre vincere i potentissimi
motori Ferrari e BRM, il geniale direttore della Lotus ha chiesto agli ingegneri
Costin e Duckworth di preparare il progetto di un nuovo motore, che doveva
essere potente e compatto. Colin è andato a trovare i costruttori desiderosi di
essere coinvolti in questa avventura. Ed è stato Walter Hayes ad accogliere la
sua proposta, e a decidere di finanziarla. |
Il blocco,
progettato inizialmente da Kevin Duckworth e Mike Costin, ha riportato la sua
prima vittoria nella F1 a Zandvoort, facendo così uno straordinario debutto con
Jim Clark al volante, nel Gran Premio dei Paesi Bassi del 1967. Il DFV ha
ottenuto così tutte le pole positions della stagione 1967, grazie a Jim Clark e
a Graham Hill. In seguito il nuovo Cosworth ha collezionato i più grandi titoli,
permettendo ai piloti che lo guidavano di salire sul podio per ben 155 volte.
L'ultima vittoria risale al 5 giugno del 1983, sulla Tyrrell di Michele
Alboreto, ma ancora oggi il DFV è il motore più premiato della F1, davanti alla
Ferrari ed alla Renault, che hanno ottenuto rispettivamente 135 e 95 vittorie.
|
|
|
BINOMI VINCENTI FORMULA 1
Enzo Ferrari - Alberto Ascari
 |
| La
stagione 1952, è una stagione di rilevo anzitutto dal punto di vista,
per così dire politico, infatti la federazione che gestisce la formula
uno emette un rigoroso regolamento che prevede delle notevoli
limitazioni tecniche per le vetture iscritte al mondiale. La Ferrari si
presenta con il modello 500, progettato, ancora una volta, dall'ingegner
Lampredi; è una vettura innovativa, estremamente competitiva ed
affidabile, indubbiamente la più accreditata al titolo. Si parte,
nuovamente da Berna, in occassione del primo Gp mancano all'appello i
due grandi del momento: Fangio è in attessa di un'adeguata offerta da
un'altra scuderia, a seguito del ritiro dalle corse dell'Alfa Romeo;
mentre Ascari si accinge a partecipare alla cinquecento miglia di
Indianapolis; la presenza della Ferrari negli Stati Uniti ha più che
altro uno scopo promozionale, infatti la Ferrari comincia a produrre
auto sportive stradali, e il popolo americano rappresenta un ottimo
target di vendita. Dal punto di vista sportivo è dunque, quasi,
irrilevante la gara americana che si conclude infatti con il ritiro di
Ascari dopo un inizio decisamente poco brillante. Intanto a brillare è
l'altra Ferrari quella guidata da Taruffi che a Berna stravince. Al
rientro di Ascari le cose si rivelano essere davvero molto semplici,
Ascari è uno dei migliori piloti in circolazione, la vettura è di gran
lunga superiore a tutte le altre.... la vittoria sembra essere la più
facile copnseguenza di tutto ciò; infatti sarà così il modello 500
comincia a collezzionare vittorie a ripetizione e senza alcuna
difficolta. C'era solo un uomo davvero in grado di tener testa ad una
furia come Ascari, si tratta del campione del mondo Juan Manuel Fangio;
l'argentino purtroppo sarà coinvolto in un spaventoso incidente
stradale, che fortunatamente non metterà fine alla sua carriera ma che
sicuramente renderà impossibile la sua presenza nella stagione corrente.
Per la Ferrari e per Ascari è davvero tutto molto semplice, vincono
anche con una gara d'anticipo e partecipano a Monza con la certezza del
titolo..... sembra più una parata che una gara. Nel 1952, così la
Ferrari vince per la prima volta un titolo mondia... lo fa alla sua
maniera, in grande stile, vincendo, con Ascari sei gare su otto... è
solo l'inizio di una meravigliosa favola!!!
|
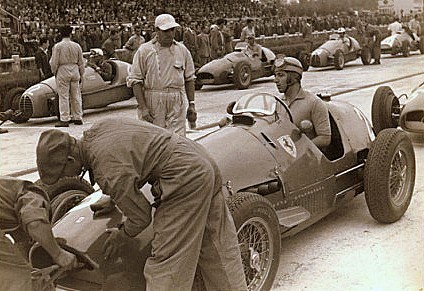 |
 |
1952 - Ascari Ferrari 500 F2 Modena
|
1951 Alberto Ascari -Monza
|
 |
 |
| 1953 13 settembre GP Italia |
1953 GP Belgio |
|
| La stagione 1953 comincia con un nuovo gran premio, si corre infatti
a Buonos Aires il Gran Premio d'Argentia, per la prima volta in
assoluto, quasi tutte le scuderie si apprestano a correre su un circuito
oltre oceano. L'appuntamento è a Gennaio, in Argentina è piena estate,
il pubblico sudamericano accoglie l'evento con notevole entusiasmo,
giungono in massa da tutta la nazione per ammirare i loro beniamini
Fangio e Gonzalez. La Ferrari affida le sue quattro vettura a Nino
Farina, Villoresi, Hawthorn (neo acquisto) ed al campione del mondo in
carica Alberto Ascari. L'ex campione del mondo argentino Fangio ed il
suo connazionale Gonzalez hanno invece trovato posto presso una scuderia
emergente, si tratta della Maserati. Al via, come da copione, Alberto
Ascari crea il vuoto, la sua Ferrari 500 è indubbiamente l'auto più
competitiva in assoluto, seppure abbia subito delle sostanziali
modifiche, il telaio è rimasto pressoché invariato. Il passo che impone
Ascari alla gara è impressionate nessuno riesce a contenere l'asso
italiano; agonisticamente si tratta dunque dell'ennesima cavalcata
solitaria Ferrari, ma purtroppo il primo Gp d'Argentina non è solo
questo: Il calore del pubblico, come evidenziato precedentemente, è
molto intenso, le norme di sicurezza del circuito sono pressoché
inesistenti, ecco dunque che al trentaduesimo giro la tragedia si
compie: Farina nell'intento di schivare un bambino che attraversa la
pista finisce sul pubblico assiepato sul tracciato, il bilancio è
pesantissimo: innumerevoli feriti ed una dozzina di morti... nonostante
ciò la gara continua indisturbata. Al traguardo il primo è Ascari
seguito da Villoresi. In Olanda e Belgio è ancora Ascari a dominare
sbaragliando decisamente la concorrenza.... in Francia invece è ancora
una Ferrari a vincere ma al volante, stavolta, non c'è l'asso italiano,
bensì l'ultimo arrivato la nuova promessa della formula uno, l'inglese
Mike Hawthorn. Il gran premio dapprima sembra aver preso la solita e
consueta "piega", ma a circa trenta giri al termine Fangio e Hawthorn
hanno la meglio su Ascari, i due proseguono, sino al traguardo dando
vita ad uno spettacolare duello: l'inglese sembra essere più veloce ma
l'esperienza di Fangio lo ostacola nettamente, il sorpasso sembra non
essere possibile, ma a qualche giro dalla fine Hawthorn si accorge che
l'argentino non usa mai la prima marcia per affrontare le curve più
lente, è evidente che la sua Maserati abbia un problema meccanico,
Hawthorn sfrutta a suo favore questo fattore tirando le curve più che
può e costringendo Fangio a frenare al limite, ovviamente nell'uscita di
curva il pilota Ferrari, a differenza, del pilota Maserati può
ingranare tranquillamente la prima marcia ed usufruire di un uscita
molto più veloce.... il sorpasso è fatto. Per la prima volta a vincere
un Gran Premio è un pilota inglese. In Inghilterra e in Svizzera vince
ancora Ascari che si aggiudica con due Gran Premi d'anticipo sulla fine
della stagione il secondo tiotolo mondiale: La Ferrari è così, accanto
all'Alfa Romeo la scuderia con il maggior numero di mondiali vinti... e
Ascari è il primo pilota della storia ad aver vinto due titoli!! I due
Gran premi finali si svolgono in Germania ed in Italia, il primo se lo
aggiudicherà Farina (sarà la sua ultima vittoria in carriera), mentre il
secondo, sarà vinto da Fangio, complice un incidente che toglie di
mezzo tutte e quattro le vetture del cavallino. La stagione è ormai
conclusa, il binomio Ferrari-Ascari sembra imbattibile e consolidato, ma
così non è....... Si affacciano sulla Formula uno altre grandi case
costruttrici: la Mercedes, l'Alfa Romeo (pensa ad un ritorno in grande
stile) e la Lancia, quest'ultima diretta da un audace Gianni Lancia. Da
subito le preoccupazioni di Ferrari riguardano, proprio la Lancia,
l'azienda italiana infatti oltre a disporre di personale altamente
qualificato può contare su un oneroso budget..... che spende, volentieri
per accaparrassi il miglior pilota in circolazione: il campione del
Mondo Alberto Ascari. Alberto fa presente a Ferrari l'offerta ricevuta
ed ammette esplicitamente di voler mantenere il suo posto in scuderia in
cambio di un piccolo ritocco contrattuale, ma il Drake è inamovibile...
dopo ore, giorni.. mesi di trattative a Dicembre..... Ascari parla per
l'ultima volta con Ferrari: esce dall'ufficio dell'ingegnere saluta i
compagni e scoppia in lacrime; dopo due giorni è ufficiale: Ascari è il
primo pilota Lancia. Si scioglie così l'invincibile binomio che aveva
dominato nettamente la formula uno in quegli anni.... Alberto Ascari non
salirà mai più su una vettura del cavallino. |
|
|
BINOMI VINCENTI FORMULA 1
Colin Chapman - Jim Clark
|
Anthony
Bruce Colin Chapman nasce a Richmond il 19 maggio 1928, si laurea in
ingegneria, diventa pilota della RAF per poi passare alla Vauxhall: in
questo periodo, il giovanissimo Chapman matura l'idea di voler creare
una propria vettura. Sogno che realizza nel '48 sulla base di una
vecchia Austin Seven: la vettura si chiama Lotus Mark 1. A questo
modello ne seguiranno altri con i quali lo stesso Chapman partecipa a
gare di club, finché, nel '54, viene creato il Racing Team Lotus: la
squadra che da lì a poco comincerà a imporsi nell'agone internazionale.
Sbocco naturale per un geniaccio della meccanica quale era Colin Chapman
è ovviamente la F.1, e il debutto nella categoria regina delle corse
avviene nel GP di Montecarlo del 1958 con una evoluzione della Lotus 12:
i piloti sono Graham Hill e Cliff Allison, ma è il 1960 l'anno del
salto di qualità per la scuderia britannica per due ragioni: le prime
due vittorie iridate con Moss a Montecarlo e Riverside, e l'arrivo in
squadra di Jim Clark, il profeta che farà diventare grande la Lotus.
|
| Clark taglia vittoriosamente il traguardo del GP di Francia 1965 |
 |
Ancora grande lotta nel campionato del 1965. A Hill e Surtees si
aggiunge l’altro scozzese Jackie Stewart.
Clark regola gli avversari con
un’impressionate strisciata iniziale di 6 vittorie (5 consecutive) e la
debacle tecnica degli ultimi
tre Gran Premi non gli impedisce di
vincere il
secondo titolo mondiale. |
|
Sempre nel ’65 Chapman lo riporta ad Indianapolis e questa volta
vincono alla grande conducendo praticamente per tutta la corsa.
Il 1966 trova la Lotus impreparata all’introduzione dei nuovi motori
da 3000 cc e la stagione diviene un calvario. Nelle tre gare in cui
non
si ritira (6), Clark è 4°(Gran Bretagna), 3° (Olanda) e vince in U.S.A.
Il Mondiale va all’australiano Jack Brabham.
L’anno successivo inizia con i migliori auspici, Clark vince subito
in Sud Africa e la stagione si presenta in discesa.
Ma il destino ha
deciso diversamente. Poche settimane dopo Jim Clark muore in un
incidente, mai completamente chiarito, schiantandosi contro un albero in
una gara di Formula 2 sul circuito di Hockenheim.
A 32 anni aveva vinto con tutte le auto con cui si era cimentato. In
Formula 1 si aggiudicò 25 Gran Premi dei 72 disputati, ottenendo 33
pole position e 28 giri veloci in gara. Tutto ciò in un periodo in cui
il pilota faceva ancora la differenza.
 |
|
|
|
BINONI VINCENTI FORMULA 1
Ayrton Senna - Ron Dennis
Ron Dennis:
Ayrton Senna era un pilota straordinario.
La sua abilità,
astuzia, sottigliezza e il suo coraggio erano di una grandezza tale che
egli ha segnato questa generazione di piloti.
[Quando andò alla Williams] Era
come se venisse ceduto in prestito temporaneo. Era quello che sentivo,
era quello che sentiva anche lui.
Non ci furono accordi formali, ma lui
sarebbe tornato. Non era una cosa impossibile. Per noi era meglio
ricostruire il team.
Per lui era meglio che andasse via, che
continuasse a vincere e che tornasse cambiato come persona. Penso che
sarebbe rimasto a lungo
in F1 e quando, alla fine, si sarebbe ritirato,
lo avrebbe fatto su una McLaren. Di questo sono assolutamente certo.
Entrambi
[Senna e Prost] volevano vincere, entrambi sapevano che la nostra
filosofia era fornire a ciascun pilota lo stesso equipaggiamento
e che
volevamo avere due prime donne. La competizione all’interno del
team era fantastica per il team stesso.
Naturalmente le loro
personalità erano molto diverse e, inevitabilmente, questo
portò a qualche attrito occasionale.
|
Non
sono una persona particolarmente emotiva, ma questi ragazzi [Senna e
Prost] hanno dato tutto. Davano sempre il cento per cento in pista e
anche ai box. Questo dà l’idea delle loro
personalità, e quando due persone ragionano, due persone che mi
piacevano molto e delle quali mi preoccupavo molto, questo non
può che provocarti emozioni.
Ci
furono periodi molto difficili nella sua carriera in F1, periodi con i
quali lottò, che non avevano nulla a che fare con la
competitività o con la mancanza di competitività, ma
piuttosto con la politica dei Gran Premi.
Ad un certo punto aveva deciso di ritirarsi. Non gli ho mai detto di non farlo. Ne parlammo
insieme, discutemmo delle alternative e alla fine la sua passione per
le corse ebbe la meglio sugli aspetti che non gli piacevano in questo
sport. Solo una cosa disprezzò sempre: la politica.
|
|
|
BINOMI VINCENTI FORMULA 1
JEAN TODT - MICHAEL SCHUMACHER
|
Michael Schumacher (Hürth,
3 gennaio 1969) è un ex pilota automobilistico tedesco,
il più vincente campione della Formula 1 e in generale uno dei
più grandi automobilisti sportivi di tutti i tempi. Ha
conquistato 7 titoli mondiali: i primi due con la Benetton (1994 e
1995) e successivamente cinque consecutivi con la Ferrari (2000, 2001,
2002, 2003, 2004).
Schumacher detiene la gran parte dei
record della Formula 1, avendo conseguito, oltre ai titoli iridati,
anche il maggior numero di Gran Premi vinti, di Pole position, di Giri
Veloci in gara, di Hat Trick (pole position, vittoria e giro
più veloce nella stessa gara). Dotato anche di grandi doti da
collaudatore in grado di far crescere le proprie vetture, Schumacher
è stato anche il primo tedesco a divenire campione del mondo di
Formula 1 ed è stato l'icona più popolare nella Formula 1
fino al 2006, secondo un sondaggio effettuato dalla FIA.
|
|
Jean Todt:
"Quando sono arrivato in Ferrari, nel 1993," ha spiegato Todt, "ho
iniziato a portare avanti un progetto che aveva molteplici scopi:
riunire a Maranello tutte le attività legate alla Formula 1;
creare strutture all’avanguardia; cercare persone di
eccellenza per tutti i ruoli; reperire le risorse economiche necessarie
per raggiungere i nostri obiettivi e scegliere partner tecnici di
valore assoluto.
C'è poi un ingrediente che nessun manager
di successo può creare senza il contributo di tutti : lo
spirito di squadra.
Credo che il mio compito principale sia proprio
quello di indirizzare le energie di tutti nella stessa direzione
perché una barca a vela in balia di venti contrastanti
è destinata a restare ferma, se non a tornare indietro."
|
 |
 |
|
|

Il Gran Premio degli Stati Uniti 1966 fu una gara di Formula 1, disputatasi il 2 ottobre 1966 sul Circuito di Watkins Glen.
Fu l'ottava prova del mondiale 1966 e vide la vittoria di Jim Clark su Lotus-BRM, seguito da Jochen Rindt e da John Surtees.
Fu
l'unico successo per il pesante motore 16 cilindri BRM che verrà
abbandonato sia dalla Lotus che dalla BRM l'anno successivo.
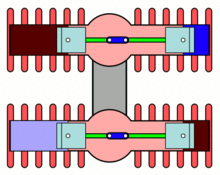
Questo motore potrebbe venire considerato come originato
dalla disposizione a tandem di due motori, un motore superiore
ed uno
inferiore, a cilindri contrapposti o del tipo boxer.
I due motori mantengono ognuno il proprio albero motore e
questi due alberi sono uniti ad un ulteriore sistema che permette di
trasferire
la potenza generata alla vettura o, nel caso di impiego in aviazione, al velivolo.
|
MV Agusta Motor S.p.A., nata come
Meccanica Verghera Agusta, è un'azienda italiana che ha prodotto in
proprio motociclette commerciali e da competizione dal 1945 al 1977.

Nata
come Società Anonima nel 1945 diventa nel 1952 Società a
responsabilità limitata per poi nello stesso anno assumere
la denominazione definitiva di Società per azioni.
Il marchio fu acquisito, nel 1992, dalla Cagiva di Schiranna
(frazione di Varese); nell'agosto del 2008 è passato al gruppo Harley-Davidson che a sua volta, nell'agosto 2010,
l'ha ceduto nuovamente allo stesso Claudio Castiglioni, ex proprietario del marchio Cagiva.
Il
suo nome è particolarmente legato alle competizioni
motociclistiche: in quelle del motomondiale si è aggiudicata dal
1952 al 1974 75 titoli iridati (38 piloti e 37 costruttori), cosa che
ne fa la casa motociclistica europea più vincente di ogni epoca. |
 |
1946 MV Agusta 98 (A2-04)
La
MV Agusta 98 è una moto molto semplice, il suo motore a due tempi
ha un cambio a soli due rapporti ed utilizza un
preselettore esterno: tecnicamente il propulsore non ha caratteristiche
tecniche innovative ed è molto simile ad altre realizzazioni
deli anni '40. Il raffredamento è ad aria co l'alettatura
particolarmente estesa e la candela di accensione posta quasi in centro
alla camera di combustione . Il telaio è in sottili tubi di
acciaio ad alta resistenza, è rigido nella parte posteriore e il
confort di marcia è affidato unicamente alle molle della larga
sella monoposto e alla forcella del tipo a parallelogramma.
|
|
Nel 1945
vide la luce la prima MV Agusta, la "98" in versione "Turismo" i cui
progetti esecutivi e stampi di fusione erano stati approntati alla fine
del 1943 e il motore girava sul banco di prova già nel 1944.
Curioso il fatto che questa moto fu presentata come "Vespa 98".
la denominazione era stata personalmente scelta dal conte Domenico
Agusta, ispirato dal sottile e acuto ronzio prodotto dal piccolo
propulsore a due tempi. Dopo le prime notizie della stampa, la MV Agusta
ricevette la formale diffida all'uso della denominazione "Vespa", da parte dei fratelli Balsamo che l'avevano depositata per il loro modello Miller Vespa del 1934..
Un tempo conclusa la vertenza legale, i fratelli Balsamo alienarono la
denominazione "Vespa" alla Piaggio che la utilizzo per il suo nuovo
scooter, destinato a diventare particolarmente noto a livello mondiale.
Le consegne della "98" iniziarono l'anno successivo, quando MV
Agusta iniziò anche la sua attività agonistica sportiva. L'esordio
vincente avvenne nella gara di regolarità con la MV98 a 3 Velocità, il 6
ottobre a La Spezia. Vittoria replicata sette giorni dopo in circuito a Valenza (AL), sull'onda delle quali venne prodotta la 98 Sport, dotata di forcella telescopica, telaio più corto, assetto ribassato, motore più potente (quasi 5 CV).
Nel 1947, al Salone di Milano,
la MV Agusta si presentò con una nutrita serie di novità:
la "98 Turismo Lusso" con cambio a 3 velocità, la "Zefiro"
con motore 2 tempi bicilindrico di 125 cm³ (rimasta a livello
prototipico) e la "250" con motore monocilindrico a 4 tempi. L'anno
successivo avvenne la partecipazione al Campionato Italiano
Velocità 125 con la 125 Tre Marce derivata dalla 98.
|
Vittorie all'ultimo giro. 
|
Quello di Mika Hakkinen al G.P. di Spagna 2001, non è certo il primo caso di
un pilota colpito dalla sfortuna, sotto forma di un problema meccanico alla
propria monoposto, all’ultimo giro di un Gran Premio iridato di Formula 1.
Ecco tutti i precedenti di coloro che hanno perso una gara di campionato del
mondo negli ultimissimi metri.
12 dicembre 1959, Sebring (Stati Uniti)
Jack Brabham, neocampione del mondo con la Cooper, domina il primo Gran Premio
degli Stati Uniti ma all’ultimo giro rimane senza benzina e si ferma lungo il
percorso. Viene superato dai compagni di squadra Bruce McLaren, che va a
vincere, e Maurice Trintignant, e dal ferrarista Tony Brooks, e arriva al
traguardo a piedi spingendo la propria vettura e staccato di cinque minuti dal
vincitore.
14 giugno 1964, Spa Francorchamps (Belgio)
A due giri dalla fine Dan Gurney (Brabham), in testa alla gara, rientra ai box
per rifornirsi ma viene fatto ripartire perché non c’è più benzina: si
fermerà lungo il tracciato. Passa al comando Graham Hill (BRM), che a metà
dell’ultimo giro si ferma anch’egli per un guasto alla pompa della benzina.
E’ in testa ora McLaren (Cooper), al quale si rompe la cinghia
dell’alternatore prima dell’ultima curva, il tornante La Source. Il
rettilineo finale è in discesa e il neozelandese spera di passarlo anche a
motore spento, ma viene superato di slancio a 100 metri dall’arrivo dalla
Lotus di Jim Clark.
10 settembre 1967, Monza (Italia)
Forse la gara più incredibile della storia. Clark (Lotus), in testa dopo 13
giri, si ferma per cambiare una gomma afflosciatasi e riparte con un giro di
ritardo. Si sdoppia dai battistrada, li raggiunge e li supera a poche tornate
dalla fine. All’ultimo giro è nettamente davanti a John Surtees (Honda) e
Brabham (Brabham), unici superstiti del gruppo di testa, ma alla curva Ascari
viene sfilato dai due, che vanno a giocarsi il successo in volata. Vincerà
Surtees, mentre Clark arriverà con oltre 20 secondi di distacco, senza benzina!
9 giugno 1968, Spa Francorchamps (Belgio)
Jackie Stewart (Matra) ha un vantaggio di mezzo minuto su McLaren (McLaren) ma
all’inizio dell’ultimo giro rientra ai box per rifornirsi. La sosta va per
le lunghe e nel frattempo la corsa termina con la vittoria di McLaren. Stewart
è classificato quarto, staccato di un giro.
10 maggio 1970, Montecarlo (Monaco)
Brabham (Brabham), al comando davanti a Jochen Rindt (Lotus), a 15 giri dalla
fine comincia ad accusare noie ai freni e rallenta vistosamente. All’ultimo
giro Rindt gli è vicino. Brabham, pressato, alla curva del gasometro,
l’ultima, va a sbattere contro il guard-rail. Rindt lo supera e va a cogliere
un insperato successo, l’australiano è secondo.
18 luglio 1970, Brands Hatch (Gran Bretagna)
Nuova beffa di Rindt ai danni di Brabham. Il pilota-costruttore sorpassa
l’austriaco a 12 giri dalla fine. All’ultima tornata ha 14’’ di
vantaggio sul rivale ma improvvisamente rimane senza benzina. Rindt lo sorpassa
spietatamente e sul traguardo lo sopravanza di oltre mezzo minuto.
17 giugno 1973, Anderstorp (Svezia)
Ronnie Peterson (Lotus) resiste per tutta la gara agli attacchi di un gruppetto
formato da Denny Hulme (McLaren), Emerson Fittipaldi (Lotus) e Stewart
(Tyrrell). A 4 passaggi dalla conclusione Fittipaldi e Stewart si ritirano per
problemi al motore. Resta solo Hulme, che all’ultima tornata approfitta delle
difficoltà di Peterson con la tenuta di strada della sua monoposto per
superarlo in extremis.
13 gennaio 1974, Buenos Aires (Argentina)
Ancora Hulme (McLaren) beneficia delle disgrazie altrui. Lo sfortunato di turno
è l’idolo locale Carlos Reutemann (Brabham) che all’ultimo giro si ferma
senza più un goccio di carburante nel serbatoio e regala l’ultimo successo
della carriera allo scontroso neozelandese.
3 luglio 1977, Digione (Francia)
Gara caratterizzata dal duello tra John Watson (Brabham) e Mario Andretti
(Lotus). L’inglese resiste ai ripetuti attacchi dell’italo-americano fino a
mezzo giro dalla fine, quando la sua vettura, equipaggiata con motore Alfa
Romeo, rimane senza benzina e “Piedone” Andretti va a vincere di misura.
4 marzo 1978, Kyalami (Sud Africa)
Stavolta Peterson approfitta delle sfortune di Riccardo Patrese (Arrows)
dominatore della corsa fino a 15 giri dal termine, e di Patrick Depailler
(Tyrrell). Il padovano viene fermato dalla rottura del motore, il transalpino è
costretto a lasciar passare Peterson all’ultimo giro perché a secco di
benzina.
23 maggio 1982, Montecarlo (Monaco)
A due giri dalla fine comincia a piovere e Alain Prost (Renault) va a sbattere
contro il guard-rail in rettilineo quando è ormai salutato da tutti vincitore.
Passa al comando Patrese (Brabham) che all’ultimo giro va in testacoda alla
curva del Loews e rimane momentaneamente fermo. Viene superato da Didier Pironi
(Ferrari) e Andrea De Cesaris (Alfa Romeo), i quali finiscono la benzina quasi
nello stesso istante e si fermano a loro volta. Nel frattempo Patrese riesce a
riaccendere il motore e piomba sul traguardo ignaro di aver vinto.
2 giugno 1991, Montreal (Canada)
Nigel Mansell (Williams) conduce la corsa dal primo metro, ma a meno di un
chilometro dal traguardo un problema elettrico gli manda fuori uso il cambio e
il “Leone” deve cedere la vittoria, l’ultima della sua carriera, a Nelson
Piquet (Benetton). Mansell verrà classificato al sesto posto.
|
|
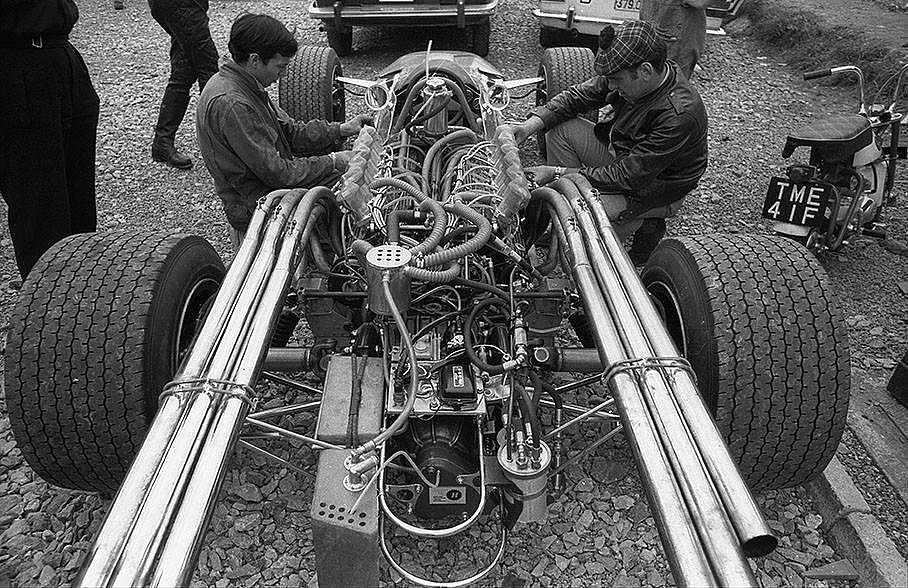 Matra Sports MS11 V12 - 1968 Matra Sports MS11 V12 - 1968
Il
V12 Matra fu declinato nel corso degli anni in una nutrita serie di
varianti, ma tutte conservarono le stesse caratteristiche di cui sopra,
più i valori di cilindrata (2993 cm³) e di alesaggio e
corsa (79.7 x 50.0 mm). Come in alcuni altri V12 sportivi
dell'epoca (tra cui il V12 BRM), gli assi a camme sono molto
ravvicinati fra loro e le valvole sono inclinate fra loro di 56°.
Durante la progettazione si è curata molto la fluidodinamica e
per questo è stato curato il disegno dei condotti di aspirazione
e scarico. L'utilizzo della lega di magnesio permise di ottenere una
struttura leggera e allo stesso scopo furono utilizzate bielle in
titanio. Tuttavia i primi prototipi di tale motore furono realizzati in
lega di alluminio ed erogavano una potenza massima di 370 CV. In
seguito ad alcuni perfezionamenti, e al definitivo utilizzo del
magnesio, la potenza fu portata a 395 CV, guadagnando anche sul piano
dell'affidabilità.
|
 |
|
Storia della Formula 1

Emergono le tecnologie (1962-1967)
Nel 1962, la
squadra Lotus mise in pista la Lotus 25 spinta dal nuovo motore della
Coventry-Climax FWMV V8. L'automobile era dotata di un telaio composto
dalla monoscocca in alluminio. Questo rappresentò un notevole
passo in avanti tecnologico dalla introduzione del motore centrale, ma
il loro inizio non fu soddisfacente. Jim Clark finì secondo in
quella stagione lasciando il titolo a Graham Hill e la sua nuova BRM V8
con il motore detto " a canne d'organo" in quanto gli scarichi erano 4
corti terminali (per ciascuna bancata) simili alle canne di un organo.
Non appena la
vettura e motore divennero affidabili, iniziò l'era della Lotus
e di Clark. Jim vinse il titolo per due volte in tre anni, nel 1963 e
nel 1965, l'unico caso nella storia di un pilota che si aggiudica il
campionato di f.1 e la 500 Miglia nello stesso anno. Per la 1964 la
Lotus introdusse la nuova Lotus 33 e la Ferrari fece un notevole sforzo
finanziario e tecnologico per vincere il titolo. La Ferrari
provò tre motori differenti durante la stagione — il
già esistente V6, il V8 ed il 12 cilindri "piatto" —
mentre la Lotus stava lottando con i problemi di gioventù della
nuova vettura. I titoli andarono a John Surtees e alla Ferrari. Il
mondiale di Surtees è passato alla storia, considerato che fu il
solo pilota a conquistare Campionati Mondiali nell'automobilismo e nel
motociclismo. Il Gran Premio del Messico del 1965 fu l'ultima gara
delle Formula 1 da 1.5 litri, e vide Richie Ginther dare alla Honda
la sua prima vittoria al termine di un'annata che, sotto tanti aspetti,
fu estremamente deludente per la debuttante scuderia giapponese.
La stagione 1966
vide un "Ritorno di Potenza" in Formula 1, dato che cambiarono le
regole per i motori ancora una volta, ammettendo motori di 3.0 litri
aspirati, o 1.5 litri sovralimentati.
Il 1966 fu anno di transizione per molte scuderie, che iniziarono la
stagione con motori 1.5 litri che con l'aumento della corsa del pistone
riuscivano a raggiungere i 2.2 litri di cilindrata, oppure ripescando i
vecchi motori 2,5 litri con cilindrata elevata a 2,7 secondo il
regolamento della Tasman cup.
La Ferrari era grande favorita con una versione di 3 litri V12
derivato da quello della Ferrari 275P (vettura sport ampiamente
testata), ma quei motori nati sulle vetture per gare di durata erano
poco potenti e e le vetture pesanti (circa 600 kg); un V6 di 2.4 litri
derivati dalla Dino F1 del 1958/1960 mantenne qualche promessa (Bandini
2º a Montecarlo), ma Surtees lasciò la squadra a metà stagione dopo una
disputa con il team manager Dragoni. Grandi problemi vennero anche dagli
pneumatici: la Ferrari all'inizio del 1966 era l'unica scuderia ad aver
progettato una vera F1 di 3000 cm³, mentre le gomme non erano ancora in
grado di sopportare le sollecitazioni dovute al raddoppio di cilindrata
e coppia.
La Coventry-Climax, fornitrice principale di gran parte dei competitori,
si ritirò dal mondo dello sport lasciando squadre come la Lotus in
difficoltà con le versioni allargate di quei motori obsoleti. La Cooper
passò allo sviluppo di un altro obsoleto Maserati V12 originariamente
progettato per la Maserati 250 F negli ultimi anni '50, mentre la BRM
effettuò la scelta di progettare un pesante e complesso motore H-16.
Il grande vincitore fu Jack Brabham, di cui la squadra omonima Brabham Racing Organisation
aveva conquistato la vittoria nei costruttori per due anni di fila con
il V8 di derivazione Oldsmobile della Repco e il telaio semplice ed
efficace. Con le due sole valvole per cilindro e non più di 330
cavalli di potenza, il motore Repco era di gran lunga meno potente
della concorrenza tra i nuovi motori da 3 litri ma diversamente dagli
altri era leggero, sicuro e affidabile fin dalla partenza delle nuove
regole. Inoltre le Brabham erano le monoposto di gran lunga più
leggere tra nuove le 3.0 litri.
Il 1966 fu l'anno di Jack Brabham, l'unico a trionfare
contemporaneamente sia come pilota che come proprietario di scuderia,
mentre nel 1967 toccò al suo compagno di squadra, il
neozelandese Denny Hulme, al quale Brabham affidò la seconda
vettura del team.
Nel 1967 la Lotus introdusse la Lotus 49, spinta dal Ford-Cosworth
DFV V8, motore che dominò la Formula 1 per i successivi 15 anni. Come il
Repco, il Cosworth era leggero e compatto ma era un autentico motore da
corsa con l'uso di 4 valvole per cilindro e testate bialbero e
garantiva molta più potenza. La Cosworth aveva puntato ai 400 cavalli di
potenza che il motore aveva addirittura dimostrato di superare nelle
prime prove. Il motore DFV era stato progettato per essere portante (una
idea pionieristica la ebbe la Lancia con il modello D50).
Questo permise a Chapman di progettare una monoscocca che terminava
subito dopo il sedile del pilota mentre la Brabham usava una struttura
tubolare molto classica che sosteneva motore, la scatola del cambio e le
sospensioni posteriori. Il neonato DFV soffrì di guasti frequenti
dovuti alle vibrazioni eccessive dell'albero motore, costringendo Keith Duckworth
a riprogettare molte parti e permettendo a Hulme di vincere la corona
mondiale piloti grazie a una maggiore affidabilità del suo V8 Repco.
Il 1967 vide anche risultati lusinghieri dal pilota rhodesiano John Love
con un Cooper-Climax da 2.7 litri a quattro cilindri; Love, che era sui
quarant'anni, anche se era visto come uno dei piloti più forti del Sudafrica
non era una stella, conducendo in testa e piazzandosi secondo nel Gran
Premio del Sudafrica di quell'anno. La Cooper di Love era
originariamente progettata per le gare più brevi della Coppa Tasmania;
per disputare un Gran Premio di durata maggiore Love aggiunse due
serbatoi di benzina ausiliari. Sfortunatamente, quei serbatoi di benzina
si guastarono e lo costrinsero al rifornimento dopo aver condotto in
testa gran parte della gara.[
John Love era il re incontrastato del campionato nazionale del
Sudafrica per vetture di Formula 1, disputato dal 1960 al 1975,
aggiudicandosi il titolo piloti sei volte negli anni '60. Le vetture da
competizione per quella serie si erano ritirate dal campionato mondiale
anche se esisteva una dura selezione di macchine costruite localmente o
modificate. I piloti da competizione in quella serie gareggiavano
normalmente le gare locali e il campionato del mondo, naturalmente solo
qualche evento occasionale disputato in Europa, anche se a quei livelli
riuscivano a ottenere soltanto piccoli successi.
Nei tardi anni '60, le gare "d'oltremare" fuori dall'Europa
costituivano almeno un terzo dei gran premi di ogni anno. Il culmine
della stagione rimaneva nel vecchio continente, dove le gare si
disputavano nella tarda primavera e in estate, mentre le gare al di
fuori del continente europeo cadevano usualmente all'inizio o alla fine
della stagione, un modello che si è protratto fino ai nostri giorni.
C'era inoltre un buon numero di gare non valide per il titolo mondiale
disputate fuori dall'Europa, e il Gran Premio del Sudafrica, insieme
alle gare in Australia, era occasionalmente una di queste.
|
 |
Effetto Venturi:
Anche l'effetto Venturi è
un'applicazione del teorema di Bernoulli che sfrutta l'accelerazione
dell'aria in un condotto ricavato fra l'asfalto ed il fondo vettura.
Il condotto era sigillato perfettamente dalle "minigonne", le bandelle
laterali che, scorrendo lungo le fiancate, impedivano all'aria di
entrare nel fondo vettura dai lati.
Dato che la portata (quantità di aria al secondo) dell'aria
sotto le fiancate non cambia, l'aria era costretta ad accelerare nel
punto di restringimento del condotto, portando ad una diminuzione della
pressione che determinava la deportanza
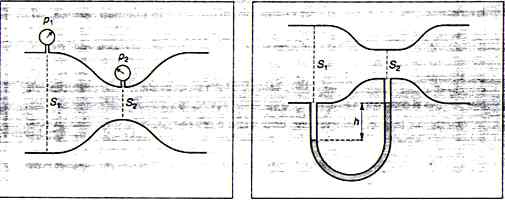 |
|
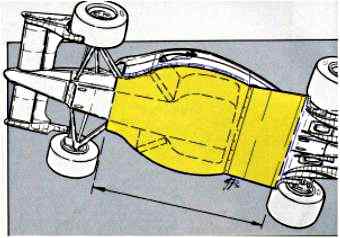 |
Era fondamentale quindi garantire il massimo
afflusso di aria con moto non turbolento (il teorema di Bernoulli non
è più valido per il moto turbolento, si riduce
l'efficienza del profilo alare) e il massimo deflusso nella parte
posteriore, che avveniva per mezzo di opportuni "estrattori" (condotti
a sezione via via più grande.
Nel tentativo di ridurre l'efficienza di tale soluzione la federazione
internazionale impose ben presto delle minigonne fisse, non
perfettamente aderenti al suolo ed arrivò nell'83 ad
introdurre un nuovo fondo piatto in cui l'effetto Venturi era limitato
ai soli diffusori (altro nome degli estrattori) posteriori.
Anche il fondo piatto tuttavia non è esente da rischi di
"decolli", basti vedere queste immagini:
|
|
|
 Le wing-car. Le wing-car.
|
 Nel 1977 vedono la luce due importanti innovazioni
tecniche: la Renault turbo fa il proprio debutto al Gran Premio di Gran Bretagna
mentre la Lotus-Ford 78 debutta in Argentina. Entrambe le vetture influenzeranno
il mondo delle corse per molti anni a venire. La Lotus è il primo risultato
felice della messa in pratica della teoria del cosiddetto "effetto suolo" (la
capacità di sfruttare l'aria che passa sotto la macchina). L'idea trae le sue
origini dalle macchine Land Speed Record nei lontani anni 30, in particolare, le
Auto Unions progettate dal Professor Eberan-Eberhorst che aveva applicato degli
elementi laterali ed un fondo sagomato che creava l'effetto venturi.
Durante il 1969 la BRM aveva portato avanti diverse sperimentazioni sui principi
dell'effetto suolo. Tempo dopo Tony Rudd e Peter Write della Lotus, che avevano
lavorato insieme alla BRM continuarono a sviluppare il concetto insieme a Ralph
Bellamy e, ovviamente, Colin Chapman. A quest'ultimo piaceva molto l'impiego
multiplo dei componenti e l'idea di sfruttare l'aria sotto la vettura accese il
suo interesse. L'elemento mancante nei modelli precedenti erano gli
alettoni laterali di tipo flessibile. Ma anche in questo caso la quantità di
pressione negativa rimaneva piuttosto bassa. Ulteriori test furono effettuati
all'interno di una galleria del vento. Chapman supponeva che riducendo la
distanza libera da terra si sarebbe avuto un aumento della pressione; i test gli
daranno ragione. Spostando il piano a profilo aerodinamico del muso più vicino
alla superficie stradale in modo che la distanza libera fosse di soli quattro
pollici si ottiene effettivamente un "sollevamento" della superficie stradale!
La squadra invia relazioni sulle proprie scoperte a Chapman ogni settimana e
viene consigliata di seguire più strade. Il primo test ha luogo nell'agosto del
1976, quando Gunnar Nilsson in segreto guida la macchina lungo il circuito di
Snetterton. Quell'anno la macchina non viene utilizzata in modo da sfruttare
l'effetto sorpresa per l'anno successivo. E certo il lancio avviene in grande,
al Gran Premio d'Argentina, ma il concetto è talmente innovativo che ben pochi
comprendono quello che stanno vedendo. . Le due nuove Lotus 78 sono guidate da
Nilsson e dall'asso americano Mario Andretti che avrebbe aiutato la Lotus a
tornare fra le grandi. Nel 1977 vedono la luce due importanti innovazioni
tecniche: la Renault turbo fa il proprio debutto al Gran Premio di Gran Bretagna
mentre la Lotus-Ford 78 debutta in Argentina. Entrambe le vetture influenzeranno
il mondo delle corse per molti anni a venire. La Lotus è il primo risultato
felice della messa in pratica della teoria del cosiddetto "effetto suolo" (la
capacità di sfruttare l'aria che passa sotto la macchina). L'idea trae le sue
origini dalle macchine Land Speed Record nei lontani anni 30, in particolare, le
Auto Unions progettate dal Professor Eberan-Eberhorst che aveva applicato degli
elementi laterali ed un fondo sagomato che creava l'effetto venturi.
Durante il 1969 la BRM aveva portato avanti diverse sperimentazioni sui principi
dell'effetto suolo. Tempo dopo Tony Rudd e Peter Write della Lotus, che avevano
lavorato insieme alla BRM continuarono a sviluppare il concetto insieme a Ralph
Bellamy e, ovviamente, Colin Chapman. A quest'ultimo piaceva molto l'impiego
multiplo dei componenti e l'idea di sfruttare l'aria sotto la vettura accese il
suo interesse. L'elemento mancante nei modelli precedenti erano gli
alettoni laterali di tipo flessibile. Ma anche in questo caso la quantità di
pressione negativa rimaneva piuttosto bassa. Ulteriori test furono effettuati
all'interno di una galleria del vento. Chapman supponeva che riducendo la
distanza libera da terra si sarebbe avuto un aumento della pressione; i test gli
daranno ragione. Spostando il piano a profilo aerodinamico del muso più vicino
alla superficie stradale in modo che la distanza libera fosse di soli quattro
pollici si ottiene effettivamente un "sollevamento" della superficie stradale!
La squadra invia relazioni sulle proprie scoperte a Chapman ogni settimana e
viene consigliata di seguire più strade. Il primo test ha luogo nell'agosto del
1976, quando Gunnar Nilsson in segreto guida la macchina lungo il circuito di
Snetterton. Quell'anno la macchina non viene utilizzata in modo da sfruttare
l'effetto sorpresa per l'anno successivo. E certo il lancio avviene in grande,
al Gran Premio d'Argentina, ma il concetto è talmente innovativo che ben pochi
comprendono quello che stanno vedendo. . Le due nuove Lotus 78 sono guidate da
Nilsson e dall'asso americano Mario Andretti che avrebbe aiutato la Lotus a
tornare fra le grandi. Quella prima gara termina con la distruzione di un
cuscinetto della ruota mentre Andretti è in lotta per il secondo posto. La gara
viene infine vinta da Jody Scheckter su una Wolf alla sua prima uscita. Durante la gara in Sud Africa si assiste ad un
tragico incidente che porta alla morte di un vigile del fuoco e del pilota
gallese Tom Pyrce. La gara viene vinta da Niki Lauda, alla sua prima vittoria
dopo il Gran Premio di Germania l'anno precedente. Per il 1977 sono previsti due
Gp degli Stati Uniti. Il GP dell'Ovest che si corre a Long Beach, in California
viene vinto dall'americano Mario Andretti che ottiene così la prima vittoria
della Lotus 78. Il Gran Premio di Spagna è la tappa seguente e la Lotus 78 dà
qui prova di grandi capacità sul campo. Andretti commenterà in seguito che per
quanto non risultasse la più veloce nei rettilinei, nelle curve sembrava
addirittura che la macchina corresse su una rotaia. Il Gran Premio di Belgio
quest'anno si corre a Zolder ma le condizioni atmosferiche sono identiche
all'anno precedente… piove. Il primo giro vede entrambe le auto della prima
fila, la Lotus di Andretti e la Brabham di John Watson eliminate in uno scontro.
Le condizioni atmosferiche certo non favoriscono i concorrenti rimasti ma il
compagno di squadra di Andretti, Gunnar Nilsson, ottiene una vittoria popolare
dopo essere partito al 3° posto. A Monaco, la Cosworth festeggia il suo 10°
anniversario quando con Scheckter raggiungono la 100° vittoria per il Mondiale
Costruttori. Monaco vede inoltre il debutto in pista di un giovane italiano di
nome Riccardo Patrese. Quella prima gara termina con la distruzione di un
cuscinetto della ruota mentre Andretti è in lotta per il secondo posto. La gara
viene infine vinta da Jody Scheckter su una Wolf alla sua prima uscita. Durante la gara in Sud Africa si assiste ad un
tragico incidente che porta alla morte di un vigile del fuoco e del pilota
gallese Tom Pyrce. La gara viene vinta da Niki Lauda, alla sua prima vittoria
dopo il Gran Premio di Germania l'anno precedente. Per il 1977 sono previsti due
Gp degli Stati Uniti. Il GP dell'Ovest che si corre a Long Beach, in California
viene vinto dall'americano Mario Andretti che ottiene così la prima vittoria
della Lotus 78. Il Gran Premio di Spagna è la tappa seguente e la Lotus 78 dà
qui prova di grandi capacità sul campo. Andretti commenterà in seguito che per
quanto non risultasse la più veloce nei rettilinei, nelle curve sembrava
addirittura che la macchina corresse su una rotaia. Il Gran Premio di Belgio
quest'anno si corre a Zolder ma le condizioni atmosferiche sono identiche
all'anno precedente… piove. Il primo giro vede entrambe le auto della prima
fila, la Lotus di Andretti e la Brabham di John Watson eliminate in uno scontro.
Le condizioni atmosferiche certo non favoriscono i concorrenti rimasti ma il
compagno di squadra di Andretti, Gunnar Nilsson, ottiene una vittoria popolare
dopo essere partito al 3° posto. A Monaco, la Cosworth festeggia il suo 10°
anniversario quando con Scheckter raggiungono la 100° vittoria per il Mondiale
Costruttori. Monaco vede inoltre il debutto in pista di un giovane italiano di
nome Riccardo Patrese.
 Al Gran Premio di Svezia ad Anderstorp, Andretti vola via
lasciando i rivali alle proprie spalle, ma resta senza carburante a due soli
giri dalla fine, regalando praticamente la vittoria a Jacques Laffite sulla sua
Ligier motorizzata Matra. Si ristabilisce l'equilibrio quando al Gran Premio di
Francia la Brabham di Watson resta a secco e Andretti a sua volta gli "ruba" la
vittoria. Di ritorno sui circuiti del Gran Premio dopo un'assenza di quasi 70
anni: ecco la pioniera francese Renault unitasi ad un altro nome illustre, la
Michelin. E' infatti quest'ultima ad introdurre nella Formula Uno i pneumatici a
tele radiali, proprio come all'inizio del secolo aveva aperto la strada per i
cerchioni rimovibili. Oltre a tutto questo, la Renault monta un "trucchetto" sul
suo manicotto che cambierà la Formula Uno nel giro di qualche anno. Le loro
macchine montano motori turbocompressi da 1,5 litri con una potenza al freno
pari a circa 500 bhp. Al Gran Premio di Svezia ad Anderstorp, Andretti vola via
lasciando i rivali alle proprie spalle, ma resta senza carburante a due soli
giri dalla fine, regalando praticamente la vittoria a Jacques Laffite sulla sua
Ligier motorizzata Matra. Si ristabilisce l'equilibrio quando al Gran Premio di
Francia la Brabham di Watson resta a secco e Andretti a sua volta gli "ruba" la
vittoria. Di ritorno sui circuiti del Gran Premio dopo un'assenza di quasi 70
anni: ecco la pioniera francese Renault unitasi ad un altro nome illustre, la
Michelin. E' infatti quest'ultima ad introdurre nella Formula Uno i pneumatici a
tele radiali, proprio come all'inizio del secolo aveva aperto la strada per i
cerchioni rimovibili. Oltre a tutto questo, la Renault monta un "trucchetto" sul
suo manicotto che cambierà la Formula Uno nel giro di qualche anno. Le loro
macchine montano motori turbocompressi da 1,5 litri con una potenza al freno
pari a circa 500 bhp.
 Entro il 1985 questi motori raggiungeranno una potenza al
freno pari a 1000 bhp. Il Gran Premio di Gran Bretagna segna il debutto del
giovane Franco-Canadese Gilles Villeneuve alla guida della McLaren M23. Con
tutto ciò, la gara viene comunque vinta da James Hunt. Il Gran Premio di
Germania viene spostato a Hockenheim e vinto da Niki Lauda. Alan Jones alla
guida di una Shadow vince a sorpresa il Gran Premio d'Austria mentre Niki Lauda
continua a fare punti con un secondo posto. Lauda accumula un'altra vittoria
nella gara successiva in Olanda e vola così in testa alla classifica mentre
Andretti, che aveva vinto ben tre corse, è continuamente afflitto da noie al
motore. Lauda conferma inoltre la propria intenzione di lasciare la scuderia di
Maranello alla fine dell'anno. Andretti vince la seconda gara in Italia ma con
il secondo posto di Lauda, il campionato è quasi nelle sue mani. Il Gran Premio
degli Stati Uniti, vinto da James Hunt, taglia la testa al toro. Entro il 1985 questi motori raggiungeranno una potenza al
freno pari a 1000 bhp. Il Gran Premio di Gran Bretagna segna il debutto del
giovane Franco-Canadese Gilles Villeneuve alla guida della McLaren M23. Con
tutto ciò, la gara viene comunque vinta da James Hunt. Il Gran Premio di
Germania viene spostato a Hockenheim e vinto da Niki Lauda. Alan Jones alla
guida di una Shadow vince a sorpresa il Gran Premio d'Austria mentre Niki Lauda
continua a fare punti con un secondo posto. Lauda accumula un'altra vittoria
nella gara successiva in Olanda e vola così in testa alla classifica mentre
Andretti, che aveva vinto ben tre corse, è continuamente afflitto da noie al
motore. Lauda conferma inoltre la propria intenzione di lasciare la scuderia di
Maranello alla fine dell'anno. Andretti vince la seconda gara in Italia ma con
il secondo posto di Lauda, il campionato è quasi nelle sue mani. Il Gran Premio
degli Stati Uniti, vinto da James Hunt, taglia la testa al toro.
 Lauda si rifiuta
di correre le ultime due gare e la Ferrari ingaggia Gilles Villeneuve per
terminare la stagione. Dopo le vittorie di Hunt e Scheckter la stagione giunge
alla fine. Parallelamente, anche per la BRM giunge il momento di concludere il
proprio rapporto con la F1; la squadra di Bourne, che aveva vinto un'ultima
volta nel 1972, chiude i battenti. Mario Andretti aveva vinto 4 gare nel 1977 ma
problemi di affidabilità avevano ristretto le sue possibilità concrete di
vincere il campionato; nel 1978 avrebbe però realizzato il suo sogno di gioventù
ottenendo finalmente il titolo iridato. Lauda si rifiuta
di correre le ultime due gare e la Ferrari ingaggia Gilles Villeneuve per
terminare la stagione. Dopo le vittorie di Hunt e Scheckter la stagione giunge
alla fine. Parallelamente, anche per la BRM giunge il momento di concludere il
proprio rapporto con la F1; la squadra di Bourne, che aveva vinto un'ultima
volta nel 1972, chiude i battenti. Mario Andretti aveva vinto 4 gare nel 1977 ma
problemi di affidabilità avevano ristretto le sue possibilità concrete di
vincere il campionato; nel 1978 avrebbe però realizzato il suo sogno di gioventù
ottenendo finalmente il titolo iridato.
Nel 1978 Andretti
viene affiancato alla Lotus da Ronnie Peterson in sostituzione di Gunnar Nilsson
affetto da un tumore che presto lo avrebbe condotto alla morte. Peterson entra
alla Lotus con un ruolo di supporto, nella speranza di rimettere in piedi la
propria carriera dopo il disastroso periodo con la Tyrrell. Per il 1978 la Lotus
impiega ora il nuovo modello 79 con scomparti laterali che possono essere
modificati a seconda delle condizioni del tracciato. In tutto, la Lotus
quell'anno vince otto delle sedici gare complessive con sei vittorie per
Andretti e due per Peterson. Ulteriore novità del 1978 era la squadra Arrows
composta da Alan Rees, Jackie Oliver e l'ex- designer della Shadow Tony
Southgate. Anche nel loro caso si tratta di una macchina alata ma con alcune
differenze di linea negli scomparti laterali. La Ferrari, con i suoi nuovi
pneumatici Michelin riesce ad agguantare più di una vittoria ma la macchina che
in assoluto colpisce di più quell'anno è sicuramente la Brabham-Alfa BT46 con
ventola posteriore per l'aspirazione dell'aria dal fondo della macchina. La
macchina fa sensazione al Gran Premio di Svezia dove riesce a portare a casa una
vittoria molto convincente. I festeggiamenti nella squadra Brabham dureranno
poco poiché la macchina viene esclusa poco dopo. Il 1978 è l'anno in cui un
pilota americano riesce a conquistare il titolo di Campione del Mondo per la
seconda volta nella storia; titolo che per Andretti resterà per sempre segnato
dalla morte del suo compagno di squadra Ronnie Peterson a Monza. Il 1978 è l'anno in cui un
pilota americano riesce a conquistare il titolo di Campione del Mondo per la
seconda volta nella storia; titolo che per Andretti resterà per sempre segnato
dalla morte del suo compagno di squadra Ronnie Peterson a Monza.
Con una decisione che avrebbe presto
rimpianto, Carlos Reutemann lascia la Ferrari per andare alla Lotus. Viene così
sostituito da Jody Scheckter che si troverà in squadra con Villeneuve. John
Watson lascia la Brabham per andare alla McLaren ed il suo posto viene affidato
al promettente brasiliano Nelson Piquet. La guerra tra Michelin e Goodyear è
tuttora in corso. Poiché la Michelin rifornisce solamente Renault e Ferrari il
loro compito è infinitamente più semplice di quello della Goodyear. Sempre più
squadre provvedono ad adattare le linee delle proprie macchine a quelle della
macchina alata; con pneumatici più morbidi le macchine migliori riescono ad
ottenere una rigidezza in curva superiore ai 3g in confronto ai valori di 1g dei
primi anni sessanta e di 0,6 - 0,7g delle ultime vetture a motore frontale negli
anni cinquanta.  La Lotus esce con la Type 80 che però si rivela un vero
disastro, e così ripiegano sulla Type 79 dell'anno precedente. Come l'anno
precedente era stata una stagione da record, questa sarebbe stata per la Lotus
una stagione in tono minore e l'inizio di un lento ma inarrestabile declino
della famosa scuderia britannica. La nuova Williams FW07 guidata da Alan Jones e
da Clay Regazzoni si dimostrerà erede di diritto della Lotus 79. Ligier aveva
deciso per un motore Ford-Cosworth DFV invece del motore Matra V12. La loro
macchina si dimostra particolarmente adatta nei percorsi tortuosi. La BT48 della
Brabham è molto veloce nelle mani di Lauda e Piquet ma problemi meccanici
continueranno ad affliggere la squadra per tutto l'anno, ad eccezione della
vittoria di Lauda al GP Dino Ferrari di Imola, gara fuori campionato. In
seguito, quell'anno, la Brabham si affideranno per la loro BT49 ad un motore
otto-cilindri Ford-Cosworth DFV. Secondo la leggenda, la Tyrrell 009 fu
costruita sui progetti del modello della Lotus 79 che la società era riuscita a
procurarsi tramite il costruttore di modelli Tamaya! La Renault inaugura la
stagione con la RS01 dell'anno precedente ma con il motore a turbocompressore
riesce ad ottenere la pole position alla prima gara della stagione. Per la gara
di Monaco si convertono al doppio turbocompressore a gas di scarico in modo da
combattere il "turbo lag"; al Gran Premio di Francia riescono infine ad ottenere
la loro prima vittoria. Le prime due corse della stagione, Argentina e Brasile,
vengono vinte da Jacques Laffite per la Ligier. La Ferrari si accaparra la gara
seguente che si svolge in Sud Africa mentre la Ligier torna alla ribalta in
Spagna, questa volta con Patrick Depailler. Il Gran Premio del Belgio è una gara
veramente competitiva nella quale la vettura di testa cambierà ben sei volte
prima che Jody Scheckter su Ferrari agguanti la testa del gruppo e mantenga la
posizione fino alla fine. Monaco si trasforma in una lotta tra Scheckter e la
Williams di Regazzoni ma per quanto tenti, il pilota svizzero non riesce a
superare la rossa. Sfortunatamente questo sarà l'ultimo Gran Premio per l'ex
Campione del Mondo James Hunt che al termine della gara lascia la Wolf e si
ritira dalle corse. La Lotus esce con la Type 80 che però si rivela un vero
disastro, e così ripiegano sulla Type 79 dell'anno precedente. Come l'anno
precedente era stata una stagione da record, questa sarebbe stata per la Lotus
una stagione in tono minore e l'inizio di un lento ma inarrestabile declino
della famosa scuderia britannica. La nuova Williams FW07 guidata da Alan Jones e
da Clay Regazzoni si dimostrerà erede di diritto della Lotus 79. Ligier aveva
deciso per un motore Ford-Cosworth DFV invece del motore Matra V12. La loro
macchina si dimostra particolarmente adatta nei percorsi tortuosi. La BT48 della
Brabham è molto veloce nelle mani di Lauda e Piquet ma problemi meccanici
continueranno ad affliggere la squadra per tutto l'anno, ad eccezione della
vittoria di Lauda al GP Dino Ferrari di Imola, gara fuori campionato. In
seguito, quell'anno, la Brabham si affideranno per la loro BT49 ad un motore
otto-cilindri Ford-Cosworth DFV. Secondo la leggenda, la Tyrrell 009 fu
costruita sui progetti del modello della Lotus 79 che la società era riuscita a
procurarsi tramite il costruttore di modelli Tamaya! La Renault inaugura la
stagione con la RS01 dell'anno precedente ma con il motore a turbocompressore
riesce ad ottenere la pole position alla prima gara della stagione. Per la gara
di Monaco si convertono al doppio turbocompressore a gas di scarico in modo da
combattere il "turbo lag"; al Gran Premio di Francia riescono infine ad ottenere
la loro prima vittoria. Le prime due corse della stagione, Argentina e Brasile,
vengono vinte da Jacques Laffite per la Ligier. La Ferrari si accaparra la gara
seguente che si svolge in Sud Africa mentre la Ligier torna alla ribalta in
Spagna, questa volta con Patrick Depailler. Il Gran Premio del Belgio è una gara
veramente competitiva nella quale la vettura di testa cambierà ben sei volte
prima che Jody Scheckter su Ferrari agguanti la testa del gruppo e mantenga la
posizione fino alla fine. Monaco si trasforma in una lotta tra Scheckter e la
Williams di Regazzoni ma per quanto tenti, il pilota svizzero non riesce a
superare la rossa. Sfortunatamente questo sarà l'ultimo Gran Premio per l'ex
Campione del Mondo James Hunt che al termine della gara lascia la Wolf e si
ritira dalle corse. Come abbiamo ricordato poc'anzi, il Gran Premio viene vinto
dalla Renault ma è la strenua lotta tra Villeneuve ed Arnoux per il secondo
posto che cattura l'attenzione dei tifosi. Questo duello con numerosi sorpassi,
alcuni dei quali addirittura in piena curva, contribuisce a far nascere la
leggenda del giovane pilota Franco-canadese. Il fatto che tale duello
riguardasse il secondo posto rende la lotta ancora più interessante. La tappa
successiva è il veloce circuito di Silverstone e qui la Williams domina la gara;
saranno lei e la Ferrari a contendersi le rimanenti gare del campionato per
conquistare il titolo. Alla fine, l'affidabilità della Ferrari si dimostra
difficile da battere e Scheckter ottiene la vittoria davanti al suo compagno di
squadra Villeneuve ed Alan Jones al terzo posto. Il nuovo decennio assiste ad
una lunga serie di cambiamenti sulla griglia di partenza, con la dismissione
della Shadow, l'unione di Wolf e Copersucar, il ritorno della Alfa-Romeo. Come abbiamo ricordato poc'anzi, il Gran Premio viene vinto
dalla Renault ma è la strenua lotta tra Villeneuve ed Arnoux per il secondo
posto che cattura l'attenzione dei tifosi. Questo duello con numerosi sorpassi,
alcuni dei quali addirittura in piena curva, contribuisce a far nascere la
leggenda del giovane pilota Franco-canadese. Il fatto che tale duello
riguardasse il secondo posto rende la lotta ancora più interessante. La tappa
successiva è il veloce circuito di Silverstone e qui la Williams domina la gara;
saranno lei e la Ferrari a contendersi le rimanenti gare del campionato per
conquistare il titolo. Alla fine, l'affidabilità della Ferrari si dimostra
difficile da battere e Scheckter ottiene la vittoria davanti al suo compagno di
squadra Villeneuve ed Alan Jones al terzo posto. Il nuovo decennio assiste ad
una lunga serie di cambiamenti sulla griglia di partenza, con la dismissione
della Shadow, l'unione di Wolf e Copersucar, il ritorno della Alfa-Romeo.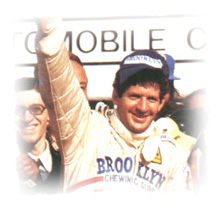 Fuori
dalla pista continuano ad esserci contrasti tra FISA e la Formula One
Constructors' Association (FOCA). Le squadre maggiori come Renault, Ferrari
(Fiat) ed Alfa-Romeo sono tendenzialmente dalla parte della FISA mentre le
squadre britanniche si trovano a sostenere la FOCA. La battaglia riguarda i
motori a turbocompressione, sostenuti dai primi e i vantaggi dell'effetto suolo,
sostenuto dagli ultimi. Le prime quattro gare di quell'anno vengono vinte da
quattro piloti diversi. Alan Jones per la Williams, Rene Arnoux per la Renault,
Nelson Piquet per la Brabham e Carlos Reutemann sulla Williams. Jones vince
nuovamente in Spagna. Qui si assiste inoltre ad un distacco tra FISA e FOCA che
risulta nel ritiro di Renault, Ferrari ed Alfa-Romeo unitamente a tutti i punti
campionato assegnati al vincitore. In questo stato di grande confusione, sarà la
Goodyear a forzare le parti ad un tavolo delle trattative. Il Gran Premio di
Francia sembra prospettare una vittoria francese con Arnoux in testa davanti a
J Fuori
dalla pista continuano ad esserci contrasti tra FISA e la Formula One
Constructors' Association (FOCA). Le squadre maggiori come Renault, Ferrari
(Fiat) ed Alfa-Romeo sono tendenzialmente dalla parte della FISA mentre le
squadre britanniche si trovano a sostenere la FOCA. La battaglia riguarda i
motori a turbocompressione, sostenuti dai primi e i vantaggi dell'effetto suolo,
sostenuto dagli ultimi. Le prime quattro gare di quell'anno vengono vinte da
quattro piloti diversi. Alan Jones per la Williams, Rene Arnoux per la Renault,
Nelson Piquet per la Brabham e Carlos Reutemann sulla Williams. Jones vince
nuovamente in Spagna. Qui si assiste inoltre ad un distacco tra FISA e FOCA che
risulta nel ritiro di Renault, Ferrari ed Alfa-Romeo unitamente a tutti i punti
campionato assegnati al vincitore. In questo stato di grande confusione, sarà la
Goodyear a forzare le parti ad un tavolo delle trattative. Il Gran Premio di
Francia sembra prospettare una vittoria francese con Arnoux in testa davanti a
J acques Laffite ma presto Jones li raggiunge e li supera. Quest'ultimo vince
ancora in Inghilterra mentre Laffite arriva primo in Germania. Dopo la vittoria
di Jean-Pierre Jabouille in Austria le due tappe successive se le aggiudica
Piquet.. la battaglia per il titolo riguarda ormai solo due piloti:
l'australiano Alan Jones ed il brasiliano Nelson Piquet. Sarà Jones a
conquistare il titolo con la vittoria sul circuito di Watkins Glen. acques Laffite ma presto Jones li raggiunge e li supera. Quest'ultimo vince
ancora in Inghilterra mentre Laffite arriva primo in Germania. Dopo la vittoria
di Jean-Pierre Jabouille in Austria le due tappe successive se le aggiudica
Piquet.. la battaglia per il titolo riguarda ormai solo due piloti:
l'australiano Alan Jones ed il brasiliano Nelson Piquet. Sarà Jones a
conquistare il titolo con la vittoria sul circuito di Watkins Glen.
|
La differenza tra una vera, completa wing-car e una Ferrari sta tutta quì sotto, nella larghezza dei profili alari.
A sinistra la T5, a destra la Tyrrell 010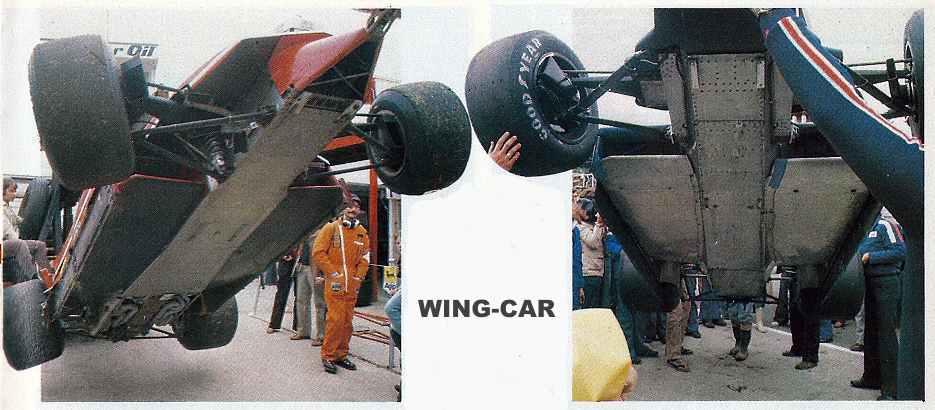
La differenza tra una vera, completa wing-car e una Ferrari sta tutta quì sotto, nella larghezza dei profili alari.
A sinistra la T5, a destra la Tyrrell 010
Classifica delle Wing-Car
 |
 |
1 - Lotus 79 (1978
|
2 - Williams FW07B (1980)
|
|
|
 |
 |
| 3 - Ferrari 126 C2 |
4 - Renault RE30 (1982) |
|
|
 |
 |
5 - Brabham BT49B (1980)
|
6 - Ligier JS11 (1979)
|
|
|
|
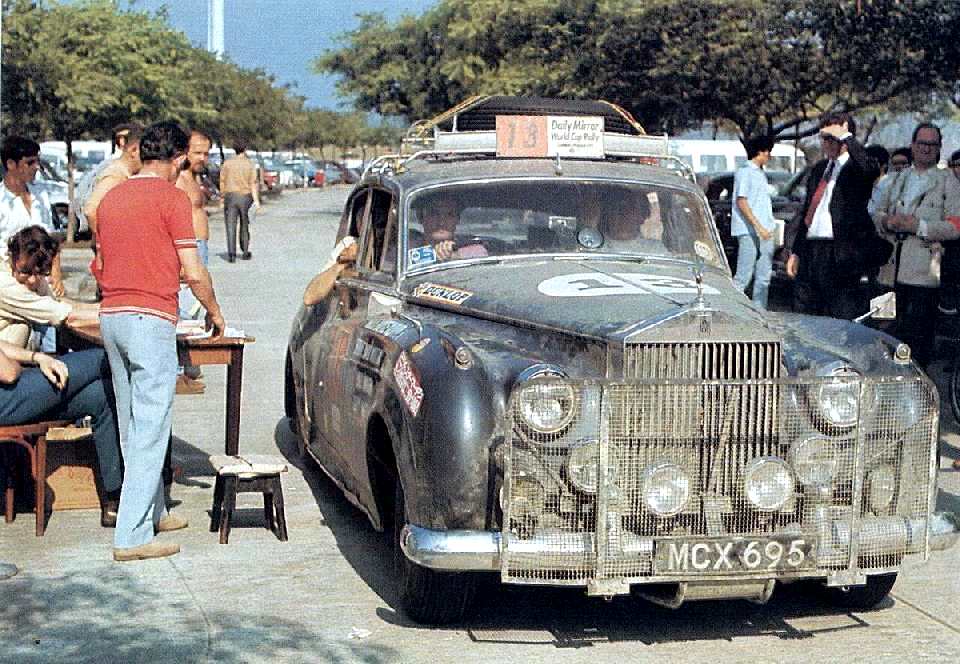 |
David Martin / William Martin /Julian Martin, Rolls Royce Silver Cloud I. Rally "Londra . Città del Messico", 1970

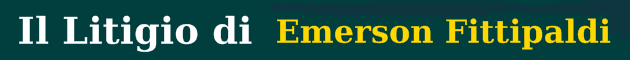
|
9
settembre 1973 - Jackie Stewart, su Tyrrell-Ford, conquistava
il suo terzo campionato del mondo.
Il pilota scozzese acquisisce la matematica certezza del titolo
arrivando quarto nel Gran Premio d’Italia, operando una spettacolare
rimonta dal ventesimo posto dopo essersi fermato per cambiare una gomma.
Ma soprattutto viene favorito dalla dissennata tattica della squadra
della Lotus.
|
 |
Ronnie Peterson
|
 |
|
Ronnie Peterson, al volante della nera vettura
inglese, conquista la pole position e alla partenza scatta in testa
seguito dal compagno di squadra Emerson Fittipaldi,
l’unico che può ancora dare fastidio a Stewart nella corsa
al mondiale. I due distanziano nettamente tutti gli avversari: Peter Revson
(McLaren-Ford) arriverà terzo a quasi mezzo minuto. Incredibilmente,
però, dai box non arrivano ordini a Peterson di lasciar passare
Fittipaldi: in pratica Colin Chapman lascia liberi i suoi due
piloti di fare la loro corsa.
Finisce così che lo svedese taglia
vittorioso il traguardo precedendo Fittipaldi di soli
8 decimi.
Il brasiliano, campione del mondo uscente e spodestato, è giustamente
indispettito dall’atteggiamento del suo team e alla fine dell’anno
passerà alla McLaren, con la quale si aggiudichera l’anno successivo il
suo secondo iride, mentre Stewart lascerà le competizioni dopo la morte
del suo compagno di squadra François Cevert nelle prove del Gran Premio degli Stati Uniti,
ultima gara del campionato del mondo del 1973.
|
|
|
|
|
Il Gran Premio di Francia si è svolto domenica 2 luglio 1961 sul circuito di Reims. La gara è stata vinta da Giancarlo Baghetti su Ferrari,
alla sua prima vittoria in Formula 1, seguito da Dan Gurney su Porsche e da Jim Clark su Lotus.
|
 Gran Premio d'Olanda 1968 - Graham Hill
Gran Premio d'Olanda 1968 - Graham Hill |
 |
|
Storia della Formula 1
Per il 1968
la Lotus perse i diritti esclusivi nell'uso della DFV. La McLaren
costruì una vettura potenziata con il DFV e nuove scuderie entrano in
scena con Ken Tyrrell fondatore di una sua propria, la Tyrrell usando le Matra-Ford con l'ex pilota della BRM Jackie Stewart
come prima guida. Clark vinse la sua ultima gara nel primo giorno
dell'anno, all'apertura di quella stagione, il Gran Premio del Sudafrica
del 1968. Il 7 aprile 1968 il due volte campione del mondo rimase
ucciso a Hockenheim durante lo svolgimento di una gara della Formula 2
non valida per il campionato europeo di categoria.
Quell'anno vide inoltre due innovazioni
significative. Il primo fu la liberalizzazione delle sponsorizzazioni
che la FIA decise di consentire dopo il ritiro dei supporti alle
scuderie. Ciascuna vettura poteva apporre scritta e colorazione diversi
dai colori nazionali. Nel maggio la Lotus, prima del Gran Premio di
Spagna si presentò a Jarama soppiantando il tradizionale colore
nazionale britannico verde nella livrea rossa, oro e bianca della marca
Gold Leaf della Imperial Tobacco. La seconda innovazione fu
l'introduzione degli alettoni che fino a quel momento si erano visti
soltanto sulle vetture di Endurance e della serie CanAm della
Chaparral. Colin Chapman iniziò ad affilare le armi di gara con
modesti ali anteriori e uno spoiler sulla Lotus 49B di Graham Hill a
Monaco. Brabham e Ferrari sono andati meglio al Gran Premio del Belgio
con ali di grande ampiezza montati su un vano alto sopra il pilota. La
Lotus rispose con ali anch'esse grandi, collegate direttamente alla
sospensione posteriore. Brabham e Matra produssero un'ala anteriore
montata e collegata alla sospensione anteriore. Alla fine di quella
stagione la maggior parte delle vetture utilizzavano alettoni mobili
con diversi sistemi di controllo. Ci furono diversi tipi di alettoni, a
forma di spunzoni, e persino quelli sprofondati in entrambe le
sospensioni. La Lotus si aggiudicò entrambi i titoli nel 1968
con Graham Hill, con Stewart classificato secondo.
La vettura Matra del 1968 fu la più
innovativa per l'uso strutturale dei serbatoi di benzina ispirati
all'aeronautica, ma la FIA decise di vietare tale tecnologia per il
1970. Per il 1969 la Matra prese la decisione radicale di entrare come
scuderia e costruire una nuova macchina usando la struttura del
serbatoio del team Tyrrell, nonostante questa soluzione valesse per una
singola stagione. La stagione 1969 partì con vetture che usavano
ali larghe e più sofisticate dell'annata precedente. Quando la
Lotus, al Gran Premio di Spagna, ruppe il fissaggio degli spunzoni ai
quali gli alettoni erano fissati, la FIA constatò la loro grande
pericolosità e li vietò dalla gara successiva di Monaco.
Vennero reintrodotti nel seguito della stagione ma con restrizioni in
dimensioni e altezza, fissate direttamente al telaio in una posizione
solida e ben definita. La questione della sicurezza cominciò a
diventare importante in Formula 1 e il Gran Premio del Belgio a Spa
rischiò di non svolgersi a causa della minaccia dei piloti di
boicottare il circuito se non fossero state aggiornate misure di
sicurezza così come da loro richiesto. Jackie Stewart vinse
facilmente il titolo del 1969 con la nuova Matra MS80, un successo
spettacolare per un costruttore e una squadra che erano entrati
soltanto l'anno precedente in Formula 1. Sarà questo il solo
titolo vinto da un telaio costruito in Francia, e bisognerà
aspettare 36 anni per vedere un altro costruttore francese (ma sempre
con base della scuderia in Gran Bretagna) conquistare il titolo. Il
1969 vide inoltre un breve ritorno di interesse nel sistema di
trasmissione sulle quattro ruote motrici, il four wheels drive, con il
record di quattro vetture equipaggiate con quel sistema schierate al
Gran Premio di Gran Bretagna. Johnny Servoz-Gavin fu il solo pilota che
prese punti con il 4WD, terminando in sesta posizione con la Matra MS84
al Gran Premio del Canada, anche se la trasmissione alle ruote
anteriori era materialmente disconnessa.[14]
Gli pneumatici larghi e le forze che spingevano la vettura verso il
basso erano risultate migliori per l'aumento del grip aerodinamico, e
questa tecnologia venne praticamente abbandonata. Jacky Ickx si
piazzò al secondo posto nel campionato su una Brabham diventata
ancora competitiva dopo l'abbandono dei motori Repco a favore di quelli
DFV.
Per la stagione 1970
la Tyrrell dopoalcune prove rifiutò di utilizzare i motori Matra V12 e
ruppe il sodalizio, passando a telai March, prima di diventare
costruttore.[.
La Matra era diventata una filiale della Chrysler e la Tyrrell derivava
molto dei relativi innesti dalla Ford e dalla Elf (associata con la
Renault) la collaborazione terminò. Ken Tyrrell acquistò il telaio 701
della March
come soluzione provvisoria in vista di sviluppare la nuova vettura per
la stagione successiva. La nuova Lotus 72 a cuneo era una macchina molto
innovatrice, caratterizzata dalla flessibilità delle sospensioni, barra
del fascio di torsione, radiatori montati posteriormente, freni
anteriori interni e l'ala posteriore sporgente. I problemi originari
della 72 erano dovuti alle sospensioni, ma una volta risolti la vettura
dimostrò la sua superiorità e la nuova prima guida della Lotus, l'austriaco Jochen Rindt,
dominò il campionato prima di morire a Monza a causa dell'improvvisa
rottura dell'albero del freno prima di affrontare la Parabolica durante
la sessione di qualifiche. Fu l'unico a conquistare il titolo postumo
per la Lotus. Il 1970 vide l'introduzione delle gomme slick dalla Goodyear.
Dopo la morte di Rindt la scuderia Lotus ebbe una
stagione 1971 alquanto interlocutoria con i suoi due nuovi e inesperti
piloti, Emerson Fittipaldi and Reine Wisell. La squadra spese gran
parte del tempo sperimentando una vettura potenziata da un motore a gas
turbina e ancora con il sistema di trasmissione sulle quattro ruote
motrici. Dopo il ritiro di Jack Brabham, il suo vecchio team – la
Brabham Racing Organisation – andò incontro a un rapido
declino. Usando il proprio telaio largamente ispirato a quello della
Matra MS80 ma più convenzionale, la Tyrrell e Jackie Stewart
raggiungono facilmente il successo in entrambi i campionati.
Con un telaio perfezionato sulla 72, adesso colorato di nero e
oro per una nuova sponsorizzazione, la John Player Special, la Lotus
conquistò il titolo nella stagione 1972
con la sorpresa ventiseienne del pilota brasiliano Emerson Fittipaldi
che divenne il campione del mondo più giovane, stabilendo un record
battuto solamente 33 anni dopo. Stewart si piazzò al secondo posto in
classifica, ma la sua stagione venne compromessa da un'ulcera allo
stomaco.
Nella stagione 1973, i due piloti della Lotus,
Fittipaldi and Ronnie Peterson gareggiarono contro la Tyrrell di
Stewart supportata da François Cévert. In quell'annata
Stewart vinse il titolo piloti, ma durante la gara finale della
stagione, il Gran Premio degli Stati Uniti
a Watkins Glen, Cevert uscì di pista durante le qualifiche del sabato
rimanendo ucciso all'istante. Stewart e la Tyrrell si ritirarono dalla
gara consegnando di fatto il titolo costruttori alla Lotus. Alla fine
della stagione Stewart rese pubblica la decisione di ritirarsi, una
decisione presa già prima di quel Gran Premio.
La McLaren terminò la stagione 1973 con tre vittorie e diverse
pole position, completando il recupero dalla morte del suo fondatore. La
personale interpretazione della McLaren sulla concezione del telaio
della Lotus 72, la M23 venne considerata il miglior progetto messo in
campo. Fittipaldi colse l'occasione di lasciare la Lotus per la McLaren
che gli offrì il posto migliore dopo che Chapman si era rifiutato di
concederlo.
|
 |
Nino Benvenuti
Campione mondiale dei pesi medi |
 |
|
Emile Griffith vs. Nino Benvenuti è stato un incontro di pugilato disputatosi il 17 aprile 1967 presso il Madison Square Garden di New York, negli Stati Uniti. Si trattò di un match (il primo di una trilogia
Griffith vs. Benvenuti) con in palio il titolo mondiale dei pesi medi
versione WBC e WBA. Benvenuti sconfisse il campione ai punti per
decisione unanime.
|
LINK: I MIGLIORI PUGILI ITALIANI
Il Timossi Arno XI è stato l’unico
motoscafo da corsa ufficialmente motorizzato
dalla Ferrari a cavallo dei lontani
anni ’50/60.
Il Ferrari Arno XI è un idroplano da record costruito in esemplare unico nel 1953 dai Cantieri Timossi
di Azzano di Tremezzina (CO) per l'ingegnere e campione di motonautica
Achille Castoldi. L'imbarcazione fu dotata di un motore Ferrari V12
realizzato appositamente: benché derivato da quello delle
monoposto 375 F1 a differenza di queste era sovralimentato dotato di due compressori volumetrici.
Il 15 ottobre 1953 durante il "Gran Premio d'Italia" Trofeo Campari ha raggiunto la velocità massima di 241,708 km/h (pari a
130,51 nodi) sul lago d'Iseo a Sarnico (BG) guidato dal pilota
argentino della Maserati José Froilán González, ad assistere al record erano presenti i piloti Alberto Ascari e Luigi Villoresi. Nel 1954 passò nelle mani del pilota e ingegnere Nando dell'Orto e
l'idroplano ritornò nel mondo delle corse fino al 1968, poi lo
lasciò in un magazzino alla periferia di Milano dove rimase fino
alla fine degli anni novanta.Nel 2012 è stato messo in vendita ad un'asta nel Principato di Monaco al Grimaldi Forum. Dal 2013 è conservato al Museo Ferrari di Maranello (MO).
|
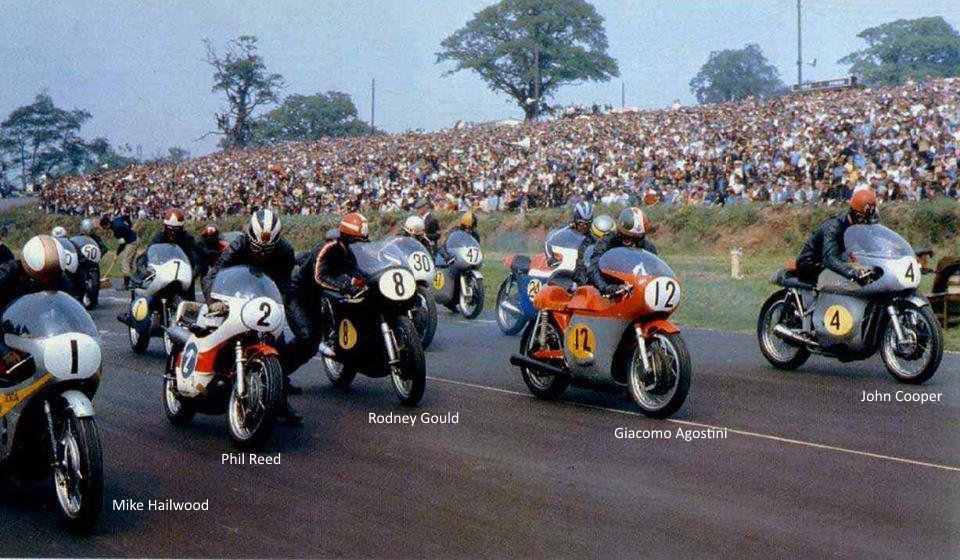 |
|
CIRCUITO DI PIACENZA
|
|
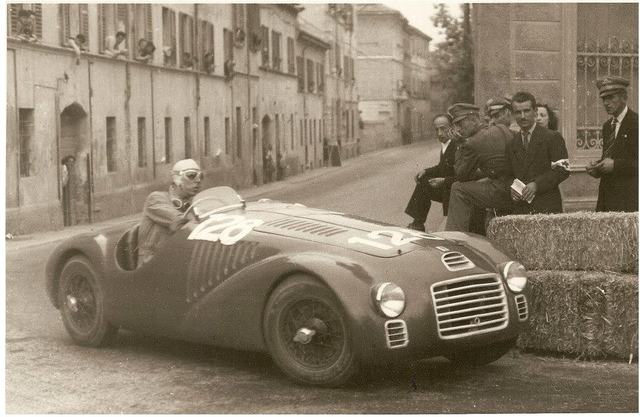
11 maggio 1947: al “Circuito di Piacenza” si scrive una pagina
importantissima della storia dell’automobile: guidata da Franco Cortese
debutta la 125 S, prima vettura a marchio Ferrari.
|
Nella classe di minor
cilindrata esordiscono, invece, Elio Zagato e Nuccio Bertone,
carrozzieri estrosi e geniali, artefici
di un’eccellenza che è
caratteristica eloquente del Made in Italy.
|
Francesco
Giardini su una sua Maserati A6GCS verso il 4° posto alla Mille
Miglia del 1955. Francesco è stato un appuntamento fisso della
Mille Miglia,
gareggiando in questa corsa ogni anno dal 1948 al 1956.
Arrivano gli inglesi..
|
 Le squadre inglesi si fanno notare sempre più frequentemente alle
griglie di partenza dei Gran Premi. L'olandese Tony Vandervell esce
dalla BRM, la prima e più grande scuderia britannica entrata nel
frattempo in crisi, e si mette in proprio. Per le auto del suo nuovo
progetto decide di adottare un motore sviluppato dalla celebre Norton
Motor Cycles, mentre commissiona il disegno del telaio a Colin Chapman.
Ai fratelli Charles e John Cooper, che avevano messo in piedi una
fiorente attività occupandosi di auto da Formula 3, affida il compito di
costruirlo e montarlo. Sarà Stirling Moss a guidare alla vittoria una di
queste nuove auto al Trofeo Internazionale di Silverstone. La Ferrari e
la Maserati continueranno a vincere grazie alla bravura di piloti come
Fangio e Hawthorn, anche se ormai per le auto italiane i tempi sono
cambiati e le rosse non riescono più a dominare in questo sport come
hanno fatto dopo la seconda guerra mondiale. Le squadre inglesi si fanno notare sempre più frequentemente alle
griglie di partenza dei Gran Premi. L'olandese Tony Vandervell esce
dalla BRM, la prima e più grande scuderia britannica entrata nel
frattempo in crisi, e si mette in proprio. Per le auto del suo nuovo
progetto decide di adottare un motore sviluppato dalla celebre Norton
Motor Cycles, mentre commissiona il disegno del telaio a Colin Chapman.
Ai fratelli Charles e John Cooper, che avevano messo in piedi una
fiorente attività occupandosi di auto da Formula 3, affida il compito di
costruirlo e montarlo. Sarà Stirling Moss a guidare alla vittoria una di
queste nuove auto al Trofeo Internazionale di Silverstone. La Ferrari e
la Maserati continueranno a vincere grazie alla bravura di piloti come
Fangio e Hawthorn, anche se ormai per le auto italiane i tempi sono
cambiati e le rosse non riescono più a dominare in questo sport come
hanno fatto dopo la seconda guerra mondiale.
Il Gran Premio di Gran
Bretagna del 1957 vede la partecipazione di tutte le auto delle scuderie
britanniche: le tre Vanwalls guidate da Moss, Brooks e Stuart
Lewis-Evans, le 2 BRM e le 3 Cooper, una delle quali guidata da Brabham.
Al via Moss si lancia in testa e prende il largo, ma la sua corsa viene
rallentata da diverse noie al motore. Al 26° giro, ormai rassegnato,
rileva l'auto di Brooks che in quel momento si trova in nona posizione.
Poi un'incredibile serie di guasti (forature, grippaggi, frizioni rotte)
colpisce i primi riconsegnando a Moss la testa della gara. Quando Moss
supera il traguardo la folla dà inizio a grandi festeggiamenti: il Gran
Premio di Gran Bretagna è stato vinto da uno dei suoi figli. Con la
Maserati che si ritira dalle corse, la stagione del 1958 prende il via
senza una delle scuderie più prestigiose.
 |
La Ferrari ha un nuovo
modello, la 246 Dino, per i suoi piloti Hawthorn, Collins e l'astro
nascente italiano Luigi Musso. La Vanwall può contare ancora una volta
su Moss, Brooks e Stuart Lewis-Evans, mentre la Cooper riconferma
Brabham e Roy Salvadori. Da quest'anno una nuova norma prevede che le
auto usino come carburante la benzina, invece dell'alcool o del metano.
Questo comporta la necessità di alcune modifiche ai vecchi motori e la
Vanwall non riesce a completare il lavoro in tempo per la gara
d'apertura in Argentina. Qui Moss, alla guida di una Cooper, si ferma
una volta in meno del solito ai box per guadagnare più tempo possibile,
ma mette in serio pericolo la durata delle sue gomme nel finale e taglia
il traguardo con i pneumatici consumati fino alle tele. Si aggiudica la
gara successiva un'altra Cooper, ma questa volta pilotata da Maurice
Trintignant, dopo una corsa ad eliminazione. Entrambe queste vittorie
sono ottenute su Cooper private, patrocinate da Rob Walker. |
La Ferrari ha un nuovo
modello, la 246 Dino, per i suoi piloti Hawthorn, Collins e l'astro
nascente italiano Luigi Musso. La Vanwall può contare ancora una volta
su Moss, Brooks e Stuart Lewis-Evans, mentre la Cooper riconferma
Brabham e Roy Salvadori. Da quest'anno una nuova norma prevede che le
auto usino come carburante la benzina, invece dell'alcool o del metano.
Questo comporta la necessità di alcune modifiche ai vecchi motori e la
Vanwall non riesce a completare il lavoro in tempo per la gara
d'apertura in Argentina. Qui Moss, alla guida di una Cooper, si ferma
una volta in meno del solito ai box per guadagnare più tempo possibile,
ma mette in serio pericolo la durata delle sue gomme nel finale e taglia
il traguardo con i pneumatici consumati fino alle tele. Si aggiudica la
gara successiva un'altra Cooper, ma questa volta pilotata da Maurice
Trintignant, dopo una corsa ad eliminazione. Entrambe queste vittorie
sono ottenute su Cooper private, patrocinate da Rob Walker. Tra queste
due prime gare passano quattro mesi:
 approfittando di questo tempo Moss
e Fangio partecipano ad una 500 km a Cuba. Fangio però non prenderà mai
parte al via poiché viene sequestrato dai ribelli filo-castristi che
stanno protestando contro la decisione del governo di sostenere
finanziariamente la competizione nonostante le terribili condizioni
economiche del paese. Fortunatamente verrà liberato poco dopo la
conclusione della corsa, vinta da Moss. Al Gran Premio d'Olanda, che si corre sul circuito di
Zandvoort, il podio è tutto britannico, con la Vanwall del vincitore
Moss e le BRM di Schell e Behra. La gara successiva, il Gran Premio del
Belgio a Spa, viene vinto da Tony Brooks, il cui stile di guida morbido
sembra esaltare le caratteristiche di questo circuito dalle curve larghe
e veloci. Con il Gran Premio di Francia si assiste al trionfo di
Hawthorn, che porta la Ferrari alla prima vittoria dal 1956, ma anche
alla tragedia della morte di Luigi Musso, l'ultimo dei grandi piloti
italiani. La gara è anche l'ultima nella formidabile carriera di Fangio.
Peter Collins all'inizio della stagione si impegna solennemente a dare
tutto il proprio aiuto all'amico Hawthorn nella caccia al titolo
mondiale e a Silverstone Collins ha l'occasione per dimostrarsi di
parola, impegnandosi in un duello con Moss. L'auto di Moss presto è
fuori uso. Collins va a vincere e il suo amico Hawthorn, finendo
secondo, incamera preziosi punti. approfittando di questo tempo Moss
e Fangio partecipano ad una 500 km a Cuba. Fangio però non prenderà mai
parte al via poiché viene sequestrato dai ribelli filo-castristi che
stanno protestando contro la decisione del governo di sostenere
finanziariamente la competizione nonostante le terribili condizioni
economiche del paese. Fortunatamente verrà liberato poco dopo la
conclusione della corsa, vinta da Moss. Al Gran Premio d'Olanda, che si corre sul circuito di
Zandvoort, il podio è tutto britannico, con la Vanwall del vincitore
Moss e le BRM di Schell e Behra. La gara successiva, il Gran Premio del
Belgio a Spa, viene vinto da Tony Brooks, il cui stile di guida morbido
sembra esaltare le caratteristiche di questo circuito dalle curve larghe
e veloci. Con il Gran Premio di Francia si assiste al trionfo di
Hawthorn, che porta la Ferrari alla prima vittoria dal 1956, ma anche
alla tragedia della morte di Luigi Musso, l'ultimo dei grandi piloti
italiani. La gara è anche l'ultima nella formidabile carriera di Fangio.
Peter Collins all'inizio della stagione si impegna solennemente a dare
tutto il proprio aiuto all'amico Hawthorn nella caccia al titolo
mondiale e a Silverstone Collins ha l'occasione per dimostrarsi di
parola, impegnandosi in un duello con Moss. L'auto di Moss presto è
fuori uso. Collins va a vincere e il suo amico Hawthorn, finendo
secondo, incamera preziosi punti. Questa amicizia ha tragicamente fine
quando Collins perde la vita nella sfida con Tony Brooks al Nurburgring.
Vincerà Brooks. La corsa al titolo di Campione del Mondo ora ha un
terzo, serio contendente: Tony Brooks. La lotta si sposta in Portogallo.
Qui Moss ha la possibilità di vincere, ma un suo errore e la sua lealtà
gli sono fatali. Hawthorn riesce così a guadagnare i 6 punti di cui ha
bisogno per continuare a mantenere la testa della classifica. Moss ha
confuso un cartello con scritto HAW-REC (Hawthorn-record)
interpretandolo HAW-REG ("tutto regolare per Hawthorn"), senza capire
quindi che il suo rivale ha appena preso un altro punto dopo aver fatto
registrare il giro di pista più veloce. Al termine della gara, inoltre,
Moss prende le difese di Hawthorn, dopo che il pilota della Ferrari è
stato accusato di aver spinto la sua auto durante la gara. Infrazione
del regolamento che avrebbe procurato a Hawthorn la squalifica, se Moss
non fosse intervenuto per salvarlo. Due anni dopo è Moss che si trova in
una situazione simile, ma nessuno lo aiuta a scagionarsi dalle accuse.
Il mondo dell'automobilismo era, nel frattempo, irrimediabilmente
cambiato. Questa amicizia ha tragicamente fine
quando Collins perde la vita nella sfida con Tony Brooks al Nurburgring.
Vincerà Brooks. La corsa al titolo di Campione del Mondo ora ha un
terzo, serio contendente: Tony Brooks. La lotta si sposta in Portogallo.
Qui Moss ha la possibilità di vincere, ma un suo errore e la sua lealtà
gli sono fatali. Hawthorn riesce così a guadagnare i 6 punti di cui ha
bisogno per continuare a mantenere la testa della classifica. Moss ha
confuso un cartello con scritto HAW-REC (Hawthorn-record)
interpretandolo HAW-REG ("tutto regolare per Hawthorn"), senza capire
quindi che il suo rivale ha appena preso un altro punto dopo aver fatto
registrare il giro di pista più veloce. Al termine della gara, inoltre,
Moss prende le difese di Hawthorn, dopo che il pilota della Ferrari è
stato accusato di aver spinto la sua auto durante la gara. Infrazione
del regolamento che avrebbe procurato a Hawthorn la squalifica, se Moss
non fosse intervenuto per salvarlo. Due anni dopo è Moss che si trova in
una situazione simile, ma nessuno lo aiuta a scagionarsi dalle accuse.
Il mondo dell'automobilismo era, nel frattempo, irrimediabilmente
cambiato.
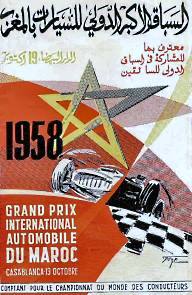 |
 |
L'ultimo Gran Premio si corre in Marocco. Qui Moss vince e fa
suo il record del giro di pista, ma Hawthorn, finendo secondo, si laurea
Campione del Mondo, primo britannico della storia, con un solo punto di
vantaggio su Moss. Verso la fine della gara Lewis-Evans esce di pista e
la sua Vanwall prende fuoco. Il pilota riesce a divincolarsi dai
rottami, ma senza liberarsi del tutto dalle fiamme. In preda al panico
scappa dai soccorritori e sei giorni più tardi muore per le gravi
ustioni riportate. Hawthorn si ritirerà dalle corse in dicembre… e
morirà in un incidente d'auto il gennaio successivo. L'automobilismo è
uno sport pericoloso e sempre lo sarà. Non si può negare che la
possibilità di ferirsi o di morire sia sempre in agguato, ma non
dobbiamo permettere che questa nostra consapevolezza ci renda cinici. I
piloti di un tempo erano più uniti fra loro di quanto non lo siano oggi
ed erano sempre molto scossi per la morte di un compagno. Noi
appassionati dovremmo gioire per la bravura e il coraggio dei piloti più
che piangere per la loro scomparsa. Chris Nixon ha scritto un bellissimo
libro, intitolato "Mon Ami Mate", sull'automobilismo sportivo degli anni
'50, il cui tema centrale è il vincolo d'amicizia tra Hawthorn e
Collins. Non potrei consigliarvi un libro più caldamente. Hawthorn si ritirerà dalle corse in dicembre… e
morirà in un incidente d'auto il gennaio successivo. L'automobilismo è
uno sport pericoloso e sempre lo sarà. Non si può negare che la
possibilità di ferirsi o di morire sia sempre in agguato, ma non
dobbiamo permettere che questa nostra consapevolezza ci renda cinici. I
piloti di un tempo erano più uniti fra loro di quanto non lo siano oggi
ed erano sempre molto scossi per la morte di un compagno. Noi
appassionati dovremmo gioire per la bravura e il coraggio dei piloti più
che piangere per la loro scomparsa. Chris Nixon ha scritto un bellissimo
libro, intitolato "Mon Ami Mate", sull'automobilismo sportivo degli anni
'50, il cui tema centrale è il vincolo d'amicizia tra Hawthorn e
Collins. Non potrei consigliarvi un libro più caldamente.
|
|

Fiat 500 A "Topolino" - 1936
|
 |
Fiat 500 B "Topolino " - 1948
|
Fiat 500 C "Topolino "- 1949
|
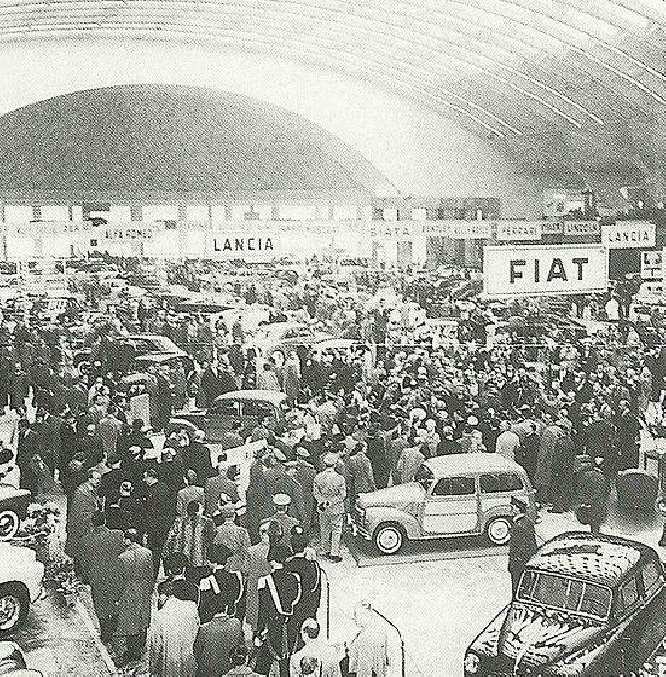
Torino Aprile 1952
Il
XXXIV Salone dell'Automobile è inaugurato da Gronchi (Roma, Archivio
Storico della CGIL).
Lo sviluppo dell'industria automobilistica italiana
divenne il simbolo della rapida
crescita economica del nostro paese.
|
 |
|
Storia della Formula 1
Ferrari e McLaren al vertice (1974-1977)
La stagione 1974
vedeva favoriti nelle previsioni la McLaren e Fittipaldi, ma era un
risultato chiuso prima del previsto. La Ferrari si riprese dalla misera
stagione 1973 con le sue prime vere vetture a monoscocca, la 312 B3
potenziata flat-12 e guidata dal giovane austriaco Niki Lauda e l'esperto pilota italo-svizzero Clay Regazzoni.
Malgrado il guasto della nuova Lotus 76, Peterson è riuscito a vincere
gare con la 72 vecchia di quattro anni. Il pilota argentino della
Brabham Carlos Reutemann fu altrettanto abile a vincere con la nuova
BT44 e il giovane talento sudafricano Jody Scheckter finì molte corse a
punti, inclusa la vittoria nel Gran Premio di Svezia
ad Anderstorp con la M23 somigliante alla Tyrrell 007. La stagione e le
speranze di Lauda si incrinarono dopo un incidente al primo giro del
Gran Premio di Germania. Soltanto l'ultima corsa della stagione decise
il titolo piloti tra Fittipaldi, Regazzoni e Scheckter.
In quest'annata le innovazioni vennero introdotte dalle Lotus 49 e
72 che cambiarono il disegno della macchina. Il motore completamente
sollecitato e sospensioni variabili flessibili erano ora la norma, la
maggior parte delle vetture avevano la carrozzeria a forma di cuneo e le
prese d'aria erano piazzate sopra le teste dei piloti. La principale
innovazione di questo periodo venne introdotta nel 1975, quando è
comparsa la Ferrari 312T con la scatola del cambio trasversale per
distribuire meglio il peso della vettura.
Le rosse vinsero tre titoli costruttori consecutivi nel 1975, 1976, e nel 1977.
Lauda conquistò con relativa facilità il suo primo titolo piloti nel
1975. La più grande sorpresa della stagione fu la piccola scuderia Hesketh che vinse il Gran Premio d'Olanda con James Hunt.
Malgrado schierasse soltanto una macchina rifiutando qualsiasi
sponsorizzazione il team finì al 4º posto nella classifica costruttori.
L'anno vide inoltre Lella Lombardi
conquistare mezzo punto terminando al 6º posto nel Gran Premio di
Spagna in una gara funestata dalla morte di quattro spettatori centrati
in pieno dalla Lola di Rolf Stommelen e quindi interrotta. Fu l'unica donna a prendere punti in un Gran Premio di Formula 1.
Questo periodo viene inoltre ricordato per la presenza di diversi
team privati che formarono una delle più enormi, variopinte e
competitive griglie nella storia dell'automobilismo. Il basso costo del
motore Ford-Cosworth DFV incoraggiò molti neofiti a debuttare nella
Formula costruendo un proprio telaio, con diversi gradi di variazione in
termini di successo. Oltre alla già citata Hesketh, Ensign, Penske, e Theodore Racing
entrarono e uscirono in poco tempo senza destare poco più di
un'impressione. La Penske in particolare, prima scuderia statunitense a
vincere un Gran Premio, nella fattispecie quello di Austria del 1976 con
John Watson, in seguito troverà maggiore gloria nella categoria americana NASCAR. Altri team, come la Shadow, Wolf, e la Arrows,
che fu l'ultima tra questi a lasciare la categoria, archiviarono molti
più successi, gareggiando da pari a pari con le scuderie più di nome.
Per il 1976, Emerson Fittipaldi, insieme al fratello Wilson,
anch'esso pilota, prese la sorprendente decisione di fondare una
scuderia propria con il decisivo sostegno finanziario delle Compagnie
dello Zucchero del Brasile, che pretese il cambio di denominazione – da Fittipaldi Automotive a Copersucar
– e la livrea della vettura con i colori nazionali e la bandiera
brasiliana. James Hunt, appena venne a conoscenza del futuro della
Hesketh, compromesso dalla mancanza di uno sponsor (Lord Hesketh ha
tentato di ottenere maggiori finanziamenti, stabilito che Hunt era in
grado di lottare per il titolo, ma non poteva più permettersi di
finanziare la scuderia soltanto con le sue risorse personali), firmò un
contratto con la McLaren. Nel 1976 il secondo titolo successivo per
Lauda sembrava inevitabile, fino al suo arresto improvviso sotto la
pioggia nell'incidente occorso al Bergwerk durante il secondo giro
dell'ultimo Gran Premio di Germania corso al vecchio Nürburgring,
riportando gravi ustioni. Gli erano state impartite le estreme unzioni,
ma incredibilmente si riprese e guidò la Ferrari sei settimane più
tardi nel Gran Premio d'Italia. Perse il campionato per un solo punto su
James Hunt nella gara finale, disputata in condizioni impossibili sotto
una pioggia battente al Fuji
nella prima edizione del Gran Premio del Giappone quando dopo aver
percorso appena un giro lasciò la sua vettura parcheggiata nei box,
dichiarando che il rischio era troppo grande e rifiutandosi di
gareggiare in quelle condizioni estreme.
L'innovazione più radicale del 1976 venne dalla Tyrrell P34
equipaggiata con 6 ruote. La P34 era una buona macchina, spesso
terminava le gare terza o quarta e vincendo inoltre il Gran Premio di
Svezia, ma non era superiore alle migliori vetture a 4 ruote. Il 1976
vide la scuderia Lotus adottare le spazzole di montaggio o pannelli
esterni in plastica sotto la assai poco competitiva 77; McLaren e
Brabham sperimentarono con dighe e divisori nel tentativo di diminuire
l'area di bassa pressione sotto l'automobile, ma non trovarono effetti
significativi sulle prestazioni; nei fatti nessuno era a conoscenza
delle vere intenzioni di Chapman.
Le polemiche seguite alla gara del Fuji danneggiarono le relazioni
tra Lauda ed Enzo Ferrari. Il pilota austriaco divenne ufficialmente la
seconda guida della scuderia, mentre Carlos Reutemann era il leader.
Lauda firmò un contratto con la Brabham alla fine della stagione 1977,
dopo aver constatato che Enzo Ferrari rifiutava di dargli una vettura
per la fine della stagione. Il suo secondo titolo era basato
principalmente su regolarità e affidabilità. Malgrado i conflitti con il
proprietario e lo status di seconda guida, Lauda godeva di grande
rispetto nel team Ferrari che lo mise sempre in condizione di dare il
meglio dalla sua vettura. Nei fatti era un'annata tra le più competitive
di sempre ma nessun altro rivale del pilota austriaco emerse a tentare
di togliere punti per la conquista dei due titoli. A sorpresa, la nuova
scuderia Wolf, nata dalle ceneri della Frank Williams Racing Cars
e la Hesketh, vinse all'esordio assoluto nel Gran Premio di Argentina
stabilendo inoltre un connubio eccellente con Jody Scheckter che finì
secondo dietro a Niki Lauda.
Il 1977 vide anche due innovazioni tecniche radicali destinate a
cambiare il futuro della Formula 1. Lo scopo degli esperimenti della
Lotus effettuati nel 1976 venne rivelato con la Lotus 78, che introdusse
l'effetto suolo
per la prima volta nella massima serie, usando i profili alari
sigillati a terra facendo scorrere i pannelli esterni. Generava un
improvviso aumento delle forze al suolo diminuendo drasticamente
improvvisi malfunzionamenti.[ La Lotus 78, guidata da Mario Andretti e Gunnar Nilsson vinse cinque Gran Premi nel 1977. La Renault
rivelò il secondo quando la loro RS01 ha fatto la prima apparizione
potenziata da un motore turbo da 1.5 litri, derivato dalle loro vetture
nella categoria sport. Anche se i motori sovralimentati avevano avuto un
certo successo negli anni '50 e i regolamenti che ammettevano i motori
turbocompressi erano esistiti per 11 anni, nessuna scuderia di Formula 1
ne costruì una, ritenendo che il consumo di combustibile e il ritardo
di spinta negherebbe la sua potenza superiore. L'ingegnere motoristico Bernard Dudot, che aveva osservato i motori della Offenhauser usati nella serie statunitense Indycar, spinse per questa scelta.
L'entrata della Renault significò anche l'acquisto degli
pneumatici radiali in Formula 1, forniti dalla Michelin. La Goodyear,
che godeva del monopolio prima dell'entrata della Michelin, usava ancora
la gomma progettata con pieghe trasversali per le gare. La Goodyear
vide questa entrata della casa francese come una seria minaccia e fece
uno sforzo notevole nella ricerca e sviluppo per le proprie gomme sulla
parte radiale. La stagione 1977 per la Tyrrell fu disastrosa perché la
Goodyear era troppo occupata a fornire i quattro piccoli pneumatici
anteriori richiesti dalla P34. Senza uno sviluppo continuo, gli
pneumatici persero gradualmente di competitività e il concetto della
vettura a sei ruote venne abbandonato prima del loro bando definitivo
decretato dalla Federazione nel 1982.
|
 |
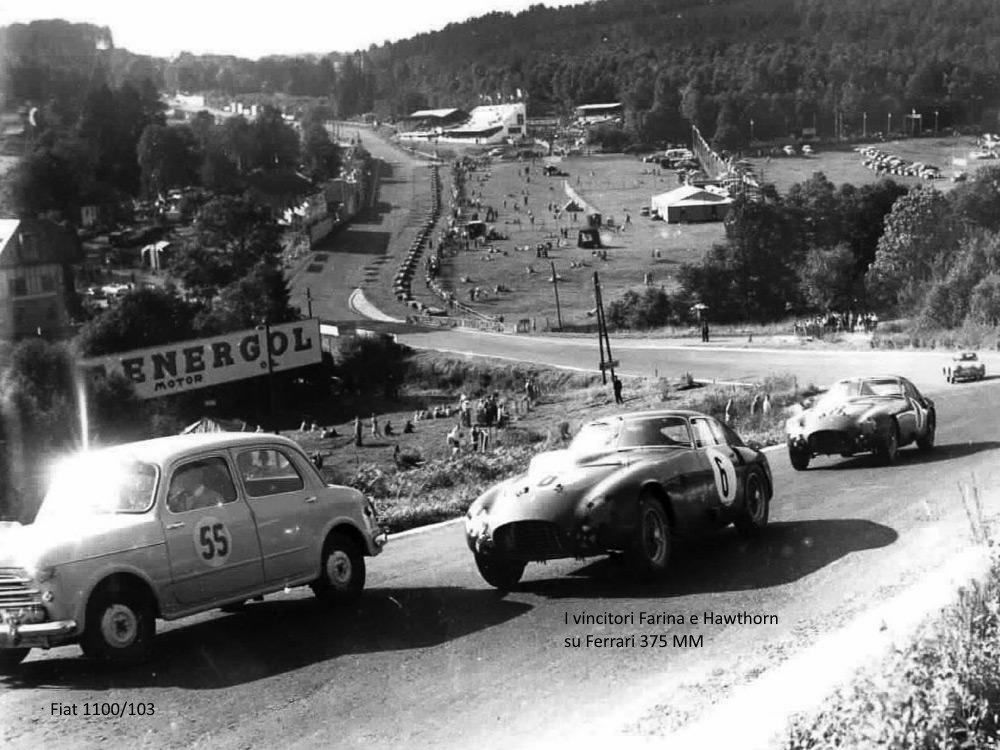 |
24 Ore di Spa 1953 - Curva Eau Rouge
Fotogallery
Auto d´epoca al GP di Bari per la rievocazione storica

21 Giugno 1966 - Sua Altezza Reale il Principe Filippo durante una visita alla Coventry Climax Ltd.
|
|
Coventry Climax
è stato un costruttore britannico di motori speciali: il nome
è particolarmente legato alle competizioni automobilistiche dopo
le 40 vittorie in Gran Premi di Formula 1 tra il 1958 e il 1965 con
Cooper, Lotus e Brabham.
Ha equipaggiato anche le ultime Cooper. Fu il primo motore
clienti, che veniva usato da quasi tutti i team privati. Vinse quattro
mondiali, due con la Cooper e due con la Lotus. Il cambio regolamentare
avvenuto nel 1966 con il raddoppio della cilindrata da 1500 a 3000cmc
portò al disimpegno della Casa, che fece solo qualche sporadica
apparizione con motori 2000 o 2400 cmc derivati dalle precedenti unità
1500. Venne anche realizzato un 3000cmc per la Shannon che si rivelò
essere un totale insuccesso.
|
 Dominio inglese. Dominio inglese.
|
 La
Ferrari vince il Campionato del Mondo nel 1961, ma già l'anno dopo
per la scuderia italiana le cose cambiano radicalmente. La
stagione del 1962 vede infatti la Ferrari subire un abbandono di
massa da parte di tecnici ed ingegneri, compresi il capo ingegnere
e il team manager della scuderia, la causa, com'è nella tradizione
Ferrari, sono i problemi di politica interna. Per la stagione '62
vengono così recuperate, per affrontare le compagini inglesi e
tedesche sempre più competitive, le stesse auto dell'anno
precedente. Il primo pilota é Phil Hill, mentre il resto della
squadra è composto da Willy Mairesse, Ricardo Rodriguez, Giancarlo
Baghetti e Lorenzo Bandini. Le speranze tedesche sono riposte solo
sulla Porsche. Queste, guidate dal pilota americano Dan Gurney e
dal famoso corridore svedese Jo Bonnier, utilizzano motori a otto
cilindri in linea, raffredati ad aria e montati su telai tubolari
molto evoluti. Alla Lotus, Innes Ireland viene rimpiazzato senza
tante cerimonie da Trevor Taylor per fare coppia con Jimmy Clark,
il nuovo pupillo di Colin. Chapman progetta per lui, il modello 25
usando un telaio monoscocca che fa risultare il posto di guida
molto simile ad una vasca da bagno. La
Ferrari vince il Campionato del Mondo nel 1961, ma già l'anno dopo
per la scuderia italiana le cose cambiano radicalmente. La
stagione del 1962 vede infatti la Ferrari subire un abbandono di
massa da parte di tecnici ed ingegneri, compresi il capo ingegnere
e il team manager della scuderia, la causa, com'è nella tradizione
Ferrari, sono i problemi di politica interna. Per la stagione '62
vengono così recuperate, per affrontare le compagini inglesi e
tedesche sempre più competitive, le stesse auto dell'anno
precedente. Il primo pilota é Phil Hill, mentre il resto della
squadra è composto da Willy Mairesse, Ricardo Rodriguez, Giancarlo
Baghetti e Lorenzo Bandini. Le speranze tedesche sono riposte solo
sulla Porsche. Queste, guidate dal pilota americano Dan Gurney e
dal famoso corridore svedese Jo Bonnier, utilizzano motori a otto
cilindri in linea, raffredati ad aria e montati su telai tubolari
molto evoluti. Alla Lotus, Innes Ireland viene rimpiazzato senza
tante cerimonie da Trevor Taylor per fare coppia con Jimmy Clark,
il nuovo pupillo di Colin. Chapman progetta per lui, il modello 25
usando un telaio monoscocca che fa risultare il posto di guida
molto simile ad una vasca da bagno.
 Questo
modello tiene conto di due dei principali fattori nella
progettazione di un telaio: la solidità e la leggerezza. La BRM si
affida a Graham Hill e Richie Ginther come rispettivamente primo e
secondo pilota, mentre la Cooper ha Bruce McLaren e Tony Maggs.
Brabham che ha lasciato la Cooper è impegnato nella preparazione
delle sue vetture che debutteranno più avanti nella stagione. A
Zandvoort, in Olanda, si corre il primo Gran Premio della
stagione. La gara inizia con Clark, Gourney e Graham Hill che
lottano per il comando. Hill vince il suo primo Gran Premio alla
guida di una BRM, che festeggia la seconda vittoria assoluta,
grazie all'esclusione dei suoi due contendenti per guasti
meccanici. A Monaco, nella gara successiva, Hill e Clark hanno
tutta l'intenzione di riprendere il duello, ma quasi subito le
loro auto li lasciano a piedi. Vince McLaren seguito dalla Ferrari
di Phil Hill. Il Gran Premio del Belgio di SPA passa alla storia
come la prima vittoria assoluta di Jimmy Clark. Questo
modello tiene conto di due dei principali fattori nella
progettazione di un telaio: la solidità e la leggerezza. La BRM si
affida a Graham Hill e Richie Ginther come rispettivamente primo e
secondo pilota, mentre la Cooper ha Bruce McLaren e Tony Maggs.
Brabham che ha lasciato la Cooper è impegnato nella preparazione
delle sue vetture che debutteranno più avanti nella stagione. A
Zandvoort, in Olanda, si corre il primo Gran Premio della
stagione. La gara inizia con Clark, Gourney e Graham Hill che
lottano per il comando. Hill vince il suo primo Gran Premio alla
guida di una BRM, che festeggia la seconda vittoria assoluta,
grazie all'esclusione dei suoi due contendenti per guasti
meccanici. A Monaco, nella gara successiva, Hill e Clark hanno
tutta l'intenzione di riprendere il duello, ma quasi subito le
loro auto li lasciano a piedi. Vince McLaren seguito dalla Ferrari
di Phil Hill. Il Gran Premio del Belgio di SPA passa alla storia
come la prima vittoria assoluta di Jimmy Clark.
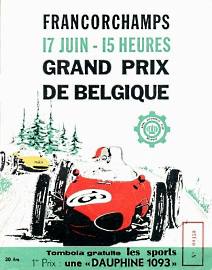 |
 |
Nessuno in Formula
1 aveva prestato attenzione a questo giovane pilota fino a quando
non è finalmente riuscito a salire sul gradino più alto del podio.
Il Gran Premio di Francia si tiene a Rouen in Normandia. Le prime
tre posizioni sulla griglia di partenza sono occupate da Clark, in
pole position, e da Hill e McLaren. La Ferrari è costretta al
ritiro e quando tutti i migliori vengono fermati da guasti
meccanici è Dan Gurney su Porsche ad approfittare di questa
favorevole situazione, aggiudicandosi la vittoria. E' poi la volta
del Gran Premio di Gran Bretagna ad Aintree. La Ferrari riesce a
qualificare solo una vettura, guidata da Phill Hill, il quale
però, prima di ritirarsi per noie al motore, non riesce ad andare
oltre la nona posizione. La folla assiste al lungo duello tra
Clark e l'ex campione di motociclismo John Surtees, che corre su
Lola. Dopo aver rotto la seconda marcia del cambio, Surtees si
deve accontentare del secondo posto. Con la seconda vittoria
stagionale, Clark si trova adesso spalla a spalla con Graham Hill
nella corsa per il titolo mondiale. Al Gran Premio di Germania,
sul celebre circuito del Nurburgring, la Porsche è determinata a
vincere davanti ai suoi sostenitori. Per la felicità dei tifosi
Dan Gurney ottiene la Pole Position con tre secondi di vantaggio
sulla BRM di Graham Hill, ed abbassa il record di giro più veloce
di ben dieci secondi rispetto al precedente detenuto da Phil Hill
su Ferrari. Le prime posizioni delle griglie di partenza sono occupate dalle
auto di cinque diverse scuderie: Porsche, BRM, Lotus, Lola e
Cooper, facendo presagire una gara indimenticabile. I piloti i cui
nomi sono destinati a diventare leggendari sono Gurney, Hill,
Clark, Surtees e McLaren. Il tempo è bruttissimo e il freddo è
tale da gelare anche i cuori dei piloti più ardenti. Sul tracciato
di circa 22 km, per altro rovinato da diversi piccoli smottamenti,
la visibilità scende a meno di cento metri, pari cioè alla
distanza che un auto da corsa copre in poco più di un secondo. La
partenza viene così posticipata di un'ora per lasciare che le
parti allagate del circuito si asciughino. Dopo aver compiuto il
giro di ricognizione le auto prendono posto con cautela sulla
griglia di partenza. Il pubblico, composto da più di 350000
spettatori, nonostante le terribili condizioni atmosferiche
partecipa con rispetto al minuto di silenzio in memoria dell'eroe
perduto Wolfgang Von Tripps. Quindi lo starter dà il segnale di
partenza e le auto rombano via. Tutte tranne la Lotus di Clark che
si spegne subito ma che viene miracolosamente evitata dai piloti
partiti alle sue spalle. Alla fine del primo giro la Porsche
argento di Gurney è al comando con grande soddisfazione delle
autorità tedesche presenti in tribuna. Già al secondo giro, però,
Graham Hill riesce ad aprirsi un varco sorpassando Gurney e
passando in testa. La battaglia è ormai circoscritta a questi tre
grandi piloti, che passano sulla linea del traguardo con solo
cinque secondi di distacco fra il primo e il terzo. In un giorno
in cui anche il più piccolo errore avrebbe potuto provocare un
disastro, nessuno dei tre mette una ruota in fallo. Surtees, che
ha superato Gurney, si trova a tre secondi e mezzo da Hill e
comincia a nutrire serie speranze di poter persino vincere.
Preparato a superare di slancio Hill all'ultimo giro, Surtees si
trova improvvisamente davanti l'auto di un doppiato che gli
ostacola il passaggio. Riesce comunque a raggiungere il traguardo
due secondi e mezzo prima del furioso Surtees. Con ancora tre gare
da disputare, il campionato potrebbe arrivare ad una svolta nel
prossimo Gran Premio di Monza.
Le prime posizioni delle griglie di partenza sono occupate dalle
auto di cinque diverse scuderie: Porsche, BRM, Lotus, Lola e
Cooper, facendo presagire una gara indimenticabile. I piloti i cui
nomi sono destinati a diventare leggendari sono Gurney, Hill,
Clark, Surtees e McLaren. Il tempo è bruttissimo e il freddo è
tale da gelare anche i cuori dei piloti più ardenti. Sul tracciato
di circa 22 km, per altro rovinato da diversi piccoli smottamenti,
la visibilità scende a meno di cento metri, pari cioè alla
distanza che un auto da corsa copre in poco più di un secondo. La
partenza viene così posticipata di un'ora per lasciare che le
parti allagate del circuito si asciughino. Dopo aver compiuto il
giro di ricognizione le auto prendono posto con cautela sulla
griglia di partenza. Il pubblico, composto da più di 350000
spettatori, nonostante le terribili condizioni atmosferiche
partecipa con rispetto al minuto di silenzio in memoria dell'eroe
perduto Wolfgang Von Tripps. Quindi lo starter dà il segnale di
partenza e le auto rombano via. Tutte tranne la Lotus di Clark che
si spegne subito ma che viene miracolosamente evitata dai piloti
partiti alle sue spalle. Alla fine del primo giro la Porsche
argento di Gurney è al comando con grande soddisfazione delle
autorità tedesche presenti in tribuna. Già al secondo giro, però,
Graham Hill riesce ad aprirsi un varco sorpassando Gurney e
passando in testa. La battaglia è ormai circoscritta a questi tre
grandi piloti, che passano sulla linea del traguardo con solo
cinque secondi di distacco fra il primo e il terzo. In un giorno
in cui anche il più piccolo errore avrebbe potuto provocare un
disastro, nessuno dei tre mette una ruota in fallo. Surtees, che
ha superato Gurney, si trova a tre secondi e mezzo da Hill e
comincia a nutrire serie speranze di poter persino vincere.
Preparato a superare di slancio Hill all'ultimo giro, Surtees si
trova improvvisamente davanti l'auto di un doppiato che gli
ostacola il passaggio. Riesce comunque a raggiungere il traguardo
due secondi e mezzo prima del furioso Surtees. Con ancora tre gare
da disputare, il campionato potrebbe arrivare ad una svolta nel
prossimo Gran Premio di Monza.
 |
 |
I due massimi contendenti al titolo
mondiale si piazzano al primo e al secondo posto sulla griglia di
partenza. Clark irrompe subito al comando, ma alla fine del primo
giro la BRM di Graham Hill lo ha già superato ed è in testa. La
Lotus non si vede passare sul circuito e infatti, è ferma ai box.
Finita la sua corsa in anticipo a causa di una trasmissione
grippata, Clark può solo guardare il suo amico e rivale correre
verso la vittoria e confermare il proprio primato in classifica.
Ginther, sull'altra BRM, arriva secondo, regalando alla squadra di
Bourne una bellissima doppietta.
 Dopo
quindici anni di cocenti sconfitte, finalmente il campionato è
nelle mani degli uomini della BRM. Tuttavia, lo scozzese Clark non
è di questo avviso e, dopo la sua convincente vittoria al Gran
Premio degli USA, rimanda l'assegnazione del titolo all'ultima
gara che si disputerà in Sud Africa. Hill, che ha ottenuto il
massimo dei punti dalle gare che è riuscito a terminare, può
contare su un vantaggio di nove punti sull'avversario. Da parte
sua Clark può, vincendo l'ultima competizione, portarsi a casa il
titolo mondiale. Succede però che il guasto di un pezzo di
ricambio da 50 centesimi faccia svanire di colpo le speranze di
Clark, consegnando la corona a Hill. Graham Hill all'età di 33
anni, dopo sei anni di corse e solo nove anni dopo aver conseguito
la patente, diventa il pilota più popolare d'Inghilterra. Aveva
cominciato facendo il meccanico e guadagnando 1 sterlina al
giorno. Oggi ha concretizzato il suo sogno. Diventare Campione del
Mondo di Formula 1. Dopo
quindici anni di cocenti sconfitte, finalmente il campionato è
nelle mani degli uomini della BRM. Tuttavia, lo scozzese Clark non
è di questo avviso e, dopo la sua convincente vittoria al Gran
Premio degli USA, rimanda l'assegnazione del titolo all'ultima
gara che si disputerà in Sud Africa. Hill, che ha ottenuto il
massimo dei punti dalle gare che è riuscito a terminare, può
contare su un vantaggio di nove punti sull'avversario. Da parte
sua Clark può, vincendo l'ultima competizione, portarsi a casa il
titolo mondiale. Succede però che il guasto di un pezzo di
ricambio da 50 centesimi faccia svanire di colpo le speranze di
Clark, consegnando la corona a Hill. Graham Hill all'età di 33
anni, dopo sei anni di corse e solo nove anni dopo aver conseguito
la patente, diventa il pilota più popolare d'Inghilterra. Aveva
cominciato facendo il meccanico e guadagnando 1 sterlina al
giorno. Oggi ha concretizzato il suo sogno. Diventare Campione del
Mondo di Formula 1.
|
|
Arturo Merzario
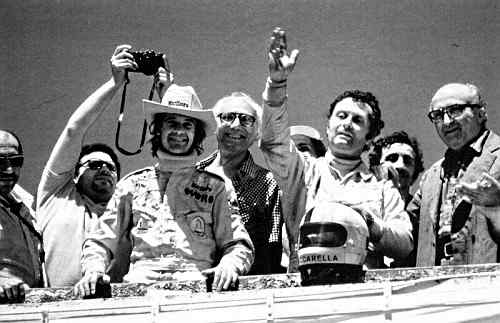
Arturo Merzario - "nino" Vaccarella - a destra Ing.
Carlo Chiti
Arturo Merzario, si rimprovera di non essere riuscito a domare la 312 B3
"Spazzaneve", la più bizzosa fra le monoposto di Maranello,
e attribuisce a questo la rottura con Ferrari. In effetti, nessuno
riuscì a mettere in riga quel Cavallino recalcitrante. Ma
ciò non consola Merzario, che in ogni modo è
considerato uno dei migliori piloti di Sport. Nato l'11 marzo 1943 a
Civenna (CO), debuttò nel 1963 con un'Alfa Romeo Giulietta
Spider. L'anno dopo acquistò una Fiat - Abarth 1000 e vinse
molto in salita, in pista e all'estero. Dopo il servizio militare
continuò con l'Abarth 1000, qualificandosi come uno dei
migliori interpreti del modello e diventando vice campione nell'Europeo
Turismo '67. Ciò gli aprì le porte dell'Abarth,
per la quale guidò ufficialmente dal 1968 al 1971
conquistando il Campionato Italiano '68 e l'Europeo della Montagna '69.
Nel 70 passò alla Ferrari, ma corse pure con la Tecno F2 e
l'Abarth Sport. Nel 1972, vinse l'Europeo Marche 2000 con l'Abarth -
Osella, s'aggiudicò la Targa Florio e la 1000 km del
Nürburgring con la Ferrari 312 P e debuttò in
Formula 1 sostituendo Regazzoni sulla Ferrari 312 B2 nel
G.P.d'Inghilterra, dove si classifico sesto. Passò quindi
alla Iso - Ford nel 73, pur continuando con le Sport. Nel '75 corse in
Formula 1 con una Williams e una Coper-sucar. Nel '76 e nel '77
guidò una March F1, tranne nel G.P. d'Austria '77 dove
guidò una Shadow. Nello stesso anno diede una mano all'Alfa
Romeo per la conquista del Mondiale Sport. Nel '78 e '79
pilotò una Formula 1 di sua costruzione. Dopo la parentesi non proprio
felice, Merzario tornò alle Sport diventando un vero
specialista della categoria, molto ricercato dai costruttori.
L'attività agonistica di Arturo non è finita.
|
I giorni dell'ALFA
1000 km di Monza, 1975
Arturo Merzario nel 1975 alla guida di un'Alfa Romeo Tipo 33 ritorna a imporsi nel
Campionato Mondiale Marche vincendo le gare di Digione, Monza, Enna e
Nurburgring.
A
quarant'anni dal debutto è facile incontrarlo in pista come
pilota o ai bordi a guardare le corse con la passione della prima volta.
|
|
|
|
|
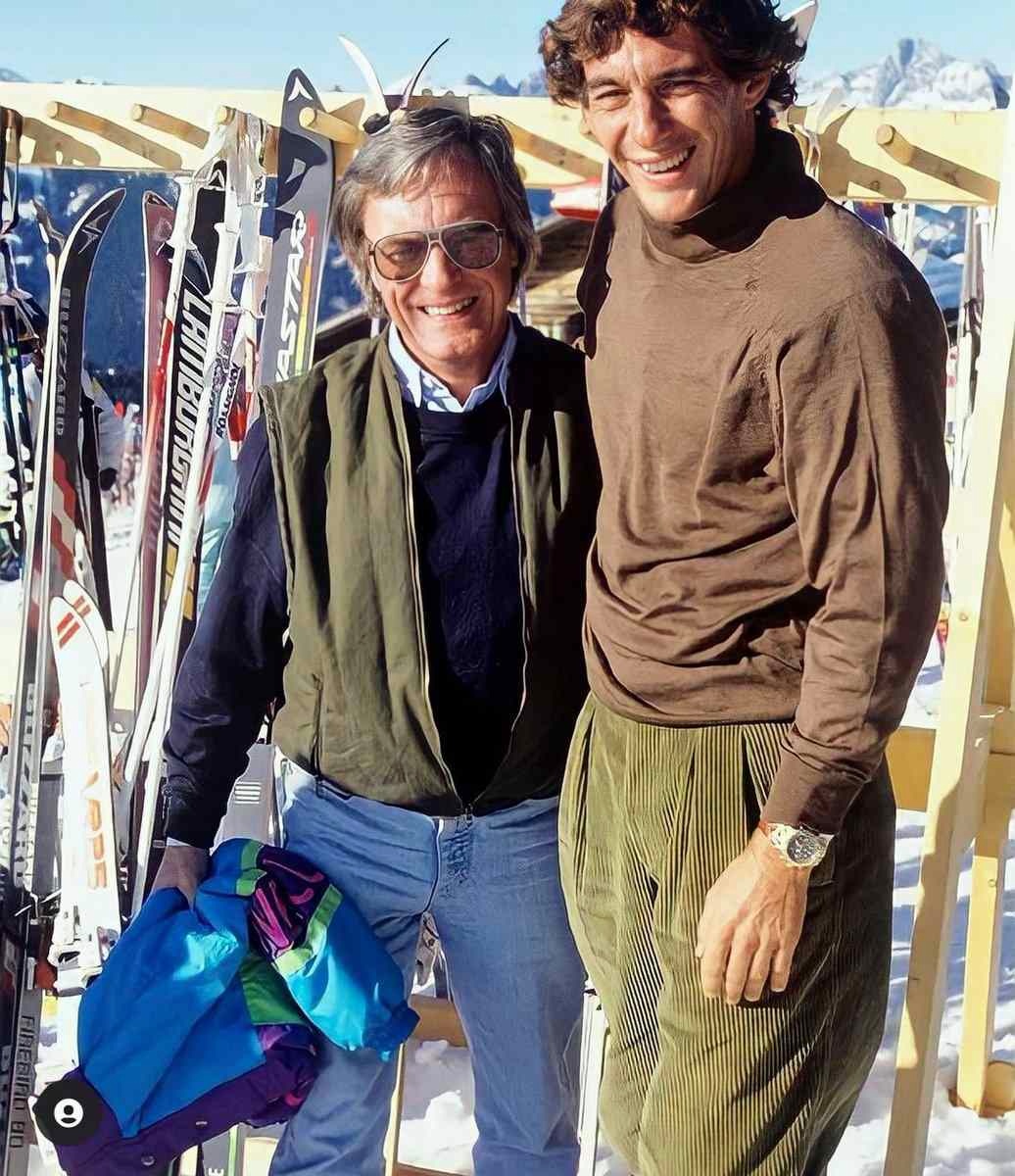 |
Due titani: Bernie Ecclestone e Ayrton Senna a Gstaad in Svizzera nel 1992
 |
|
Storia della Formula 1
Dominio di McLaren e Williams (1984-1993)
Con le controversie lasciate definitivamente alle spalle, le scuderie
di Formula 1 fiorirono con il resto degli anni '80 e i primi anni ‘90.
Malgrado l'oppressivo dominio di due squadre — McLaren e Williams —
questo periodo è visto dagli osservatori come uno dei più luminosi nei
50 anni di storia della F1.
Niki Lauda, al
rientro dopo un primo ritiro nel 1982, superò il suo compagno di
squadra Alain Prost nella corsa al titolo nella stagione 1984 soltanto
per mezzo punto di scarto, il minore distacco dal secondo classificato
registrato della storia. Da segnalare che la classifica fu, secondo
alcuni, falsata dopo l'interruzione per pioggia del Gran Premio di
Montecarlo, che provocò l'assegnazione di metà punteggio.
Prost vinse quella corsa, ma il debuttante Ayrton Senna destò
grande impressione con la modesta Toleman, piazzandosi secondo. Era il
principio di una rivalità tra i due uomini che continuò
per quasi un decennio. La McLaren motorizzata con il turbo TAG Porsche
conquistò tre titoli mondiali consecutivi, i primo con Lauda gli
altri due con Prost nel stagione 1985 e nel 1986.
La stagione 1986 fu un'altra combattuta sino all'ultimo. Le Williams motorizzate Honda di Nelson Piquet e Nigel Mansell
avevano un notevole vantaggio tecnico, ma la mancanza di ordini di
scuderia fece sì che i due si ostacolassero, mentre Prost, prima guida
della McLaren dopo il definitivo ritiro di Lauda, poté restare in corsa,
anche grazie all'affidabilità della vettura. La Williams vinse
facilmente il Campionato Costruttori in quell'anno, mentre il titolo
piloti fu deciso solo al Gran Premio finale della stagione, in
Australia. Prost vinse il titolo dopo che entrambi i piloti Williams
soffrirono di problemi agli pneumatici.
Il 1986 fu però funestato da gravi incidenti, soprattutto quello occorse
ad Elio De Angelis,
durante dei test al volante della Brabham, al circuito Paul Ricard.
Questo portò la federazione a prevedere delle grosse limitazioni ai
motori Turbo e il definitivo abbandono dal 1989.
Il 1987 fu invece un dominio totale della Williams - Honda con il
più regolare Piquet vincitore del suo terzo titolo davanti a Mansell.
La stagione 1987
vide anche il ritorno dei motori atmosferici in Formula 1, dopo
un'annata – quella del 1986 – caratterizzata soltanto dal
turbo e considerata inoltre quella delle vetture più potenti
della storia. La cilindrata fu aumentata a 3.5 litri, e i motori turbo
vennero limitati con una valvola (mutata dalla Indycar) che limitava la
pressione di sovralimentazione a 4,5 bar, ridotti poi a 2,5 nella
stagione 1988 e nella capacità del serbatoio per limitare il
loro effetto, con il divieto totale introdotto nel 1989.
Ciò nonostante, ancora per due anni dettarono legge gli ultimi
motori turbo: la Williams vinse facilmente nel 1987, mentre il 1988 fu
appannaggio della McLaren, con il nuovo propulsore Honda (quest'ultima
lasciò la Williams sul finire dell'annata precedente) che ritornò in
splendida forma con il team dei fuoriclasse Prost e Senna vincitore di
15 delle 16 gare in programma, un record ancora oggi imbattuto. Fu il
brasiliano che emerse da vincitore, conquistando il primo dei suoi tre
titoli mondiali.
Nel 1989 i turbo furono banditi, ma il dominio della McLaren, sempre
motorizzata Honda, continuò per le tre stagioni successive. Prost vinse
il terzo titolo nel 1989, Senna lo conquistò nelle stagioni 1990 e 1991.
Furono gli anni in cui esplose un'acerrima rivalità dai due
piloti, culminata da una doppia collisione nei Gran Premi del Giappone a
Suzuka nel 1989 e 1990. Nel 1989 Prost "chiuse la porta" durante un
tentativo di sorpasso in frenata del compagno di squadra mentre Senna
l'anno dopo si sentì libero di buttare fuori dalla gara del 1990 Prost
(passato alla Ferrari).
Senna, naturalmente, si era preoccupato della minaccia (e
opportunità) portata dalla risorta Williams, adesso motorizzata Renault,
che si preparava a dominare la Formula 1 per i successivi sette anni.
Più dei motori Renault, tuttavia, da cui ha permesso alla Williams e più tardi alla Benetton
di dominare la Formula 1 dal 1992 al 1997. Nei primi anni ‘90, le
scuderie iniziarono a introdurre aiuti elettronici al pilota, e il loro
uso si sparse con estrema rapidità. Le sospensioni attive (anticipate
dalla Lotus nel 1987), i cambi semi-automatici (Ferrari nel 1989), e il
controllo di trazione (Williams nel 1991) divennero essenziali per
competere. Qualcuna di queste tecnologie erano state prese in prestito
alle contemporanee automobili da strada. Altri invece vennero sviluppati
appositamente per essere utilizzati in pista e più avanti presero la
via degli autosaloni. Erano tutte vetture capaci di andare a velocità
sempre maggiori in rapporto alla capacità di spesa delle diverse
scuderie. La FIA, consapevole che l'eccesso di tecnologia minasse
totalmente l'abilità del pilota, tolse l'elettronica nel 1994.
Naturalmente, molti osservatori sostennero che tale eliminazione
derivasse dal fatto che la FIA non avesse i mezzi necessari per
supportare tali aiuti ai piloti. Neppure queste controversie diminuirono
l'entusiasmo degli sportivi britannici quando Nigel Mansell vinse il
titolo nel 1992 e fu il primo pilota a ritirarsi da campione del mondo,
dopo un decennio di tentativi falliti, né gli sportivi francesi quando
nel 1993 Alain Prost vinse il suo quarto e ultimo titolo ritirandosi
anch'egli come il collega inglese. Entrambi i piloti guidavano le
vetture della Williams.
Nel 1994 vi fu la reintroduzione del rifornimento di carburante
ai pit stops: le gare vennero trasformate in una serie di sprint, con il
risultato conseguente che le strategie finirono per guadagnare
importanza rispetto all'abilità del pilota.
Le telecamere leggere delle televisioni erano diventate pratica
comune nei primi anni '90. Proseguì inoltre il trend di collaborazioni
ufficiali tra grandi costruttori e team di formula 1, anche grazie ad
una miglior immagine grazie ai miglioramenti alla sicurezza.
Il 1994, sulla
carta, doveva essere un'annata di grande interesse: Ayrton Senna aveva
lasciato la McLaren per la Williams per rimpiazzare Prost. Il giovane
pilota tedesco Michael Schumacher guidava la Benetton motorizzata con i
nuovi motori Ford. La McLaren nutriva grandi speranze per il nuovo
motore Peugeot, e la Ferrari era proiettata a cancellare le ultime tre
stagioni deludenti con Gerhard Berger e Jean Alesi. Quella stagione fu
indimenticabile, ma per motivi ben diversi da quelli previsti.
|
 |
 |
Il comitato Vodstvo si fa controllare un pneumatico a Cravograd durante il Rally di Monte-Carlo nel 1956.
Il turbo.
|
 La Guerra tra FISA e FOCA continua anche nel 1981 e
determina il rinvio del Gran Premio d'Argentina. Bernie Ecclestone minaccia di
organizzare un proprio Campionato del Mondo Piloti Professionisti (World
Professional Championship) ma fortunatamente le parti raggiungono un accordo
durante un incontro al vertice tenutosi a Maranello, avvenimento che in seguito
verrà ricordato come l'accordo Concorde. Nel lontano 1966, quando fu modificata
la formula che prevedeva i motori da 3 litri, fu inserita anche una disposizione
relativa all'impiego di motori da 1,5 litri a turbocompressione. In mancanza di
interessati tra gli attuali fornitori di motori e con l'esplosivo successo del
motore Ford-Cosworth, la possibilità di trovare una terza via fu lasciata nelle
mani di un esterno, un esterno la cui storia aveva intrecciato quella delle
corse fin dal primo Gran Premio. La Renault aveva tentato di vincere a Le Mans
con un motore a turbocompressione ma subì la rottura dei pistoni. Bernard Dudot
fu inviato alla Garrett AiResearch per studiare a fondo la bella arte della
turbocompressione. La Guerra tra FISA e FOCA continua anche nel 1981 e
determina il rinvio del Gran Premio d'Argentina. Bernie Ecclestone minaccia di
organizzare un proprio Campionato del Mondo Piloti Professionisti (World
Professional Championship) ma fortunatamente le parti raggiungono un accordo
durante un incontro al vertice tenutosi a Maranello, avvenimento che in seguito
verrà ricordato come l'accordo Concorde. Nel lontano 1966, quando fu modificata
la formula che prevedeva i motori da 3 litri, fu inserita anche una disposizione
relativa all'impiego di motori da 1,5 litri a turbocompressione. In mancanza di
interessati tra gli attuali fornitori di motori e con l'esplosivo successo del
motore Ford-Cosworth, la possibilità di trovare una terza via fu lasciata nelle
mani di un esterno, un esterno la cui storia aveva intrecciato quella delle
corse fin dal primo Gran Premio. La Renault aveva tentato di vincere a Le Mans
con un motore a turbocompressione ma subì la rottura dei pistoni. Bernard Dudot
fu inviato alla Garrett AiResearch per studiare a fondo la bella arte della
turbocompressione.
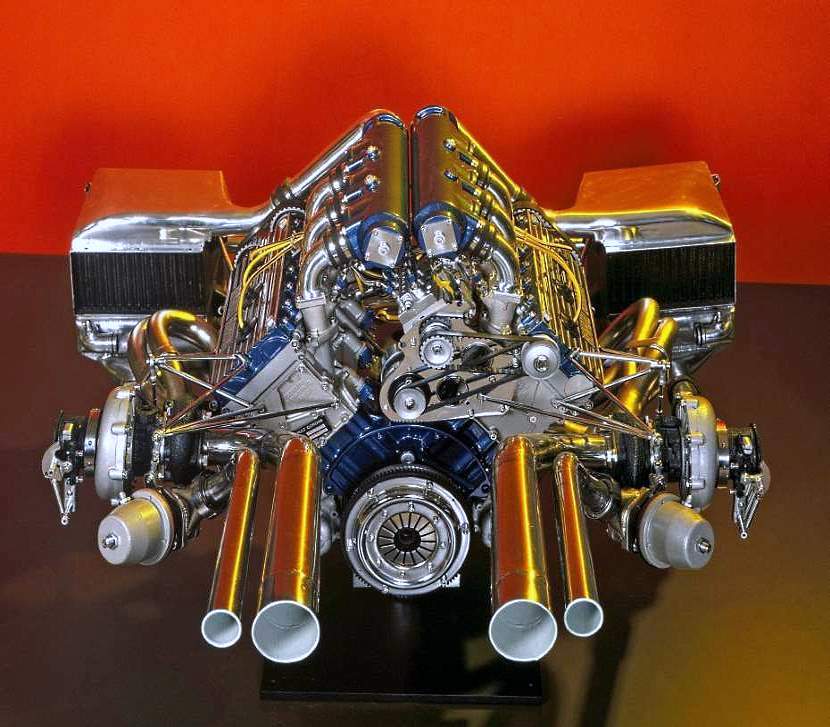 |
| Nel 1979 il motore Renault assume la configurazione biturbo, coi due gruppi KKK montati ai lati delle bancate. |
Finalmente nel 1979 il motore turbocompresso della Renault
viene montato su una macchina da Gran Premio. La BMW si unisce presto alle
ricerche, e l'era dei motori turbo vede finalmente la luce. Qualcuno aveva
pensato che i motori turbocompressi avrebbero consentito ai grandi costruttori
di sopraffare le squadre britanniche minori e la loro rinomata leadership nel
design dei telai.
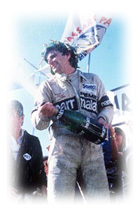 Nel 1981 la Ferrari è ormai un laboratorio su campo per
macchine a turbocompressione, ma neppure un talento del calibro di Gilles
Villeneuve riesce a portare in gara questa macchina ancora poco maneggevole. La
McLaren è ora sotto il controllo di Ron Dennis e con John Watson alla guida di
una McLaren MP4 progettata da John Barnard è la prima auto con telaio in fibra
di carbonio a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Il titolo viene assegnato
nella gara finale svoltasi a Las Vegas e Piquet con un quinto posto guadagna i
punti necessari alla sua incoronazione. Le macchine con motori a
turbocompressione hanno nel frattempo continuato a fare progressi ed alla fine
di quella stagione, avevano vinto sette gare su sedici. Per il 1982 vengono
modificate alcune regole e il divieto di utilizzo di bandelle mobili
obbliga le squadre a ridurre la distanza libera da terra a circa 25mm unitamente
ad una quasi totale mancanza di movimento delle sospensioni. I piloti
sperimentano una rigidezza in curva che in alcuni circuiti raggiunge i 4gs. Niki
Lauda, due volte Campione del Mondo, si fa convincere da un barile di denaro
offertogli dalla Marlboro ad unirsi a John Watson alla McLaren. Alan Jones
sceglie la strada opposta e se ne va dalla Formula 1 lasciando il proprio posto
alla Williams al finlandese Keke Rosberg. Il terzo concorrente al titolo
dell'anno precedente, Carlos Reutemann, si ritira anch'egli, ma solo dopo aver
partecipato alle prime due gare della stagione.. Nel 1981 la Ferrari è ormai un laboratorio su campo per
macchine a turbocompressione, ma neppure un talento del calibro di Gilles
Villeneuve riesce a portare in gara questa macchina ancora poco maneggevole. La
McLaren è ora sotto il controllo di Ron Dennis e con John Watson alla guida di
una McLaren MP4 progettata da John Barnard è la prima auto con telaio in fibra
di carbonio a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Il titolo viene assegnato
nella gara finale svoltasi a Las Vegas e Piquet con un quinto posto guadagna i
punti necessari alla sua incoronazione. Le macchine con motori a
turbocompressione hanno nel frattempo continuato a fare progressi ed alla fine
di quella stagione, avevano vinto sette gare su sedici. Per il 1982 vengono
modificate alcune regole e il divieto di utilizzo di bandelle mobili
obbliga le squadre a ridurre la distanza libera da terra a circa 25mm unitamente
ad una quasi totale mancanza di movimento delle sospensioni. I piloti
sperimentano una rigidezza in curva che in alcuni circuiti raggiunge i 4gs. Niki
Lauda, due volte Campione del Mondo, si fa convincere da un barile di denaro
offertogli dalla Marlboro ad unirsi a John Watson alla McLaren. Alan Jones
sceglie la strada opposta e se ne va dalla Formula 1 lasciando il proprio posto
alla Williams al finlandese Keke Rosberg. Il terzo concorrente al titolo
dell'anno precedente, Carlos Reutemann, si ritira anch'egli, ma solo dopo aver
partecipato alle prime due gare della stagione..
|
|
 |
Le turbo di Ferrari, Renault ed
ora della Brabham dominano la gara d'apertura a Kyalami con Prost che passa per
primo la bandiera a scacchi. Le squadre britanniche continuano a combattere
contro i motori a turbocompressione in quella che presto sarà un battaglia
persa. La Brabham, avendo a disposizione sia motori turbo sia motori Cosworth
tenta la strada intermedia. Piquet sulla Brabham vince in Brasile ma solo dopo
essersi temporaneamente convertito ad un motore tradizionale. Le macchine turbo
hanno un chiaro vantaggio nei circuiti veloci ma il problema del "turbo lag"
diviene un handicap su circuiti costellati di curve. Solo dopo la gara di Spa
questa scuderia verrà trascinata con decisione nel mondo della
turbocompressione, grazie al proprio fornitore di motori, la BMW. Alla tappa
successiva, Long Beach, è il turno del non-ritiratosi Niki Lauda; la battaglia
tra FOCA e FISA sta per scatenarsi di nuovo.
La Ferrari vince e la FOCA boicotta
il Gran Premio di San Marino;
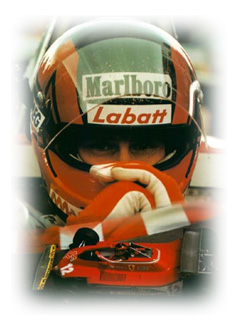 ma una contesa tra i compagni di squadra della
Ferrari Didier Pironi e Gilles Villeneuve porta alla tragedia di Zolder. Villeneuve,
intenzionato a tutti i costi a qualificarsi davanti al suo rivale, va a sbattere
contro un più lento Jochen Mass. Villeneuve non avrebbe forse mai vinto un
campionato, il suo ideale era vincere a tutti i costi, non negoziare le
posizioni di arrivo per fare punti. Alla morte del giovane pilota canadese,
questo sport ha perso un diretto discendente di Bernd Rosemeyer e Tazio
Nuvolari. Le parole usate da Cyril Posthumas per ritrarre il pilota tedeco
dell'ante-guerra: "...lanciato come una meteora nel firmamento della gare
automobilistiche..." potrebbero valere anche per questo pilota la cui vita era
la velocità. Come spesso accade, ci rendiamo conto dell'importanza di quello
che abbiamo solo nel momento in cui lo perdiamo per sempre. La gara fu vinta da
John Watson per la McLaren. A Monaco piove ma Riccardo Patrese riesce a restare
in pista e a portare a casa la sua prima vittoria. Watson e Piquet conquistano
le due gare successive, rispettivamente Detroit e Canada. ma una contesa tra i compagni di squadra della
Ferrari Didier Pironi e Gilles Villeneuve porta alla tragedia di Zolder. Villeneuve,
intenzionato a tutti i costi a qualificarsi davanti al suo rivale, va a sbattere
contro un più lento Jochen Mass. Villeneuve non avrebbe forse mai vinto un
campionato, il suo ideale era vincere a tutti i costi, non negoziare le
posizioni di arrivo per fare punti. Alla morte del giovane pilota canadese,
questo sport ha perso un diretto discendente di Bernd Rosemeyer e Tazio
Nuvolari. Le parole usate da Cyril Posthumas per ritrarre il pilota tedeco
dell'ante-guerra: "...lanciato come una meteora nel firmamento della gare
automobilistiche..." potrebbero valere anche per questo pilota la cui vita era
la velocità. Come spesso accade, ci rendiamo conto dell'importanza di quello
che abbiamo solo nel momento in cui lo perdiamo per sempre. La gara fu vinta da
John Watson per la McLaren. A Monaco piove ma Riccardo Patrese riesce a restare
in pista e a portare a casa la sua prima vittoria. Watson e Piquet conquistano
le due gare successive, rispettivamente Detroit e Canada. Al Gran Premio di
Germania la corsa per il titolo dovrebbe essere tra Pironi e Watson ma il pilota
della Ferrari subisce un incidente durante le prove per il quale riporterà
ferite tali da fargli terminare la carriera. Il Gran Premio di Svizzera, che si
corre a Digione, Francia, viene vinto da Rosberg ora in testa alla classifica.
La stagione si conclude con il Gran Premio dell'Ovest negli Stati Uniti, a Las
Vegas e nonostante sia Michele Alboreto su Tyrrell a vincere la gara, il titolo
resta in mano a Keke Rosberg. La battaglia tra auto con motori a
turbocompressione e auto a motore tradizionale è ormai finita, anche se a
parimerito, con 8 vittorie a testa. Al Gran Premio di
Germania la corsa per il titolo dovrebbe essere tra Pironi e Watson ma il pilota
della Ferrari subisce un incidente durante le prove per il quale riporterà
ferite tali da fargli terminare la carriera. Il Gran Premio di Svizzera, che si
corre a Digione, Francia, viene vinto da Rosberg ora in testa alla classifica.
La stagione si conclude con il Gran Premio dell'Ovest negli Stati Uniti, a Las
Vegas e nonostante sia Michele Alboreto su Tyrrell a vincere la gara, il titolo
resta in mano a Keke Rosberg. La battaglia tra auto con motori a
turbocompressione e auto a motore tradizionale è ormai finita, anche se a
parimerito, con 8 vittorie a testa.
|
|
|
TARGA FLORIO
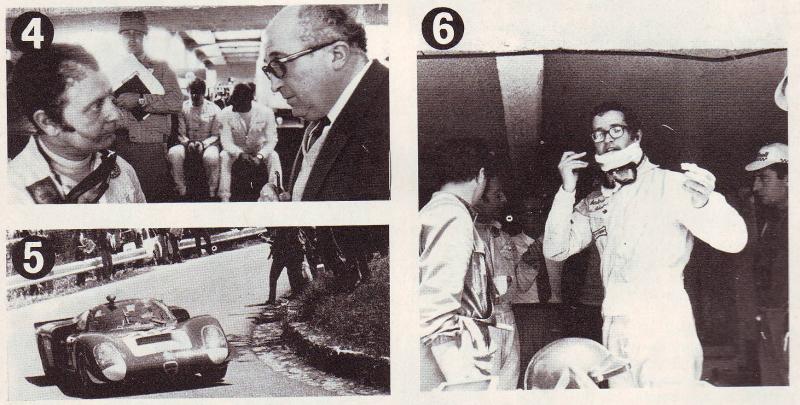 |
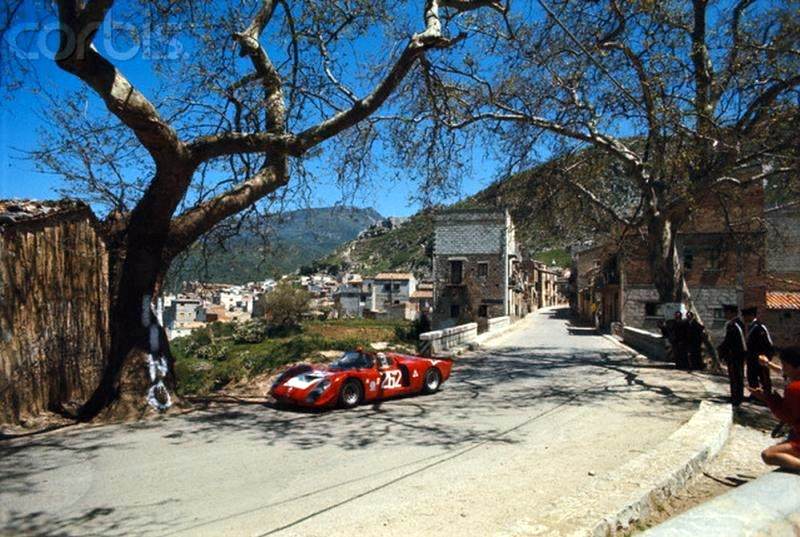
1969 - Alfa Romeo T33 . 2,5 - Vaccarella - De Adamich - Autodelta
|
 Arrows. Arrows.
|
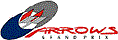 Posta sotto la tutela di un liquidatore amministrativo dopo il giudizio della
corte di Londra, ciò che è rimasto della scuderia Arrows sarà disperso tra i
diversi creditori ed investitori. Una fine poco gloriosa che il cocciuto Tom
Walkinshaw non è riuscito ad evitare. Posta sotto la tutela di un liquidatore amministrativo dopo il giudizio della
corte di Londra, ciò che è rimasto della scuderia Arrows sarà disperso tra i
diversi creditori ed investitori. Una fine poco gloriosa che il cocciuto Tom
Walkinshaw non è riuscito ad evitare.
La prima squadra Arrows nacque dalla scissione della scuderia Shadow nel 1977
e fu fondata da Jacky Oliver e
Alan Rees, ma fu soltanto in Brasile nel 1978 che una Arrows partecipò per la
prima volta all'edizione di un Gran Premio, con al volante Riccardo Patrese.
In Africa del sud, nella seconda apparizione, la scuderia è rimasta in testa
con Patrese prima della rottura del motore, mentre nella terza gara in Svezia
l'italiano conquistò la seconda piazza dietro la Brabham di Niki Lauda. Un
debutto incoraggiante rimasto senza seguito.
Nel 1981 Patrese segnò la pole nel GP degli USA, ma occorrerà aspettare il
1988 per vedere Eddie Chever e Derek Warwick offrire alla Arrows la migliore
stagione di tutti i tempi col quarto posto finale nel campionato costruttori.
Dopo quella stagione, nella quale le Arrows erano equipaggiate con un Megatron
(ex BMW turbo), le monoposto britanniche tornarono al motore Ford prima di
essere rilevate dalla compagnia giapponese Footwork International Corporation,
appartenente a Wataru Ohashi. Le ambizioni dell'investitore nipponico
consentirono alla Arrows di disporre di un motore Porsche che però non si
rivelò competitivo.
Nel 1995, Oliver e Rees ritornarono alla guida della loro squadra, ma fu un
nuovo fiasco malgrado un inatteso terzo posto di Gianni Morbidelli nel GP
d'Australia, l'ultimo disputato ad Adelaide. Fu in quel momento che entrò in
gioco Tom Walkinshaw. Lo scozzese vide nella Arrows la soluzione ideale per
proseguire a sviluppare le sue numerose attività negli sport meccanici. Nel
1997 nella piccola scuderia arrivò Damon Hill, campione del mondo. A fine 97
Hill e la Yamaha lasciarono Walkinshaw in una situazione difficile.

Il ricchissimo scozzese decise di lanciarsi nella costruzione di un proprio
V10 da F1 ingaggiando Brian Hart. John Barnard, ex McLaren e Ferrari prese in
mano il destino della A19. Si rivelerà denaro speso senza ottenere risultati.
Dopo aver pensato di partire, nel 2000 Tom Walinshaw riprende in mano il
destino del team.
La Arrows è ripartita nel 2001 per una nuova campagna mondiale sostenuta da
investitori asiatici che hanno acquistato il diritto d'utilizzo di un vecchio
V10 conosciuto sotto il nome della Peugeot. Ancora una volta il successo è
venuto a mancare e nel 2002 malgrado un V10 Cosworth, il naufragio è stato
inevitabile.
|
|

Scuderia Ferrari "sharknose"
|

Cameraman legato per filmare Jack Brabham

|
Modena 1969: prime prove di
Clay Regazzoni
sulla Dino 166 F2. Oltre all'Ing.Marelli si riconoscono da sinistra il
giornalista Pino Allievi,
il capomeccanico Giulio Borsari ed il fotografo-giornalista Giancarlo
Cevenini.
|
Sacrificio di Collins
Peter Collins è ricordato tuttora non solo come uno dei piloti
meritevoli del titolo, ma anche come il più generoso e, purtroppo, anche
come uno
dei più sfortunati: la sua carrierà finì infatti insieme alla sua
vita contro un albero del circuito del Nurburgring, nel Gran Premio di
Germania del '58.
Quell'anno,
il pilota britannico avrebbe potuto finalmente coronare il suo sogno
iridato andato invece al compagno di squadra Mike
Hawthorn.
 |
 Monza - Partenza Gran Premio d'Italia 1956 Monza - Partenza Gran Premio d'Italia 1956
|
 |
|
 |
L'episodio che fa di Collins un gigante di lealtà alla squadra e di
generosità nei confronti di un compagno di squadra, è quello che accadde
nel Gran Premio d'Italia nel '56, quando l'inglese
cedette la propria
vettura a Fangio, rimasto appiedato con la sua, consentendogli così di
arrivare secondo
alle spalle di Moss e di conquistare il titolo iridato.Titolo cui avrebbe legittimamente potuto ambire lui stesso.
Un gesto che consegnò l'inglese della Ferrari
al perenne ricordo di chi
segue le corse. La sua era stata una carriera iniziata in F.1 nel 1952 al
volante della HWM e poi proseguita con la Vanwall, la Maserati e
conclusasi tragicamente con la Ferrari.
La sua scomparsa scosse talmente Mike Hawthorn, suo compagno di squadra
nonché fraterno amico e vincitore del titolo al termine di quella
disgraziata
stagione di corse e di morte (oltre a Collins, persero infatti
la vita anche l'altro ferrarista Luigi Musso e il britannico della Vanwall
Lewis Evans),
da indurlo a chiudere la carriera alla fine dell'annata. Il
destino sarà comunque beffardo anche con il campione del mondo del '58.
|
|
|
Fiat 524C Spider Cabriolet (1932)
Parlare di Fiat è parlare principalmente di utilitarie, ma negli anni
trenta le utilitarie non esistevano affatto e le vetture prodotte dalla
casa torinese erano comunque gioielli. Forse meno eleganti e ricercati
delle Lancia o meno improntati alla sportività come le Alfa Romeo che
gareggiavano e vincevano in tutto il mondo. Ma la 524C Spider Cabriolet
resta comunque un modello bellissimo con la sua carrozzeria cabriolet
scura con decorazioni arancioni e la protezione in tela della ruota di
scorta. Il livello di manutenzione e accuratezza del restauro appare
davvero eccellente.
Fiat 525 SS Spider (1929)
Stesso discorso anche per l'altra Fiat degli anni trenta presentata
all'esposizione tigulluina. La 525 SS Spider è solo di qualche anno
precedenterispetto all'altro modello.Splendida comunque con la sua
carrozzeria chiara con parafanghi e cofano motore scuro; è uno spider
"puro", con la carrozzeria molto più bassa come linea di cintura.
Abbastanza simile nelle linee della calandra che però è maggiormente
curata a livello costruttivo in quanto completamente cromata.
|
|
Lancia Astura Torpedo GL (1933)
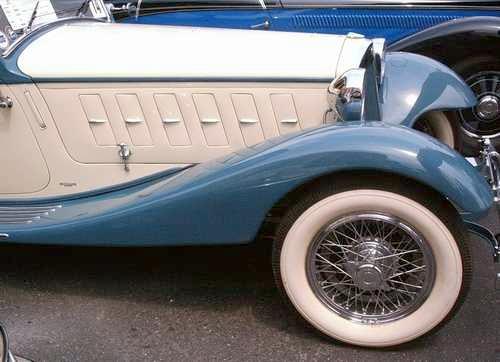 |
|
 |
Questa è una vettura leggermente più anziana. E' anche molto più piccola
ma è un vero gioiello. Al di là della perfezione del restauro
colpiscono anche i singoli particolari che solo una dettagliata
relazione fotografica possono illustrare come meritano. La carrozzeria
bicolore crema-azzurro è spettacolare e contribuisce non poco alla sua
bellezza non meno che i pneumatici bianchi. Da segnalare anche la zona
abitacolo con i due posti anteriori separati dai due posteriori e tutti
protetti da una piccola vetratura specifica. Ripeto, un vero gioiello
che a prima vista sembra non imporsi all'attenzione in mezzo alle altre
vetture. Ma a ben guardare, da intenditore che osserva e giudica anche i
particolari, non si può fare a meno di restare colpiti da tanta
bellezza.
|
Un weekend perfetto per Senna, fino all'inspiegaile errore al Portier

Ayrton Senna tenta la fuga nel GP di Monaco 1988
|
 |
 |
Alain Prost vince il GP di Monaco 1988
davanti a Berger e Alboreto |
|
Le telecamere inquadrano il pilota della McLaren,
alquanto nervoso, scendere dalla macchina . Senna si allontana dalla
vettura continuando a guardare un punto fisso del tracciato, forse
proprio quello che l’ha appena tradito. Si toglie i guanti, si slaccia
il casco, e solo a questo punto tutto il mondo può osservare la sua
rabbia mista a delusione. È scuro in volto, e continua a fissare le
macchine che scorrono in quel punto.
Ma perché quell’incidente? Mancavano 12 giri alla fine e Senna aveva
55 secondi di vantaggio sul suo compagno di squadra, e avversario numero
1, Alain Prost. Il francese stesso non ha tuttora altre spiegazioni se
non: “non voleva limitarsi a battermi, lui voleva umiliarmi.”
Monaco, la sua casa, il suo regno, la pista dove era diventato un
eroe nel 1984. Lo aveva tradito. Quel weekend fu un punto di svolta
nella carriera di Ayrton. Ecco la sua descrizione delle qualifiche che
anticiparono la gara:
“A Monaco avevamo le gomme da gara non le gomme da qualifica, cosi
la pressione durava giro dopo giro. Non uno solo. Ero arrivato ad un
punto dove ero due secondi al giro più veloce del mio compagno di
squadra che stava usando la stessa macchina, stesso motore, esattamente
la stessa. Ma improvvisamente mi resi conto che stavo andando troppo
veloce. Che non c’era più margine, in niente, che non stavo più guidando
consciamente la mia monoposto, e che ero finito in un’altra dimensione.
Quando ho sentito quello dentro di me, ho alzato il piede. Ad un certo
punto il circuito non era più il circuito ma solo un tunnel. Ho detto a
me stesso: oggi è un giorno speciale. Non uscire più in pista. Sei
vulnerabile”.
La gara fu praticamente un monologo del Brasiliano. Quando Prost
riuscì a liberarsi di Berger che gli aveva fatto da tappo per 53 giri
aveva un ritardo di 50 secondi dal compagno di squadra. Un abisso
incolmabile. Prost cercò almeno di ottenere il giro più veloce, e per
circa 10 giri vi fu una battaglia tra i primi due a suon di giri più
veloci. Alla fine fu Senna a prevalere, e quando capì che Prost era
rassegnato al secondo posto si mise a girare ben 4/5 secondi più lento
del suo miglior giro, come d’altro canto aveva cominciato a fare anche
il Francese.
“Avevo corso quella che considero la mia gara perfetta. Sia in
termini di qualifica, prestazioni in gara e set up della macchina. Prima
dell’incidente, avevo avuto una prima distrazione al Casino, dove la
macchina aveva saltato una marcia quando mi sono distratto un attimo.
Avevo ripreso il ritmo giusto, ma poi la cosa e’ successa di
nuovo.”[Ayrton Senna]
Ayrton sbaglia, si rilassa troppo presto e si lascia sfuggire una
facile vittoria. La sua faccia, una volta uscito dalla monoposto dice
solo una cosa: perché? Com’è potuto accadere che un campione come me
sbagliasse così? Non ci sono spiegazioni. Rimane per qualche minuto ad
osservare malinconicamente, con sguardo rassegnato quella curva. Poi
sparisce nel nulla.
Cinque ore dopo (cinque ore di puro panico per la Mclaren),
quando Jo Ramirez riuscì a parlare con lui, si trovava nel suo
appartamento di Monaco, e stava ancora riflettendo sull’accaduto, e si
disperava. La sera stessa Ron Dennis, al Galà della McLaren, vista la
reazione del suo pilota dopo l’accaduto, volle solamente stare vicino a
lui per rincuorarlo.
Alcuni tecnici che lavoravano allora alla Mclaren sostengono ancora
al giorno d’oggi che Senna avesse una piccola foratura in uno degli
pneumatici posteriori, e che si fosse intestardito a continuare con
quelle gomme piuttosto che cambiarle. Alcuni sostengono invece di avere
sentito Ayrton dire che Dio gli era apparso in quella curva, ma sono
fonti non certificare,e quindi questa affermazione potrebbe essere
falsa. Quello che possiamo affermare con certezza è che Senna in
quell’occasione ricevette una dura lezione di vita. E da quel giorno la
sua visione del suo lavoro cambiò molto. Ayrton aveva raggiunto i suoi
limiti, e come diceva un grande delle corse, “per conoscere i tuoi limiti devi prima superarli”, e li superò, andando a finire contro il muro.
Alla fine lui disse che l’incidente l’aveva aiutato: l’aveva reso più
forte e gli aveva insegnato a mantenere sempre alta la concentrazione.
|
|
|
BRUNO ARCARI
Campione mondiale dei pesi superleggeri
|
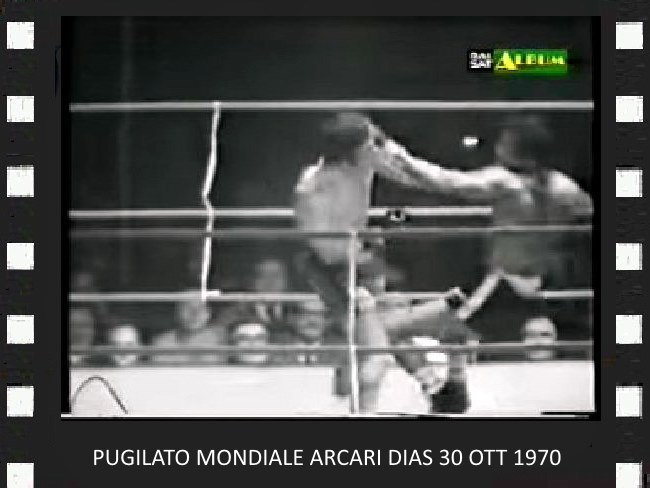 |
| Bruno Arcari è un ex pugile italiano.
E' stato campione europeo e mondiale WBC dei pesi superleggeri,
rinunciando in entrambi i casi al titolo senza essere stato mai
sconfitto in incontri con il titolo in palio. |
 |
|
Storia della Formula 1
Il biennio della Benetton: sicurezza, regolazioni e regolamenti (1994-1995)
A partire dal 1986, quando Elio De Angelis perì durante i test sul circuito Paul Ricard a Le Castellet, e fino al 1994
nessun pilota era più deceduto alla guida di una vettura di Formula 1.
C'erano stati parecchi incidenti sconvolgenti (per esempio Nelson Piquet
e Gerhard Berger a Imola o Martin Donnelly
a Jerez de la Frontera), ma non furono fatali. La velocità delle
monoposto della massima serie era aumentata continuamente in otto anni,
malgrado i motori turbo
fossero stati dichiarati illegali, la riduzione della lunghezza degli
pneumatici e la rimozione degli aiuti elettronici al pilota. C'era un
"aria di invincibilità" in Formula 1, una credenza che le vetture
fossero intrinsecamente sicure e i piloti non sarebbero più deceduti.[18]
Al Gran Premio di
San Marino del 1994 questa "presunzione" crollò bruscamente e
drammaticamente, dapprima con le gravi ferite occorse a Rubens
Barrichello durante le prove libere del venerdì poi con la morte
di Roland Ratzenberger nelle prove ufficiali del sabato e infine con
quella di Ayrton Senna durante la gara.[19] Ancora, Karl Wendlinger restò in stato di coma per due settimane dopo uno scontro al Gran Premio di Montecarlo.[20],
oltre ad altri gravi incidenti (uno scontro alla partenza che causò
feriti tra gli spettatori, una ruota persa da Alboreto che ferisce 4
meccanici).
Il conto dei decessi e i due feriti gravi rappresentarono una
scossa terribile per tutti. Non solo due piloti rimasero uccisi durante
un singolo week-end di gara, ma uno di loro era il tre volte campione
del mondo. Sembrava di essere tornati improvvisamente negli anni '70,
dove in una stagione di 12 gare, morivano in media due piloti e altri
tre o quattro rimanevano gravemente feriti. La FIA reagì rapidamente e
con grandissima severità con cambiamenti importanti da far rispettare
per il resto dell'annata e in quelle seguenti, rappresentando l'inizio
della spinta da parte della FIA per aumentare la sicurezza in Formula 1.
Mentre cambiamenti significativi non potevano essere fatti alle
vetture nel 1994, la FIA richiese la perforazione dei contenitori d'aria
(gli "airboxes") per ridurre il loro effetto "ram-air" e quindi la
potenza. Per la stessa ragione i combustibili speciali, in precedenza
una strana mistura di benzene e toluene,
vennero vietati; soltanto quelli con caratteristiche simili alla
benzina commerciale vennero permessi. Per ridurre le forze verso il
basso, e quindi la velocità delle vetture in prossimità delle curve, era
già stata introdotta, peraltro già ad inizio stagione, venne introdotta
una speciale "plancia" di legno adattata sotto la parte centrale del
telaio, forzando una larga sezione del pavimento 5 cm più lontano dalla
pista. Se tale plancia consumandosi venisse portata sopra una certa
tolleranza al Regolamento (approssimativamente 10 mm), la vettura
sarebbe stata ritenuta illegale.
Più avanti, dal 1995, i progetti sono stati richiesti per essere
disegnati secondo un piano di riferimento (la mascherina), e rigorose
limitazioni sono state fatte rispettare quanto alle tolleranze minime e
massime per le funzioni del veicolo (come il formato dell'apertura della
cabina di guida, un'idea molto nota nelle serie Champ Car
e IndyCar da almeno un decennio, e dei dispositivi aerodinamici,
comunemente chiamate ali). Dopo, la massima cilindrata del motore venne
ridotta da 3.5 a 3 litri. Ulteriori cambiamenti erano demandati dalla
FIA per continuare a provare di mettere un freno nell'incremento di
velocità nelle vetture di Formula 1 durante la loro progressione lungo
gli anni. Questi cambiamenti includono l'aumento del formato di apertura
della cabina di guida (per assicurare l'uscita del pilota con una certa
facilità, minimizzando possibili impatti laterali), introducendo gli
pneumatici con quattro scanalature (per ridurre la velocità in curva e
il grip) e la carrozzeria più stretta (questo complicherebbe il
raffreddamento e inoltre ridurrebbe la velocità), formati e elementi
delle ali rialzati e ridotti (tagliando le forze aerodinamiche, altro
elemento di riduzione della velocità), e introducendo accurati controlli
sulle tolleranze di rigidezza e le misure di accertamento sulle vetture
e sulle loro conformità nelle regolazioni prestabilite (per esempio, i
test del peso sulle ali e sulla carrozzeria per accertarsi il loro
mantenimento integro e non flettessero per dare vantaggi aerodinamici in
linea retta).
La rapida introduzione di tutti questi nuovi regolamenti – particolarmente quelli introdotti nel 1994
– rese l'atmosfera se possibile ancora più caotica in Formula 1.
Michael Schumacher doveva disperatamente combattere per la conquista del
suo primo Campionato del Mondo Piloti mentre la sua squadra, la
Benetton venne scoperta in frequenti violazioni del Regolamento FIA, e
Schumacher venne sospeso di conseguenza per diverse corse. Anche la gara
valevole per il titolo in Australia fu controversa, a causa della
collisione con il rivale Damon Hill, figlio di Graham, con eliminò l'avversario, assicurandosi il mondiale.
Nella stagione 1995
la situazione realtiva alla sicurezza cominciò dunque a migliorare
mentre Schumacher vinceva il suo secondo titolo piloti, e la Benetton il
suo primo titolo costruttori con relativa facilità, battendo la
scuderia Williams di Hill e David Coulthard.
Il motore Renault, che ha alimentato entrambe le squadre era
virtualmente imbattibile, con la sola Ferrari a contrastarla timidamente
con la vittoria singola al Gran Premio del Canada di Jean Alesi, la sua unica vittoria in carriera.
|
 |
|
|
|
 |
| Mercedes: lo Stile, la
Produzione, le Corse. |
|
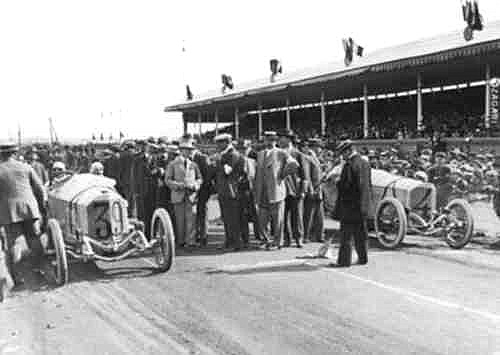 |
 |
VI°Grand Prix de l'A.C.F., Lione.
Su questo circuito la larghezza della sede stradale davanti alle
tribune consentiva di dare la partenza alle vetture per coppie, sempre
in base al sorteggio.
La prima era partita alle otto del mattino.
Salzer con il numero 39 e Wagner, penultimi nell'ordine di partenza,
scatteranno alle 8.09'.30'' di una bella giornata di sole.
|
19 ottobre 1924. IV° Gran Premio
d'Italia a Monza.
Daimler Mercedes "2 liter" Achtzylinder Rennwagen M 218.
Nell'immagine ripresa dall'interno dei box si evidenzia la disposizione
degli strumenti sul cruscotto con il manometro e la pompa di pressione
del serbatoio a disposizione del meccanico, mentre il manometro per la
pressione dell'olio ed il contagiri sono dietro al volante.
Su quest'ultimo, il disco dentato permette la regolazione dell'anticipo
mentre la leva del cambio è sulla destra all'esterno della
vettura, in questo caso la numero dodici di Louis Zborowski che vediamo
con la tuta bianca lavorare sul motore con il suo meccanico.
|
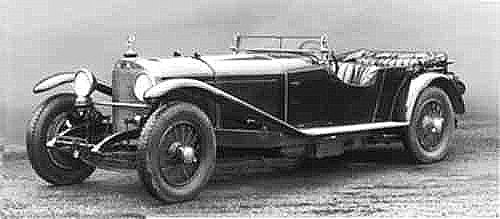 |
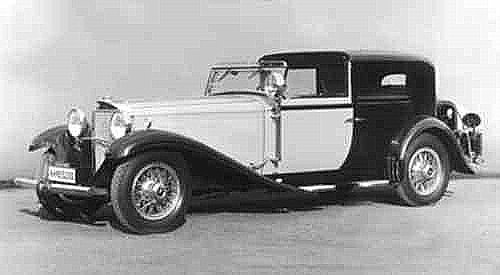 |
1926-1930. Mercedes Benz Typ S 26/120/180
PS. (W.9856 S).
Questa vettura continua la serie di prestigiose macchine da Gran
Turismo e Sport sotto la direzione di progetto di H. C. Ferdinand
Porsche.
Il motore è quello della 680 S di 6789 cmc., modificato in
alcuni parametri come la compressione, ora a 5:1, i giri, a 3200 /l' e
l'alimentazione, assicurata da due carburatori verticali Mercedes.
La velocità massima raggiungibile è di 188 km/h,
naturalmente con l'ausilio del compressore. |
1930-1938. Mercedes Benz Typ 770 "Grosser
Mercedes" (W. 07-M. 07) 150 PS. È stata la vettura di
maggior prestigio della Casa, presentata nell'autunno 1930 al Salone di
Parigi, poteva tranquillamente rivaleggiare con le miglior automobili
della produzione mondiale.
Il prezzo del nudo chassis era di 29500 Raich Mark, che saliva a 47.500
per una Cabriolet sovralimentata: all'epoca l'equivalente del valore di
una villa nella zona elegante di Berlino.
Fin dalla presentazione è stata in listino con la versione
sovralimentata equipaggiata con il motore M 07 K da 150/200 PS.
Nonostante a causa della sua mole, (5600 mm. di lunghezza, 1800 mm. di
altezza, 1840 mm. di larghezza e 2700 kg di peso), le intenzioni
fossero quelle di destinarla ad austera berlina di rappresentanza, gli
acquirenti la preferirono nelle bellissime carrozzerie coupè
e Cabriolet dell'epoca.
Nell'immagine una esemplare Coupè de Ville realizzata dalla
carrozzeria Jos. Neuss anche se, a parere personale, non gli giovano le
nervature longitudinali sul cofano. La ordinò il signor
Federico Wolmer di Amburgo, residente in Venezuela.
|
 |
 |
19 giugno 1927. Corsa di Apertura al
Nurburgring.
Una parte dello schieramento di partenza.
Con i numeri 1 e 2 sono le Mercedes Benz 680 "S", caratterizzate dal
telaio più basso visibile nel confronto con la numero 3 che
è una Modell "K" 24/100/140 PS.
In seconda fila a sinistra si scorge il cofano di una OM, mentre con il
numero 11 è una Austro Daimler.
|
7 agosto 1932. Corsa in salita al Klausen.
Hans Stuck si aggiudica la prova al volante di una 720 SSKL. ufficiale.
Si notano i fori di alleggerimento nella parte posteriore del
longherone del telaio.
|
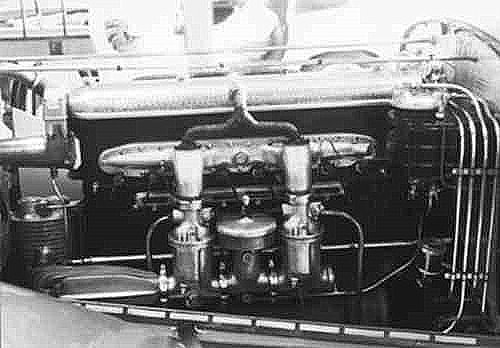 |
 |
| 1930-1932. Mercedes Benz Typ SS.
(W06-M.06) 27/140/200 Ps. Il motore, visto dal lato aspirazione, con i
due carburatori verticali a valle del compressore. |
15 aprile 1930. 4a Mille Miglia.
La coppia Caracciola-Werner con la Mercedes 720 SSK sul Passo della
Raticosa.
Caracciola è al debutto in questa corsa ed ha al suo fianco
il più famoso Christian Werner, ottimo pilota di Grand Prix
e già vincitore di due Targa Florio, nel 1922 e 1924.
Data la considerevole mole della vettura, compiono una ottima gara
attribuendosi il sesto posto assoluto e primi della loro categoria.
|
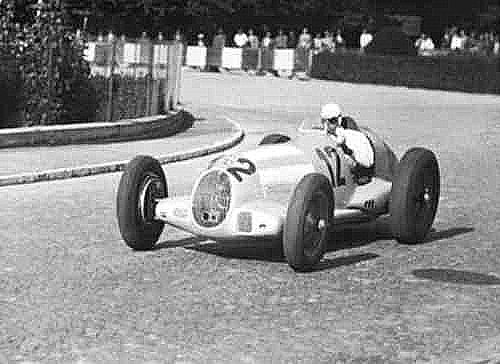 |
 |
| 23 ottobre 1936. III° Gran Premio
di Svizzera. Bremgarten. Con il numero 12 è Caracciola. |
1938. Mercedes Benz W. 154 (W. 154-M.
154). 468 PS. Una vista d'insieme della vettura durante le prove del
Gran premio di Tripoli.
Oltre a Neubauer, che indica qualche cosa a Brauchitsch, si notano
l'inclinazione del motore la comparsa della "T" ad indicare la vettura
di riserva.
|
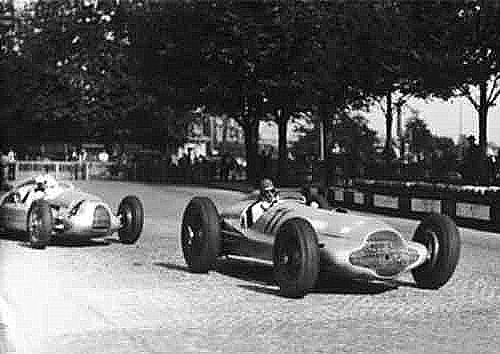 |
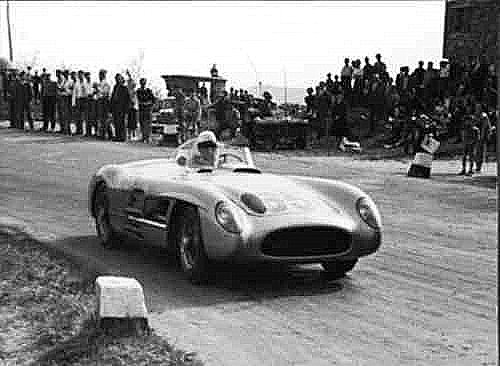 |
| 21 agosto 1938, quinto Gran Premio di
Svizzera. Una ripresa nelle prove, sotto il sole, Brauchitsch con la
vettura n° 11 (in gara avrà il 10), precede l'Auto
Union di Muller, l'altra sotto la pioggia della gara con Lang ripreso
di ¾ da dietro. |
Juan Manuel Fangio, al solito,
è autore di una gara superba, al termine della quale, con un
motore funzionante a sette cilindri da due terzi del percorso,
concluderà secondo. |
Mercedes-Benz W196 Streamliner
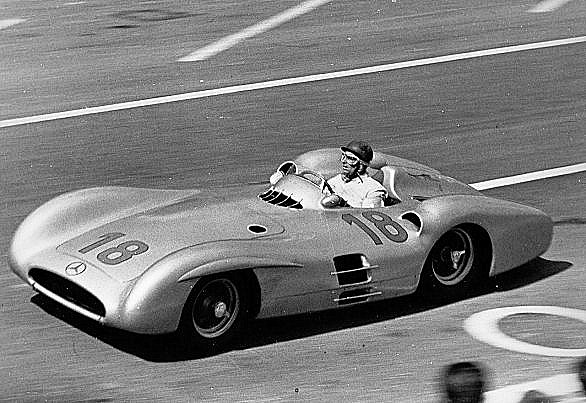 |
Al
Goodwood Revival 2011, evento che avrà luogo tra il 16 ed il 18 settembre,
Mercedes sarà presente per celebrare un’occasione speciale, i 100 anni dalla
nascita di Juan Manuel Fangio, nome leggendario dell’automobilismo legato a
doppio filo all’epopea delle Frecce d’Argento.
Cuore dell’esibizione della
Stella sarà una dimostrazione dinamica delle vetture da corsa che l’asso
argentino pilotò nelle stagioni 1954 e 1955 fino al titolo di Campione del Mondo
di Formula 1.
A pilotare questi gioielli, tra gli altri ci saranno Juan
Manuel Fangio II, nipote del pentacampione, e Sir Stirling Moss, che di Fangio
fu compagno di squadra. Il primo piloterà una W 196 R di F1 del 1954, mentre il
secondo sarà al volante di una 300 SLR del 1955.
|
Mercedes-Benz W196
Una delle monoposto più competitive che
la formula 1 abbia visto
alla partenza di un gran premio è
sicuramente la Mercedes W196.
 |
IL suo debutto avvenne il 4 luglio 1954 sul circuito di Reims in
Francia con i piloti Manuel Fangio, Hans Herrmann e Karl Kling; Fangio
vinse la gara seguito da Kling, mentre Herrmann segnò il
giro più veloce, da quel giorno iniziò il dominio
Mercedes, che si ritirò dai campi di gara già nel
1955 dopo aver vinto facilmente due mondiali con il pilota argentino,
la sua superiorità era evidente e non c'era più
nulla da dimostrare. Ad onor del vero bisogna aggiungere che la supremazia Mercedes venne
facilitata dalla prematura scomparsa del grandissimo Alberto Ascari,
che durante un test sul circuito di Monza, uscì
rovinosamente di pista alla parabolica con la Ferrari 750 Monza; erano
le 12.26 del 26 maggio 1955.
Fangio con la freccia d'argento vinse 8 gare (Reims, Nurburgring, Berna
e Monza nel 1954, Buenos Aires, Spa, Zandvoort e Monza nel 1955),
mentre Stirling Moss vinse nel 1955 ad Aintree ottenendo anche il giro
più veloce. Tecnicamente la Mercedes W196 era
all'avanguardia, il propulsore 8 cilindri di 2497 cc. ad iniezione
diretta meccanica e valvole desmodroniche era grado di sviluppare una
potenza di 275 cv., il motore era inclinato a sinistra di 25 gradi per
ottimizzare gli spazi all'interno del vano motore e per garantire un
baricentro più basso rispetto alla concorrenza, il telaio in
tubi era rivestito dalla carrozzeria in alluminio ed il peso
complessivo della vettura era di 720 kg.
La W196 subì anche delle evoluzioni, ad esempio nel 1955
sparì la versione a ruote coperte utilizzata in alcune gare
nel 1954, perché nel campionato del 1955 non erano
più ammesse monoposto a ruote coperte, un'altra vistosa
modifica riguardò l'impianto frenante, che passò
da entrobordo a fuoribordo sulle ruote anteriori.
In sintesi la Mercedes e Juan Manuel Fangio con il modello W 196 R
impressionarono il mondo della Formula 1. |
 |
Berlino 1954
AVUS GRAN PRIX
1° K.Kling (Mercedes Benz) - 2° J.M.Fangio (Mercedes Benz) - 3° H Herrmann (Mercedes Benz)
Monza - Garage Ferrari 1971
Smith - ER6 Kawasaki
 |
Jean-Pierre Wimille - Robert Benoit
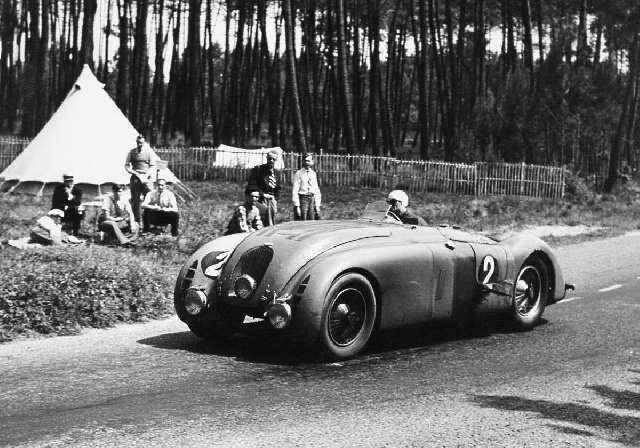
Bugatti T 57 G - motore 8 cilindri da 3.266 cc
La T 57, in versione sportiva, si rivelò
anche una straordinaria auto da corsa, vincendo per due volte la 24 Ore
di Le Mans: nel 1937 a trionfare furono Jean-Pierre Wimille e Robert
Benoit su una T 57 G modificata, con carrozzeria aperta e motore 8
cilindri da 3.266 cc, che ottenne la media record di 136,997 km/h; nel
1939, nuovo record a 139,781 km/h di media, grazie alla T 57 C con
motore sempre a 8 cilindri ma con cilindrata di 3.251 cc,
sovralimentato con compressore:
al volante ancora Jean-Pierre Wimille in coppia con Pierre Veyron.
Quest' ultimo periodo di ripresa coincise purtroppo con l' inizio della
fine del mito Bugatti, che avvenne pochi mesi pið tardi, non
solo a causa dello scoppio
della Seconda Guerra Mondiale.
L' 11 agosto 1939, provando la Tipo 57 vittoriosa a Le Mans su un
rettilineo stradale nei pressi di Duppigheim, a 10 km dallo
stabilimento di Molsheim, Jean uscì di strada per evitare un
ciclista e morì a soli trent'anni.
Ettore Bugatti si rifugiò disperato nel suo ufficio; quando
ne uscì per tornare a casa, prostrato, non si reggeva in
piedi. A chi gli offriva aiuto, rispose:
"Ognuno deve essere in grado di reggere il proprio peso".
|
|
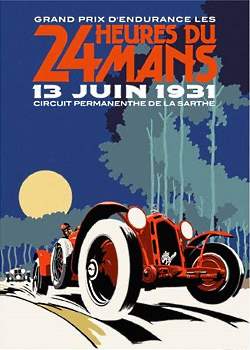 |
|
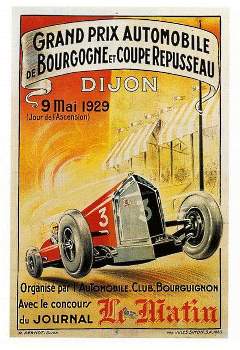 |
Vincenzo Lancia Fiat 50 hp, Targa Florio, 1908

Lancia Automobiles è una società controllata di FCA Italy, parte di Fiat Chrysler Automobiles.
Tra le più antiche case automobilistiche
italiane, fu fondata nel 1906 a Torino da Vincenzo Lancia e si
specializzò nella fabbricazione di veicoli di lusso.
Esistette come società autonoma per azioni fino al 1958, anno in cui fu
acquistata da Carlo Pesenti, proprietario di Italcementi, il quale
tuttavia nel 1969, per respingere un tentativo di scalata del suo gruppo
industriale da parte di Michele Sindona, cedette l'azienda alla FIAT
che, successivamente, nel 1986, dopo l'acquisizione dell'Alfa Romeo
dall'IRI, accorpò i due marchi sussidiari nella controllata Alfa-Lancia Industriale, in seguito nuovamente scorporati e divenuti separatamente parte del Gruppo Fiat.
Nel
2007 la Lancia divenne Lancia Automobiles che, dopo la formazione della
nuova capogruppo Fiat Chrysler Automobiles, è diventata una sussidiaria
di FCA Italy.
UN DECLINO SEMPRE PIU’ MALINCONICO.
GIANNI LANCIA, FIGLIO DEL FONDATORE VINCENZO E ARTEFICE DEI MODELLI SPORTIVI
DEGLI ANNI 50 (DALL’AURELIA B20, ALLA D24 ALLA D50) SI E’ SPENTO
ALL’ETA’ DI 90 ANNI.
|
 |
Si è spento a Torino, all’età di 90 anni, Giovanni “Gianni” Lancia,
figlio del fondatore Vincenzo. L’erede della dinastia Lancia riposa nel
cimitero di Fobello (provincia di Vercelli), nella cappella di
famiglia, accanto al padre.
Da questo piccolo paese, dove la dinastia Lancia imperversava fin
dalla metà del 1500, anche Vincenzo, classe 1881, si era stabilito a
Torino e qui aveva fondato il marchio automobilistico con il suo nome.
La morte di Gianni Lancia sembra quasi un altro segno del declino che
il marchio Lancia sta attraversando, ignorato dal Gruppo FCA e
relegato, da Sergio Marchionne a un brand di importanza esclusivamente
nazionale.
GIOVANE E COMBATTIVO
Gianni Lancia entra in azienda molto giovane e nel
’47 ne era salito alla guida. Ha solo 23 anni e una laurea fresca in
ingegneria conseguita all’Università di Pisa. Il giovane Lancia è bravo,
intraprendente, volitivo, visionario. Non contento dell’immagine
aziendale inizia subito un profondo processo di cambiamento ingaggiando il grande Vittorio Jano.
Da questa nuova gestione l’azienda di Chivasso si trasforma in un grande brand con forte accento sportivo. Vessillo di questo nuovo corso è la Aurelia, che nella versione B20 magistralmente carrozzata da Pininfarina diventa una delle prime Gran Turismo della storia e la prima in assoluto equipaggiata con un motore 6 cilindri a V.
L’impronta sportiva del marchio Lancia continuò a espandersi con la nascita della Squadra Corse Lancia animata da un esercito di nuovi modelli per la categoria Sport e monoposto.
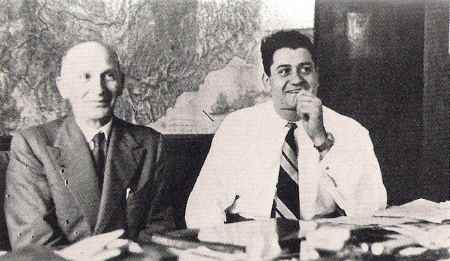 |
 |
Vittorio Jano - Gianni Lancia
|
Lancia D50
|
1954 - Mille Miglia - Lancia D24

Gianni Lancia con il pilota Aberto Ascari
|
Nascono, in quest’ottica la coupé D20 e le barchette sport D23, D24
(vincitrice della Carrera Panamericana Mexico del ’53 e la Mille Miglia del 1954
con Alberto Ascari) e D25. Il salto in Formula 1 avviene nel ’54 con la D50 progettata
da Jano (recentemente vista alla Vernasca Silver Flag 2014) |

|
 |
Lancia D23
|
Lancia D24 |
| Il Gran Premio di Pau 1955 è stata una gara extra-campionato di Formula 1, tenutasi l'11 aprile 1955 sul Circuito di Pau, a Pau, in Francia. |
|

Scuderia Lancia D50 - Gran Premio di Pau 1955
1 Jean Behra -2 Eugenio Castellotti -3 Roberto Mieres
|
Lancia D24
|
 |
| La D24, raggiungerà fama
internazionale dopo la vittoria alla Carrera Panamericana nel novembre
1953 (che le meriterà la denominazione di Lancia D24 Carrera),
calcherà la scena fino al termine della stagione 1954 ottenendo
parecchie affermazioni di prestigio (Mille Miglia, Targa Florio, Giro
di Sicilia) e verrà anche equipaggiata – nelle ultime
uscite – dal motore da 3,7 litri costruito per la macchina
destinata a sostituire la D24, ovvero la D25. Come per tutte le
macchine da corsa che si rispettino, anche la D24 subisce nel corso
della sua esistenza parecchie modifiche destinate a migliorare ora le
prestazioni ora l'affidabilità: si tratta peraltro di
affinamenti di non grande rilevanza. |
L’ABBANDONO
I successi sportivi, tuttavia, non riescono a eguagliare quelli finanziari, gravati da ingenti investimenti (le fabbriche e un grattacielo) che avevano fiaccato le casse aziendali.
Fortemente osteggiato da contrasti interni, nel 1955 Gianni Lancia è costretto a vendere l’azienda. Il marchio viene ceduto al Gruppo Pesenti. Il nuovo Presidente, Giampiero Pesenti, fa terra bruciata di tutti i Lancia del consiglio di Amministrazioni: prima Gianni poi le sorelle Eleonora e Anna Maria.
Si trasferisce in Brasile, dove mette in piedi un’attività nel settore alimentare. Negli ultimi anni di vita torna in Europa e sceglie la Costa Azzurra
per una tranquilla pensione, al riparo da qualsiasi tentativo di
estorcergli qualche intervista sui bei tempi alla guida della Lancia.
|
La locomotiva Bayard
La locomotiva Bayard è una delle
locomotive a vapore costruite come prima dotazione della ferrovia
Napoli-Portici.
Per alcuni decenni fu ritenuta la prima locomotiva
italiana. |
 |
|
Il Museo nazionale ferroviario di Pietrarsa
è un museo ferroviario ubicato tra Napoli (quartiere di San
Giovanni a Teduccio) e Portici. Il complesso è posto tra il mare
e la stazione ferroviaria di Pietrarsa-San Giorgio a Cremano.
Il museo è gestito dalla Fondazione FS Italiane delle Ferrovie dello Stato Italiane.
|
STEFANO GAI CAMPIONE ITALIANO FERRARI CHALLENGE 2011 - TROFEO PIRELLI
|
|
A Maranello
nel 73 arriva Luca Cordero di Montezemolo un Avvocato giovanissimo a cui la
Ferrari affida la direzione sportiva.
Sotto la sua direzione la Ferrari ha
vinto campionati mondiali piloti e costruttori.
|
Corteo Storico per le Finali Mondiali Ferrari 2011
|
Riviera dei Fiori
|
Il Gran Premio di San
Remo 1949 è stato un Gran Premio di gara automobilistica tenutasi a San
Remo il 3 aprile 1949. La gara, che si tiene in due manche, è stato
vinto da Juan Manuel Fangio . 1949 Gran Premio di San Remo -
https://it.qaz.wiki/wiki/1949_San_Remo_Grand_Prix
Gran Premio di San Remo 1949. La gara, che si tenne in due manche, fu vinta da Juan Manuel Fangio .
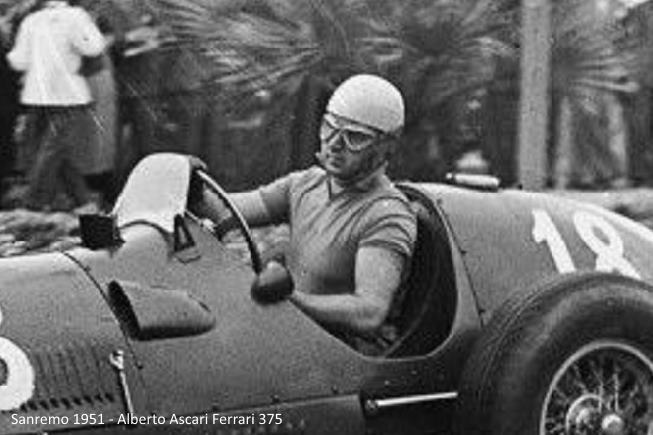 |
|
 |
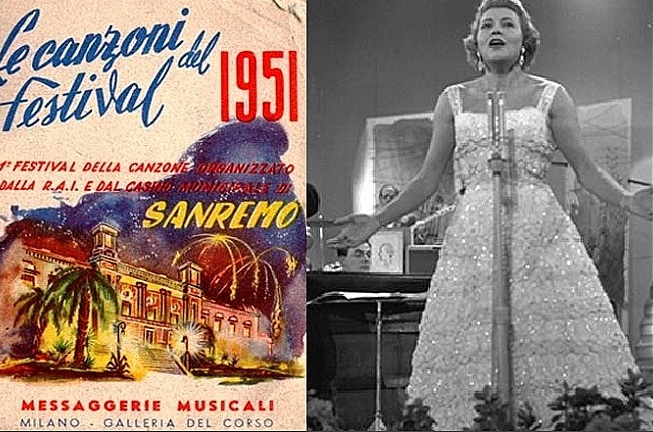 |
|
La gara fu contraddistinta dal dominio delle Ferrari che si aggiudicarono le prime tre posizioni con Alberto Ascari,
Dorino Serafini e lo svizzero Rudolf Fischer. Solamente l'incidente
occorso a Luigi Villoresi al 62º giro quando urtava l'auto di Reg
Parnell parcheggiata a lato della strada impediva un podio tutto
italiano. Si è trattata della prima vittoria stagionale per il
corridore milanese che nell'occasione ha collaudato con successo un
nuovo propulsore da 4500 cm³ a doppia accensione sviluppato
dalla casa di Modena.
Nilla Pizzi fu la vincitrice del primo Festival di Sanremo nel 1951,
con Grazie dei fiori.
|
|
Il Gran Premio di San
Remo 1949 è stato un Gran Premio di gara automobilistica tenutasi a San
Remo il 3 aprile 1949. La gara, che si tiene in due manche, è stato
vinto da Juan Manuel Fangio . 1949 Gran Premio di San Remo -
https://it.qaz.wiki/wiki/1949_San_Remo_Grand_Prix
|
Il Gran Premio di San
Remo 1949 è stato un Gran Premio di gara automobilistica tenutasi a San
Remo il 3 aprile 1949. La gara, che si tiene in due manche, è stato
vinto da Juan Manuel Fangio . 1949 Gran Premio di San Remo -
https://it.qaz.wiki/wiki/1949_San_Remo_Grand_Prix
Il Gran Premio di San
Remo 1949 è stato un Gran Premio di gara automobilistica tenutasi a San
Remo il 3 aprile 1949. La gara, che si tiene in due manche, è stato
vinto da Juan Manuel Fangio . 1949 Gran Premio di San Remo -
https://it.qaz.wiki/wiki/1949_San_Remo_Grand_Prix
 |
|
Storia della Formula 1
Fine dell'era dei privati (1996-1999)
Per la stagione 1996,
la FIA diede mandato di un più largo formato della minima grandezza
della cabina di guida, con la protezione della testa del pilota, per
assicurargli maggiore sicurezza. Come parte del piano per ricostruire la
Ferrari, Jean Todt
fece ingaggiare Michael Schumacher dal team Benetton in quell'anno, in
cambio dei due piloti Alesi e Berger. Ci furono effetti immediati, nel
suo primo anno con la scuderia Schumacher vinse tre gare, più di quanto
la squadra aveva ottenuto nei cinque anni precedenti. La Ferrari non
poteva ancora lottare per il titolo e Damon Hill diede un impatto forte
al suo campionato, conquistando la corona dopo tre anni di tentativi
falliti.
Nella stagione 1997,
un altro figlio di un pilota leggendario della F1 conquistò il
titolo ancora una volta con la Williams, e Jacques Villeneuve divenne
il quarto pilota a vincere nello stesso anno in Formula One e nel
campionato CART (gli altri erano Mario Andretti, Emerson Fittipaldi, e
Nigel Mansell). Questa stagione fu più combattuta della
precedente, e Villeneuve conquistò il Campionato Piloti soltanto
nella gara finale. Ancora una volta, Michael Schumacher ebbe una
collisione con il suo rivale nella corsa finale, ma a differenza del
1994 l'evento si ritorse contro di lui: Schumacher non solo venne
battuto in gara, ma per aver tentato di buttare deliberatamente fuori
dalla pista Villeneuve, gli fu tolta la seconda posizione nel
Campionato, pur preservando tutti i risultati ottenuti.
Alla fine del 1997
la Renault si ritirò momentaneamente dalla Formula 1. La
McLaren-Mercedes prese la corona di campione per i due anni successivi,
entrambi conquistati da Mika Häkkinen. Nelle prime gare del 1998
il finlandese era veramente irraggiungibile e i suoi contendenti,
Schumacher e Villeneuve, potevano solo guardare. Schumacher nel
prosieguo della stagione diede vita ad una ammirabile rimonta che lo
portò a lottare per il titolo fino all'ultima gara, ma lo
spegnimento del motore sulla griglia del Gran Premio del Giappone e una
successiva foratura nel corso della gara resero il tutto vano. La
stagione 1999 fu una stagione combattuta quanto anomala. Villeneuve fu
subito fuori dai giochi con la nuova scuderia BAR mentre Schumacher fu
a lungo in lotta con Häkkinen fino a che, a causa di un
inconveniente meccanico ai freni, impattò contro le barriere di
pneumatici a Silverstone, nel Gran Premio di Gran Bretagna,
fratturandosi una gamba. Il suo compagno di squadra Eddie Irvine
divenne così primo pilota della Scuderia Ferrari e finì
lui stesso in corsa per il titolo. Schumacher lo aiutò al
rientro dopo sei gare saltate e sebbene Irvine perse per solo due punti
dal vincitore Mika Häkkinen, il suo sforzo bastò per ridare
alla Ferrari il titolo costruttori che non vinceva dal 1983.
Dietro le
corse al titolo, tuttavia, vi erano segnali di fermento non
incoraggianti di problemi in Formula 1. Nomi presenti per lungo tempo,
gloriosi e rispettati come Brabham e Lotus, con il passaggio di
Ecclestone alla guida della serie e la scomparsa di Chapman, svanirono
subito dalle griglie di partenza. La scuderia francese Ligier si
trovò in condizioni economiche disperate e venne venduta ad
Alain Prost. La scuderia di Ken Tyrrell continuò ancora per
qualche tempo, con risultati miseri, fino al 1998, quando la BAR
rilevò il team. La variopinta era delle piccole scuderie fondate
da privati stava volgendo al termine e lo stesso accadde con le
sponsorizzazioni. Nomi come Larrousse, Dallara, Simtek, Pacific Racing,
e Forti non si videro più. Le ultime a chiudere i battenti
furono la Jordan, Arrows e la Minardi
che sopravvissero ancora qualche tempo. La breve notorietà della Jordan
nel 1998 e nel 1999, sotto la guida di piloti di solida esperienza come
lo stesso Damon Hill, Heinz-Harald Frentzen, e il fratello minore di Michael, Ralf Schumacher
fu l'ultimo sussulto di orgoglio dei privatisti e non rappresentò
un'autentica rinascita dello sport. Anche un team come la Benetton, di
proprietà e guida italiani ma di telaio britannico, campioni soltanto
pochi anni prima, stava sopravvivendo a malapena. Jackie Stewart
fronteggiò la sua scuderia dal 1997 al 1999 con il sostegno della Ford
ma alla fine arrivò la vendita inevitabile e la trasformazione del nome
nella Jaguar.
|
 |
|
Lancia D50
 |
 |
| L'Attrice Linda Christian con il Marchese Alfonso De Portago all'aeroporto di Londra |
Ferrari Lancia D50 Streamliner 1956 (Alfonso De Portago) |
|
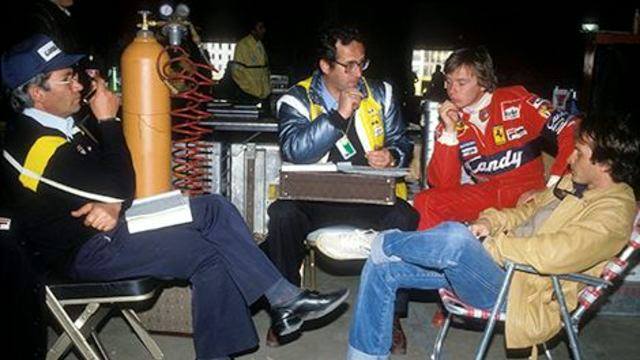 |
Gran Premio di Germania 1981
Antonio Tomaini, Mauro Forghieri, Didier Pironi e Gilles Villeneuve
|
|

1950. La Fia organizza il
primo campionato mondiale di F1. L’ Alfa Corse partecipa con Giuseppe Farina , Juan Manuel Fangio
e Luigi Fagioli (un vero veterano: nato nel 1898) ma soprattutto ancora con
l’imbattibile 158, che verrà sostituita a fine stagione con l’appena appena modificata 159. Il propulsore raggiunge oramai i 350 cavalli. L’Alfetta vince
tutte le gare europee del campionato. La Fia aveva messo nel calendario iridato
anche la 500
Miglia di Indianapolis (vi rimarrà sino al 1960)
nell’inutile speranza di gettare un ponte verso le anarchiche federazioni
sportive americane. Ma il tentativo di osmosi non avrà alcun successo. Fangio
vince 3 gare (Monaco, Belgio, Francia) e Farina le altre 3 (Gran Bretagna,
Svizzera, Italia) laureandosi campione del mondo. Il pilota torinese, all’ultima
gara di Monza,farà debuttare - vincendo - la 159 che l’anno successivo
consentirà a Fangio di vincere il primo dei suoi 5 titoli di campione del
mondo.
L'Alfa Romeo 158 come era al debutto nel 1950.
158, come tanti
numeri di progetto nel mondo dell’auto, non è un numero progressivo. Le prime
due cifre significano 1500cc. L’8 sta per otto cilindri. L’Alfa Romeo 158 è la
vettura più longeva del mondo delle corse. Progettata nel 1937, finì il suo
ciclo nel 1950. Corse per 13 anni. Un record, pur tenendo conto dello stop
imposto dalla seconda guerra mondiale a tutte le attività sportive.
Il telaio
della macchina fu progettato da Orazio Satta Puliga, il propulsore da Gioachino
Colombo. Alberto Massimino si occupò delle sospensioni e del cambio.
Quest’ultimo fu posizionato in un unico blocco nel retrotreno, come nelle
Lancia. Furono utilizzati i migliori materiali dell’epoca, a volta addirittura
futuristici. Il monoblocco era realizzato in elektron, una speciale lega
ultraleggera al magnesio.
L’albero motore era costruito con acciaio ad alto tenore di nichel e cromo. La
distribuzione, a cascata di ingranaggi, era a quattro valvole per cilindro. Il
motore era sovralimentato con un compressone volumetrico Roots monostadio.
Sviluppava 158 cavalli, a 6500 giri/minuto. Si giunse poi a 195 cavalli, a 7000
giri/minuto. Niente male, se si considera che la vettura era dotata di impianto
frenante a tamburo e di strettissime ruote a raggi nelle quali venivano montati
pneumatici Pirelli Stelvio.
IL DEBUTTO. L’ Alfa
Corse, all’epoca diretta da Enzo Ferrari, il 7 agosto 1938 porta la vettura al
circuito del Montenero di Livorno: un percorso cittadino di 5800 metri da ripetere 25
volte (145 km). Conquista il primo e il secondo posto nella Coppa Ciano riservata alle
“voiturette” con Emilio Villoresi e Clemente Biondetti. Nel 1939 l’evoluzione:
il motore dell’Alfetta (così chiamata perché compatta, in linea coi nuovi
regolamenti della categoria vetturette) sviluppa 225 cavalli a 7500 giri/minuto.
Giuseppe Farina si aggiudica la Coppa Ciano (Livorno) e Clemente Biondetti la
Coppa Acerbo.
Nel 1940 Farina vince la gara per vetturette al Gran Premio di
Tripoli
LA
GUERRA. Scoppia il secondo
conflitto mondiale e chi può ricovera le vetture in un luogo sicuro e
soprattutto lontano dai centri abitati.
Le Alfette vengono nascoste nelle
campagne attorno a Milano ed in alcuni granai della Toscana.
SI
RIPARTE. Nel 1946 la
federazione automobilistica internazionale autorizza la ripresa delle
competizioni. All’Alfetta viene ritoccato il motore, che raggiunge la potenza di
250 cavalli. Già in quell’anno la 158 vince il GP delle Nazioni a Ginevra. Il
team è diretto da Gian Paolo Garcea, responsabile del reparto esprienze della
casa milanese. Il podio è monopolizzato dai piloti Alfa: 1. Giuseppe Farina, 2.
Carlo Felice Trossi, 3. Jean Pierre Wimille. Alla gara partecipa anche Tazio
Nuvolari, che è quarto al termine su Maserati. La stampa esalta la giornata come
una riscossa del lavoro italiano dopo la sconfitta bellica. Le Alfa avevano già
precedentemente debuttato in una gara svoltasi a St. Cloud (vincitore Raymond
Sommer su Maserati), ritirandosi per problemi al cambio. Varzi e Wimille sono
poi primo e secondo al GP del Valentino di Torino. Al GP di Milano vince invece
Carlo Felice Trossi, seguito da Varzi e da Consalvo Sanesi.
3
STADI. Nel 1947 arriva il
nuovo compressore Roots 3 stadi. La potenza è di 275 cavalli. L’annata
internazionale vede ben 4 vittorie della
casa del quadrifoglio. Sul terribile Bremgarten (GP di Svizzera) ed al GP del
Belgio si impone Wimille. Il GP di Bari vede la vittoria di Varzi e il 17esimo
GP d’Italia (disputatosi a Milano, attorno al Parco Sempione) vede vincere Carlo
Felice Trossi.
1948. Achille Varzi perde
la vita durante le prove del GP di Svizzera al Bremgarten. Poche ore prima era
morto il motociclista Omobono Tenni. La gara viene vinta da Carlo Felice Trossi.
Wimille vince invece il 35esimo GP di Francia a Reims davanti ai compagni di
squadra Sanesi ed Alberto Ascari. A fine stagione si corre a Monza il
tradizionale GP dell’Autodromo, vinto ancora da Wimille. Dietro a lui, Trossi,
Sanesi e Piero Taruffi. Tutti, ovviamente, su Alfetta.
1949
TRAGICO. All’inizio dela
stagione Jean Pierre Wimille, che è ormai il pilota di punta della squadra
milanese, perde la vita alla Temporada Argentina di Buenos Aires. Il conte Trossi si spegne a causa di un cancro.
|
|

Lotus Climax 25
N.Cilindri 8 - Cilindrata cmc.1496 - Potenza CV. 204 - Peso Kg. 450
|
|
|
Negli anni 60 la F1 ebbe una grande trasformazione,
dai preistorici mezzi a motore anteriore, si passava a piccole e veloci
f1 a motore posteriore, rivoluzione portata da Cooper che
"scandalizzò" Enzo Ferrari.
Una delle innovazioni fu il telaio monoscocca nel 1962, un idea
derivata dall'aeronautica.
La monoscocca era una scocca portante che sostituiva la complessa
disposizione dei tubi usata fino ad allora x realizzare i telai delle
vetture. Con la monoscocca la carrozzeria era il telaio, e non
semplicemente un qualcosa avvitata su di essa. Debutto nel 1962 in F1
con la Lotus 25 Climax.Oltre a semplificare la struttura della macchina,
la Lotus 25 era tre volte + rigida del telaio in tubi della Lotus 24
dello stesso anno, in più la Lotus 25 pesava la
metà. Più il telaio è rigido
più è in grado di sostenere un carico elevato e
maggiore èprecisione con cui si può controllare
la sospensione.
Con un telaio più rigido e con i progressi nelle mescole
delle gomme, i pneumatici divennero sempre più larghi: la
loro dimensione nel 1960 era di 6,5 pollici x arrivare nel 1969 a 14
pollici, che di conseguenza aumentò la velocità e
stabilità in curva.
MONZA 1963 CLARK VINCE IL GP DI MONZA E SI LAUREA
CAMPIONE DEL MONDO
QUELL'ANNO CLARK VINCE 7 GP SU 10 ED UN
SECONDO POSTO
1963 - La Lotus vince il suo primo titolo costruttori
|
 |
1949, Hockenheim

Altri Anni... |
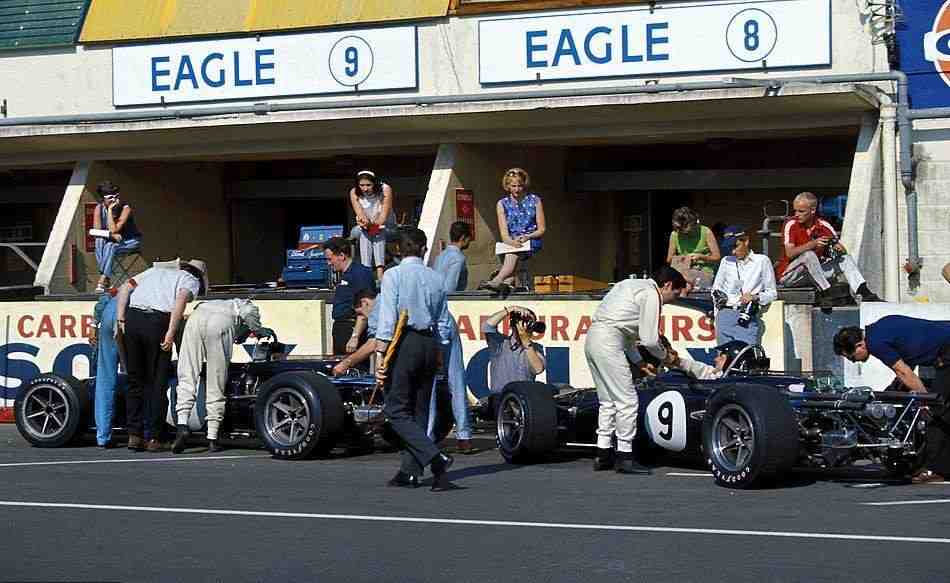 |
Il Gran Premio di Francia 1967 fu una gara di Formula 1, disputatasi il 2 luglio 1967 sul Circuito Bugatti a Le Mans.
Fu la quinta prova del mondiale 1967 e vide la vittoria di Jack Brabham su Brabham-Repco, seguito dal compagno di squadra
Denny Hulme e da Jackie Stewart. |
|
1
maggio, sono 60 anni esatti dalla vittoria di Stirling Moss e Denis
Jenkinson su Mercedes nella Mille Miglia 1955,
segnarono il record mai
più battuto.
|
 |
|
Storia della Formula 1
La Renault spodesta la Ferrari (2005-2006)
Nella stagione 2005,
la Formula 1 vide la Ferrari uscire subito fuori dai giochi, con il
team Renault dominare la prima parte della stagione e Fernando Alonso
mostrare una chiara sicurezza per tutto il campionato. Nella seconda
parte della stagione la McLaren dimostrò significativi progressi, con
risultati costantemente migliorati e un riscontro di vittorie da 6 sulle
7 corse. Tuttavia la poca affidabilità della vettura inglese, a fronte
di prestazioni invidiabili, permise ad Alonso di controllare per tutta
la stagione.
Per un istante era sembrato che Räikkönen potesse lottare seriamente con Alonso,
ma a tre gare dalla fine, in Brasile Alonso fu il primo spagnolo e il
più giovane Campione del Mondo, battendo dopo 33 anni il record di
Fittipaldi. Il Campionato Costruttori sembrava di facile conquista per
la McLaren,
che era considerata l'automobile più veloce del lotto e nel corso della
stagione era migliorata in affidabilità. Il cambio di regolamenti
avvenuto in quell'anno – due in particolare, il divieto del cambio degli
pneumatici e soprattutto quello del motore dopo due gare – e un
inopinato ritiro di Juan Pablo Montoya
nella gara finale della stagione, il Gran Premio di Cina a Shanghai,
assicurò anche quel titolo alla Renault. Una statistica ha dimostrato il
dominio dei due team: si sono lasciati sfuggire soltanto una gara, il
controverso Gran Premio degli Stati Uniti (alla quale parteciparono solo
tre scuderie), la sola gara che Schumacher e la Ferrari hanno vinto in
quell'annata.
I piccoli team
specialisti finirono per sparire a partire dal settembre 2005, con la
Minardi acquistata dalla Red Bull e rinominata Scuderia Toro Rosso per
gareggiare come team satellite della stessa Red Bull Racing. La Jordan
venne acquistata dalla multinazionale dell'acciaio russo–canadese
Midland nei primi mesi del 2005 e cambiò il nome in Midland F1 per la stagione 2006. Nel giugno 2005, la BMW acquistò la maggioranza delle azioni della Sauber,
cambiando il nome alla scuderia, mentre la Williams cessò la
collaborazione con la BMW fornendo una disposizione commerciale
preferenziale con la Cosworth. Allo stesso modo, la Honda acquistò le
azioni della BAR e rientrò a tutti gli effetti come scuderia. Per il
2006 le scuderie manufattrici raggiunsero il livello più basso di
presenza mai toccato in precedenza nella storia dello sport.
La stagione 2006 fu l'ultima ad avere due fornitori degli pneumatici, la giapponese Bridgestone e la francese Michelin.
Quest'ultima, probabilmente scottata dalle controversie suscitate nella
gara statunitense del 2005, annunciò il ritiro anticipato al termine
del 2006 – il termine prefissato era alla fine del 2007 – poiché,
secondo una disposizione della FIA del dicembre 2005 che prevedeva un
unico fornitore degli pneumatici, non voleva rimanere l'unica
fornitrice. La Bridgestone fornirà dunque in esclusiva le gomme in
Formula 1 fino al 2010 compreso.
La Renault e Fernando Alonso confermarono i successi nei
campionati Costruttori e Piloti, ma la stagione fu più combattuta del
previsto. La regola del cambio di motore rimaneva invariata, ma venne
reintrodotto il cambio degli pneumatici e un nuovo sistema di
qualifiche, il cosiddetto “knock-out” che rimpiazzava definitivamente il
poco gradito, da pubblico e piloti, “giro secco”. Il campione del mondo
spagnolo conquistò sei vittorie (quattro di queste furono consecutive),
mentre Giancarlo Fisichella vinse la terza gara della sua carriera.
Schumacher e la Ferrari, dopo un inizio stentato, iniziano la rimonta
vincendo quattro gare nel periodo estivo, da Imola a Hockenheim.
Jenson Button vinse la sua prima gara in Formula 1 al Gran Premio
di Ungheria, mentre Alonso venne costretto al ritiro per problemi
meccanici e Schumacher non fece di meglio. Furono proprio alcuni errori
strategici del pilota tedesco – non ultima, la controversa fermata (o
blocco volontario) della vettura nella curva a 180º della Rascasse
durante le qualifiche a Montecarlo – a risultare alla lunga decisivi.
Il suo compagno di squadra Felipe Massa vinse il Gran Premio di Turchia,
Alonso estese il vantaggio su Schumacher, ma nelle due gare successive a
Monza, grazie alla rottura del motore della Renault di Alonso, e a
Shanghai il pilota tedesco si portò in perfetta parità, completando la
rimonta.
Quando sembrava che il titolo stesse scivolando nelle mani del
tedesco, ecco che in Giappone deve subire la rottura del motore a 17
giri dalla conclusione e in Brasile fu alle prese con un problema al
sistema di rifornimento, che lo obbligò a partire dalla quinta fila. Nel
prosieguo della gara subì un contatto con Fisichella che lo fece
ripartire dai box in ultima posizione, da cui iniziò una splendida
rimonta fino al quarto posto. Ad Alonso basta un piazzamento a punti per
confermarsi, diventando così il più giovane campione del mondo ad aver
conquistato per due volte consecutive il titolo mondiale. Felipe Massa
vince la seconda gara in carriera davanti al suo pubblico, esattamente
come fece Senna nel 1993.
|
 |

La Fiat 600, un simbolo del miracolo economico italiano
Galleria Fotografica Temporada Argentina
Come
la seconda guerra mondiale finì, gli argentini cominciarono lentamente
a tornare alla pratica sport motoristici, dopo anni in cui era stato
sospeso a causa della carenza di parti di ricambio, pneumatici e
materie prime di base per lo sviluppo o per preparare automobili. Ma
quelle auto e quelli motori che aveva taciuto durante la Grande Guerra erano ancora intatte e pronte
per tornare a essere avviato. |
 |
|
Nel
1946, il Automovil Club Argentino (ACA) ha ripreso il compito di
diffondere lo sport dell'automobile, organizzando due Fuerza Limitada
(Limited Force) le gare che simboleggiava il riavvio dell'attività dopoguerra.
L’Automobile
Club del paese sudamericano, con l’appoggio del Governo del
generale Peròn, punta su Fangio con grande convinzione. Nei
primi mesi del 1947, hanno deciso di organizzare una serie di tre gare
per il cosiddetto "Autos Especiales" (macchine speciali) o Grand Prix,
con la presenza dei grandi assi europei del momento e utilizzando per
questo due "parco tipo "circuiti con l'approvazione delle
autorità internazionali, uno a Retiro di Buenos Aires, e l'altro
presso il Parque Independencia a Rosa.
|
 |
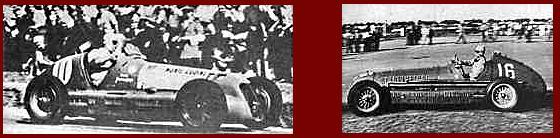 |
1948 - Secondo Gran Premio
Juan Domingo Peron |
1948 - Primo Gran Premio Internazionale General San Martin |
 |
|
1949 Secondo Gran Premio Juan Domingo Peron
1949 -Terza Coppa Acciòn de San Lorenzo
|
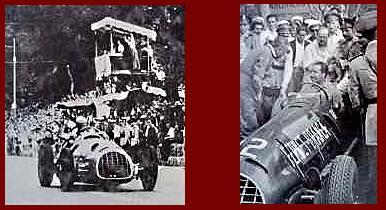 |
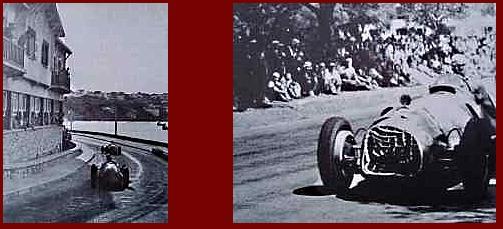 |
| 1949 Terzo Gran Premio Juan Domingo Peron |
1950 Terzo Gran Premio Internazionale General San Martin |
 |
 |
|
1950 -Quarta Coppa de acciòn San Lorenzo 1950 - GP Juan Domingo Peron 1951
|
GP di Montevideo 1952
|
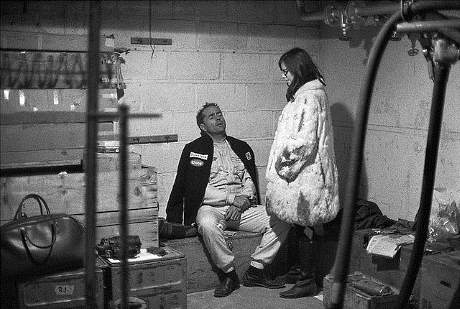 |
 |
1967 - Phil Hill 24 Ore di Le Mans
|
Hospitality anni '60 - Le Mans 1967
|
|
Alfa Romeo 6C 2300 Berlinetta Mille Miglia (1937)
Questa automobile colpisce per le sue forme aerodinamiche e decisamente
moderne per l'epoca. La carrozzeria era stata realizzata dalla Touring
con una modalità costruttiva "Superleggera" che permetteva appunto
leggerezza e robustezza e che venne anche adottata da molti modelli
della Ferrari del primo periodo. Tale sistema costruttivo prevedeva la
realizzazione di una leggerissima struttura tubolare che sosteneva la
pannellatura di rivestimento in alluminio. La 6C 2300 MM era dotata di
un 6 cilindri in linea da circa 105 CV di potenza massima a 4800 giri e
l'esemplare mostrato è solo uno delle tante varianti che la meccanica
ebbe modo di originare sotto le mani esperte dei migliori carrozzieri
dell'epoca. |
CURVA DUNLOP
 |
L’edizione dell’86
è l’ultima gara dove si vedrà la mitica
nonché terribile curva Dunlop, causa di tanti incidenti. La
vittoria di quella Le Mans andò ancora una volta alla Porche
del trio formato da Bell, Stuck e Holbert. Sempre Pescarolo ricorda
quell’edizione: "All’inizio della curva Dunlop si
entrava sui 280 km/h. Era veramente una curva difficile da affrontare,
eravamo veloci ma non al massimo. Si sono visti tanti grandi incidenti,
alcuni fatali, le macchine in quel punto decollavano, era veramente
terribile.
Dal punto di vista di un pilota era qualcosa di straordinario, molto
pericoloso, ma anche molto interessante". Pescarolo spiega meglio come
i piloti affrontavano quel punto del tracciato: "L’entrata
della chicane era veramente veloce.
Si arrivava a 285 km/h, poi una grande frenata prima della curva.
La chicane si attraversava tutta in terza ed era veramente interessante
per un pilota, perché frenare e scalare in curva non
è affatto facile".
|
|
|
 |
Astronauta James Irwin, missione Apollo 15, 1 agosto 1971 con il "Lunar Roving Vehicle" (NASA)
La Honda si ritira!
|
05/12/2008
 La
Honda lascia la Formula 1: nell'anno della crisi finanziaria e industriale,
la casa giapponese si è data tempo un mese per trovare un acquirente per il
suo team. L'alternativa è chiudere il paddock e lasciare senza monoposto
Jenson Button e Rubens Barrichello, peraltro ancora non confermati al
volante della Honda. Domani mattina, potrebbe giungere l'annuncio ufficiale
della messa in vendita del team di Brackley. La
Honda lascia la Formula 1: nell'anno della crisi finanziaria e industriale,
la casa giapponese si è data tempo un mese per trovare un acquirente per il
suo team. L'alternativa è chiudere il paddock e lasciare senza monoposto
Jenson Button e Rubens Barrichello, peraltro ancora non confermati al
volante della Honda. Domani mattina, potrebbe giungere l'annuncio ufficiale
della messa in vendita del team di Brackley.
A rivelarlo è stato una fonte qualificata di un team rivale, al termine
di un incontro tra l'associazione dei team di Formula 1, la Fota
(l'organismo che riunisce le scuderie del Circus), ha citato le affermazioni
di Ross Brawn e Nicky Fry, i due responsabili della Honda. "Hanno tempo un
mese per trovare un acquirente, altrimenti chiudono". Secondo la Bbc la
scuderia si sarebbe anche ritirata dal mondiale 2009.
Oggi, sia Ross Brawn che Nick Fry sono volati in Giappone per partecipare
ad una riunione presso la sede della casa automobilistica nipponica. Secondo
quanto riferito da Autosport, il team verrebbe messo in vendita per 100
milioni di sterline, l'ultima data utile per l'acquisto, sostiene la
rivista, è il 31 marzo 2009. Se entro quella data non dovesse trovarsi un
acquirente potrebbero chiudersi per sempre le saracinese del garage del
team.
Sempre secondo Autosport, la scuderia potrebbe anche essere ceduta a
costo zero, con la fornitura per un anno dei motori giapponesi, oppure, per
gli ottimi rapporti che legano ancora Ross Brawn alla Ferrari, la scuderia
di Maranello potrebbe girargli i propulsori che facevano parte della
fornitura alla Force India.
|
 |
| Paddock - Rally di Monte-Carlo 1959 |
 |
 |
|
|

MONOSCOCCA - MOTORE PORTANTE - LOTUS 72 -
EFFETTO SUOLO
|
|

|
|
L’uomo vestito di nero
scattò dal muretto un attimo prima che il bolide tagliasse
il traguardo. Come sempre, mentre la bandiera a scacchi sventolava
decretando l’ennesima vittoria di uno dei suoi gioielli, in
segno di gioia lanciò in aria il berretto di velluto nero
con la tesa di stoffa ed alzò le braccia al cielo. |
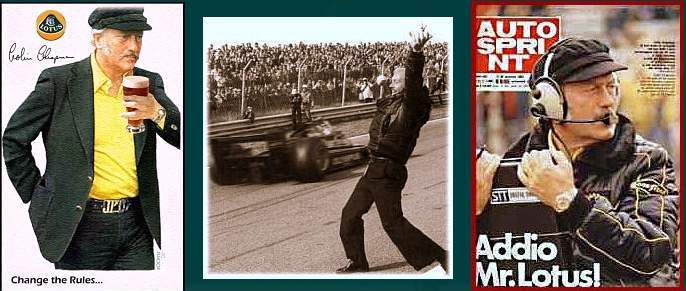 |
Le vittorie Lotus? Una più bella dell'altra. Ma forse, la
più significativa per noi italiani è quella
ottenuta
da De Angelis al GP di Austria 1982. Un arrivo in volata con
la Williams di Rosberg da crepacuore.
Chapman lancia in aria il suo cappello per l'ultima volta.
|
|
Il sedici dicembre di quello
stesso 1982 che aveva già portato via Villeneuve e Paletti
il Circus della F1 viene scosso da un breve annuncio: -”Colin
Chapman”- leggono gli speaker dei notiziari di tutto il mondo
–“è morto improvvisamente stroncato da
un infarto”-.
Pochissimi dettagli, tanto da indurre in molti il sospetto che, come
accadeva a James Bond , anche lui potesse tornare presto sulla scena
dopo aver finto la morte, magari per sfuggire ad una situazione
finanziaria preoccupante.
Non sarà così, i “baffi del
diavolo” scompariranno per sempre dagli autodromi di tutto il
mondo ed Enzo Ferrari, tanto più vecchio di lui, gli
sopravviverà ancora per sei anni; senza un simile
avversario, di certo i meno affascinanti della sua lunga vita.
|
|

Jim Clark (Ford Lotus Cotina) seguito da Jack Brabham (Ford Mustang) - Goodwood, 1966
lLa Ford Inglese per opporsi allo
strapotere della Jaguar MKII 3.8 si rivolse a Colin Chapman.
La Cortina Lotus nelle mani di Chapman divenne una macchina veloce
grazie anche ad un elaborato sistema
di molle elicoidali e bracci su un
ponte alleggerito.
L'hanno guidata piloti leggendari come Jim Clark, Graham Hill, Jackie
Stewart, Jacky Ickx.
La Cortina Lotus fu una vera palestra di campioni.
tticon
1965 - La foto di Colin Chapman e di Jim Clark
alla partenza della gara di Silverstone,
al volante della mitica Lotus Cortina. 5
 |
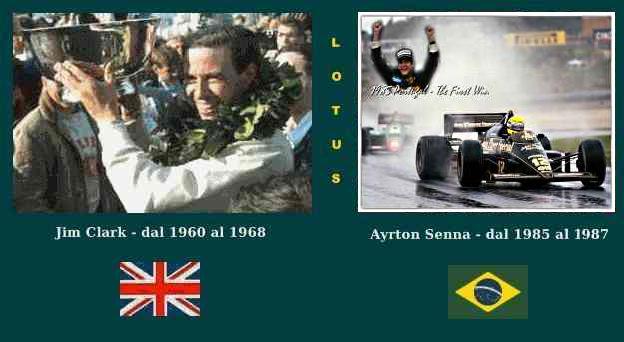 |

La Lotus fondata negli Anni Cinquanta dal
geniale Colin Chapman, è stata probabilmente la Casa
costruttrice di monoposto più innovative. L'ultima di 79
vittorie nei Gran Premi a Monaco nel 1987
con Senna. Jim Clark il
pilota simbolo.
Le sue innovazioni sono state copiate da tutto il mondo della F1, e non
solo.
Per stare davanti alle LOTUS di Chapman bisognava imitarle, carpirne i
segreti della tecnica, e prenderne le sembianze aerodinamiche sempre
all’avanguardia.
Dire a Chapman che una sua idea non funzionava, era come mostrare un
panno rosso a un toro.
Con questa filosofia schierò in pista l’efficacia
di un’originalità tecnica,
“esperimenti”, motorizzazioni a turbina (Lotus56b),
quattro ruote motrici (Lotus56b-Lotus63), prima monoscocca (25), motore
utilizzato come componente strutturale (Lotus49), giochi di sospensioni
(Lotus88) e poi la (Lotus78)e(Lotus79) che ha portato la rivoluzione
del tubo venturi resa possibile dai nuovi profili alari e dalla
possibilità di abbassare le macchine, e il primo telaio in
composti per una vettura stradale.
Chapman era una catena di innovazioni mai viste prima, il mondo della
F1 si aspettava sempre qualche “diavoleria” da lui.
Chapman amava la sfida, tanto che la sua piccola scuderia si
confrontava contro Ferrari, Porsche, Cooper per citarne alcune
impegnate in quegli anni. Ma lo fece senza paura, tanto che nel GP di
Montecarlo del 1958, a soli 30 anni, debuttò con il modello
“16” con motore anteriore Climax non
all’altezza della concorrenza, ma che si segnava con un
telaio valido, da li portò il Team Lotus a vincere un
campionato dopo l’altro tra il 1960 al 1980 (
1963-1965-1968-1970-1972-1973-1978) diventando il Team col maggior
numero di vittorie in così pochi anni.
Chapman è stato anche un eccezionale scopritore e istigatore
di talenti, sia in pista che in fabbrica:
Clark, Hill, Rindt, Fittipaldi, Andretti, Peterson….Lotus
18, Lotus 25, Lotus 38, Lotus 49, Lotus 56 la longeva Lotus 72, la
Lotus79…le sportive Seven, Elite, Elan, Europa,
Esprit…… le sportivissime Lotus 11 e Lotus
23,…..un unica firma in comune: Antony Colin Bruce Chapman
il Fondatore della Lotus Engineering.
|
|
|
Jochen Rindt - Masten Gregory
Ferrari 250 LM

Debutta al Salone di Parigi del 1963. La sua linea
riprende quella della 250 P, rispetto alla quale appare ancora
più armonica. Progettata con l’obiettivo di
omologarla fra le granturismo, fu costretta dalla Federazione
Internazionale a confrontarsi con le più potenti Sport. Ne
uscì a testa alta, perché questo bolide a motore
posteriore centrale condensava il meglio della cultura tecnica di
Maranello.
Il suo 12 cilindri da 3.3 litri, forte dei 320 cavalli erogati,
spingeva con una carica inesauribile. Al resto ci pensava il magnifico
equilibrio dinamico.
Uno dei primi a scommettere sulle qualità di questa
“rossa” fu Luigi Chinetti, titolare della NART. La
storia gli diede ragione. Numerosi furono infatti i successi del
piccolo prototipo. Fra questi, le doppiette alla 12 Ore Reims del
‘64 e alla 500 Km di Spa Francorchamps del ‘65.
Ma il trionfo più importante arrivò alla 24 Ore
di Le Mans dello stesso anno, davanti a bolidi più
performanti di casa Ford e Ferrari. Oggi di lei resta il ricordo delle
sue imprese e il fascino di un design senza tempo, che ha influenzato
le realizzazioni successive.
|
|
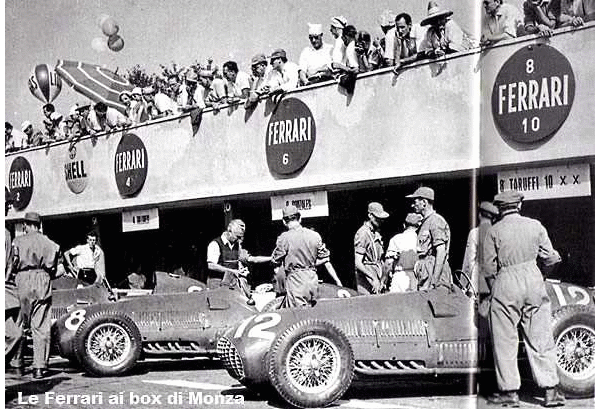 |
Gran Premio d'Italia 1951
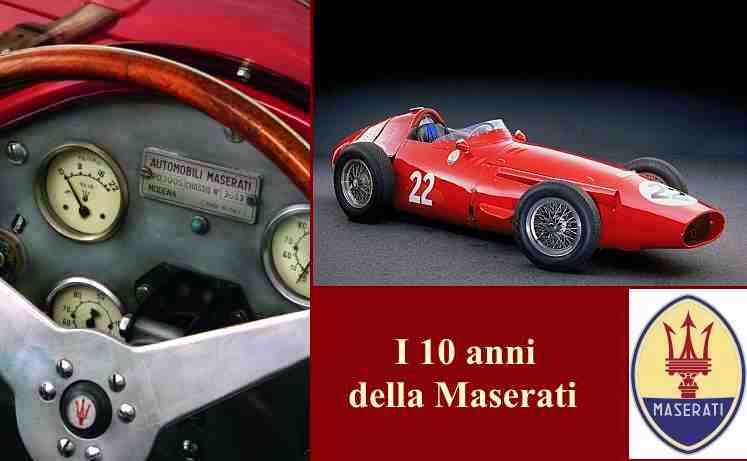 |
|
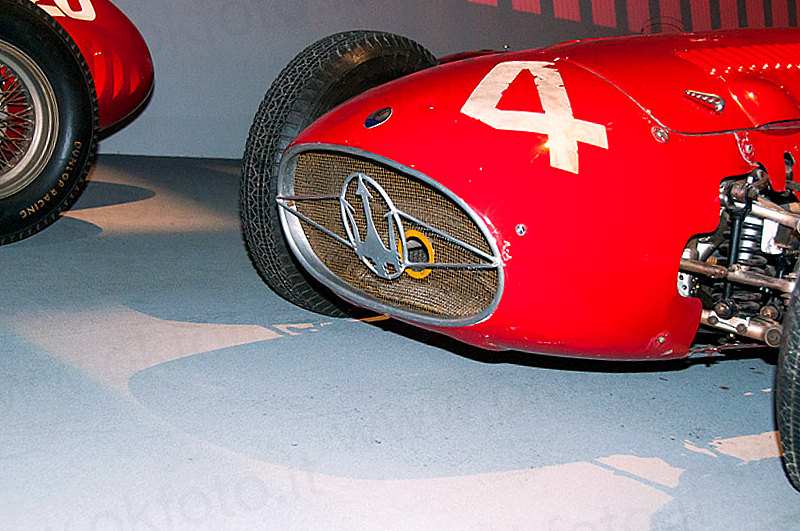
Sono
tre i marchi automobilistici italiani che immediatamente vengono alla
mente quando si parla di F1. Ovviamente Ferrari, certamente Alfa Romeo,
ma anche e soprattutto Maserati. Nonostante
la Maserati sia stata cinvolta in F1 solamente 10 anni, tra il 1950 ed
il 1960, insieme all’Alfa Romeo, ha rappresentato le radici di
quella tradizione sportiva poi sfociata nella Ferrari.I
fratelli Maserati infatti, dalla loro fabbrica di Bologna, furono
coinvolti nel costruire componenti per le competizioni sportive ben
prima di costruire automobili. Parliamo dell’epoca precedente
alla Prima Guerra Mondiale,quando producevano candele di accensione.Subito
dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, decisero di mettere insieme
una prima vettura da competizione.Uno dei fratelli, Alfieri Maserati,
con la collaborazione degli altri, mise insieme un motore otto cilindri
per la Diatto, antica casa automobilistica piemontese. Alla fine
decisero di comprare una delle vetture della Diatto, la modificaronoper
rispettare le regolazioni del 1926 e vinsero la Targa Florio,
proprio con Alfieri al volante. Da quel momento in poi si
puo’ dire che nacque la tradizione sportiva della casa del
tridente.
 Monza 1955 - Esperimenti Maserati
|
Alfieri Maserati alla Targa Florio del 1926)
(La Maserati 8C)
All’inizio
degli anni 30, continuarono le evoluzioni motoristiche dei fratelli
Maserati. Questa volta pero’ misero insieme
anche uno chassis:
nacque la 8C. La vettura fu costruita in due varianti la 2500 e la
2800. L’obiettivo dei fratelli Maserat
i era quellodi attaccare
la supremazia dell’Alfa Romeo P3 e per far questo si avvalsero di
piloti come Baconin Borzacchini,
un fedelissimo del tridente, e
soprattutto dal 1933 di Tazio Nuvolari.
|
|
Purtroppo
la Maserati fu anche protagonista di una delle pagine piu’
nere ella storia del Gran Prix. Nel 1933, durante il GP
d’Italia,
tutte e due i piloti della scuderia, Giuseppe Campari ed il fedelissimo
Borzacchini persero la vita a causa di un rocambolesco
incidente,
mentre erano rispettivamente primo e secondo.
La tragedia venne a
sommarsi ad un periodo, come quello antecedente la Seconda Guerra
Mondiale, che non fu uno deipiu’ felici, soprattutto
perche’ la Maserati non riusci’ a competere con la Mercedes
in quanto a sviluppo tecnologico delle vetture.
Subito
dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Maserati presento’ la 4CLT.
Nonostante la 4CLT non fosse cosi’ competitiva come
le Mercedes,
fu ancora una volta capace di aggiudicarsi diverse gare e di
rappresentare la piattaforma per la nascita di quella
vettura che a
tutt’oggi e’ una vera e propria leggenda: la Maserati 250F.
La
250F montava un motore 2.5 litri per adeguarsi ai regolamenti
dell’epoca. Fu anche una vettura molto popolare tra i piloti
privati
e fu via via migliorata. Divenne una dominatrice assoluta alla
meta’ degli anni 50, quando la Mercedes si ritiro’ dalle
competizioni della F1.
|
|
Andrea De Adamich - Tino Brambilla - Ferrari Dino
Temporada Argentina '68 - F.2
La
stagione 1968 della Temporada Argentina (XVII Temporada Argentina) fu
un campionato motoristico riservato a vetture di Formula 2,
e fu disputata su 4 gare. La serie venne vinta dal pilota italiano Andrea De Adamich su Ferrari.
|
 |
| IL DEBUTTO DELLA MCLAREN IN F1 |
|
|
 |
|
Bruce
Leslie McLaren nasce ad Auckland (Nuova Zelanda) e trascorse i suoi
primi anni nel mondo delle corse e dei motori ispirato dal padre. Concluse gli studi universitari in ingegneria.
Nel '52, a soli quindici anni, prende la licenza per pilotare e nel
'57, dopo aver vinto il trofeo "Un pilota per l'Europa", si trasferisce
dalla Nuova Zelanda all'Inghilterra ben deciso a sfondare come pilota.
E' Jack Brabham che ne valorizza il talento, dandogli
l'opportunità di correre in F.2 nel 1958. Debuttò
in F.1 nel GP di Germania del '58 (GP corso insieme alle F.2).
Nella massima categoria, l'anno dopo a Sebring (USA),
all'età di 22 anni, 3 mesi e 12 giorni, si impose per la
prima volta con la Cooper, restando il più giovane vincitore
di GP di tutti i tempi fino al 2003.
Nel 1963, il pilota neozelandese Bruce McLaren fondava una propria
scuderia. Bruce, ingegnere prima che pilota, aveva debuttato nelle
corse già nel ’58 partecipando al Gran Premio di
Germania di Formula 1 con una Cooper di F2 giungendo 5°. La sua
carriera come pilota iniziò quindi con un risultato di tutto
rispetto. L’anno seguente, e fino al 1965 corse con la Cooper
con la quale ottenne 3 vittorie e 3 giri veloci; nel 1960 (alla sua
seconda stagione completa in F1) giunse secondo nel mondiale, mentre
nel 1962 fu terzo nella classifica finale.
La sua formazione universitaria, l’esperienza che aveva
maturato in famiglia e nelle competizioni, e la possibilità
di formare una scuderia avvalendosi della fornitura di telai e motori
esistenti, crearono le premesse per la nascita della “Bruce
McLaren Motor Racing”.
Il primo obiettivo di questo giovane team fu quello di partecipare alla
fortunata quanto remunerativa serie Tasman e le innumerevoli gare per
Sport-Prototipo che arricchivano lo scenario automobilistico
dell’epoca. Già da subito il team si avvalse della
collaborazione dell’avvocato Teddy Mayer che
conferì alla squadra fondi ed un’aria di
organizzazione, competenza e credibilità che gli fruttarono
innumerevoli successi agonistici ed aziendali.
Primi successi, primi soldi, primi investimenti in progetti propri. In
un mondo delle corse popolato da tanti che volevano acquistare
monoposto per correre in proprio, Bruce e Teddy ebbero
l’istinto quanto la fortuna di appoggiarsi alla Elva-Trojan
per la produzione dei propri modelli commerciali per le corse, i quali
portarono altri fondi in seno alla squadra.
La giovane azienda presto acquisì popolarità e
prestigio, tanto che marchi come Firestone e Ford si rivolsero ad essa
per sviluppare i propri prodotti.
La Cooper, per la quale correva ancora Bruce in F.1 stava per chiudere
e, così come aveva fatto Brabham, nasce tra mille
difficoltà un team di F.1 che ebbe il suo battesimo in
occasione del Gran Premio di Monaco del 1966. L’esordio non
fu brillante ma presto, anche grazie a fornitori di materiali
innovativi quali l’alluminio, motori competitivi e soldi
degli sponsor, la giovane squadra si pone all’attenzione di
tutti.
 |
SPA 1968
PRIMA VITTORIA PER LA MCLAREN |
Il circuito di Spa-Francorchamps nacque dall’unione delle
strade che collegavano le città di Francorchamps, Malmedy e
Stavelot.
Il vecchio circuito di SPA, dove la McLaren colse il suo primo successo
con Bruce McLaren, era un tracciato di forma triangolare di 14 km di
lunghezza.
Spa era uno dei tracciati in cui contava maggiormente
l’abilità del pilota, in particolare uno dei
tratti più impegnativi del tracciato è il mitico
Eau Rouge – Raidillon.

Il Team McLaren si presentò alla gara 1968 di Spa con la
vettura color papaia M7A e con il motore Cosworth-Ford DFV 3.0-litri
V8. I due piloti del team erano Bruce McLaren e Danny Hulme.
Durante le qualifiche, le McLaren si posizionano in seconda fila con
qualche problema nelle curve veloci. G. Hill, l’uomo che ha
preso in mano la Lotus dopo la scomparsa di Clark, si ritira nelle
prime fasi.
In gara la McLaren si comporta meglio che in qualifica ed in testa si
porta Hulme. Dietro a Hulme c’è Stewart e dietro
di lui Bruce McLaren.
Hulme, però, è costretto al ritiro per il
cedimento di un semiasse e così in testa balza il pilota
della Tyrell, Stewart. Bruce è impegnato invece nel duello
con i piloti della BRM, Courage e Pedro Rodriguez.
A pochi giri dalla fine, quando ha la gara in pugno, Stewart finisce la
benzina e Bruce McLaren può cogliere il successo.
È la prima vittoria per il team McLaren.
|
Le tragedie
Timmy Mayer, su una Cooper T70 del team McLaren, all'ultima prova del
Campionato Tasman del 1964, a Longford.
Moises Solana, il 27 luglio 1969 in Messico nella "Hillclimb Valle de
Bravo-Bosencheve" si schianta al volante della sua M6B privata.
Bruce McLaren, mentre effettuava dei test al volante di una M8D, gli
vola via il cofano motore, perde il controllo e si schianta contro un
terrapieno, il 2 Giugno 1970, a Goodwood.
Dick Brown, il 14 giugno 1970 sul circuito di Mosport, nelle prove
della gara Can-Am perde la vita al volante della sua M6B.
John Foulston, muore il 29 settembre 1987 a Silverstone, testando una
M15A. |
Invece,
sfiorano la morte:
Vic Elford nel 1969, durante il GP di Germania, con la sua M7B privata
esce di strada e si frattura il braccio in tre parti.
Denis Hulme nel 1970, durante i test privati, mentre metteva a punto la
M15A per la Indycar, rimase gravemente ustionato ad una mano.
Mike Hailwood nel 1974, nel GP di Germania di F.1, con una M23
urtò contro le barriere e si fratturò caviglia,
tibia e ginocchio.
Mika Hakkinen nel 1995, nelle prove del GP d'Australia di F.1,
sbatté violentemente con la sua MP4/10B contro il rail ed
oltre alle gravi ferite entrò in coma. |
|
|
|
|
 |
|
Storia della Formula 1
La spy-story ed il blocco dei propulsori (2007-2008)
La stagione 2007
è caratterizzata dal congelamento dello sviluppo nei progetti e nelle
caratteristiche dei motori V8 al termine del 2006, i motori non dovranno
essere più ritoccati almeno fino al termine della stagione 2008, anche
se il primo atto ufficiale della "Formula One Commission", il nuovo
organismo unitario decisionale sui regolamenti, ha espresso il parere di
allungare almeno di altri due anni tale blocco, e quindi fino al 2010
quando sarà previsto un ritorno al motore turbocompresso, alimentato
stavolta a diesel. Sono consentite solo modifiche di rifinitura allo
scopo di portare il regime massimo di rotazione del V8 a 19.000 giri.
Ciò significa che chi avesse commesso qualche errore nel progetto, dovrà
portarselo dietro per due o quattro anni. La lista dei componenti da
sostituire è stata presentata dalle scuderie alla FIA prima della fine
del 2006, in modo da garantire maggiore affidabilità. La realizzazione
materiale del motore deve avvenire entro la gara di apertura della
stagione e da quel momento ogni ulteriore modifica sarà consentita
soltanto per cause di forza maggiore – fallimento del fornitore o uscita
di produzione di un componente – oppure per diminuire i costi di
produzione.
A livello agonistico
fu la prima stagione dopo 15 anni senza Michael Schumacher, con Alonso
passato alla McLaren e Räikkönen andato in Ferrari. Con
l'uscita di scena di Jacques Villeneuve e Juan Pablo Montoya, si devono
confermare i buoni propositi – il polacco Robert Kubica e Nico
Rosberg, entrambi in attesa di conferme – e si scoprono nuovi
talenti come il britannico Lewis Hamilton, primo pilota di colore a
gareggiare in Formula 1. Proprio Hamilton fu protagonista di una
eccezionale stagione d'esordio in cui, contro avversari del calibro di
Alonso e Räikkönen, si ritrovò vicinissimo alla
vittoria del titolo mondiale.
Dopo un errore in Cina, in cui si ritirò perdendo il primo "match
point", in Brasile, ultima gara del campionato, Hamilton non riuscì a
conquistare i punti necessari, e la vittoria di gara e campionato
andarono inaspettatamente a Räikkönen, che era rimasto alle spalle di
Alonso e Hamilton per tutta la stagione. L'ultimo pilota della Finlandia
a vincere la corona iridata era stato Mika Häkkinen, nel 1999.
Räikkönen vince con 1 punto di vantaggio sui 2 avversari della McLaren, riuscendo dove aveva precedentemente fallito.
La stagione 2008
vide la conferma del talento di Lewis Hamilton. Con Alonso tornato alla
Renault in seguito agli screzi dell'anno precedente derivati dalla
lotta interna con il più bravo compagno Hamilton, il campionato vide una
accesa lotta tra l'inglese e Felipe Massa, mentre il campione del mondo
Räikkönen, in testa nella prima metà di campionato, si dovette
accontentare del terzo posto dopo una seconda parte pessima, a pari
punti con un ispirato Kubica, su una BMW competitiva. Il mondiale si
decise ancora una volta in Brasile, all'ultima curva, con Hamilton che
agguanta il punto necessario per diventare campione del mondo,
strappando il record di giovinezza di Alonso.
|
 |
 |
| Monza 1958 - Partenza in senso antiorario |
|
Il Gran Premio di Napoli 1955 è stata una gara extra-campionato di Formula 1 tenutasi l'8 maggio, 1955 sul circuito di Posillipo, a Napoli.
La corsa, disputatasi su un totale di 60 giri, è stata vinta da Alberto Ascari su Lancia D50.
Il Gran Premio, andato in scena il giorno seguente il BRDC International Trophy
di Silverstone, vide l'iscrizione di sole 10 vetture.
Partito dalla
pole position, Ascari prese subito il comando della corsa seguito da
Luigi Musso e Jean Behra su Maserati,
il pilota francese ebbe
però un incidente nella difficile curva in discesa dopo il
traguardo e perse quattro giri per le riparazioni ai box.
Ascari continuò con un ritmo regolare ma in grado di far
aumentare gradatamente il suo vantaggio fino alla conquista
del secondo
successo stagionale. Fu anche l'ultima vittoria in Formula 1 per il
pilota milanese che sarebbe scomparso
il 26 maggio in un tragico
incidente all'Autodromo di Monza testando una vettura Sport.
|
|
Ferrari 512 S
Nel giugno del 1969 Enzo Ferrari vendette
metà
del suo pacchetto azionario alla Fiat.
|
|
Ferrari usò parte di quei soldi per costruire 25 auto allo
scopo di competere con la Porsche 917: la Ferrari 512, spinta da un 5
litri V12, venne introdotta per la stagione 1970. In onore della ventesima partecipazione della Porsche, lo stesso
Ferdinand Porsche abbassò il tricolore francese alle 16:00. Alle 17:30 tutte le Ferrari avevano già perso contatto con
la testa, nel contempo
iniziò a piovere. Subito dopo Reine Wisell stava procedendo a velocità ridotta
alla Maison Blanche, con la sua Ferrari 512 S "coda lunga".
Derek Bell, a bordo di un'altra 512 S arrivò a una
velocità di circa 160 km/h superiore. Bell compì
un miracolo nell'evitare l'impatto
ma la 512 S di Clay Regazzoni urtò quella di Wisell e l'auto
di Mike Parkes le centrò entrambe, incendiandosi. I pompieri
arrivarono rapidamente e nessun pilota si infortunò seriamente
La Porsche aveva vinto a Le Mans per la prima volta, l'ultimo e
più ricercato trionfo per l'ex sfavorita che era riuscita a
vincere tutte le altre gare e titoli della categoria sport
durante gli anni '60. |
|
Podio Gran Premio d'Austria 1975
|
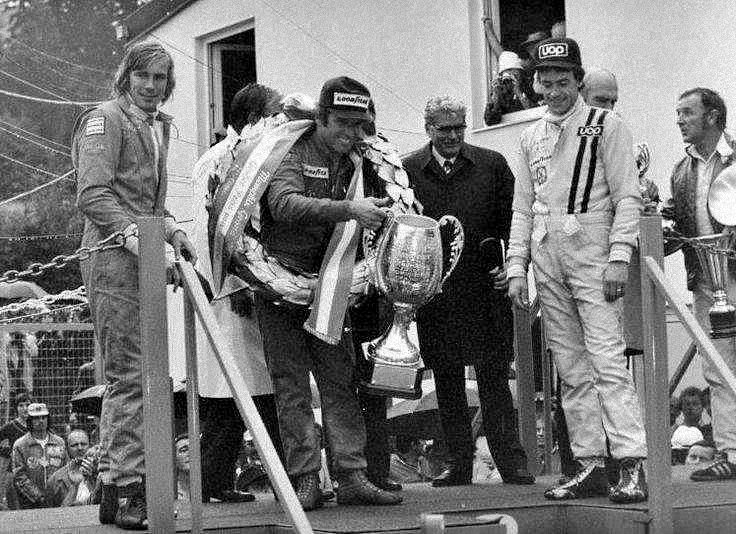 |
|
Il Gran Premio d'Austria 1975, valido anche come Gran Premio d'Europa 1975,
è stata la dodicesima prova della stagione 1975 del Campionato
mondiale di Formula 1. Si è corsa domenica 17 agosto 1975 sull'Österreichring.
La gara è stata vinta dall'italiano Vittorio Brambilla su
March-Ford Cosworth; per il vincitore si trattò del primo, e
unico, successo nel mondiale. Ha preceduto sul traguardo i britannici
James Hunt su Hesketh-Ford Cosworth e Tom Pryce su Shadow-Ford Cosworth.
La gara venne interrotta per la forte pioggia dopo soli 29 dei 54 giri
previsti. Solo la metà dei punti venne assegnata.Nel corso del warm up Mark Donohue, pilota statunitense al volante di una March del team Penske,
ebbe un incidente le cui conseguenze lo portarono al decesso pochi
giorni dopo il gran premio. Nello stesso incidente perirono due addetti
al tracciato.
|
Camion delle consegne Douglas-Vespa del 1955
Piaggio &
C. opera nel settore scooter, moto e ciclomotori utilizzando i marchi
Piaggio, Gilera, Aprilia e Moto Guzzi, Derbi; è attivo inoltre
nel trasporto leggero a tre e quattro ruote. Detiene inoltre ulteriori
marchi storici come Laverda.
Il primo progetto per questa motocicletta fu prodotto a Pontedera nel
1946: è un mezzo con trasmissione senza catene, con il cambio sul
manubrio e una carrozzeria in grado di proteggere il guidatore.
Il nome “Vespa” fu coniato dallo stesso Enrico Piaggio il quale di
fronte al prototipo del nuovo mezzo esclamò: “sembra una vespa!” per la
somiglianza con l'omonimo insetto grazie alla parte centrale molto
ampia, la “vita” stretta e per il ronzio del motore.
Enrico Piaggio ne mise in produzione 2.500.
|
1959 Lambretta Li in Totò, Peppino e… la dolce vita, Movie, 1961

Lambretta 125 D del 1951
|
La Lambretta è uno scooter italiano prodotto dalla industria meccanica Innocenti di Milano, nel quartiere Lambrate, dal 1947 al 1972.
Il nome "Lambretta" deriva dal fiume Lambro, che scorre nella zona in cui sorgevano proprio gli stabilimenti di produzione.
La Lambretta 125 D nacque nel 1951 , era uno scooter essenziale ma
contribuì alla motorizzazione degli italiani dopo la lunga grande
guerra.
Montava un motore 2 tempi monocilindrico raffreddato ad aria che
sviluppava 5.22 Cv a 4750 giri, sufficenti a far muovere con agilità
questo scooter dal peso ridotto di 79 Kg in ordine di marcia. La
velocità massima oscillava tra i 70 e i 75 Kmh.
Questa prima versione del 1951 aveva il comando del freno posteriore a
bacchetta, il manubrio in ferro cromato con tappi in alluminio alle
estremità e sella color marrone.
Veniva venduta all'epoca nei colori verde o camoscio o beige ad
eccezione dei telai selle, dei cerchi ruota, dei mozzi, della leva barra
torsione, dei tondini pedana, del portatarga, della staffa portatarga e
del cavalletto verniciati color alluminio. |
 |
Famiglia Villeneuve anni '70
 |
| Sotto gli occhi vigili di Enzo, Niki Lauda prova a Fiorano la Ferrari 312T |
 |
 |
| Jean-Pierre Jarier applica i loghi dei suoi sponsor alla propria tuta. |
Indy 500: un secolo di storia americana dai toni europei
 |
 |
|
|
 Jamie Camaras 2008 Indy 500 Crash Jamie Camaras 2008 Indy 500 Crash |
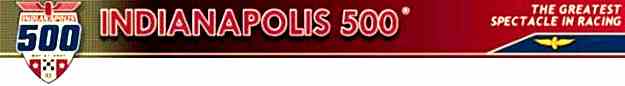 |
|
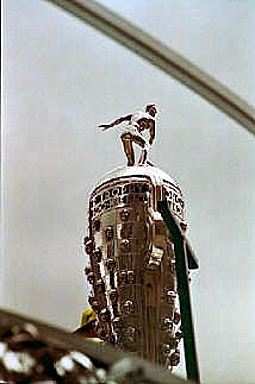 |
|
 |
Non è il solo pilota o
la sola macchina che conquistano il diritto di partecipare alla corsa e un posto
in griglia, ma la combinazione di entramb.
Se per cause di forza maggiore il
pilota o la macchina devono venire sostituiti, l'equipaggio che si forma non
mantiene la propria posizione,
ma parte dalla trentatreesima e ultima posizione.
L'unicità della fase di qualificazione di questa gara risiede nel numero dei
giri necessari per calcolare
la posizione di partenza: non un singolo giro
cronometrato, ma quattro consecutivi.
Le macchine cominciano la corsa con una
partenza lanciata, che avviene tradizionalmente (unica corsa automoblistica al
mondo) su undici file
di tre macchine ciascuna. Dopo la fine della corsa il
vincitore e la sua macchina vengono accolti nella victory lane, sorta di circolo
dei vincitori dove solo lui e il suo team possono entrare e festeggiare la
vittoria.
Dopo essersi tolto il casco la prima cosa che viene passata al pilota
è, dopo il berretto dello sponsor, una bottiglia di latte. Questa pratica ebbe
origine
da unevento avvenuto nel 1936 quando il vincitore, Louis Meyer fu
fotografato mentre beveva una bottiglia di latte ghiacciato.
 |
NASCE NEL 1911 IL MITO
DELL’INDIANA
All’inizio
del XX° Secolo l’automobilismo conquistò gli Stati Uniti. Gli americani
intuirono che l’automobile avrebbe mutato profondamente le loro abitudini,
il
loro standard di vita, la loro stessa cultura. Nel 1902 sorse a Detroit nel
Michigan a nord dell’Indiana la General Motors, l’anno dopo,
sempre nella
capitale del Michigan, Henry Ford fondava la Ford Motor
Company.
Nel giro
di vent’anni nacquero negli Stati Uniti più di mille marche di automobili,
ridotte poi da una severa selezione a circa una ventina.
Parallela allo sviluppo
industriale progredì la passione per le corse.
Nel 1909
venne inaugurata la pista di Indianapolis. Fu costruita per servire alle prove
dei costruttori americani di automobili e destinata a diventare
il più grande
spettacolo del mondo. Il primo fondo stradale della pista era costituito da
terra spianate e compressa oltretutto molto pericoloso,
tanto da far decidere i
responsabili per una nuova pavimentazione che fu realizzata con uno strato di
mattonelle.
Per coprire le due miglia e mezzo del percorso ce ne vollero
esattamente tre milioni.
 |
 |
Nel 1911, nella prima edizione della “500 Miglia”,
ben 40 vetture dinnanzi a oltre ottantamila spettatori si lanciarono in una
battaglia infernale sui tremilioni
di mattonelle infide che pavimentavano
l’anello; al vincitore sarebbero toccati 14.000 dollari, una piccola fortuna. Il
battesimo fu felice:
un pilota americano, Ray Harroun, su una vettura americana,
la Marmon Wasp, una 6 cilindri di dieci litri di cilindrata, aprì l’albo d’oro
di quella
che sarebbe diventata la più famosa corsa automobilistica al
mondo.
Dal 1911
fu la corsa che contese a qualsiasi altra manifestazione automobilistica il
titolo di gara più spettacolare, veloce, ricca e pericolosa
del panorama
motoristico internazionale.
La prima
modifica ai 3 milioni di mattonelle avvenne nel 1935 decisero di applicare uno
strato di asfalto sulla pista ad eccezione del rettifilo principale.
Un
“catino” di poco più di 4 chilometri con 4 curve a 90 gradi leggermente
sopraelevate, che ogni anno ospiterà per un mese l’espressione
più viva dello
spirito agonistico americano, spirito che a Indianapolis ha modo di
estrinsecarsi in tutte le sue caratteristiche.
L’importante, il difficile, è
proprio riuscire a prendere il via. Le prove di qualificazione atte a definire i
fortunati 33 concorrenti che potranno prendere
parte alla gara, costituiscono un
primo spettacolo. Vi furono e vi sono piloti e meccanici che per Indianapolis
lavorano un anno intero, mettendo poi
tutto in gioco in pochi giri di prova in
cui se tutto gira a puntino ci si qualifica e se dovesse andare male si torna a
casa.
|
|
 |
La 500
Miglia di Indianapolis viene disputa di solito il 30 maggio, il “Memorial Day”.
Tra le decine di migliaia di spettatori che provengono da ogni parte
degli Stati
Uniti, molti sono assillati dal problema di trovare un parcheggio per la propria
vettura nelle immediate vicinanze della pista. Pertanto,
in gran quantità
giungono a Indianapolis giorni prima dell’evento, accampandosi e ammazzando
l’attesa tra fiumi di birra e miriadi di salsicce
la cui inconfondibile
fragranza la si percepisce a chilometri di distanza.
Quando il
direttore di corsa, dopo la tradizionale sfilata delle majorette’s, pronuncia la
fatidica frase: “Start your engines!” (avviate i vostri motori),
il rumore di
qualche decina di migliaia di cavalli lacera l’aria. Le 33 vetture, dopo aver
percorso a velocità ridotta un giro di pista dietro alla stafety car,
danno
quindi inizio alla “bagarre” che durerà per 200 giri percorsi in senso
antiorario.
Gli
incidenti sono all’ordine del giorno. Quando capitano, si accendono i semafori
gialli che impongono ai piloti di moderare l’andatura vietando i sorpassi. La
particolare configurazione della pista ha imposto nel corso degli anni una
specializzazione sia per gli uomini sia per le macchine. Infatti, fino ai primi
anni Sessanta il catino di Indianapolis fu una specie di tabù per i piloti
europei, che non riuscivano ad adattarsi convenientemente alla particolare
tecnica di guida richiesta. Lo stesso discorso vale per le vetture, che esigono
un’impostazione del tutto particolare. Dato che a Indianapolis le curve sono
tutte a sinistra, queste macchine presentano il baricentro spostato sulla
sinistra e verso l’avantreno, mentre le due ruote interne, quelle di sinistra,
hanno un passo accorciato rispetto a quelle di destra. Le altissime velocità
raggiungibili hanno fatto (e fanno tutt’ora) di Indianapolis una pista assai
pericolosa: l’elenco dei piloti che vi hanno perduto la vita è purtroppo
lunghissimo.
|
|
22 aprile, 1951, il circuito ha ospitato la
quinta Ospedaletti San Remo Grand Prix. Entrato in gara oltre 90 giri
di pista 3,380 km
sono stati tre Ferrari 375S, nelle mani di Alberto
Ascari, Luigi Villoresi e Dorino Serafini. C'erano altre due Ferrari
sulla griglia,
una 212 F1 gestito dal team Ecurie Espadon per il pilota
svizzero Rudi Fischer e inoltrata privatamente 125 F1 per l'inglese
Peter Whitehead.
La gara fu contraddistinta dal dominio delle Ferrari che si aggiudicarono le prime tre posizioni con Alberto Ascari,
Dorino Serafini e lo svizzero Rudolf Fischer.
|
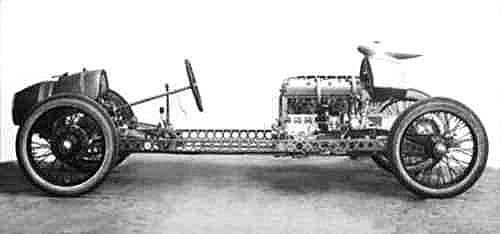
Osservando il nudo telaio si possono
notare soluzioni tecniche che sono state riprese in epoche successive,
quali i serbatoi del carburante e dell'olio sistemati sopra le gambe dl
pilota, il telaio in acciaio alleggerito con numerosi fori, il
radiatore dell'olio sistemato posteriormente di dimensioni maggiori e
soprattutto la disposizione del motore davanti all'assale posteriore
delle ruote
e molto prossimo al baricentro della vettura. |
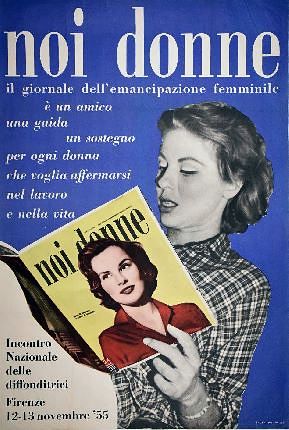 |
 |
 |
|
Storia della Formula 1
Dalla Brawn all'ascesa della Red Bull (2009-2013)
Il campionato di Formula 1 2009, vinto dall'inglese Jenson Button su Brawn GP,
fu uno dei campionati più discussi che la storia della F1 abbia mai
conosciuto: le polemiche non derivarono dalla vittoria della stessa
Brawn Gp, che ereditava le strutture di una scuderia quale la Honda che
nella stagione precedente aveva concluso nelle retrovie della
classifica, ma soprattutto per una serie di episodi molto accesi che si
trascinarono durante tutto il corso della stagione. In primo luogo tenne
banco il conflitto per motivi tecnici che coinvolse direttamente la FIA
di Max Mosley e la FOTA, l'associazione dei team, di Luca Cordero di Montezemolo,
che addirittura minacciò un possibile ritiro della Ferrari dalla F1.
Quando infatti venne ritenuto regolare, a causa di buco nel regolamento,
il diffusore utilizzato dalla Brawn e da altre scuderie, i grandi team
decisero di voltare le spalle ad Ecclestone per costruire una serie
alternativa, della quale potevano gestire anche i ritorni finanziari
derivanti dalla disputa delle gare. Dopo numerose ed accese trattative
venne rinnovato il Patto della Concordia, mentre Button conquistò il
titolo difendendosi dal ritorno di una scuderia in rapida crescita come
la Red Bull.
Proprio la scuderia austriaca, grazie al disegnatore Adrian
Newey, autore delle Williams che dominarono gli anni Novanta e delle
McLaren vincitrici con Häkkinen, visse un periodo magico a partire dal
2010, anno della definitiva affermazione. Con una macchina estremamente
competitiva e due piloti complementari come l'esperto Mark Webber ed il
giovane talento Sebastian Vettel la Red Bull seppe issarsi in testa alle
classifiche, tuttavia la rivalità interna al team produsse uno dei
campionati più avvincenti di sempre, visto che spesso in gare dominate
la scuderia austriaca, per inesperienza o per problemi come i primi
avuti da Vettel ad inizio anno, non ottenne vittorie o punti già
conquistati. Talenti come Hamilton ed Alonso (nel frattempo passato in
Ferrari) sopperiscono all'inferiorità della propria vettura con il
talento e così si arriva a 2 gare dalla fine con ben 5 piloti in grado
di vincere il mondiale, mentre il titolo costruttori viene vinto dalla
Red Bull. Il finale di stagione è grandioso: il campione uscente Button
esce di scena nella lotta al titolo alla penultima corsa, Hamilton getta
il titolo in 2 sorpassi azzardati a Monza e Singapore, Webber crolla
nel finale sbagliando in Corea e disputando delle pessime qualifiche ad
Abu Dhabi. Alonso arriva da favorito al gran finale di Abu Dhabi ma un
errore strategico e l'incapacità dello spagnolo di recuperare le
posizioni perse fanno sì che il mondiale vada a Vettel che solo fino a
qualche gara prima pareva fuori dai giochi e che mai prima era stato al
comando della graduatoria iridata. Va inoltre segnalato come il 2010 sia
un anno di svolta con il ritorno in F1 di Michael Schumacher sulla
rientrante Mercedes (che ha comprato la Brawn) e la riapparizione sulla
scena di team come Sauber e soprattutto Lotus e di piccole squadre come
la Virgin e la HRT che vanno a sostituire i costruttori BMW, Toyota e
Honda che a causa della crisi economica di fine 2008 e degli scarsi
risultati abbandonano il circus.
Il 2011 inizia con novità regolamentari come il KERS e il DRS per
permettere più sorpassi in una Formula 1 che pian piano ne vedeva
sempre di meno, e le gomme fornite dalla Pirelli che si degradano
abbastanza in fretta. Nonostante le novità è sempre Vettel con la sua
Red Bull-Renault a comandare il gruppo con il solo Hamilton capace nelle
prime gare di tenere il suo passo, ma poi Hamilton ha un calo,
lasciando via libera a Vettel per la conquista del suo secondo titolo
con 4 gare d'anticipo ai danni di Jenson Button.
Il 2012 vide un
inizio avvincente: delle prime sette gare nessuno è stato capace
di vincerne due, e i Gran Premi di Cina e di Spagna hanno visto
rispettivamente le prime vittorie in carriera di Nico Rosberg e di
Pastor Maldonado. In un campionato in cui la Red Bull (Soprattutto con
Vettel) non è stata veloce come negli ultimi 2 anni, dopo il
Gran Premio d'Italia in cui si pensava che Alonso potesse far suo il
mondiale, Vettel dal Gran Premio di Singapore ottiene i piazzamenti
necessari per diventare il più giovane pilota nella storia a
vincere tre mondiali di Formula 1. Da segnalare che in questa stagione
si mise in luce il messicano della Sauber Sergio Pérez e il
ritorno in Formula 1, dopo due anni nei rally, di Kimi
Räikkönen
Il 2013 vide il passaggio, tra molte polemiche, di Hamilton alla
Mercedes, del secondo (e definitivo) ritiro di Michael Schumacher, e del
clamoroso calo di prestazioni della McLaren, che da lottare per il
titolo scende ad occupare costantemente la zona centrale della
classifica. La stagione si rivelò a due facce: le prime 10 gare videro
un grande equilibrio. Ma dopo la prima gara, vinta da Kimi Raikkonen, la
vittoria in Malesia porta Vettel prima a guidare la classifica del
campionato dopo le prime 10 gare, poi a vincere le ultime 9, diventando
così il pilota ad aver realizzato la più grande striscia vincente della
Formula 1 e il più vincente in una sola stagione (13 vittorie) a pari
merito con Michael Schumacher.
|
 |
|
|
 |
1953 Mille Miglia - Brescia Piazza della Vittoria
Maranello - Stabilimento Ferrari
|
Jochen Rindt, Jo Siffert i Graham Hill
|
|
Il 30 maggio (1951),
il Gran Premio Centenario di Cristoforo Colombo di Formula 2 fu tenuto a
Genova per commemorare
il 500° anniversario della nascita dell'uomo a
cui si deve la scoperta delle Americhe.
Poco prima del Gran Premio della
Svizzera, corsa che da' il via al campionato mondiale, subisce uno
strano infortunio al Gran Premio Colombiano a Genova, corsa di Formula
due. Al 37. giro, alla curva di Boccadasse, la coda della sua Ferrari è
in fiamme.
"Con la solita calma - scrivono - il
gioviale Ascari aumentava la frenata accostando verso l'esterno della
strada.
Appena la macchina fu ferma, salta, ma un piede gli si impiglia
nel volante. Aiutato da Biondetti e da Franco degli Uberti riesce a
liberarsi. Riporta comunque una ustione di secondo grado all'avambraccio
destro."
|
|
 |
| 1967 LeMans - Cambio di motore dalle prove alla gara sulla Ferrari 330 P4 V12/60° 3983 cc. P5.0 |
1952 Grand Prix de la Sarre
Juan Carlos I di Spagna
Il Gran Premio di Spagna 1973, XIX Gran Premio de España di Formula 1 e quarta gara del campionato di Formula 1 del 1973, si è disputato
il 29 aprile sul Circuito del Montjuïc ed è stato vinto da Emerson Fittipaldi su Lotus-Ford Cosworth |
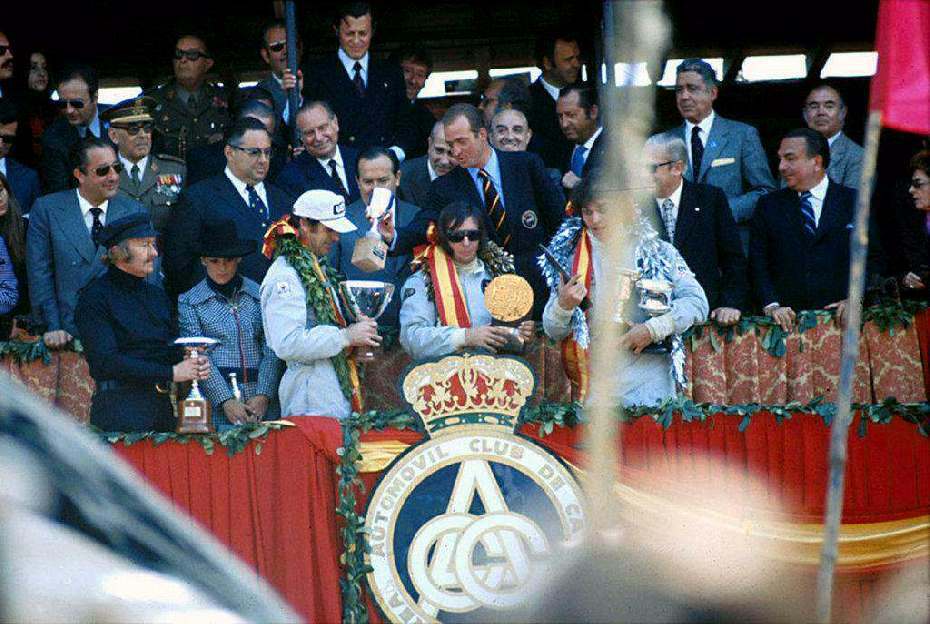 |
| 1 |
 Emerson Fittipaldi Emerson Fittipaldi |
Lotus-Ford |
75 |
1:48:19.3 |
| 2 |
 François Cevert François Cevert |
Tyrrell-Ford |
75 |
+ 42.7 |
| 3 |
 George Follmer George Follmer |
Shadow-Ford |
75 |
+ 1:13.1 |
|
La Ferrari e Silverstone: la prima vittoria in F1 nel 1951
 |
 |
Silverstone 9 Luglio 2011- Il Gran Premio di Gran Bretagna di Fernando Alonso
comincerà in anticipo rispetto ai suoi 23 colleghi.
Il pilota spagnolo
avrà infatti l’opportunità di fare un giro di pista con una monoposto Ferrari di Formula 1 già alle 11.20,
prima della Drivers’ Parade. Nessun cambio regolamentare ad hoc ma soltanto la possibilità di guidare
la stessa vettura
che José Froilan Gonzalez portò al successo, il primo
della Scuderia nella massima competizione automobilistica
nell’edizione
1951 di questa gara, la 375 F1.
|

Cargo Service anni '60
|
 |
|
Storia della Formula 1
Il ritorno al turbo e il dominio Mercedes (2014-oggi)
Il 2014 vide il passaggio dai motori V8 da 2,4 l ai V6 turbo
da 1,6 l; si trattò del primo ritorno alla sovralimentazione da quando
questa fu bandita, venticinque anni prima. Le marce passarono da 7 a 8,
mentre, con l'introduzione di sistemi quali brake-by-wire
ed ERS, nonché soprattutto con l'adozione di una doppia
alimentazione combinata termica ed elettrica, i motori vennero
ribattezzati con il termine power unit.[25]
La prima stagione con i nuovi regolamenti, vide il dominio totale
della Mercedes che fa bottino pieno: vince 16 gare su 19, realizza 11
doppiette, in tutte le gare ha portato sempre un pilota sul podio,
incamera 701 punti e conquista sia il titolo costruttori sia quello
piloti, che fin dalle prime uscite si indirizza verso un duello tra i
due alfieri della casa, Lewis Hamilton e Nico Rosberg.
L'inglese, dopo i problemi al motore in Australia, vince le successive 4
gare, superando Rosberg in classifica. Ma a Monaco, con un errore del
tedesco in qualifica, comincia il duello. Rosberg fa sua quest'ultima
gara, oltre ad Austria e Germania, mentre Hamilton, tra rotture ed
errori in qualifica, trionfa solamente in Gran Bretagna, davanti al suo
pubblico. Il GP di Spa vedrà l'apice della lotta tra i due: al secondo
giro il tedesco, nel tentativo di superare il rivale, gli buca una
gomma; sarà la fine dei sogni di gloria per Rosberg, infatti dalla
successiva prova di Monza comincia la cavalcata trionfale di Hamilton,
che vince 6 delle ultime 7 gare e nell'appuntamento finale ad Abu Dhabi,
oltre alla gara conquista il suo secondo titolo mondiale.
L'unico pilota non a
bordo della Mercedes a vincere le restanti 3 gare è stato Daniel
Ricciardo sulla Red Bull, che nel corso della stagione ha costantemente
battuto il compagno di squadra Sebastian Vettel. Oltre al campione
uscente, le maggiori delusioni sono state la Ferrari, che nonostante
abbia gareggiato con due campioni del mondo quali Alonso e Raikkonen,
ha ottenuto solamente due podi, entrambi con lo spagnolo, e la Lotus
che, perso il finlandese, ottenne solamente 10 punti, in una stagione
che la vide arrancare nelle retrovie per via della scarsa
competitività del motore Renault. La stagione va ricordata per
l'impresa compiuta da Jules Bianchi nel Gran Premio di Montecarlo,
capace di portare alla Marussia i suoi primi e unici 2 punti della sua
storia. Il francese, però, cinque mesi dopo a Suzuka ha un
incidente contro una gru, sotto la pioggia, posizionata per rimuovere
la vettura incidentata di Adrian Sutil nello stesso punto; mai
più risvegliatori dal coma, Bianchi morirà il 18 luglio
2015, in seguito ai danni causati dall'incidente: ventuno anni dopo
Ayrton Senna, un pilota trova nuovamente la morte durante una gara di
Formula 1.
Nel 2015 Hamilton conferma le prestazioni della passata stagione.
Delle prime 13 gare, Lewis ne vince 7, ma oltre a Rosberg, dovrà
guardarsi le spalle anche dalla ritrovata Ferrari ora nelle mani di
Sebastian Vettel, che vince in Malesia, in Ungheria e a Singapore, dove
il tedesco parte dalla pole e mantiene la testa per tutta la gara. Ciò
non basta tuttavia a scalfire il vantaggio tecnico della Mercedes che in
Russia, con quattro gare d'anticipo, si conferma campione del mondo
costruttori, mentre nella gara successiva ad Austin Hamilton si conferma
campione del mondo.
Il 2016
ha visto confermarsi il dominio Mercedes ma con il trionfo di Rosberg,
che si è laureato campione del mondo dopo una lotta serrata col compagno
di squadra Hamilton. Rosberg, poco dopo la vittoria del titolo, lascerà
la Formula 1.
La stagione 2017 vede un nuovo cambio regolamentare per quanto
riguarda l'aerodnamica e le gomme delle monoposto. Le gomme anteriori
passano da 245 mm a 305 mm, quelle posteriori da 325 a 405 mm. Le
vetture tornano ad avere una larghezza complessiva di 2,000 mm, anziché
1,800. Aumenta anche la larghezza dell'ala anteriore, ora di 1,800 mm
(come dal 2009 al 2013), con un profilo a freccia e del fondo vettura,
fino ad un massimo di 1,600 mm.Il diametro di tutti e quattro gli
pneumatici cresce, inoltre, di 1 cm. Per le prime cinque gare della
stagione è la Pirelli
a selezionare le quantità di gomme, delle tre mescole portate, che
verrà assegnata a ciascun pilota. Fino al Gran Premio di Spagna, la casa
milanese ha assegnato ad ogni pilota sette set della mescola più
morbida, quattro di quella intermedia e due di quella più dura a
disposizione per ogni gara. Ciò per lo scarso numero di test effettuati
sulle nuove coperture. Le nuove gomme comportano un aumento del peso
minimo della vettura da 702 a 728 kg.La quantità massima di benzina
imbarcabile per la gara viene portata da 100 Kg a 105 Kg, a causa della
maggior resistenza aerodinamica delle nuove vetture, mentre il consumo
istantaneo rimane invariato a 100kg/h a 10500 giri.Altre modifiche
riguardano un aumento del carico aerodinamico grazie ad accorgimenti,
come il già citato fondo allargato, insieme ad un diffusore posteriore
di dimensioni maggiorate sia in lunghezza che in altezza (passa da 125
mm a 175 mm, come nel 2010). L'ala posteriore è più bassa (da 950 mm a
800 mm) e larga (da 750 mm a 950 mm), con un andamento obliquo delle
paratie laterali, facendola assomigliare ad un parallelogramma, alla
vista laterale della monoposto. Il regolamento che aboliva la pinna
posteriore, utilizzata fino al 2010, è stato eliminato, quindi le
squadre hanno la possibilità di adottare, nuovamente, tale soluzione.Le
unità motrici utilizzabili, senza incorrere in penalità, da questa
stagione, sono solamente quattro. Sempre da quest'anno non sarà più
possibile accumulare unità motrici sostituendone più di una durante un
evento Gran Premio (come nel caso di Hamilton nel Gran Premio del Belgio 2016).
Difatti solo l'ultima unità montata in monoposto potrà essere
utilizzata per gareggiare. Tutte le altre sostituite verranno "bruciate"
e non saranno utilizzabili. Le novità regolamentari sembrano
rivitalizzare il campionato, con una Ferrari che ritrova la
competitività vincendo due gare nelle prime tre. Successivamente con gli
aggiornamenti portati, la Mercedes sembra tornare dominatrice e vince
la maggior parte delle gare fino a dopo la sosta estiva con la gara di
Monza, la Ferrari riesce a vincere solo a Monaco e in Ungheria, ma
Vettel si piazza comunque in ottime posizioni in modo tale da arrivare a
Singapore con solo 3 punti di svantaggio su Hamilton. A Singapore
entrambe le Ferrari sono vittime di un incidente e costrette al ritiro
mentre ottiene la vittoria Hamilton. I successivi appuntamenti in
Malesia e Giappone vedono protagonista la scarsa affidabilità
motoristica della Ferrari e la strada spianata verso il titolo per Lewis
Hamilton che lo conquista in Messico con 2 gare d'anticipo.
|
 |
 |
Buenos Aires 1987 - Luciano Pavarotti in compagnia di Juan Manuel Fangio
Gran Premi anni '30
Ecco lo squadrone argenteo con le vetture 3 litri. |
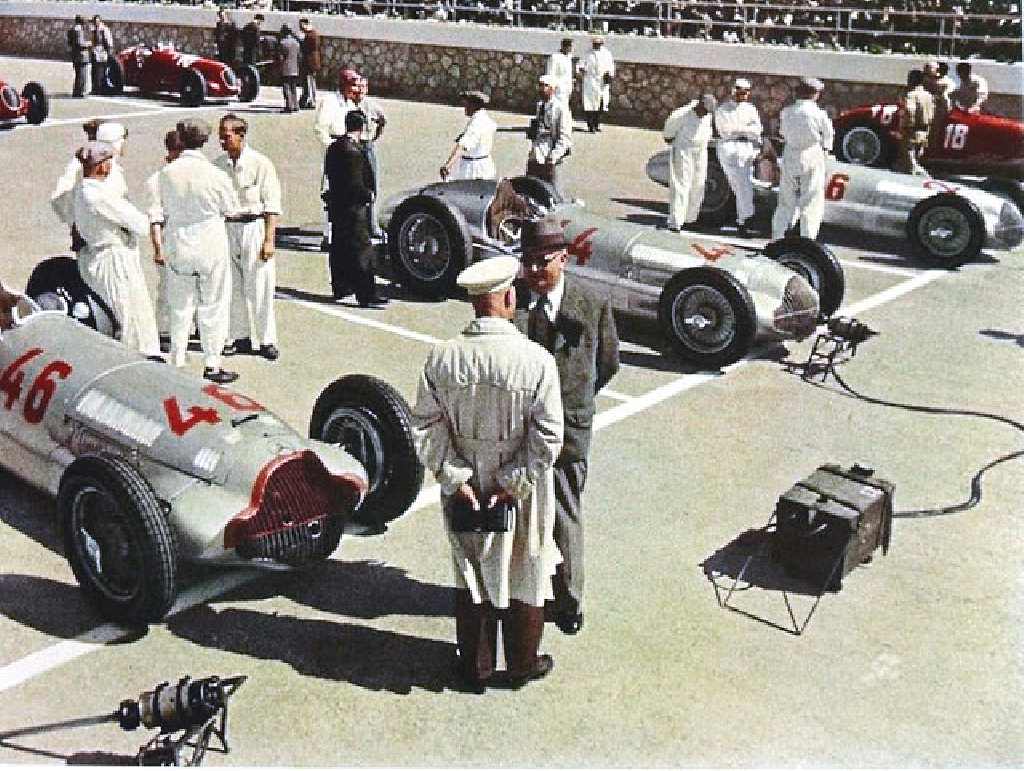
|
 |
|

|
 |
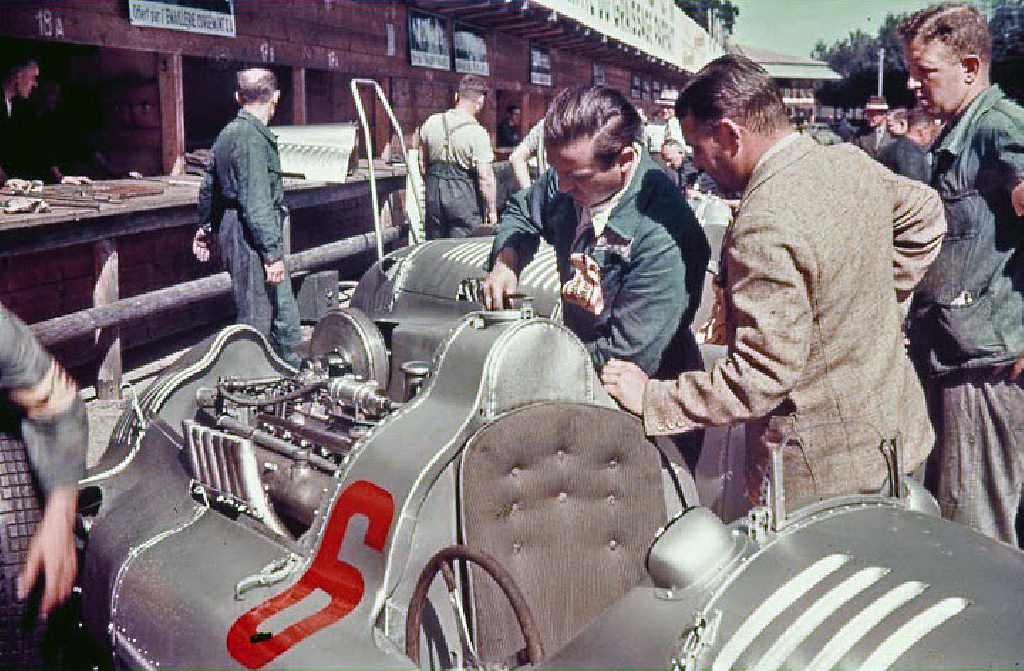 |

|
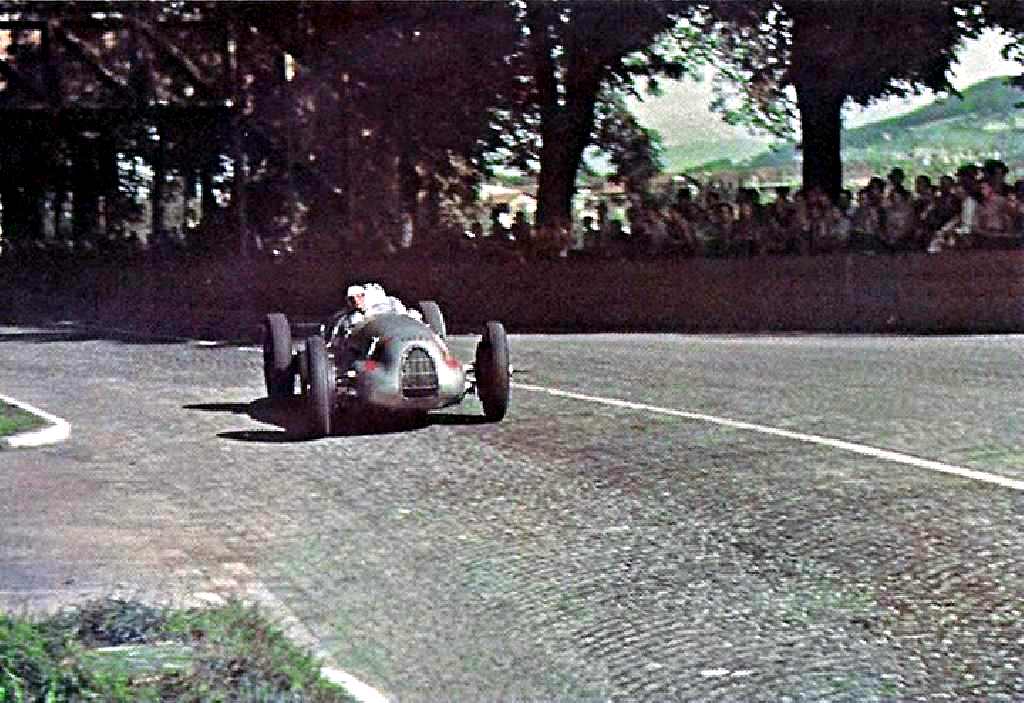
|
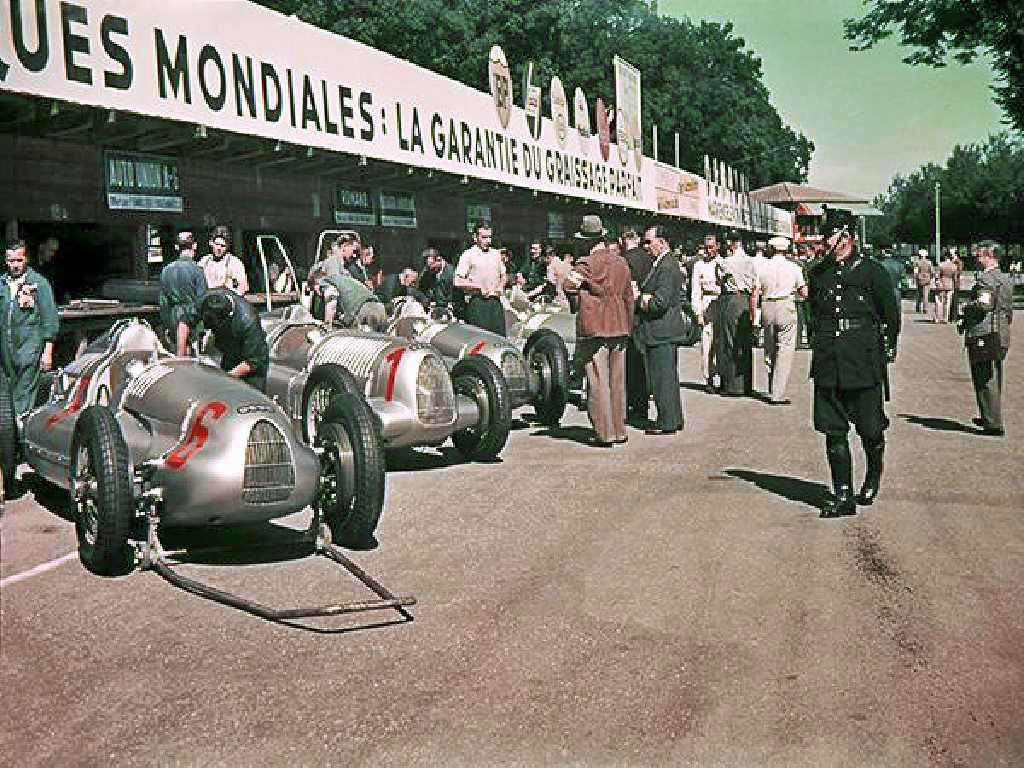 |
|

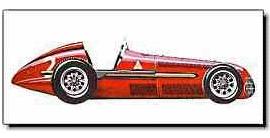
Alfa Romeo
La prima vettura ad aggiudicarsi il titolo
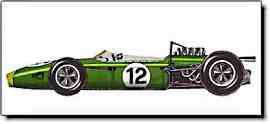
Brabham: vince il titolo guidata dal suo
costruttore

Lotus 49
L'evoluzione vincente

McLaren M23 - M26 una copia ben riuscita
della Lotus 72

Carrozzeria rimovibile
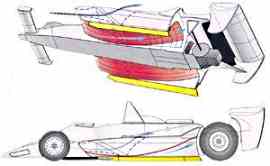
La wing-car

1977 Arriva il turbo

FW14 La perfezione del telaio e del motore
Renault

Ferrari F2002: domina la stagione 2002 con
15 successi.
Con questa vettura, M. Schumacher vince il quinto titolo
iridato, terzo consecutivo.
|
|

 La Ferrari 500 F2 si conferma la miglior macchina e
Ascari La Ferrari 500 F2 si conferma la miglior macchina e
Ascari
Campione del Mondo (5 successi) il miglior pilota.

Lotus 25 - Clark si aggiudica il titolo del 1963
La monoscocca - Il telaio
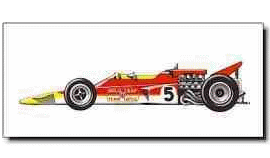
Lotus 72 la vettura più longeva e
vincente della storia

312 serie T il capolavoro di Forghieri per la
Ferrari

Sei ruote poco efficienti ma geniali

Lotus 79
La più bella vettura mai costruita

Mc Laren-Honda Mp4: con le versioni 4 , 5 e 6,
vince 39 gare
fra il 1988 e il 1991.

Spinta dal motore Mercedes torna alla vittoria la
McLaren

Ferrari F2003 GA:
La vettura che consente
a Michael
Schumacher di conquistare il sesto titolo piloti.
____________________________________________
|
|
|
Lancia Astura Coupe' GL (1938)

La Lancia era una delle migliori rappresentanti del lusso in campo
automobilistico. Ma anche una casa che si distingueva per una scelta di
carrozzerie splendide, frutto di un "design" di gusto superiore. Come
una Bugatti italiana...
La Astura Coupè GL lascia a bocca aperta per
la purezza di linee tradizionali ed aerodinamiche nello stesso tempo,
una perfezione e maniacale ricerca del miglior rendimento nascondendo
ogni organo meccanico sotto una carrozzeria ben profilata.
Un due porte con abitacolo compatto e un cofano lungo, lungo, lungo...
Sembra
quasi di vedere il progettista che traccia rapidamente come un pittore
delle linee tese sui fogli da disegno alla ricerca della perfezione
stilistica illuminato dal futurismo. Il risultato: una automobile
lussuosa, slanciata e sportiva destinata ad una élite ristretta di pochi
fortunati dal senso estetico superiore. |


|
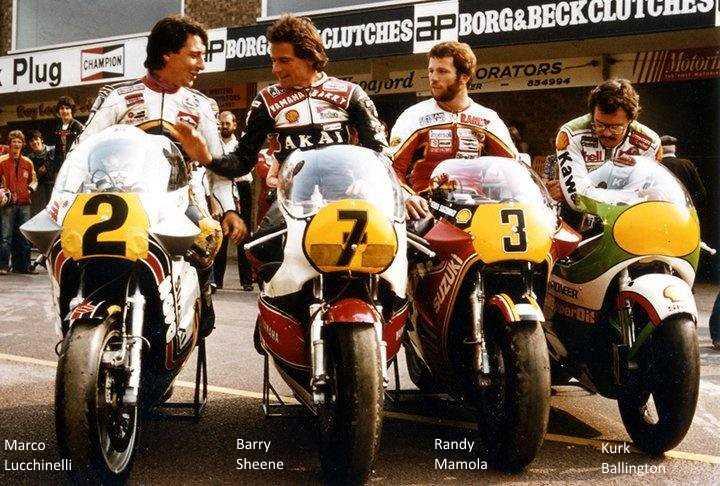 |
LE 10 MIGLIORI MONOPOSTO DI F1 DELLA STORIA
 |

Ferrari F2004 (2004)
Non si esagera se si pensa alla F2004 come alla
migliore monoposto di F1 fin’ora costruita. La scalata al
successo di questa vettura è stata aiutata dalla fortuna di
godere dei servigi di Michael Schumacher, ma il modo e la
facilità con cui vinse entrambi i titoli furono eccezionali.
Dall’affidabilità quasi perfetta; dalla
facilità di guida; dall’aerodinamica
ineguagliabile; dalle ottime performance del suo propulsore alla
perfetta sinergia delle sospensioni… non
c’è crepa sulla F2004. Una monoposto tremendamente
efficace
sotto ogni aspetto.
|
2) Lotus 49 (1967-70’)
La Lotus 49 è una delle poche monoposto
ad aver vinto al suo GP d’esordio, a Zandvoort nel 1967. Tale
vittoria, conquistata da Clark dopo il ritiro del compagno di squadra
Hill, valse anche la prima vittoria per il Cosworth.
Questa monoposto fu la prima con motore posteriore a incorporare il
propulsore come elemento portante della vettura stessa, comportando una
maggiore rigidità e un notevole guadagno di spazio.
Il titolo non arrivò subito a causa delle
difficoltà iniziali ma nel 1968 Hill riuscì a
vincere il mondiale.
Grazie all’incredibile
flessibilità di questa monoposto, non vi furono inoltre
problemi ad adattarla all’introduzione degli alettoni e solo
verso la fine degli anni ’70 si registrò un calo
prestazionale che la mandarono in pensione.
La Lotus 49 fu anche la
prima vettura ad avere degli sponsor.
|
|

3) Ferrari F2002
Un altro capolavoro della casa di Maranello, solo
di poco inferiore alla successiva F2004.
Nelle mani di Schumacher
regalò al pilota tedesco il quinto titolo mondiale (ad
agosto) permettendogli di eguagliare il record di Fangio. Affidabile,
permise inoltre alla Ferrari di vincere il quarto titolo costruttori di
fila.
|
4) McLaren MP4-13 (1998)
E’ la vettura meglio riuscita della
seconda metà degli anni ’90. La McLaren MP4-13 si
adattò molto bene al nuovo regolamento introdotto nel 1998
che imponevano carreggiate strette e gomme scanalate divenendo il
capolavoro di Newey e Mercedes. Regalò il titolo costruttori
alla casa inglese e il primo titolo piloti a Mika Hakkinen, battendo su
tutti i fronti i rivali di Maranello.
|
|

5) Williams FW14B (1992)
Tale monoposto era così avanti rispetto
alle avversarie che solo nel 2002 Schumacher riuscì a
ripeterne i risultati. Mansell vinse il titolo in agosto e poco
più tardi la Williams si aggiudicò anche il
costruttori. I rivali dovettero accontentarsi quell’anno
delle briciole.
Aerodinamica di Newey, motore Renault, sospensioni computerizzate e
cambio semi-automatico fecero in sostanza di questa monoposto la
migliore della prima metàdegli anni ’90.
|
6) McLaren MP4/2
(1984-’86)
In tre stagioni la MP4/2 raccolse 22 vittorie e ben
5 titoli sui 6 disponibili. La forza di tale monoposto nasceva
dall’ottima coesione tra telaio e motore che la rese una
delle vetture più competitive dell’epoca. Non
sempre si rivelò la più veloce in pista, ma il
suo V6 Porsche, affidabile e dai consumi ridotti, le permetteva di
arrivare sempre in zona punti. Diede a Lauda il suo terzo e ultimo
titolo e a Prost il primo dei suoi quattro mondiali.
|
|

7) Maserati 250F
(1954-’60)
La Maserati 250F era adorata dai piloti per
bilanciamento e guidabilità. Diede a Fangio il quinto e
ultimo mondiale nel 1957, anno in cui conquistò la sua
più grande e famosa vittoria sul vecchio circuito del
Nürburgring, nel Gp di Germania. |
8) Renault R25 (2005)
La Renault R25 diede alla casa francese sia il
titolo costruttori sia il titolo piloti, conquistato per il primo anno
da Fernando Alonso. Era indubbiamente la vettura meglio riuscita
dell’anno
e seppe ben sfruttare il cambio di regolamento
imposto dalla Federazione (cambio gomme vietato e nuove regole
sull’aerodinamica). Fece
dell’affidabilità il suo punto di forza:
stracciò la Ferrari, mal riuscita, e non si fece intimorire
nemmeno dalla McLaren, veloce ma poco affidabile.
|
|

9) Lotus 72 (1970-’75)
Capolavoro di Chapman, vinse entrambi i titoli alla
stagione d’esordio. La Lotus 72, a differenza di altre
monoposto, nacque partendo dall’aerodinamica e non da un
corpo già esistente. Il muso affilato fu reso possibile
dallo spostamento del radiatore sulle fiancate mentre
un’ulteriore innovazione furono i freni anteriore on-board.
Con 20 GP vinti e le imprese di Peterson e Fittipaldi, tale vettura
è entrata di merito nella storia della F1.
Purtroppo però, diede tragicamente la morte a Rindt, a Monza
nel 1970 |
10) Cooper T51/T53
(1959-’62)
Sono gli anni della rivoluzione in F1. John Cooper
costruì questa vettura senza minimamente sapere che avrebbe
cambiato per sempre il volto della F1. Egli mostrò come,
mettendo il propulsore dietro al pilota, si potesse guadagnare molto in
guidabilità, frenata e grip.
I due titoli vinti con Jack
Brabham nel 1959 e nel 1960 aprirono gli occhi agli altri costruttori e
ben presto tutte le monoposto furono costruite con motore posteriore.
|
|
|
|
 |
|

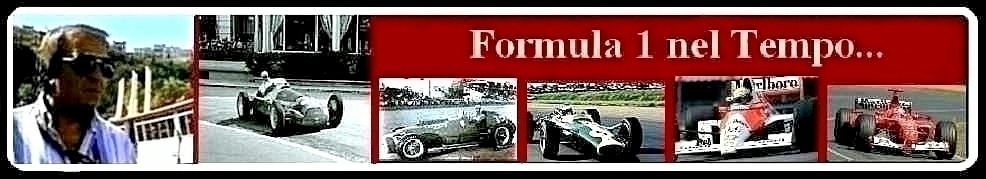







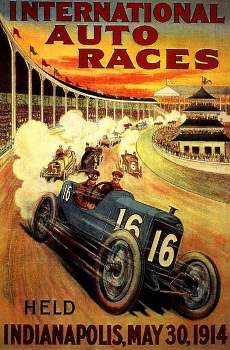
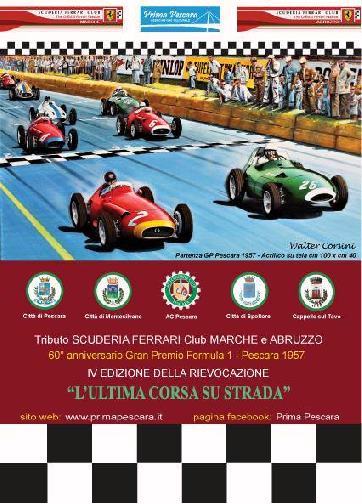










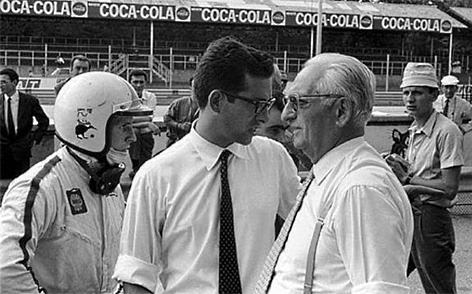



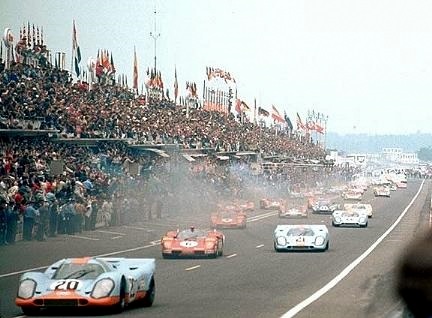

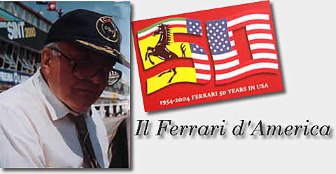
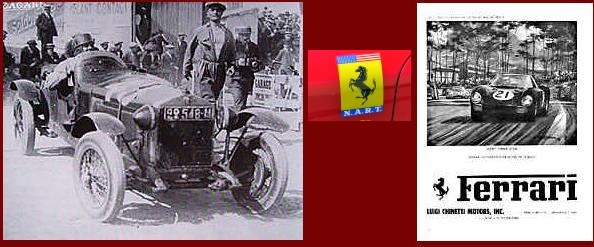

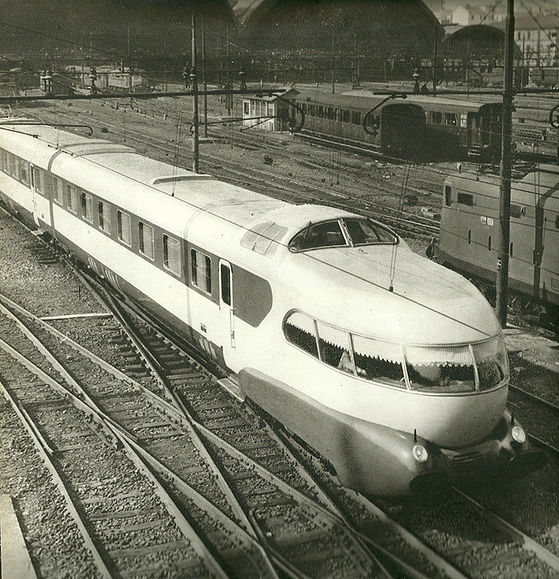



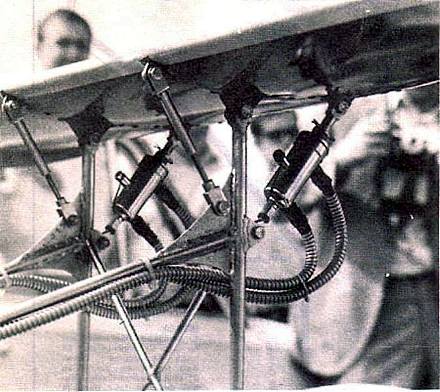
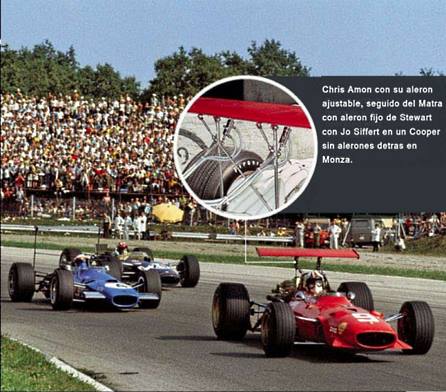

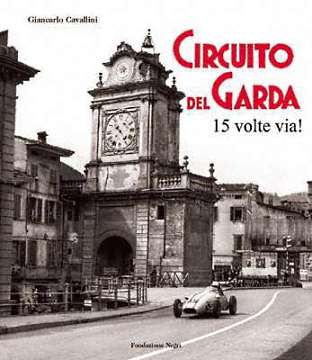





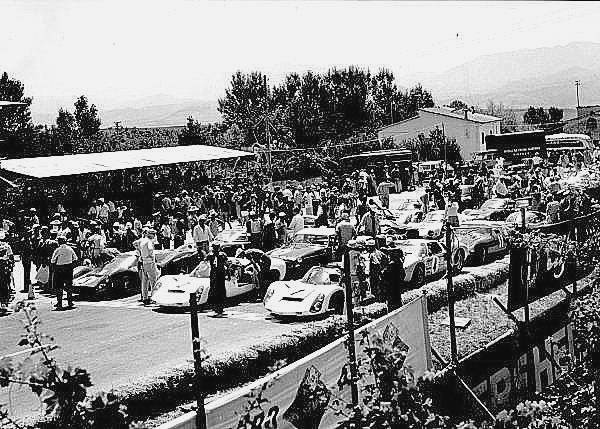
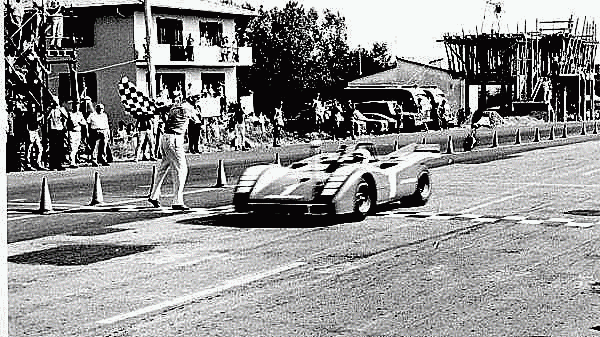
 Nel 1950 viene introdotto un campionato piloti, la cui classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti in sette gare:
Nel 1950 viene introdotto un campionato piloti, la cui classifica viene stilata in base ai risultati conseguiti in sette gare:
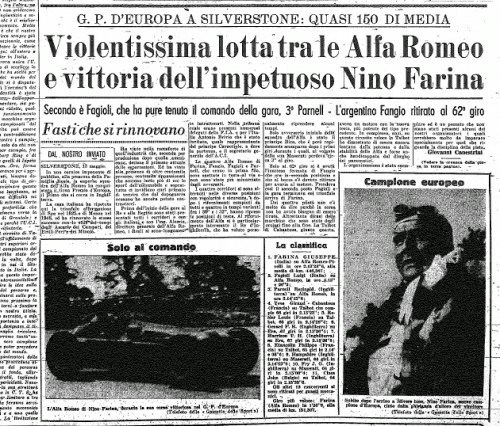
 Sebbene la Ferrari abbia perso ancora, il loro distacco dall'Alfa va
sempre più assottigliandosi. Da parte sua l'Alfa Romeo, a causa di
motivi finanziari, non è in grado di sviluppare ulteriormente le
monoposto e quindi di difendere il titolo: da qui la decisione di
abbandonare. Nessuno si potrà immaginare che, fino agli anni 80, questa
grandissima scuderia non riuscirà più a rientrare nel circus iridato.
La stagione del 1952 si corre con vetture di Formula 2 che prevedono
cilindrate di 500cc per i motori sovralimentati e di 2000cc per gli
altri. La Ferrari domina questo campionato ed il successivo vincendo 30
delle 33 gare principali, ma Fangio non è in grado di difendere il
titolo a causa di un incidente in una gara extra campionato che gli
causa la rottura del collo. In sua assenza Ascari vince tutte le gare
alle quali partecipa, conquistando il titolo mondiale. In quello stesso
anno fa il suo debutto il team inglese Cooper-Bristol che ha scelto Mike
Hawthorn come pilota di punta.
Il 1953 è ancora dominato dalla Ferrari che vede come unico rivale
Fangio, passato alla Maserati. Mike Hawthorn viene ingaggiato dalla
Ferrari e si ritrova in squadra con due campioni del mondo, Ascari e
Farina, e con un veterano d'eccezione, Villoresi; tre personaggi molto
scomodi e determinati a mantenere il controllo della squadra.
Ci riusciranno solo fino alla gara di Reims.
Sebbene la Ferrari abbia perso ancora, il loro distacco dall'Alfa va
sempre più assottigliandosi. Da parte sua l'Alfa Romeo, a causa di
motivi finanziari, non è in grado di sviluppare ulteriormente le
monoposto e quindi di difendere il titolo: da qui la decisione di
abbandonare. Nessuno si potrà immaginare che, fino agli anni 80, questa
grandissima scuderia non riuscirà più a rientrare nel circus iridato.
La stagione del 1952 si corre con vetture di Formula 2 che prevedono
cilindrate di 500cc per i motori sovralimentati e di 2000cc per gli
altri. La Ferrari domina questo campionato ed il successivo vincendo 30
delle 33 gare principali, ma Fangio non è in grado di difendere il
titolo a causa di un incidente in una gara extra campionato che gli
causa la rottura del collo. In sua assenza Ascari vince tutte le gare
alle quali partecipa, conquistando il titolo mondiale. In quello stesso
anno fa il suo debutto il team inglese Cooper-Bristol che ha scelto Mike
Hawthorn come pilota di punta.
Il 1953 è ancora dominato dalla Ferrari che vede come unico rivale
Fangio, passato alla Maserati. Mike Hawthorn viene ingaggiato dalla
Ferrari e si ritrova in squadra con due campioni del mondo, Ascari e
Farina, e con un veterano d'eccezione, Villoresi; tre personaggi molto
scomodi e determinati a mantenere il controllo della squadra.
Ci riusciranno solo fino alla gara di Reims.



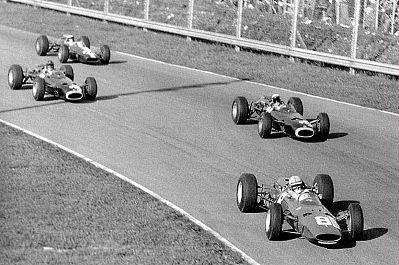


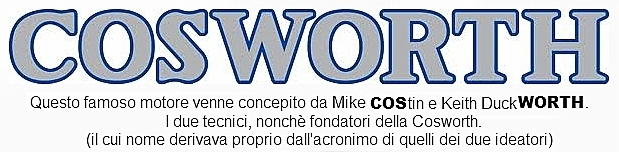
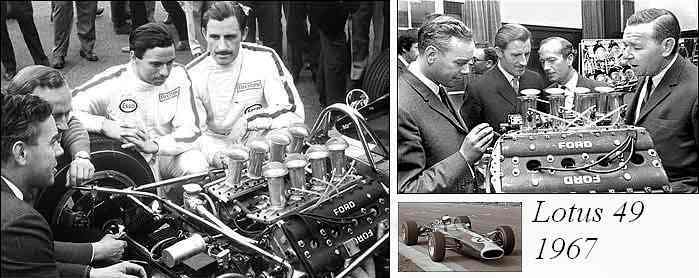
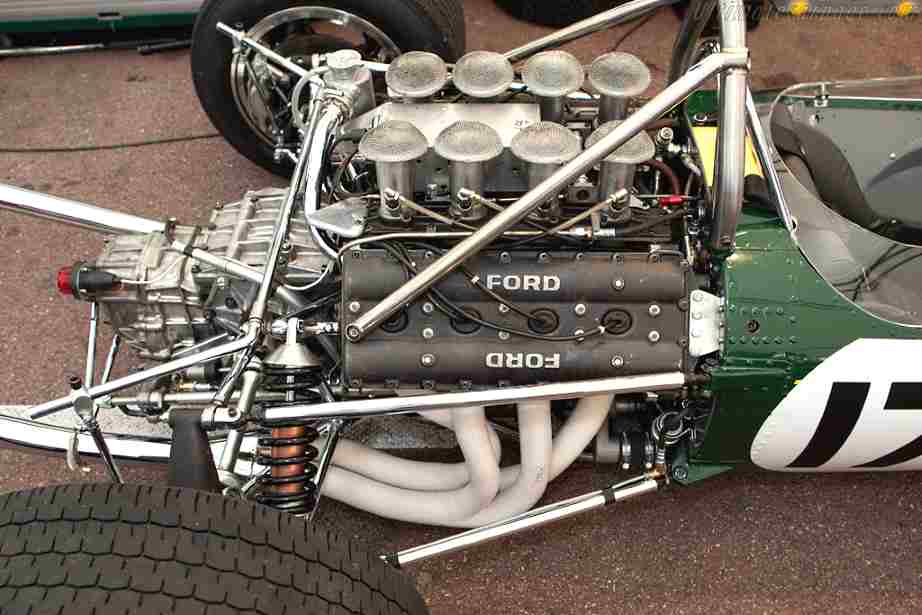



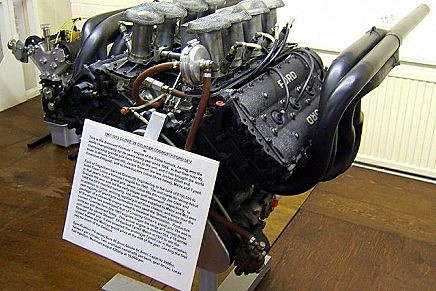


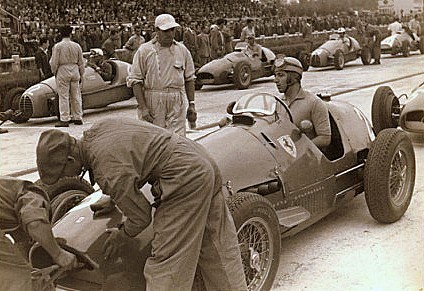










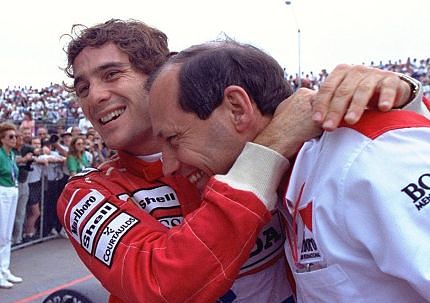






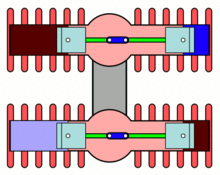

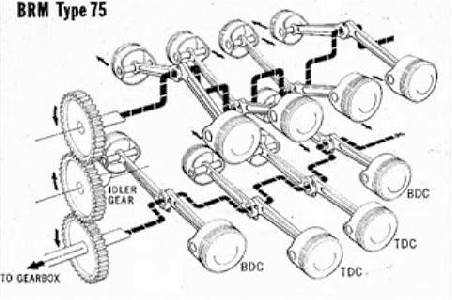


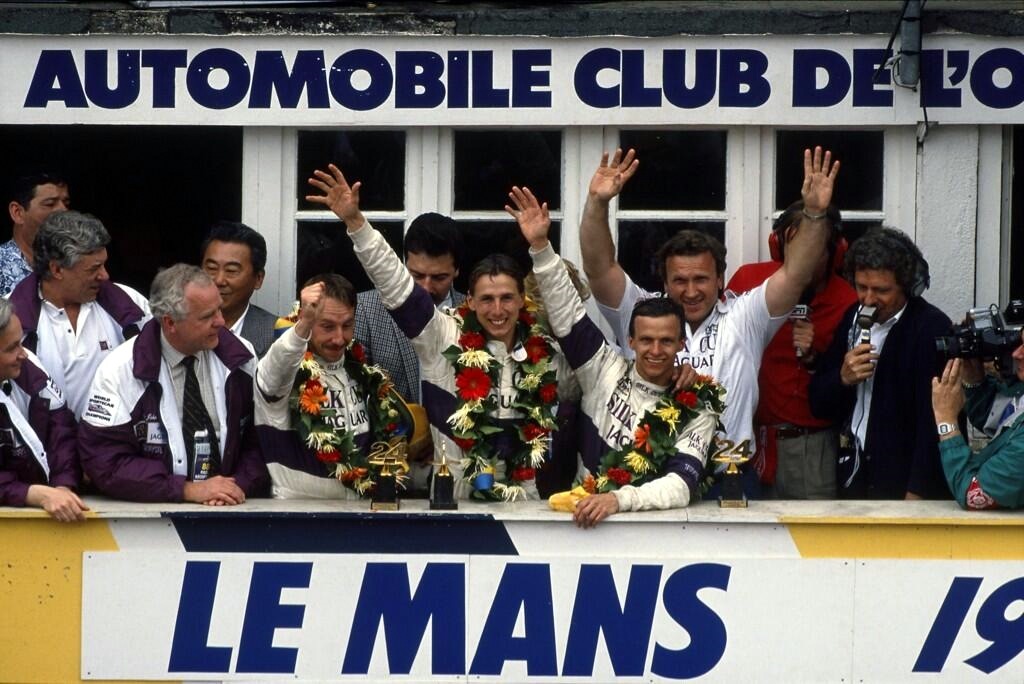




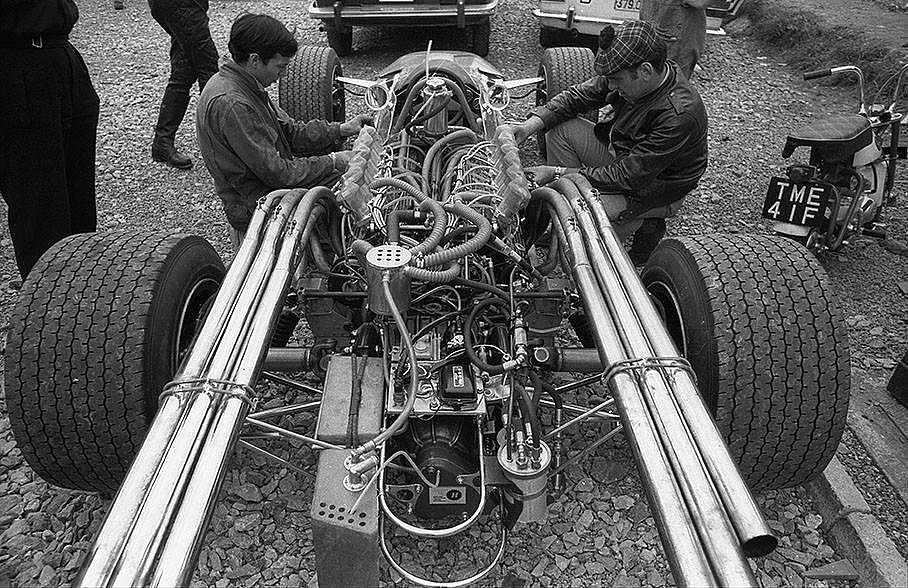









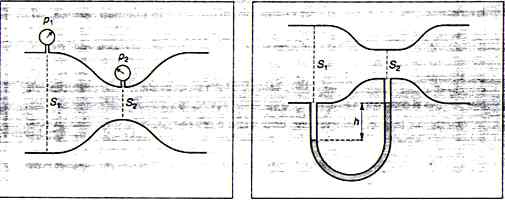

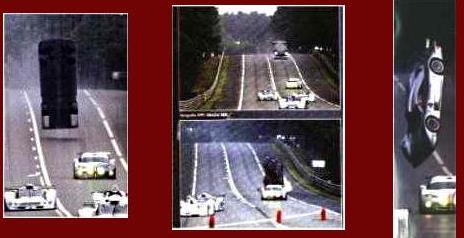
 Nel 1977 vedono la luce due importanti innovazioni
tecniche: la Renault turbo fa il proprio debutto al Gran Premio di Gran Bretagna
mentre la Lotus-Ford 78 debutta in Argentina. Entrambe le vetture influenzeranno
il mondo delle corse per molti anni a venire. La Lotus è il primo risultato
felice della messa in pratica della teoria del cosiddetto "effetto suolo" (la
capacità di sfruttare l'aria che passa sotto la macchina). L'idea trae le sue
origini dalle macchine Land Speed Record nei lontani anni 30, in particolare, le
Auto Unions progettate dal Professor Eberan-Eberhorst che aveva applicato degli
elementi laterali ed un fondo sagomato che creava l'effetto venturi.
Durante il 1969 la BRM aveva portato avanti diverse sperimentazioni sui principi
dell'effetto suolo. Tempo dopo Tony Rudd e Peter Write della Lotus, che avevano
lavorato insieme alla BRM continuarono a sviluppare il concetto insieme a Ralph
Bellamy e, ovviamente, Colin Chapman. A quest'ultimo piaceva molto l'impiego
multiplo dei componenti e l'idea di sfruttare l'aria sotto la vettura accese il
suo interesse. L'elemento mancante nei modelli precedenti erano gli
alettoni laterali di tipo flessibile. Ma anche in questo caso la quantità di
pressione negativa rimaneva piuttosto bassa. Ulteriori test furono effettuati
all'interno di una galleria del vento. Chapman supponeva che riducendo la
distanza libera da terra si sarebbe avuto un aumento della pressione; i test gli
daranno ragione. Spostando il piano a profilo aerodinamico del muso più vicino
alla superficie stradale in modo che la distanza libera fosse di soli quattro
pollici si ottiene effettivamente un "sollevamento" della superficie stradale!
La squadra invia relazioni sulle proprie scoperte a Chapman ogni settimana e
viene consigliata di seguire più strade. Il primo test ha luogo nell'agosto del
1976, quando Gunnar Nilsson in segreto guida la macchina lungo il circuito di
Snetterton. Quell'anno la macchina non viene utilizzata in modo da sfruttare
l'effetto sorpresa per l'anno successivo. E certo il lancio avviene in grande,
al Gran Premio d'Argentina, ma il concetto è talmente innovativo che ben pochi
comprendono quello che stanno vedendo. . Le due nuove Lotus 78 sono guidate da
Nilsson e dall'asso americano Mario Andretti che avrebbe aiutato la Lotus a
tornare fra le grandi.
Nel 1977 vedono la luce due importanti innovazioni
tecniche: la Renault turbo fa il proprio debutto al Gran Premio di Gran Bretagna
mentre la Lotus-Ford 78 debutta in Argentina. Entrambe le vetture influenzeranno
il mondo delle corse per molti anni a venire. La Lotus è il primo risultato
felice della messa in pratica della teoria del cosiddetto "effetto suolo" (la
capacità di sfruttare l'aria che passa sotto la macchina). L'idea trae le sue
origini dalle macchine Land Speed Record nei lontani anni 30, in particolare, le
Auto Unions progettate dal Professor Eberan-Eberhorst che aveva applicato degli
elementi laterali ed un fondo sagomato che creava l'effetto venturi.
Durante il 1969 la BRM aveva portato avanti diverse sperimentazioni sui principi
dell'effetto suolo. Tempo dopo Tony Rudd e Peter Write della Lotus, che avevano
lavorato insieme alla BRM continuarono a sviluppare il concetto insieme a Ralph
Bellamy e, ovviamente, Colin Chapman. A quest'ultimo piaceva molto l'impiego
multiplo dei componenti e l'idea di sfruttare l'aria sotto la vettura accese il
suo interesse. L'elemento mancante nei modelli precedenti erano gli
alettoni laterali di tipo flessibile. Ma anche in questo caso la quantità di
pressione negativa rimaneva piuttosto bassa. Ulteriori test furono effettuati
all'interno di una galleria del vento. Chapman supponeva che riducendo la
distanza libera da terra si sarebbe avuto un aumento della pressione; i test gli
daranno ragione. Spostando il piano a profilo aerodinamico del muso più vicino
alla superficie stradale in modo che la distanza libera fosse di soli quattro
pollici si ottiene effettivamente un "sollevamento" della superficie stradale!
La squadra invia relazioni sulle proprie scoperte a Chapman ogni settimana e
viene consigliata di seguire più strade. Il primo test ha luogo nell'agosto del
1976, quando Gunnar Nilsson in segreto guida la macchina lungo il circuito di
Snetterton. Quell'anno la macchina non viene utilizzata in modo da sfruttare
l'effetto sorpresa per l'anno successivo. E certo il lancio avviene in grande,
al Gran Premio d'Argentina, ma il concetto è talmente innovativo che ben pochi
comprendono quello che stanno vedendo. . Le due nuove Lotus 78 sono guidate da
Nilsson e dall'asso americano Mario Andretti che avrebbe aiutato la Lotus a
tornare fra le grandi. Quella prima gara termina con la distruzione di un
cuscinetto della ruota mentre Andretti è in lotta per il secondo posto. La gara
viene infine vinta da Jody Scheckter su una Wolf alla sua prima uscita. Durante la gara in Sud Africa si assiste ad un
tragico incidente che porta alla morte di un vigile del fuoco e del pilota
gallese Tom Pyrce. La gara viene vinta da Niki Lauda, alla sua prima vittoria
dopo il Gran Premio di Germania l'anno precedente. Per il 1977 sono previsti due
Gp degli Stati Uniti. Il GP dell'Ovest che si corre a Long Beach, in California
viene vinto dall'americano Mario Andretti che ottiene così la prima vittoria
della Lotus 78. Il Gran Premio di Spagna è la tappa seguente e la Lotus 78 dà
qui prova di grandi capacità sul campo. Andretti commenterà in seguito che per
quanto non risultasse la più veloce nei rettilinei, nelle curve sembrava
addirittura che la macchina corresse su una rotaia. Il Gran Premio di Belgio
quest'anno si corre a Zolder ma le condizioni atmosferiche sono identiche
all'anno precedente… piove. Il primo giro vede entrambe le auto della prima
fila, la Lotus di Andretti e la Brabham di John Watson eliminate in uno scontro.
Le condizioni atmosferiche certo non favoriscono i concorrenti rimasti ma il
compagno di squadra di Andretti, Gunnar Nilsson, ottiene una vittoria popolare
dopo essere partito al 3° posto. A Monaco, la Cosworth festeggia il suo 10°
anniversario quando con Scheckter raggiungono la 100° vittoria per il Mondiale
Costruttori. Monaco vede inoltre il debutto in pista di un giovane italiano di
nome Riccardo Patrese.
Quella prima gara termina con la distruzione di un
cuscinetto della ruota mentre Andretti è in lotta per il secondo posto. La gara
viene infine vinta da Jody Scheckter su una Wolf alla sua prima uscita. Durante la gara in Sud Africa si assiste ad un
tragico incidente che porta alla morte di un vigile del fuoco e del pilota
gallese Tom Pyrce. La gara viene vinta da Niki Lauda, alla sua prima vittoria
dopo il Gran Premio di Germania l'anno precedente. Per il 1977 sono previsti due
Gp degli Stati Uniti. Il GP dell'Ovest che si corre a Long Beach, in California
viene vinto dall'americano Mario Andretti che ottiene così la prima vittoria
della Lotus 78. Il Gran Premio di Spagna è la tappa seguente e la Lotus 78 dà
qui prova di grandi capacità sul campo. Andretti commenterà in seguito che per
quanto non risultasse la più veloce nei rettilinei, nelle curve sembrava
addirittura che la macchina corresse su una rotaia. Il Gran Premio di Belgio
quest'anno si corre a Zolder ma le condizioni atmosferiche sono identiche
all'anno precedente… piove. Il primo giro vede entrambe le auto della prima
fila, la Lotus di Andretti e la Brabham di John Watson eliminate in uno scontro.
Le condizioni atmosferiche certo non favoriscono i concorrenti rimasti ma il
compagno di squadra di Andretti, Gunnar Nilsson, ottiene una vittoria popolare
dopo essere partito al 3° posto. A Monaco, la Cosworth festeggia il suo 10°
anniversario quando con Scheckter raggiungono la 100° vittoria per il Mondiale
Costruttori. Monaco vede inoltre il debutto in pista di un giovane italiano di
nome Riccardo Patrese.
 Al Gran Premio di Svezia ad Anderstorp, Andretti vola via
lasciando i rivali alle proprie spalle, ma resta senza carburante a due soli
giri dalla fine, regalando praticamente la vittoria a Jacques Laffite sulla sua
Ligier motorizzata Matra. Si ristabilisce l'equilibrio quando al Gran Premio di
Francia la Brabham di Watson resta a secco e Andretti a sua volta gli "ruba" la
vittoria. Di ritorno sui circuiti del Gran Premio dopo un'assenza di quasi 70
anni: ecco la pioniera francese Renault unitasi ad un altro nome illustre, la
Michelin. E' infatti quest'ultima ad introdurre nella Formula Uno i pneumatici a
tele radiali, proprio come all'inizio del secolo aveva aperto la strada per i
cerchioni rimovibili. Oltre a tutto questo, la Renault monta un "trucchetto" sul
suo manicotto che cambierà la Formula Uno nel giro di qualche anno. Le loro
macchine montano motori turbocompressi da 1,5 litri con una potenza al freno
pari a circa 500 bhp.
Al Gran Premio di Svezia ad Anderstorp, Andretti vola via
lasciando i rivali alle proprie spalle, ma resta senza carburante a due soli
giri dalla fine, regalando praticamente la vittoria a Jacques Laffite sulla sua
Ligier motorizzata Matra. Si ristabilisce l'equilibrio quando al Gran Premio di
Francia la Brabham di Watson resta a secco e Andretti a sua volta gli "ruba" la
vittoria. Di ritorno sui circuiti del Gran Premio dopo un'assenza di quasi 70
anni: ecco la pioniera francese Renault unitasi ad un altro nome illustre, la
Michelin. E' infatti quest'ultima ad introdurre nella Formula Uno i pneumatici a
tele radiali, proprio come all'inizio del secolo aveva aperto la strada per i
cerchioni rimovibili. Oltre a tutto questo, la Renault monta un "trucchetto" sul
suo manicotto che cambierà la Formula Uno nel giro di qualche anno. Le loro
macchine montano motori turbocompressi da 1,5 litri con una potenza al freno
pari a circa 500 bhp.
 Entro il 1985 questi motori raggiungeranno una potenza al
freno pari a 1000 bhp. Il Gran Premio di Gran Bretagna segna il debutto del
giovane Franco-Canadese Gilles Villeneuve alla guida della McLaren M23. Con
tutto ciò, la gara viene comunque vinta da James Hunt. Il Gran Premio di
Germania viene spostato a Hockenheim e vinto da Niki Lauda. Alan Jones alla
guida di una Shadow vince a sorpresa il Gran Premio d'Austria mentre Niki Lauda
continua a fare punti con un secondo posto. Lauda accumula un'altra vittoria
nella gara successiva in Olanda e vola così in testa alla classifica mentre
Andretti, che aveva vinto ben tre corse, è continuamente afflitto da noie al
motore. Lauda conferma inoltre la propria intenzione di lasciare la scuderia di
Maranello alla fine dell'anno. Andretti vince la seconda gara in Italia ma con
il secondo posto di Lauda, il campionato è quasi nelle sue mani. Il Gran Premio
degli Stati Uniti, vinto da James Hunt, taglia la testa al toro.
Entro il 1985 questi motori raggiungeranno una potenza al
freno pari a 1000 bhp. Il Gran Premio di Gran Bretagna segna il debutto del
giovane Franco-Canadese Gilles Villeneuve alla guida della McLaren M23. Con
tutto ciò, la gara viene comunque vinta da James Hunt. Il Gran Premio di
Germania viene spostato a Hockenheim e vinto da Niki Lauda. Alan Jones alla
guida di una Shadow vince a sorpresa il Gran Premio d'Austria mentre Niki Lauda
continua a fare punti con un secondo posto. Lauda accumula un'altra vittoria
nella gara successiva in Olanda e vola così in testa alla classifica mentre
Andretti, che aveva vinto ben tre corse, è continuamente afflitto da noie al
motore. Lauda conferma inoltre la propria intenzione di lasciare la scuderia di
Maranello alla fine dell'anno. Andretti vince la seconda gara in Italia ma con
il secondo posto di Lauda, il campionato è quasi nelle sue mani. Il Gran Premio
degli Stati Uniti, vinto da James Hunt, taglia la testa al toro.
 Lauda si rifiuta
di correre le ultime due gare e la Ferrari ingaggia Gilles Villeneuve per
terminare la stagione. Dopo le vittorie di Hunt e Scheckter la stagione giunge
alla fine. Parallelamente, anche per la BRM giunge il momento di concludere il
proprio rapporto con la F1; la squadra di Bourne, che aveva vinto un'ultima
volta nel 1972, chiude i battenti. Mario Andretti aveva vinto 4 gare nel 1977 ma
problemi di affidabilità avevano ristretto le sue possibilità concrete di
vincere il campionato; nel 1978 avrebbe però realizzato il suo sogno di gioventù
ottenendo finalmente il titolo iridato.
Lauda si rifiuta
di correre le ultime due gare e la Ferrari ingaggia Gilles Villeneuve per
terminare la stagione. Dopo le vittorie di Hunt e Scheckter la stagione giunge
alla fine. Parallelamente, anche per la BRM giunge il momento di concludere il
proprio rapporto con la F1; la squadra di Bourne, che aveva vinto un'ultima
volta nel 1972, chiude i battenti. Mario Andretti aveva vinto 4 gare nel 1977 ma
problemi di affidabilità avevano ristretto le sue possibilità concrete di
vincere il campionato; nel 1978 avrebbe però realizzato il suo sogno di gioventù
ottenendo finalmente il titolo iridato.  Il 1978 è l'anno in cui un
pilota americano riesce a conquistare il titolo di Campione del Mondo per la
seconda volta nella storia; titolo che per Andretti resterà per sempre segnato
dalla morte del suo compagno di squadra Ronnie Peterson a Monza.
Il 1978 è l'anno in cui un
pilota americano riesce a conquistare il titolo di Campione del Mondo per la
seconda volta nella storia; titolo che per Andretti resterà per sempre segnato
dalla morte del suo compagno di squadra Ronnie Peterson a Monza. La Lotus esce con la Type 80 che però si rivela un vero
disastro, e così ripiegano sulla Type 79 dell'anno precedente. Come l'anno
precedente era stata una stagione da record, questa sarebbe stata per la Lotus
una stagione in tono minore e l'inizio di un lento ma inarrestabile declino
della famosa scuderia britannica. La nuova Williams FW07 guidata da Alan Jones e
da Clay Regazzoni si dimostrerà erede di diritto della Lotus 79. Ligier aveva
deciso per un motore Ford-Cosworth DFV invece del motore Matra V12. La loro
macchina si dimostra particolarmente adatta nei percorsi tortuosi. La BT48 della
Brabham è molto veloce nelle mani di Lauda e Piquet ma problemi meccanici
continueranno ad affliggere la squadra per tutto l'anno, ad eccezione della
vittoria di Lauda al GP Dino Ferrari di Imola, gara fuori campionato. In
seguito, quell'anno, la Brabham si affideranno per la loro BT49 ad un motore
otto-cilindri Ford-Cosworth DFV. Secondo la leggenda, la Tyrrell 009 fu
costruita sui progetti del modello della Lotus 79 che la società era riuscita a
procurarsi tramite il costruttore di modelli Tamaya! La Renault inaugura la
stagione con la RS01 dell'anno precedente ma con il motore a turbocompressore
riesce ad ottenere la pole position alla prima gara della stagione. Per la gara
di Monaco si convertono al doppio turbocompressore a gas di scarico in modo da
combattere il "turbo lag"; al Gran Premio di Francia riescono infine ad ottenere
la loro prima vittoria. Le prime due corse della stagione, Argentina e Brasile,
vengono vinte da Jacques Laffite per la Ligier. La Ferrari si accaparra la gara
seguente che si svolge in Sud Africa mentre la Ligier torna alla ribalta in
Spagna, questa volta con Patrick Depailler. Il Gran Premio del Belgio è una gara
veramente competitiva nella quale la vettura di testa cambierà ben sei volte
prima che Jody Scheckter su Ferrari agguanti la testa del gruppo e mantenga la
posizione fino alla fine. Monaco si trasforma in una lotta tra Scheckter e la
Williams di Regazzoni ma per quanto tenti, il pilota svizzero non riesce a
superare la rossa. Sfortunatamente questo sarà l'ultimo Gran Premio per l'ex
Campione del Mondo James Hunt che al termine della gara lascia la Wolf e si
ritira dalle corse.
La Lotus esce con la Type 80 che però si rivela un vero
disastro, e così ripiegano sulla Type 79 dell'anno precedente. Come l'anno
precedente era stata una stagione da record, questa sarebbe stata per la Lotus
una stagione in tono minore e l'inizio di un lento ma inarrestabile declino
della famosa scuderia britannica. La nuova Williams FW07 guidata da Alan Jones e
da Clay Regazzoni si dimostrerà erede di diritto della Lotus 79. Ligier aveva
deciso per un motore Ford-Cosworth DFV invece del motore Matra V12. La loro
macchina si dimostra particolarmente adatta nei percorsi tortuosi. La BT48 della
Brabham è molto veloce nelle mani di Lauda e Piquet ma problemi meccanici
continueranno ad affliggere la squadra per tutto l'anno, ad eccezione della
vittoria di Lauda al GP Dino Ferrari di Imola, gara fuori campionato. In
seguito, quell'anno, la Brabham si affideranno per la loro BT49 ad un motore
otto-cilindri Ford-Cosworth DFV. Secondo la leggenda, la Tyrrell 009 fu
costruita sui progetti del modello della Lotus 79 che la società era riuscita a
procurarsi tramite il costruttore di modelli Tamaya! La Renault inaugura la
stagione con la RS01 dell'anno precedente ma con il motore a turbocompressore
riesce ad ottenere la pole position alla prima gara della stagione. Per la gara
di Monaco si convertono al doppio turbocompressore a gas di scarico in modo da
combattere il "turbo lag"; al Gran Premio di Francia riescono infine ad ottenere
la loro prima vittoria. Le prime due corse della stagione, Argentina e Brasile,
vengono vinte da Jacques Laffite per la Ligier. La Ferrari si accaparra la gara
seguente che si svolge in Sud Africa mentre la Ligier torna alla ribalta in
Spagna, questa volta con Patrick Depailler. Il Gran Premio del Belgio è una gara
veramente competitiva nella quale la vettura di testa cambierà ben sei volte
prima che Jody Scheckter su Ferrari agguanti la testa del gruppo e mantenga la
posizione fino alla fine. Monaco si trasforma in una lotta tra Scheckter e la
Williams di Regazzoni ma per quanto tenti, il pilota svizzero non riesce a
superare la rossa. Sfortunatamente questo sarà l'ultimo Gran Premio per l'ex
Campione del Mondo James Hunt che al termine della gara lascia la Wolf e si
ritira dalle corse. Come abbiamo ricordato poc'anzi, il Gran Premio viene vinto
dalla Renault ma è la strenua lotta tra Villeneuve ed Arnoux per il secondo
posto che cattura l'attenzione dei tifosi. Questo duello con numerosi sorpassi,
alcuni dei quali addirittura in piena curva, contribuisce a far nascere la
leggenda del giovane pilota Franco-canadese. Il fatto che tale duello
riguardasse il secondo posto rende la lotta ancora più interessante. La tappa
successiva è il veloce circuito di Silverstone e qui la Williams domina la gara;
saranno lei e la Ferrari a contendersi le rimanenti gare del campionato per
conquistare il titolo. Alla fine, l'affidabilità della Ferrari si dimostra
difficile da battere e Scheckter ottiene la vittoria davanti al suo compagno di
squadra Villeneuve ed Alan Jones al terzo posto. Il nuovo decennio assiste ad
una lunga serie di cambiamenti sulla griglia di partenza, con la dismissione
della Shadow, l'unione di Wolf e Copersucar, il ritorno della Alfa-Romeo.
Come abbiamo ricordato poc'anzi, il Gran Premio viene vinto
dalla Renault ma è la strenua lotta tra Villeneuve ed Arnoux per il secondo
posto che cattura l'attenzione dei tifosi. Questo duello con numerosi sorpassi,
alcuni dei quali addirittura in piena curva, contribuisce a far nascere la
leggenda del giovane pilota Franco-canadese. Il fatto che tale duello
riguardasse il secondo posto rende la lotta ancora più interessante. La tappa
successiva è il veloce circuito di Silverstone e qui la Williams domina la gara;
saranno lei e la Ferrari a contendersi le rimanenti gare del campionato per
conquistare il titolo. Alla fine, l'affidabilità della Ferrari si dimostra
difficile da battere e Scheckter ottiene la vittoria davanti al suo compagno di
squadra Villeneuve ed Alan Jones al terzo posto. Il nuovo decennio assiste ad
una lunga serie di cambiamenti sulla griglia di partenza, con la dismissione
della Shadow, l'unione di Wolf e Copersucar, il ritorno della Alfa-Romeo.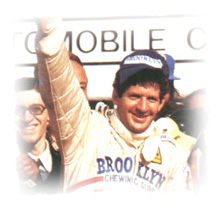 Fuori
dalla pista continuano ad esserci contrasti tra FISA e la Formula One
Constructors' Association (FOCA). Le squadre maggiori come Renault, Ferrari
(Fiat) ed Alfa-Romeo sono tendenzialmente dalla parte della FISA mentre le
squadre britanniche si trovano a sostenere la FOCA. La battaglia riguarda i
motori a turbocompressione, sostenuti dai primi e i vantaggi dell'effetto suolo,
sostenuto dagli ultimi. Le prime quattro gare di quell'anno vengono vinte da
quattro piloti diversi. Alan Jones per la Williams, Rene Arnoux per la Renault,
Nelson Piquet per la Brabham e Carlos Reutemann sulla Williams. Jones vince
nuovamente in Spagna. Qui si assiste inoltre ad un distacco tra FISA e FOCA che
risulta nel ritiro di Renault, Ferrari ed Alfa-Romeo unitamente a tutti i punti
campionato assegnati al vincitore. In questo stato di grande confusione, sarà la
Goodyear a forzare le parti ad un tavolo delle trattative. Il Gran Premio di
Francia sembra prospettare una vittoria francese con Arnoux in testa davanti a
J
Fuori
dalla pista continuano ad esserci contrasti tra FISA e la Formula One
Constructors' Association (FOCA). Le squadre maggiori come Renault, Ferrari
(Fiat) ed Alfa-Romeo sono tendenzialmente dalla parte della FISA mentre le
squadre britanniche si trovano a sostenere la FOCA. La battaglia riguarda i
motori a turbocompressione, sostenuti dai primi e i vantaggi dell'effetto suolo,
sostenuto dagli ultimi. Le prime quattro gare di quell'anno vengono vinte da
quattro piloti diversi. Alan Jones per la Williams, Rene Arnoux per la Renault,
Nelson Piquet per la Brabham e Carlos Reutemann sulla Williams. Jones vince
nuovamente in Spagna. Qui si assiste inoltre ad un distacco tra FISA e FOCA che
risulta nel ritiro di Renault, Ferrari ed Alfa-Romeo unitamente a tutti i punti
campionato assegnati al vincitore. In questo stato di grande confusione, sarà la
Goodyear a forzare le parti ad un tavolo delle trattative. Il Gran Premio di
Francia sembra prospettare una vittoria francese con Arnoux in testa davanti a
J acques Laffite ma presto Jones li raggiunge e li supera. Quest'ultimo vince
ancora in Inghilterra mentre Laffite arriva primo in Germania. Dopo la vittoria
di Jean-Pierre Jabouille in Austria le due tappe successive se le aggiudica
Piquet.. la battaglia per il titolo riguarda ormai solo due piloti:
l'australiano Alan Jones ed il brasiliano Nelson Piquet. Sarà Jones a
conquistare il titolo con la vittoria sul circuito di Watkins Glen.
acques Laffite ma presto Jones li raggiunge e li supera. Quest'ultimo vince
ancora in Inghilterra mentre Laffite arriva primo in Germania. Dopo la vittoria
di Jean-Pierre Jabouille in Austria le due tappe successive se le aggiudica
Piquet.. la battaglia per il titolo riguarda ormai solo due piloti:
l'australiano Alan Jones ed il brasiliano Nelson Piquet. Sarà Jones a
conquistare il titolo con la vittoria sul circuito di Watkins Glen.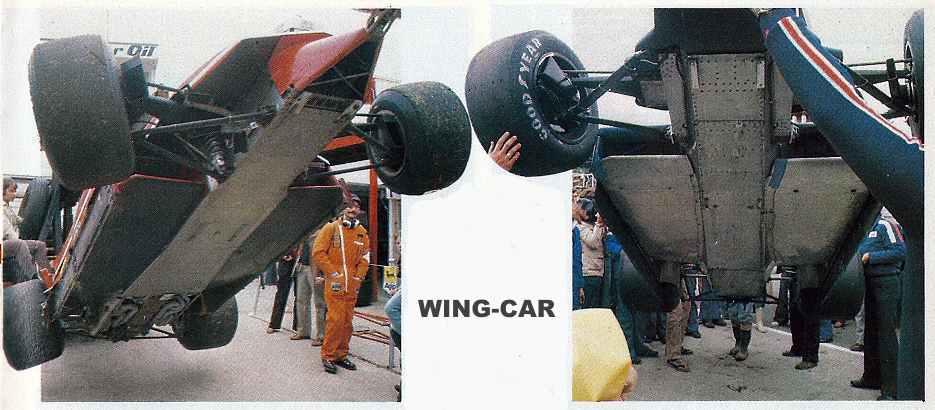






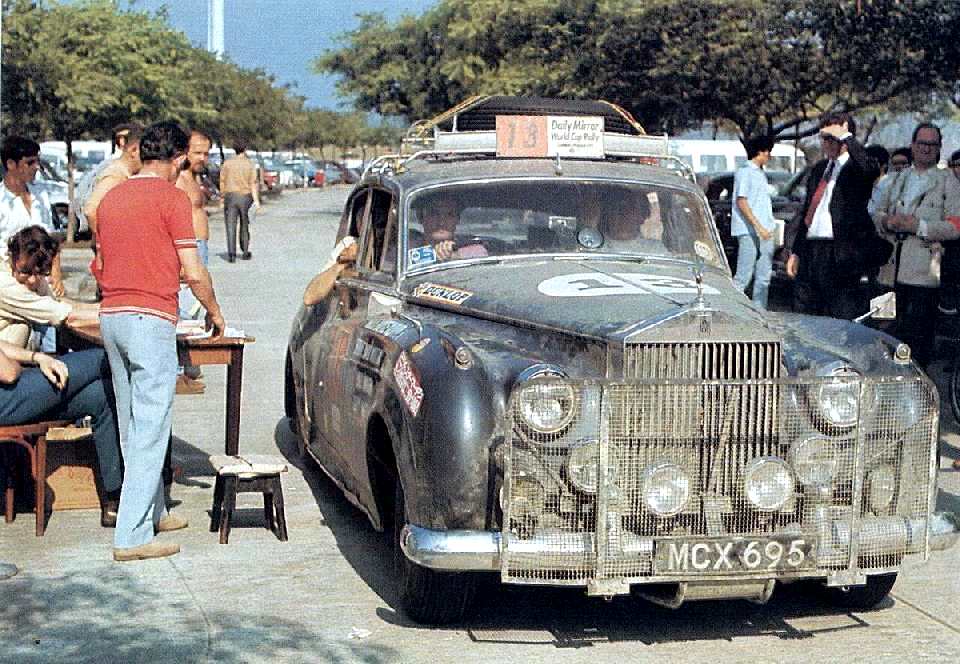
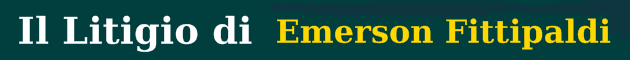

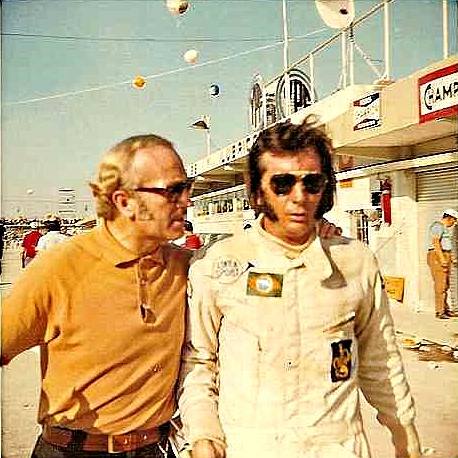


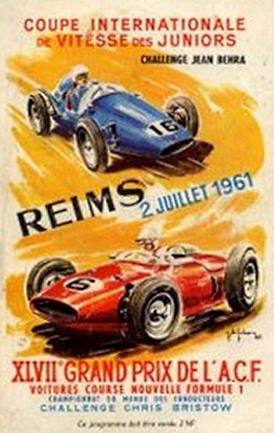





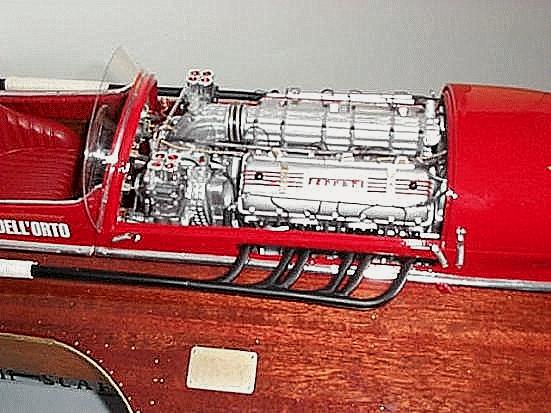


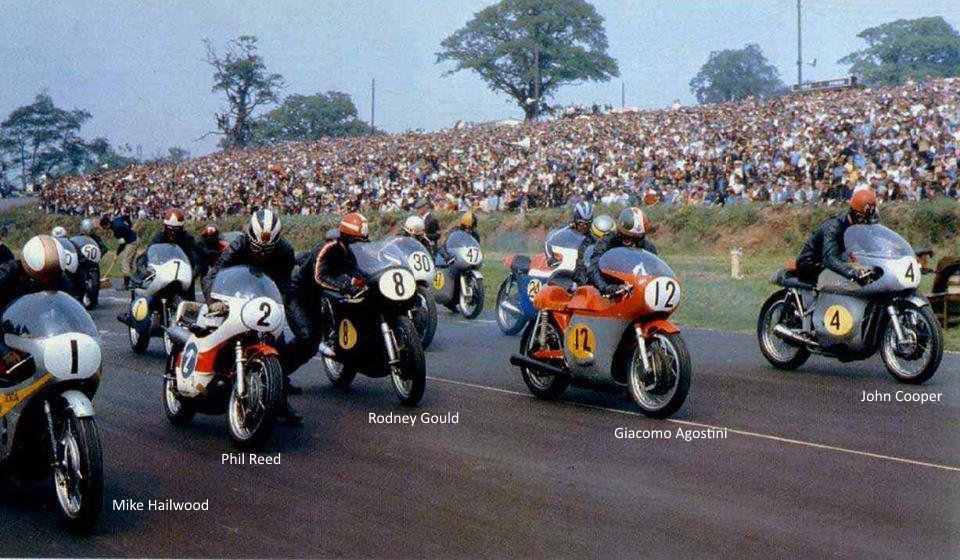


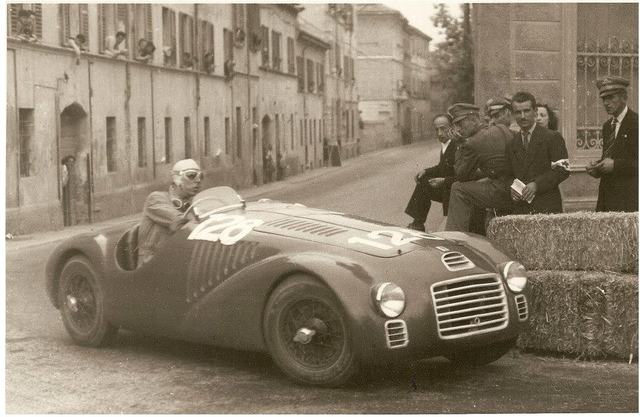
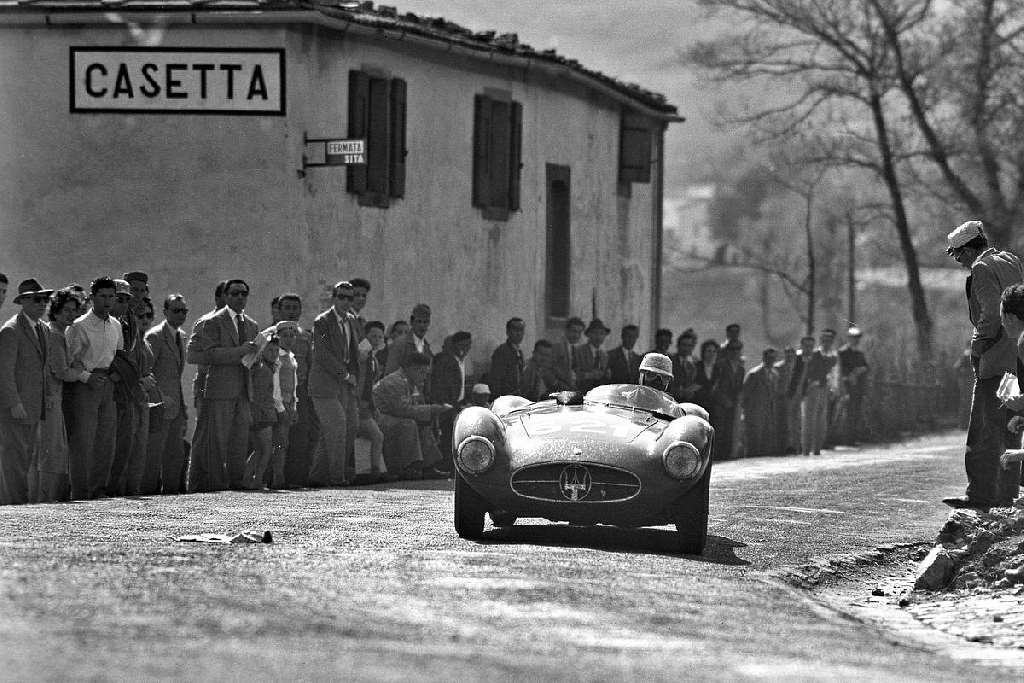
 Le squadre inglesi si fanno notare sempre più frequentemente alle
griglie di partenza dei Gran Premi. L'olandese Tony Vandervell esce
dalla BRM, la prima e più grande scuderia britannica entrata nel
frattempo in crisi, e si mette in proprio. Per le auto del suo nuovo
progetto decide di adottare un motore sviluppato dalla celebre Norton
Motor Cycles, mentre commissiona il disegno del telaio a Colin Chapman.
Ai fratelli Charles e John Cooper, che avevano messo in piedi una
fiorente attività occupandosi di auto da Formula 3, affida il compito di
costruirlo e montarlo. Sarà Stirling Moss a guidare alla vittoria una di
queste nuove auto al Trofeo Internazionale di Silverstone. La Ferrari e
la Maserati continueranno a vincere grazie alla bravura di piloti come
Fangio e Hawthorn, anche se ormai per le auto italiane i tempi sono
cambiati e le rosse non riescono più a dominare in questo sport come
hanno fatto dopo la seconda guerra mondiale.
Le squadre inglesi si fanno notare sempre più frequentemente alle
griglie di partenza dei Gran Premi. L'olandese Tony Vandervell esce
dalla BRM, la prima e più grande scuderia britannica entrata nel
frattempo in crisi, e si mette in proprio. Per le auto del suo nuovo
progetto decide di adottare un motore sviluppato dalla celebre Norton
Motor Cycles, mentre commissiona il disegno del telaio a Colin Chapman.
Ai fratelli Charles e John Cooper, che avevano messo in piedi una
fiorente attività occupandosi di auto da Formula 3, affida il compito di
costruirlo e montarlo. Sarà Stirling Moss a guidare alla vittoria una di
queste nuove auto al Trofeo Internazionale di Silverstone. La Ferrari e
la Maserati continueranno a vincere grazie alla bravura di piloti come
Fangio e Hawthorn, anche se ormai per le auto italiane i tempi sono
cambiati e le rosse non riescono più a dominare in questo sport come
hanno fatto dopo la seconda guerra mondiale.



 approfittando di questo tempo Moss
e Fangio partecipano ad una 500 km a Cuba. Fangio però non prenderà mai
parte al via poiché viene sequestrato dai ribelli filo-castristi che
stanno protestando contro la decisione del governo di sostenere
finanziariamente la competizione nonostante le terribili condizioni
economiche del paese. Fortunatamente verrà liberato poco dopo la
conclusione della corsa, vinta da Moss. Al Gran Premio d'Olanda, che si corre sul circuito di
Zandvoort, il podio è tutto britannico, con la Vanwall del vincitore
Moss e le BRM di Schell e Behra. La gara successiva, il Gran Premio del
Belgio a Spa, viene vinto da Tony Brooks, il cui stile di guida morbido
sembra esaltare le caratteristiche di questo circuito dalle curve larghe
e veloci. Con il Gran Premio di Francia si assiste al trionfo di
Hawthorn, che porta la Ferrari alla prima vittoria dal 1956, ma anche
alla tragedia della morte di Luigi Musso, l'ultimo dei grandi piloti
italiani. La gara è anche l'ultima nella formidabile carriera di Fangio.
Peter Collins all'inizio della stagione si impegna solennemente a dare
tutto il proprio aiuto all'amico Hawthorn nella caccia al titolo
mondiale e a Silverstone Collins ha l'occasione per dimostrarsi di
parola, impegnandosi in un duello con Moss. L'auto di Moss presto è
fuori uso. Collins va a vincere e il suo amico Hawthorn, finendo
secondo, incamera preziosi punti.
approfittando di questo tempo Moss
e Fangio partecipano ad una 500 km a Cuba. Fangio però non prenderà mai
parte al via poiché viene sequestrato dai ribelli filo-castristi che
stanno protestando contro la decisione del governo di sostenere
finanziariamente la competizione nonostante le terribili condizioni
economiche del paese. Fortunatamente verrà liberato poco dopo la
conclusione della corsa, vinta da Moss. Al Gran Premio d'Olanda, che si corre sul circuito di
Zandvoort, il podio è tutto britannico, con la Vanwall del vincitore
Moss e le BRM di Schell e Behra. La gara successiva, il Gran Premio del
Belgio a Spa, viene vinto da Tony Brooks, il cui stile di guida morbido
sembra esaltare le caratteristiche di questo circuito dalle curve larghe
e veloci. Con il Gran Premio di Francia si assiste al trionfo di
Hawthorn, che porta la Ferrari alla prima vittoria dal 1956, ma anche
alla tragedia della morte di Luigi Musso, l'ultimo dei grandi piloti
italiani. La gara è anche l'ultima nella formidabile carriera di Fangio.
Peter Collins all'inizio della stagione si impegna solennemente a dare
tutto il proprio aiuto all'amico Hawthorn nella caccia al titolo
mondiale e a Silverstone Collins ha l'occasione per dimostrarsi di
parola, impegnandosi in un duello con Moss. L'auto di Moss presto è
fuori uso. Collins va a vincere e il suo amico Hawthorn, finendo
secondo, incamera preziosi punti. Questa amicizia ha tragicamente fine
quando Collins perde la vita nella sfida con Tony Brooks al Nurburgring.
Vincerà Brooks. La corsa al titolo di Campione del Mondo ora ha un
terzo, serio contendente: Tony Brooks. La lotta si sposta in Portogallo.
Qui Moss ha la possibilità di vincere, ma un suo errore e la sua lealtà
gli sono fatali. Hawthorn riesce così a guadagnare i 6 punti di cui ha
bisogno per continuare a mantenere la testa della classifica. Moss ha
confuso un cartello con scritto HAW-REC (Hawthorn-record)
interpretandolo HAW-REG ("tutto regolare per Hawthorn"), senza capire
quindi che il suo rivale ha appena preso un altro punto dopo aver fatto
registrare il giro di pista più veloce. Al termine della gara, inoltre,
Moss prende le difese di Hawthorn, dopo che il pilota della Ferrari è
stato accusato di aver spinto la sua auto durante la gara. Infrazione
del regolamento che avrebbe procurato a Hawthorn la squalifica, se Moss
non fosse intervenuto per salvarlo. Due anni dopo è Moss che si trova in
una situazione simile, ma nessuno lo aiuta a scagionarsi dalle accuse.
Il mondo dell'automobilismo era, nel frattempo, irrimediabilmente
cambiato.
Questa amicizia ha tragicamente fine
quando Collins perde la vita nella sfida con Tony Brooks al Nurburgring.
Vincerà Brooks. La corsa al titolo di Campione del Mondo ora ha un
terzo, serio contendente: Tony Brooks. La lotta si sposta in Portogallo.
Qui Moss ha la possibilità di vincere, ma un suo errore e la sua lealtà
gli sono fatali. Hawthorn riesce così a guadagnare i 6 punti di cui ha
bisogno per continuare a mantenere la testa della classifica. Moss ha
confuso un cartello con scritto HAW-REC (Hawthorn-record)
interpretandolo HAW-REG ("tutto regolare per Hawthorn"), senza capire
quindi che il suo rivale ha appena preso un altro punto dopo aver fatto
registrare il giro di pista più veloce. Al termine della gara, inoltre,
Moss prende le difese di Hawthorn, dopo che il pilota della Ferrari è
stato accusato di aver spinto la sua auto durante la gara. Infrazione
del regolamento che avrebbe procurato a Hawthorn la squalifica, se Moss
non fosse intervenuto per salvarlo. Due anni dopo è Moss che si trova in
una situazione simile, ma nessuno lo aiuta a scagionarsi dalle accuse.
Il mondo dell'automobilismo era, nel frattempo, irrimediabilmente
cambiato.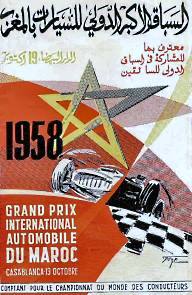

 Hawthorn si ritirerà dalle corse in dicembre… e
morirà in un incidente d'auto il gennaio successivo. L'automobilismo è
uno sport pericoloso e sempre lo sarà. Non si può negare che la
possibilità di ferirsi o di morire sia sempre in agguato, ma non
dobbiamo permettere che questa nostra consapevolezza ci renda cinici. I
piloti di un tempo erano più uniti fra loro di quanto non lo siano oggi
ed erano sempre molto scossi per la morte di un compagno. Noi
appassionati dovremmo gioire per la bravura e il coraggio dei piloti più
che piangere per la loro scomparsa. Chris Nixon ha scritto un bellissimo
libro, intitolato "Mon Ami Mate", sull'automobilismo sportivo degli anni
'50, il cui tema centrale è il vincolo d'amicizia tra Hawthorn e
Collins. Non potrei consigliarvi un libro più caldamente.
Hawthorn si ritirerà dalle corse in dicembre… e
morirà in un incidente d'auto il gennaio successivo. L'automobilismo è
uno sport pericoloso e sempre lo sarà. Non si può negare che la
possibilità di ferirsi o di morire sia sempre in agguato, ma non
dobbiamo permettere che questa nostra consapevolezza ci renda cinici. I
piloti di un tempo erano più uniti fra loro di quanto non lo siano oggi
ed erano sempre molto scossi per la morte di un compagno. Noi
appassionati dovremmo gioire per la bravura e il coraggio dei piloti più
che piangere per la loro scomparsa. Chris Nixon ha scritto un bellissimo
libro, intitolato "Mon Ami Mate", sull'automobilismo sportivo degli anni
'50, il cui tema centrale è il vincolo d'amicizia tra Hawthorn e
Collins. Non potrei consigliarvi un libro più caldamente.


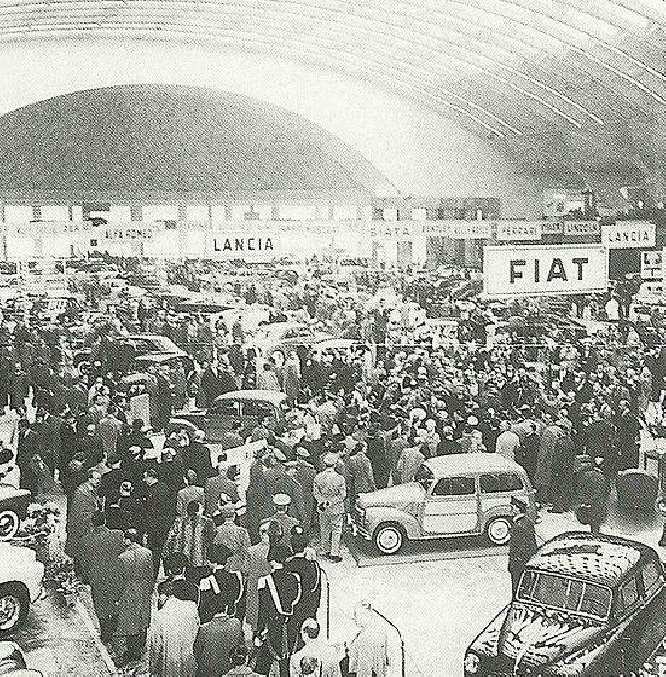
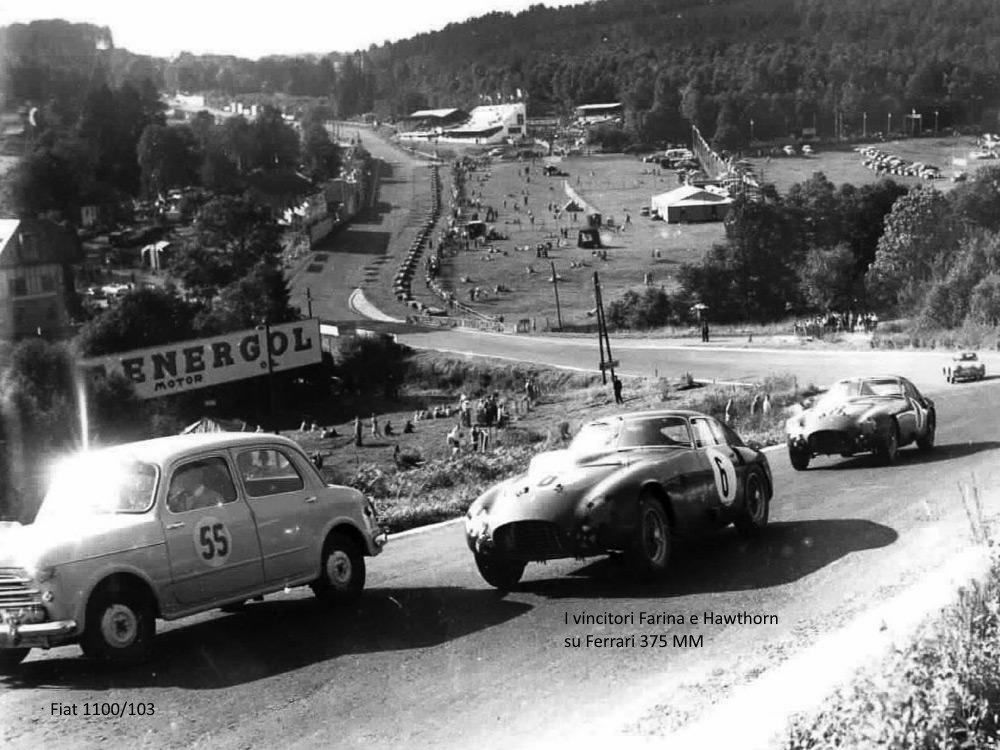



















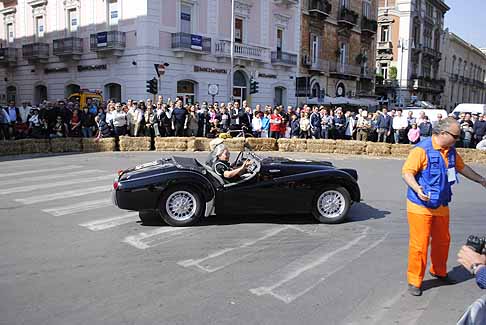

 La
Ferrari vince il Campionato del Mondo nel 1961, ma già l'anno dopo
per la scuderia italiana le cose cambiano radicalmente. La
stagione del 1962 vede infatti la Ferrari subire un abbandono di
massa da parte di tecnici ed ingegneri, compresi il capo ingegnere
e il team manager della scuderia, la causa, com'è nella tradizione
Ferrari, sono i problemi di politica interna. Per la stagione '62
vengono così recuperate, per affrontare le compagini inglesi e
tedesche sempre più competitive, le stesse auto dell'anno
precedente. Il primo pilota é Phil Hill, mentre il resto della
squadra è composto da Willy Mairesse, Ricardo Rodriguez, Giancarlo
Baghetti e Lorenzo Bandini. Le speranze tedesche sono riposte solo
sulla Porsche. Queste, guidate dal pilota americano Dan Gurney e
dal famoso corridore svedese Jo Bonnier, utilizzano motori a otto
cilindri in linea, raffredati ad aria e montati su telai tubolari
molto evoluti. Alla Lotus, Innes Ireland viene rimpiazzato senza
tante cerimonie da Trevor Taylor per fare coppia con Jimmy Clark,
il nuovo pupillo di Colin. Chapman progetta per lui, il modello 25
usando un telaio monoscocca che fa risultare il posto di guida
molto simile ad una vasca da bagno.
La
Ferrari vince il Campionato del Mondo nel 1961, ma già l'anno dopo
per la scuderia italiana le cose cambiano radicalmente. La
stagione del 1962 vede infatti la Ferrari subire un abbandono di
massa da parte di tecnici ed ingegneri, compresi il capo ingegnere
e il team manager della scuderia, la causa, com'è nella tradizione
Ferrari, sono i problemi di politica interna. Per la stagione '62
vengono così recuperate, per affrontare le compagini inglesi e
tedesche sempre più competitive, le stesse auto dell'anno
precedente. Il primo pilota é Phil Hill, mentre il resto della
squadra è composto da Willy Mairesse, Ricardo Rodriguez, Giancarlo
Baghetti e Lorenzo Bandini. Le speranze tedesche sono riposte solo
sulla Porsche. Queste, guidate dal pilota americano Dan Gurney e
dal famoso corridore svedese Jo Bonnier, utilizzano motori a otto
cilindri in linea, raffredati ad aria e montati su telai tubolari
molto evoluti. Alla Lotus, Innes Ireland viene rimpiazzato senza
tante cerimonie da Trevor Taylor per fare coppia con Jimmy Clark,
il nuovo pupillo di Colin. Chapman progetta per lui, il modello 25
usando un telaio monoscocca che fa risultare il posto di guida
molto simile ad una vasca da bagno.
 Questo
modello tiene conto di due dei principali fattori nella
progettazione di un telaio: la solidità e la leggerezza. La BRM si
affida a Graham Hill e Richie Ginther come rispettivamente primo e
secondo pilota, mentre la Cooper ha Bruce McLaren e Tony Maggs.
Brabham che ha lasciato la Cooper è impegnato nella preparazione
delle sue vetture che debutteranno più avanti nella stagione. A
Zandvoort, in Olanda, si corre il primo Gran Premio della
stagione. La gara inizia con Clark, Gourney e Graham Hill che
lottano per il comando. Hill vince il suo primo Gran Premio alla
guida di una BRM, che festeggia la seconda vittoria assoluta,
grazie all'esclusione dei suoi due contendenti per guasti
meccanici. A Monaco, nella gara successiva, Hill e Clark hanno
tutta l'intenzione di riprendere il duello, ma quasi subito le
loro auto li lasciano a piedi. Vince McLaren seguito dalla Ferrari
di Phil Hill. Il Gran Premio del Belgio di SPA passa alla storia
come la prima vittoria assoluta di Jimmy Clark.
Questo
modello tiene conto di due dei principali fattori nella
progettazione di un telaio: la solidità e la leggerezza. La BRM si
affida a Graham Hill e Richie Ginther come rispettivamente primo e
secondo pilota, mentre la Cooper ha Bruce McLaren e Tony Maggs.
Brabham che ha lasciato la Cooper è impegnato nella preparazione
delle sue vetture che debutteranno più avanti nella stagione. A
Zandvoort, in Olanda, si corre il primo Gran Premio della
stagione. La gara inizia con Clark, Gourney e Graham Hill che
lottano per il comando. Hill vince il suo primo Gran Premio alla
guida di una BRM, che festeggia la seconda vittoria assoluta,
grazie all'esclusione dei suoi due contendenti per guasti
meccanici. A Monaco, nella gara successiva, Hill e Clark hanno
tutta l'intenzione di riprendere il duello, ma quasi subito le
loro auto li lasciano a piedi. Vince McLaren seguito dalla Ferrari
di Phil Hill. Il Gran Premio del Belgio di SPA passa alla storia
come la prima vittoria assoluta di Jimmy Clark.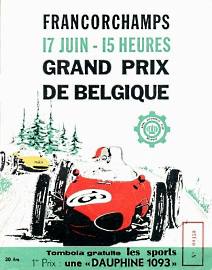

 Le prime posizioni delle griglie di partenza sono occupate dalle
auto di cinque diverse scuderie: Porsche, BRM, Lotus, Lola e
Cooper, facendo presagire una gara indimenticabile. I piloti i cui
nomi sono destinati a diventare leggendari sono Gurney, Hill,
Clark, Surtees e McLaren. Il tempo è bruttissimo e il freddo è
tale da gelare anche i cuori dei piloti più ardenti. Sul tracciato
di circa 22 km, per altro rovinato da diversi piccoli smottamenti,
la visibilità scende a meno di cento metri, pari cioè alla
distanza che un auto da corsa copre in poco più di un secondo. La
partenza viene così posticipata di un'ora per lasciare che le
parti allagate del circuito si asciughino. Dopo aver compiuto il
giro di ricognizione le auto prendono posto con cautela sulla
griglia di partenza. Il pubblico, composto da più di 350000
spettatori, nonostante le terribili condizioni atmosferiche
partecipa con rispetto al minuto di silenzio in memoria dell'eroe
perduto Wolfgang Von Tripps. Quindi lo starter dà il segnale di
partenza e le auto rombano via. Tutte tranne la Lotus di Clark che
si spegne subito ma che viene miracolosamente evitata dai piloti
partiti alle sue spalle. Alla fine del primo giro la Porsche
argento di Gurney è al comando con grande soddisfazione delle
autorità tedesche presenti in tribuna. Già al secondo giro, però,
Graham Hill riesce ad aprirsi un varco sorpassando Gurney e
passando in testa. La battaglia è ormai circoscritta a questi tre
grandi piloti, che passano sulla linea del traguardo con solo
cinque secondi di distacco fra il primo e il terzo. In un giorno
in cui anche il più piccolo errore avrebbe potuto provocare un
disastro, nessuno dei tre mette una ruota in fallo. Surtees, che
ha superato Gurney, si trova a tre secondi e mezzo da Hill e
comincia a nutrire serie speranze di poter persino vincere.
Preparato a superare di slancio Hill all'ultimo giro, Surtees si
trova improvvisamente davanti l'auto di un doppiato che gli
ostacola il passaggio. Riesce comunque a raggiungere il traguardo
due secondi e mezzo prima del furioso Surtees. Con ancora tre gare
da disputare, il campionato potrebbe arrivare ad una svolta nel
prossimo Gran Premio di Monza.
Le prime posizioni delle griglie di partenza sono occupate dalle
auto di cinque diverse scuderie: Porsche, BRM, Lotus, Lola e
Cooper, facendo presagire una gara indimenticabile. I piloti i cui
nomi sono destinati a diventare leggendari sono Gurney, Hill,
Clark, Surtees e McLaren. Il tempo è bruttissimo e il freddo è
tale da gelare anche i cuori dei piloti più ardenti. Sul tracciato
di circa 22 km, per altro rovinato da diversi piccoli smottamenti,
la visibilità scende a meno di cento metri, pari cioè alla
distanza che un auto da corsa copre in poco più di un secondo. La
partenza viene così posticipata di un'ora per lasciare che le
parti allagate del circuito si asciughino. Dopo aver compiuto il
giro di ricognizione le auto prendono posto con cautela sulla
griglia di partenza. Il pubblico, composto da più di 350000
spettatori, nonostante le terribili condizioni atmosferiche
partecipa con rispetto al minuto di silenzio in memoria dell'eroe
perduto Wolfgang Von Tripps. Quindi lo starter dà il segnale di
partenza e le auto rombano via. Tutte tranne la Lotus di Clark che
si spegne subito ma che viene miracolosamente evitata dai piloti
partiti alle sue spalle. Alla fine del primo giro la Porsche
argento di Gurney è al comando con grande soddisfazione delle
autorità tedesche presenti in tribuna. Già al secondo giro, però,
Graham Hill riesce ad aprirsi un varco sorpassando Gurney e
passando in testa. La battaglia è ormai circoscritta a questi tre
grandi piloti, che passano sulla linea del traguardo con solo
cinque secondi di distacco fra il primo e il terzo. In un giorno
in cui anche il più piccolo errore avrebbe potuto provocare un
disastro, nessuno dei tre mette una ruota in fallo. Surtees, che
ha superato Gurney, si trova a tre secondi e mezzo da Hill e
comincia a nutrire serie speranze di poter persino vincere.
Preparato a superare di slancio Hill all'ultimo giro, Surtees si
trova improvvisamente davanti l'auto di un doppiato che gli
ostacola il passaggio. Riesce comunque a raggiungere il traguardo
due secondi e mezzo prima del furioso Surtees. Con ancora tre gare
da disputare, il campionato potrebbe arrivare ad una svolta nel
prossimo Gran Premio di Monza.

 Dopo
quindici anni di cocenti sconfitte, finalmente il campionato è
nelle mani degli uomini della BRM. Tuttavia, lo scozzese Clark non
è di questo avviso e, dopo la sua convincente vittoria al Gran
Premio degli USA, rimanda l'assegnazione del titolo all'ultima
gara che si disputerà in Sud Africa. Hill, che ha ottenuto il
massimo dei punti dalle gare che è riuscito a terminare, può
contare su un vantaggio di nove punti sull'avversario. Da parte
sua Clark può, vincendo l'ultima competizione, portarsi a casa il
titolo mondiale. Succede però che il guasto di un pezzo di
ricambio da 50 centesimi faccia svanire di colpo le speranze di
Clark, consegnando la corona a Hill. Graham Hill all'età di 33
anni, dopo sei anni di corse e solo nove anni dopo aver conseguito
la patente, diventa il pilota più popolare d'Inghilterra. Aveva
cominciato facendo il meccanico e guadagnando 1 sterlina al
giorno. Oggi ha concretizzato il suo sogno. Diventare Campione del
Mondo di Formula 1.
Dopo
quindici anni di cocenti sconfitte, finalmente il campionato è
nelle mani degli uomini della BRM. Tuttavia, lo scozzese Clark non
è di questo avviso e, dopo la sua convincente vittoria al Gran
Premio degli USA, rimanda l'assegnazione del titolo all'ultima
gara che si disputerà in Sud Africa. Hill, che ha ottenuto il
massimo dei punti dalle gare che è riuscito a terminare, può
contare su un vantaggio di nove punti sull'avversario. Da parte
sua Clark può, vincendo l'ultima competizione, portarsi a casa il
titolo mondiale. Succede però che il guasto di un pezzo di
ricambio da 50 centesimi faccia svanire di colpo le speranze di
Clark, consegnando la corona a Hill. Graham Hill all'età di 33
anni, dopo sei anni di corse e solo nove anni dopo aver conseguito
la patente, diventa il pilota più popolare d'Inghilterra. Aveva
cominciato facendo il meccanico e guadagnando 1 sterlina al
giorno. Oggi ha concretizzato il suo sogno. Diventare Campione del
Mondo di Formula 1.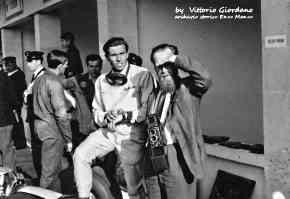














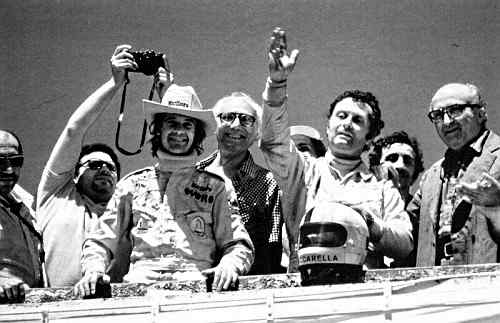
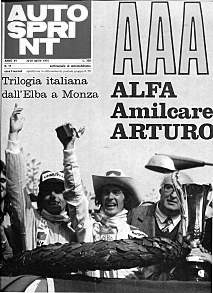
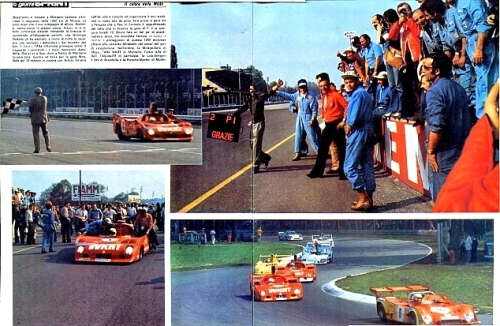
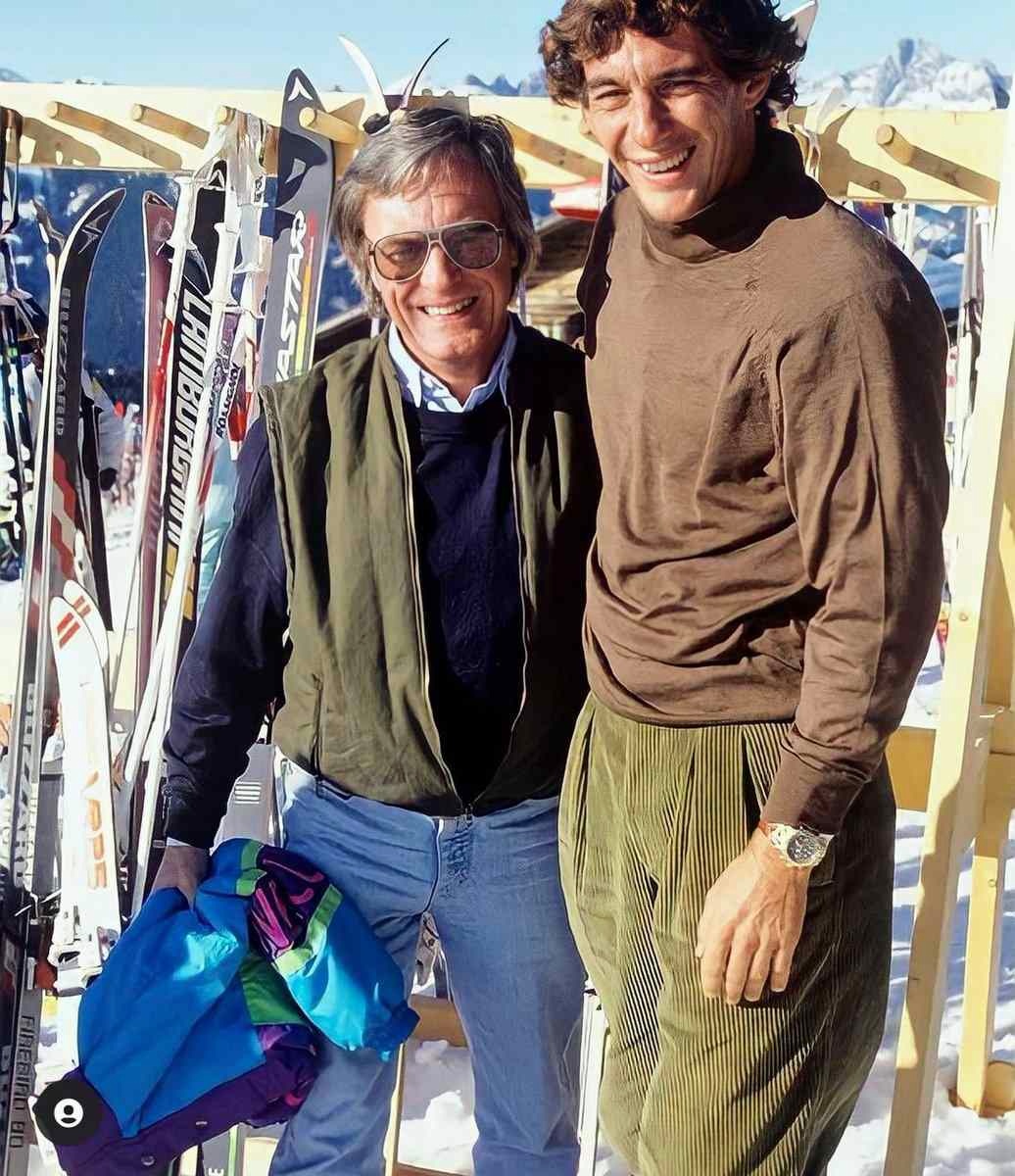

 La Guerra tra FISA e FOCA continua anche nel 1981 e
determina il rinvio del Gran Premio d'Argentina. Bernie Ecclestone minaccia di
organizzare un proprio Campionato del Mondo Piloti Professionisti (World
Professional Championship) ma fortunatamente le parti raggiungono un accordo
durante un incontro al vertice tenutosi a Maranello, avvenimento che in seguito
verrà ricordato come l'accordo Concorde. Nel lontano 1966, quando fu modificata
la formula che prevedeva i motori da 3 litri, fu inserita anche una disposizione
relativa all'impiego di motori da 1,5 litri a turbocompressione. In mancanza di
interessati tra gli attuali fornitori di motori e con l'esplosivo successo del
motore Ford-Cosworth, la possibilità di trovare una terza via fu lasciata nelle
mani di un esterno, un esterno la cui storia aveva intrecciato quella delle
corse fin dal primo Gran Premio. La Renault aveva tentato di vincere a Le Mans
con un motore a turbocompressione ma subì la rottura dei pistoni. Bernard Dudot
fu inviato alla Garrett AiResearch per studiare a fondo la bella arte della
turbocompressione.
La Guerra tra FISA e FOCA continua anche nel 1981 e
determina il rinvio del Gran Premio d'Argentina. Bernie Ecclestone minaccia di
organizzare un proprio Campionato del Mondo Piloti Professionisti (World
Professional Championship) ma fortunatamente le parti raggiungono un accordo
durante un incontro al vertice tenutosi a Maranello, avvenimento che in seguito
verrà ricordato come l'accordo Concorde. Nel lontano 1966, quando fu modificata
la formula che prevedeva i motori da 3 litri, fu inserita anche una disposizione
relativa all'impiego di motori da 1,5 litri a turbocompressione. In mancanza di
interessati tra gli attuali fornitori di motori e con l'esplosivo successo del
motore Ford-Cosworth, la possibilità di trovare una terza via fu lasciata nelle
mani di un esterno, un esterno la cui storia aveva intrecciato quella delle
corse fin dal primo Gran Premio. La Renault aveva tentato di vincere a Le Mans
con un motore a turbocompressione ma subì la rottura dei pistoni. Bernard Dudot
fu inviato alla Garrett AiResearch per studiare a fondo la bella arte della
turbocompressione. 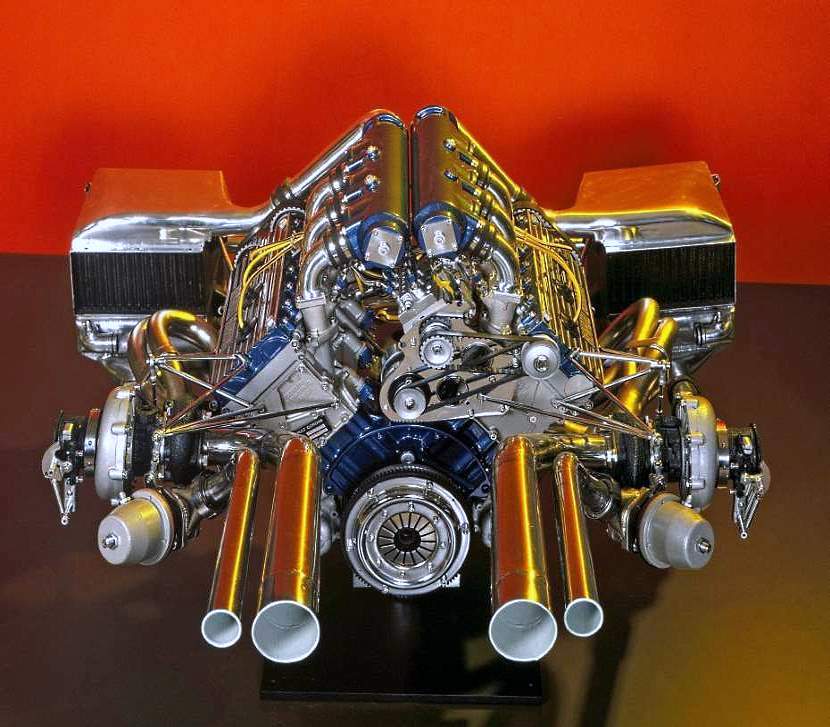
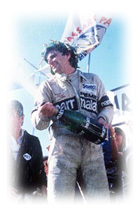 Nel 1981 la Ferrari è ormai un laboratorio su campo per
macchine a turbocompressione, ma neppure un talento del calibro di Gilles
Villeneuve riesce a portare in gara questa macchina ancora poco maneggevole. La
McLaren è ora sotto il controllo di Ron Dennis e con John Watson alla guida di
una McLaren MP4 progettata da John Barnard è la prima auto con telaio in fibra
di carbonio a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Il titolo viene assegnato
nella gara finale svoltasi a Las Vegas e Piquet con un quinto posto guadagna i
punti necessari alla sua incoronazione. Le macchine con motori a
turbocompressione hanno nel frattempo continuato a fare progressi ed alla fine
di quella stagione, avevano vinto sette gare su sedici. Per il 1982 vengono
modificate alcune regole e il divieto di utilizzo di bandelle mobili
obbliga le squadre a ridurre la distanza libera da terra a circa 25mm unitamente
ad una quasi totale mancanza di movimento delle sospensioni. I piloti
sperimentano una rigidezza in curva che in alcuni circuiti raggiunge i 4gs. Niki
Lauda, due volte Campione del Mondo, si fa convincere da un barile di denaro
offertogli dalla Marlboro ad unirsi a John Watson alla McLaren. Alan Jones
sceglie la strada opposta e se ne va dalla Formula 1 lasciando il proprio posto
alla Williams al finlandese Keke Rosberg. Il terzo concorrente al titolo
dell'anno precedente, Carlos Reutemann, si ritira anch'egli, ma solo dopo aver
partecipato alle prime due gare della stagione..
Nel 1981 la Ferrari è ormai un laboratorio su campo per
macchine a turbocompressione, ma neppure un talento del calibro di Gilles
Villeneuve riesce a portare in gara questa macchina ancora poco maneggevole. La
McLaren è ora sotto il controllo di Ron Dennis e con John Watson alla guida di
una McLaren MP4 progettata da John Barnard è la prima auto con telaio in fibra
di carbonio a vincere il Gran Premio di Gran Bretagna. Il titolo viene assegnato
nella gara finale svoltasi a Las Vegas e Piquet con un quinto posto guadagna i
punti necessari alla sua incoronazione. Le macchine con motori a
turbocompressione hanno nel frattempo continuato a fare progressi ed alla fine
di quella stagione, avevano vinto sette gare su sedici. Per il 1982 vengono
modificate alcune regole e il divieto di utilizzo di bandelle mobili
obbliga le squadre a ridurre la distanza libera da terra a circa 25mm unitamente
ad una quasi totale mancanza di movimento delle sospensioni. I piloti
sperimentano una rigidezza in curva che in alcuni circuiti raggiunge i 4gs. Niki
Lauda, due volte Campione del Mondo, si fa convincere da un barile di denaro
offertogli dalla Marlboro ad unirsi a John Watson alla McLaren. Alan Jones
sceglie la strada opposta e se ne va dalla Formula 1 lasciando il proprio posto
alla Williams al finlandese Keke Rosberg. Il terzo concorrente al titolo
dell'anno precedente, Carlos Reutemann, si ritira anch'egli, ma solo dopo aver
partecipato alle prime due gare della stagione..


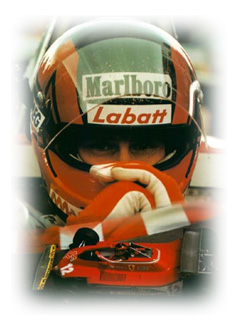 ma una contesa tra i compagni di squadra della
Ferrari Didier Pironi e Gilles Villeneuve porta alla tragedia di Zolder. Villeneuve,
intenzionato a tutti i costi a qualificarsi davanti al suo rivale, va a sbattere
contro un più lento Jochen Mass. Villeneuve non avrebbe forse mai vinto un
campionato, il suo ideale era vincere a tutti i costi, non negoziare le
posizioni di arrivo per fare punti. Alla morte del giovane pilota canadese,
questo sport ha perso un diretto discendente di Bernd Rosemeyer e Tazio
Nuvolari. Le parole usate da Cyril Posthumas per ritrarre il pilota tedeco
dell'ante-guerra: "
ma una contesa tra i compagni di squadra della
Ferrari Didier Pironi e Gilles Villeneuve porta alla tragedia di Zolder. Villeneuve,
intenzionato a tutti i costi a qualificarsi davanti al suo rivale, va a sbattere
contro un più lento Jochen Mass. Villeneuve non avrebbe forse mai vinto un
campionato, il suo ideale era vincere a tutti i costi, non negoziare le
posizioni di arrivo per fare punti. Alla morte del giovane pilota canadese,
questo sport ha perso un diretto discendente di Bernd Rosemeyer e Tazio
Nuvolari. Le parole usate da Cyril Posthumas per ritrarre il pilota tedeco
dell'ante-guerra: " Al Gran Premio di
Germania la corsa per il titolo dovrebbe essere tra Pironi e Watson ma il pilota
della Ferrari subisce un incidente durante le prove per il quale riporterà
ferite tali da fargli terminare la carriera. Il Gran Premio di Svizzera, che si
corre a Digione, Francia, viene vinto da Rosberg ora in testa alla classifica.
La stagione si conclude con il Gran Premio dell'Ovest negli Stati Uniti, a Las
Vegas e nonostante sia Michele Alboreto su Tyrrell a vincere la gara, il titolo
resta in mano a Keke Rosberg. La battaglia tra auto con motori a
turbocompressione e auto a motore tradizionale è ormai finita, anche se a
parimerito, con 8 vittorie a testa.
Al Gran Premio di
Germania la corsa per il titolo dovrebbe essere tra Pironi e Watson ma il pilota
della Ferrari subisce un incidente durante le prove per il quale riporterà
ferite tali da fargli terminare la carriera. Il Gran Premio di Svizzera, che si
corre a Digione, Francia, viene vinto da Rosberg ora in testa alla classifica.
La stagione si conclude con il Gran Premio dell'Ovest negli Stati Uniti, a Las
Vegas e nonostante sia Michele Alboreto su Tyrrell a vincere la gara, il titolo
resta in mano a Keke Rosberg. La battaglia tra auto con motori a
turbocompressione e auto a motore tradizionale è ormai finita, anche se a
parimerito, con 8 vittorie a testa.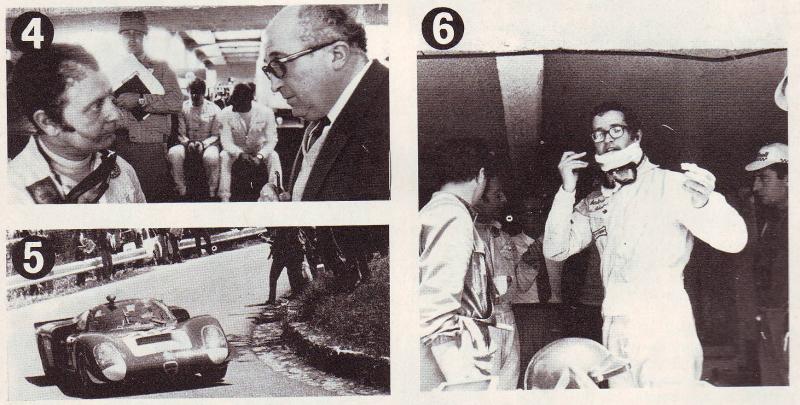
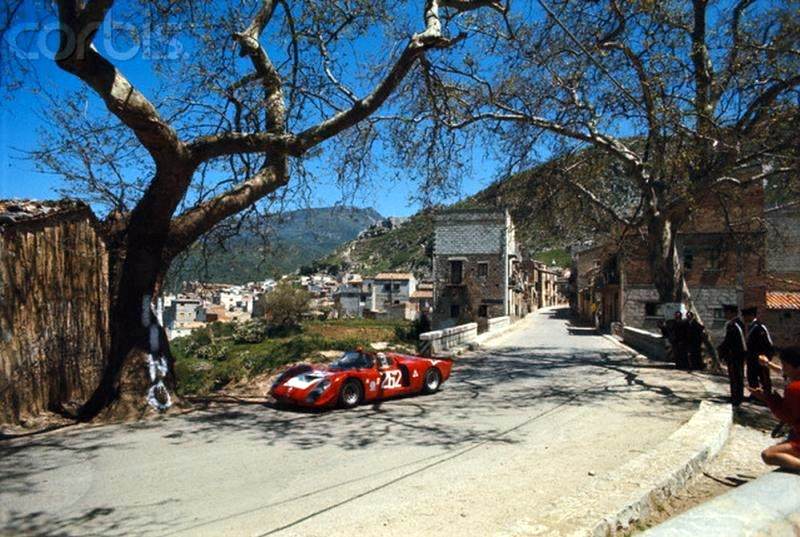








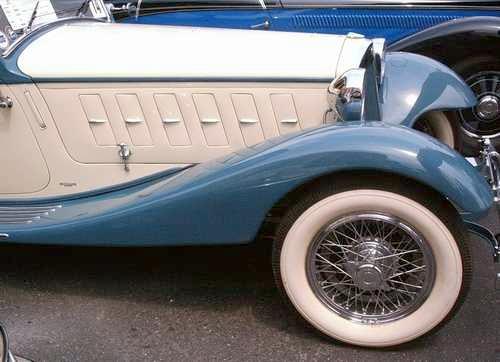




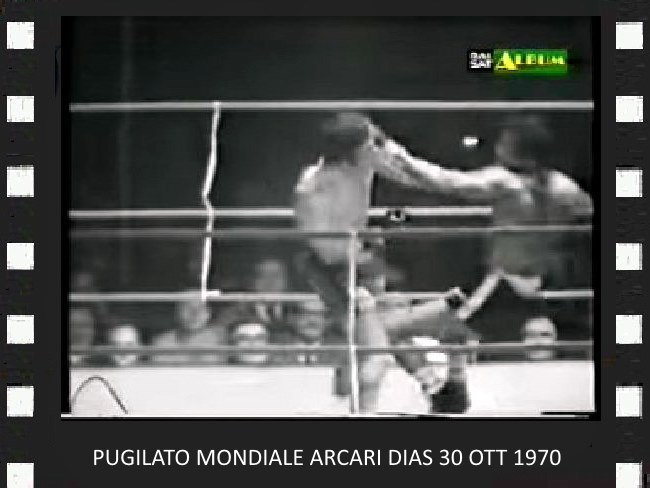
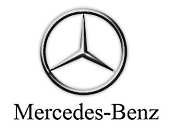
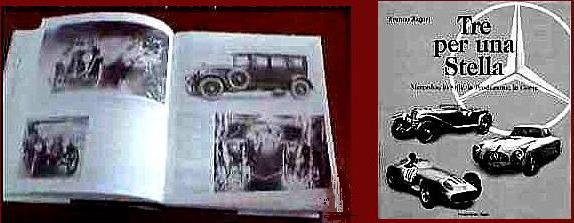
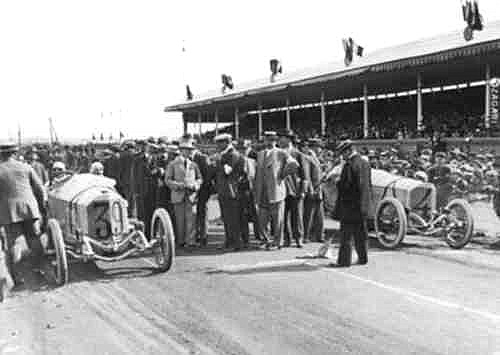

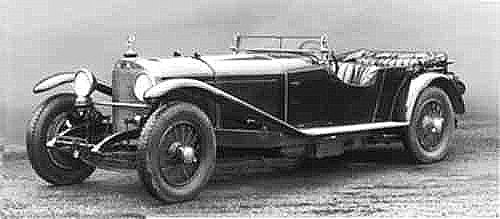
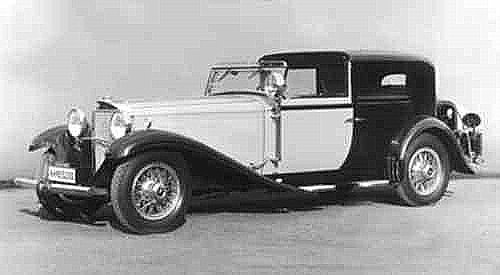


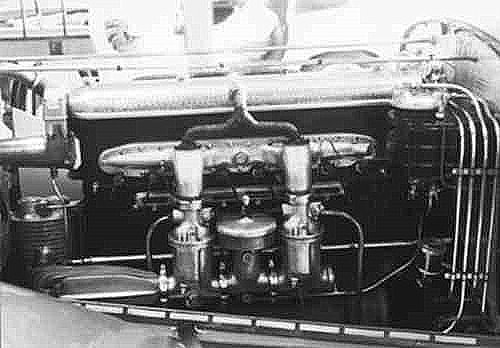

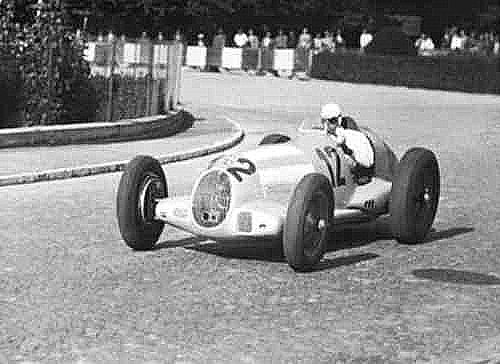

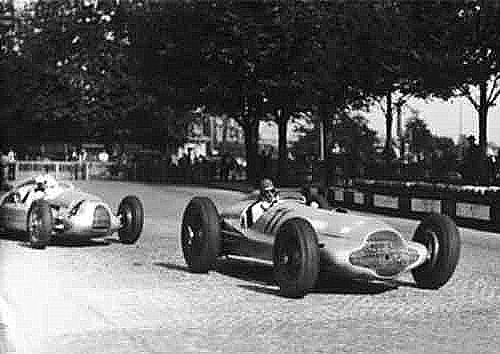
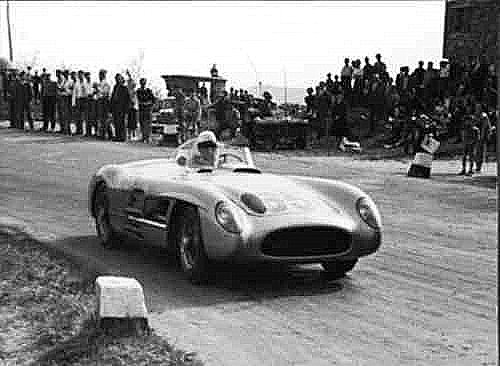
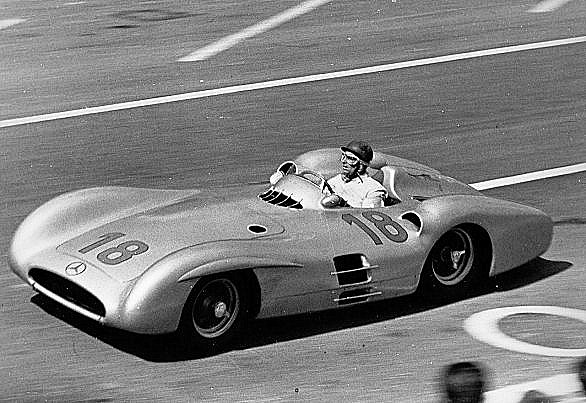




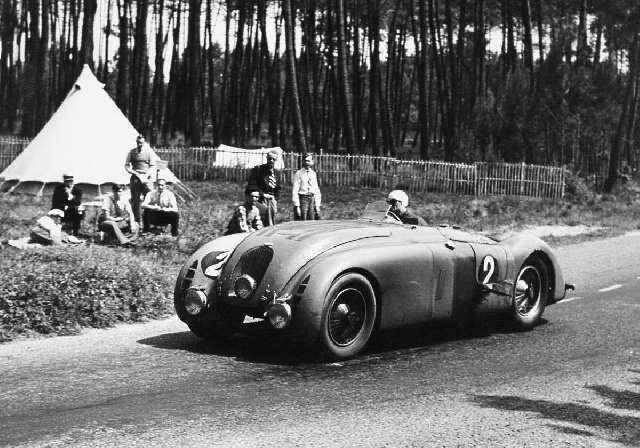
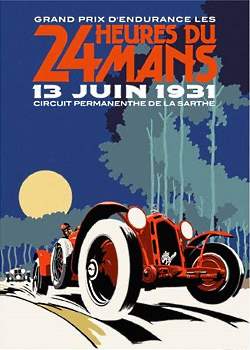

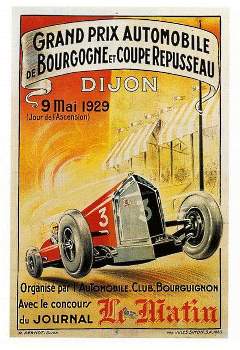


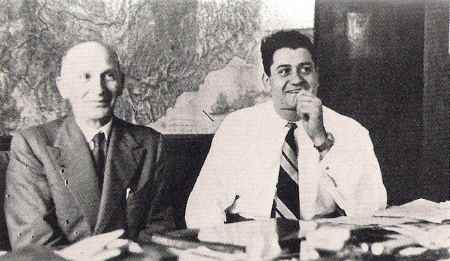







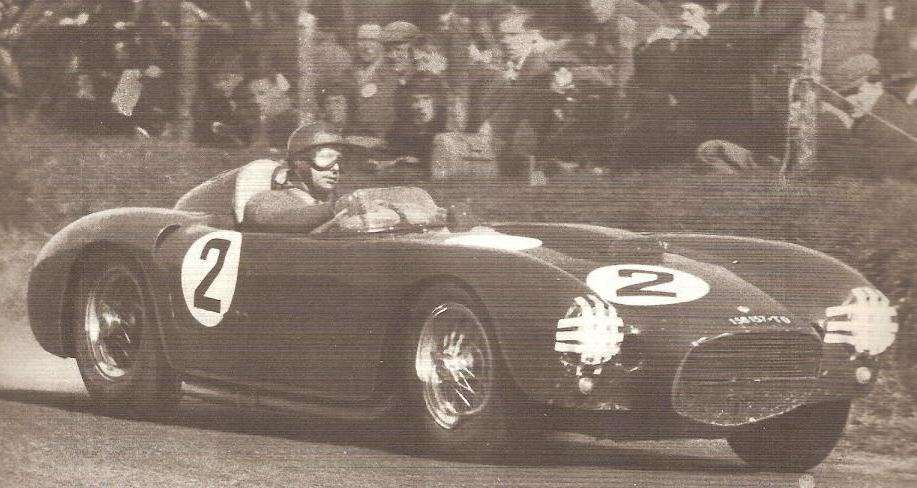

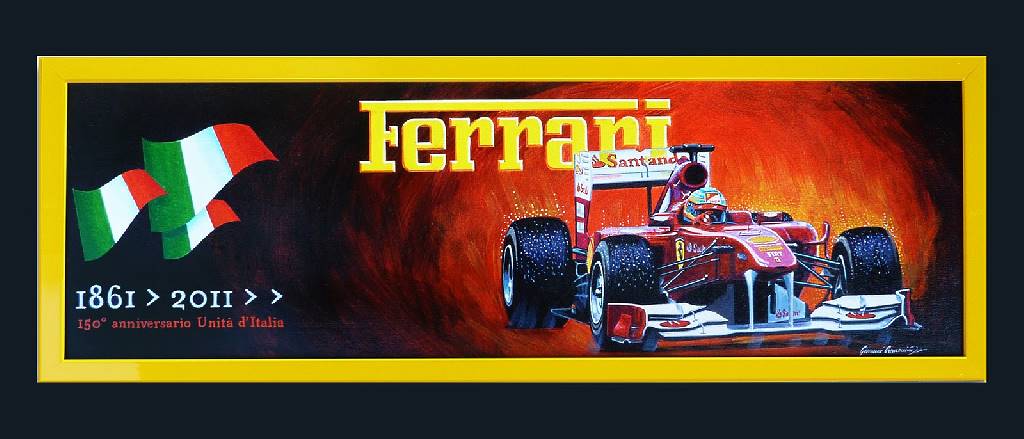





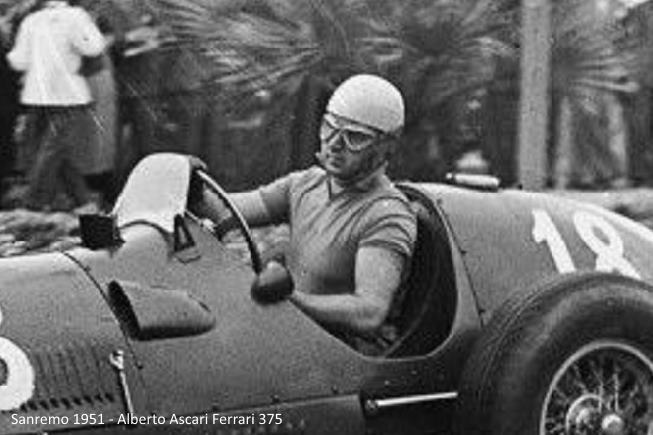

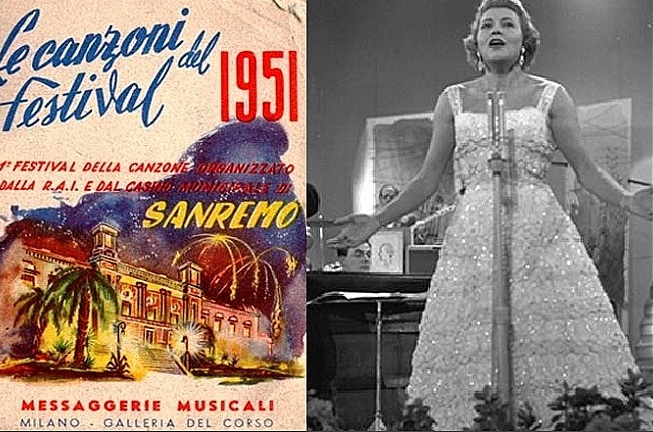



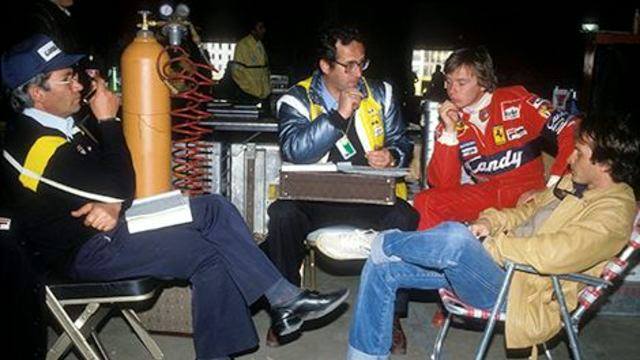


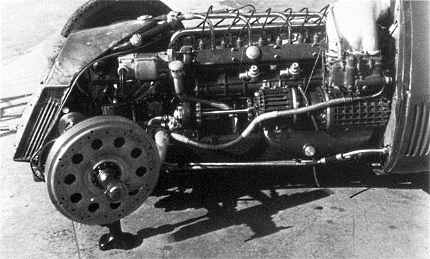


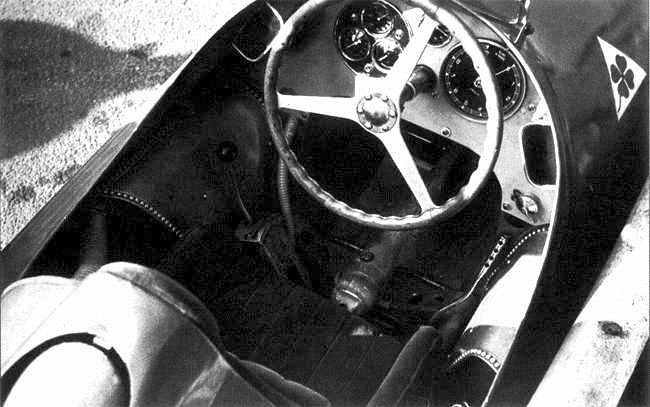



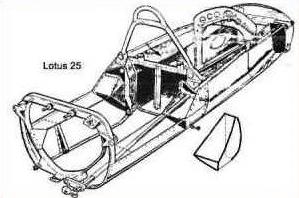





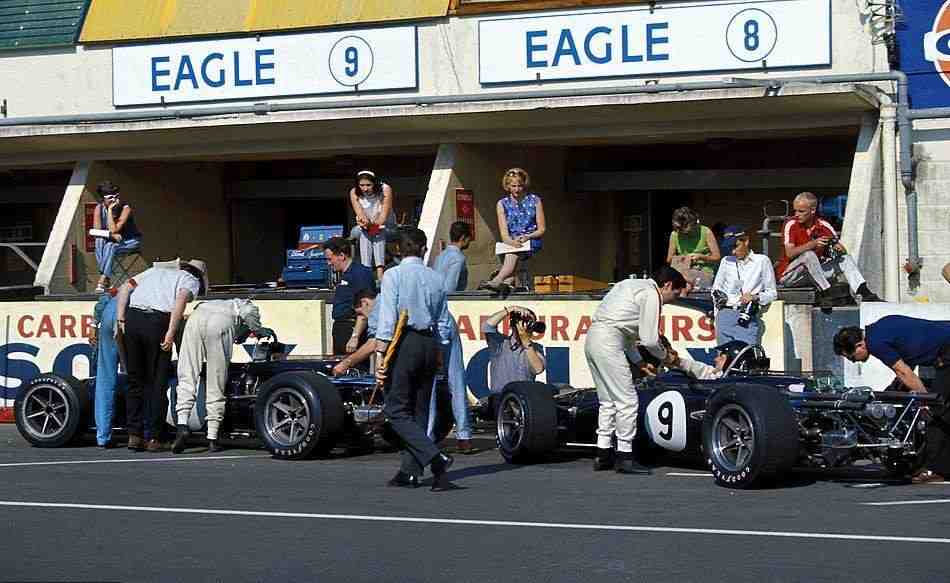

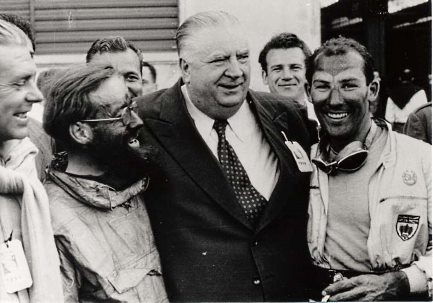


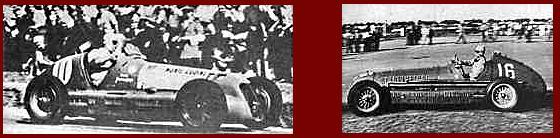

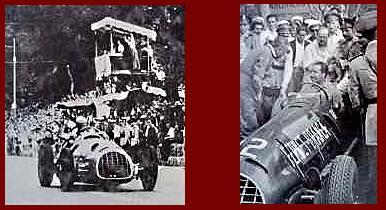
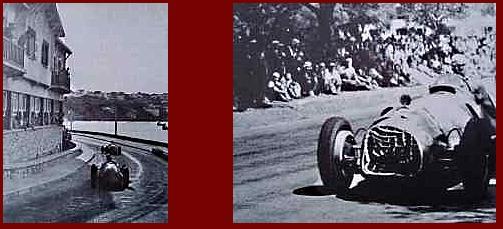


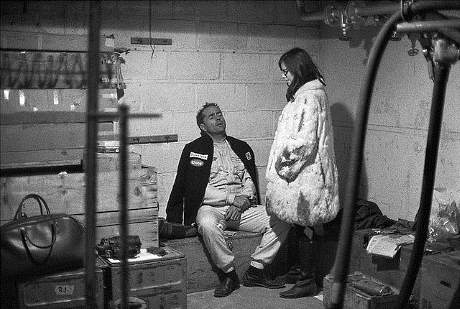





 La
Honda lascia la Formula 1: nell'anno della crisi finanziaria e industriale,
la casa giapponese si è data tempo un mese per trovare un acquirente per il
suo team. L'alternativa è chiudere il paddock e lasciare senza monoposto
Jenson Button e Rubens Barrichello, peraltro ancora non confermati al
volante della Honda. Domani mattina, potrebbe giungere l'annuncio ufficiale
della messa in vendita del team di Brackley.
La
Honda lascia la Formula 1: nell'anno della crisi finanziaria e industriale,
la casa giapponese si è data tempo un mese per trovare un acquirente per il
suo team. L'alternativa è chiudere il paddock e lasciare senza monoposto
Jenson Button e Rubens Barrichello, peraltro ancora non confermati al
volante della Honda. Domani mattina, potrebbe giungere l'annuncio ufficiale
della messa in vendita del team di Brackley.