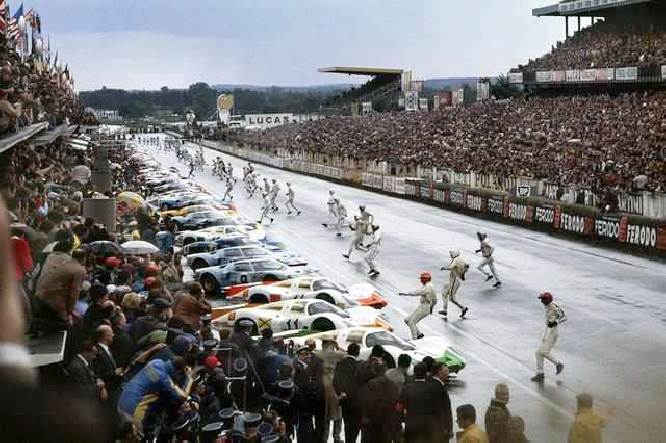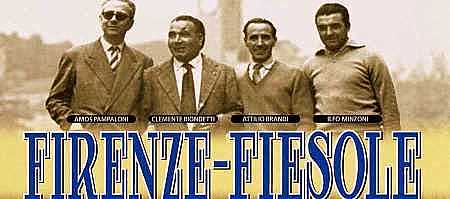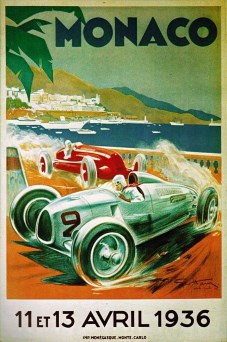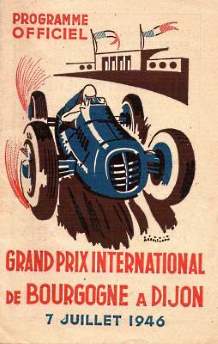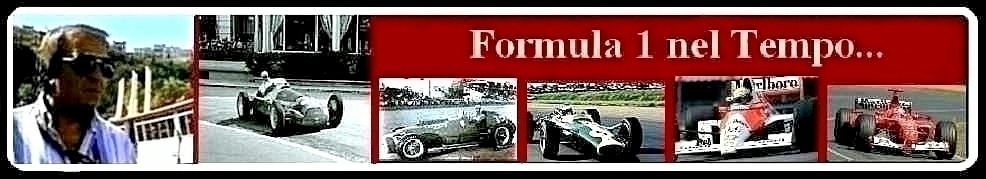
La grandezza di un pilota è misurata anche dal livello dei suoi avversari.
Alcuni piloti nel corso della loro lunga carriera hanno gareggiato contro alcuni tra i
piu' grandi campioni
di tutti i tempi e, assieme a loro, hanno scritto le pagine
più belle e incredibili della storia delle competizioni.
E' importante
sottolineare che molti piloti si sono confrontati con generazioni di piloti diverse
e su mezzi diversi: nei lunghi anni di attività hanno "battagliato"
con campioni al termine o agli inizi
della carriera, e con altri che hanno
vissuto con loro l'intero periodo agonistico.
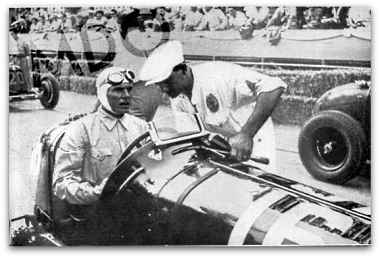
GP
San Remo 1937: Achille Varzi alla partenza
su
Maserati 4CM
|
|
|
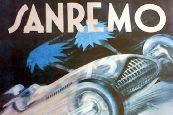

|
|

1937: Il primo Circuito di San Remo vede vincitore Achille Varzi su Maserati
|
STORIE DALLA
STORIA
26 maggio il giorno nero degli Ascari
Padre e figlio, due grandi campioni, stessa età, morti nello stesso giorno a trenta anni di differenza

Antonio Ascari aveva solo 36 anni quando perde la vita sul tracciato
di Montlery, mentre era al comando della gara, il Gran Premio di
Francia,
il più importante della stagione. La prima affermazione arrivò
nel GP d’Italia del 1924, vinse anche nel 1925 a Spa
ed era considerato
uno dei più forti piloti della sua epoca.
Alberto Ascari nasce nel 1918, in luglio, il 26 maggio del 1955 ha 36
anni, come suo padre Antonio, è cinque volte campione d’Italia,
due del
Mondo e ha già corso al volante di Alfa Romeo, Maserati, Ferrari e
Lancia. Ha vinto anche numerosi trofei,
tra cui la Coppa Trofeo Nuvolari
della Mille Miglia del 1954, la Coppa vinta al Nurburgring il 29 luglio
1951 su Ferrari 375 F1
e la Coppa conquistata a Silverstone il 20
agosto 1949 su Ferrari 125 F1.
La rivalità tra Tazio Nuvolari e Achille Varzi
Nuvolari e Varzi. Centinaia di episodi sono
stati scritti e narrati per raccontare le gesta
di questi due amici-rivali dell'automobilismo ante guerra .
Migliaia di persone si sono letteralmente
spellate le mani per applaudirli al loro passaggio in corsa.
La rivalità tra i due ha il suo apice nel 1933, a Monaco. Per tutto il Gran Premio Nuvolari, su Alfa Romeo, e Varzi,
su Bugatti, si alternano alla testa della corsa. I due percorrono
addirittura fianco a fianco l’intero penultimo giro finché,
nell’ultima tornata, Achille riesce finalmente a prevalere.
|
|
| Il 29 giugno 1936 la «Gazzetta» organizza il circuito di
Milano. Cinquantamila persone, giunte da ogni parte con i «treni
popolari», affollano il parco milanese, dove è stata tracciata una
spettacolare pista. Nuvolari è al volante della fedele Alfa Romeo, Varzi
guida una tedesca Auto Union. Alla partenza (foto) Varzi balza al
comando della corsa, ma alla fine vincono il coraggio e l'irruenza
tradizionali del mantovano. Nuvolari ha già 43 anni e i polmoni minati
dai gas di scarico che è costretto a respirare. E un crudele destino
attende «Nivola»: i suoi figli Alberto e Giorgio moriranno di malattia a
soli 18 anni di età. |
La convivenza dei piloti nei team
La storia insegna che Jean Todt decise una Dakar
con una monetina. è il sogno di tutti i direttori sportivi
quello di avere il controllo totale del team decidendone bello e
cattivo tempo. Tuttavia, se in squadra vi sono due grandi campioni,
allora non esistono più gli ordini di squadra, e se ci sono,
o i driver, generalmente per calcolo, scelgono di obbedire, oppure
potranno ignorarli, in virtù del proprio talento.
Lo dimostra la storia. Per primo, pensiamo al periodo in cui nell'Alfa convivevano Nuvolari e
Caracciola. La casa italiana, desiderosa di premiare Caracciola per la
sua disciplina e per mostrare al mondo che l'Alfa poteva vincere
indipendentemente da Nuvolari, decise che doveva essere il fuoriclasse
tedesco ad aggiudicarsi il gp di Monza del '32. Ma il mantovano volante
se ne infischiò dell'ordine di squadra.
Di recente abbiamo avuto la vicenda Alonso-Hamilton con due Paesi,
Spagna e Inghilterra, pronti a schierarsi dalla parte dei rispettivi
campioni. In pochi sanno che quella storia ebbe tra le varie
antesignane di lusso, la grande rivalità tra Moll e Varzi,
guardacaso due piloti opposti tra loro, come lo erano lo spagnolo e
l'inglese che hanno coabitato in McLaren nel 2007. L'uno, Guy Moll veloce e spregiudicato. La cui assenza di limite
derivava dall'immensa bravura. L'altro, Varzi, uno stilista dalla guida
pulita.
Moll contro Varzi, ossia Francia (Moll era algerino, all'epoca colonia
francese) contro Italia. Luogo della contesa: la squadra Alfa con
direttore sportivo un certo E. Ferrari. Anno, 1934. è noto che la polemica esplose feroce a seguito del Gp di
Tripoli di quell'anno, quando Moll accusò Varzi di
scorrettezza: da lì una polemica che ebbe protagonisti i
giornali specializzati di Francia e Italia. Ferrari ebbe la
possibilità di intervenire sulla polemica punendo Moll ed
estromettendolo da diverse corse. Ma la situazione era più
subita che gestita e la cosa non fu poi un male, se pensiamo ai duelli
entusiasmanti che ne vennero fuori.
Un'altra storia che val la pena di ricordare è quella di
Fangio e della Ferrari. Il Maestro arrivò a Maranello (nel
'56) pretendendo, e ottenendo, lo status assoluto di prima guida.
Ciò gli fu concesso da Ferrari controvoglia e unicamente
perchè il campione argentino gli serviva per tornare a
vincere. Il resto del team fu quindi messo al servizio di Fangio. Ma
Collins, che a Monza lasciò l'auto all'argentino non fu
forzato da nessuno a far quel che fece. Lo decise Lui. Gli inglesi
dicono lo fece per cavalleria. Vero, ma verso chi? Verso Fangio? Forse,
ma era più che altro deferenza. Probabilmente, il vero gesto
di rispetto fu verso Ferrari. Eh sì, perchè se
Fangio non fosse uscito vincente da quel mondiale si sarebbe scritto
che la Ferrari non era stata all'altezza del grande campione. Ci fu
anche un calcolo di Collins? Sapeva che Ferrari, dopo quel gesto
sarebbe stato legato da una sorta di "debito" nei suoi confronti?
Forse, ma non lo credo. Fu vera cavalleria, ma più che verso
Fangio, verso Ferrari. Ma fu anche deferenza, probabilmente verso
entrambi i citati. Tutto questo per dire che più che
l'ordine possono la personalità e il carisma. E se dietro al
volante della Ferrari non ci fosse stato un professionista britannico
col senso dell'onore, ma un pilota con personalità di fuoco,
questi non si sarebbe fermato cedendo l'auto al rivale. E altrettanto,
se dall'altra parte non ci fossero stati la personalità e il
carisma di Ferrari e Fangio .. penso che Collins non avrebbe ceduto il
mezzo, forse nemmeno sotto minaccia.
La legittima aspirazione di due grandi piloti,in coabitazione in un
team, di vincere è stata limitata solo dal senso dell'onore,
dal rispetto o dalla deferenza dell'uno verso l'altro, quasi mai da un
ordine. Fu il caso di Stewart e Cevert o di Villeneuve e Scheckter. La
prima la storia di un maestro e di un allievo. Una storia che sembra
raccontare di un senso di inferiorità del secondo verso il
primo, ma che invece nasconde solo un grande rispetto e una grande
intelligenza, ma anche un'ambizione: battere con merito il grande
campione ma senza scordare che il momento per competere non
può sovrapporsi al momento per imparare.
Racconta Jo Ramirez, che fu meccanico alla Tyrrell negli anni d'oro, di
un'occasione in cui Stewart aveva sbagliato all'ultima curva ma Cevert,
che lo tallonava, non era passato al comando. Fu allora che il pilota
scozzese scese dall'auto infuriato con Cevert: "perchè non
mi hai passato?! Era la tua grande occasione ..."
Il maestro pensava che l'allievo non avesse voluto superarlo per
deferenza e, giustamente, non sentiva di aver vinto ma di aver ricevuto
un regalo. Ma si sbagliava perchè Cevert gli rispose "voglio
batterti perchè sono più forte, non per un tuo
errore..."
La seconda storia, cui facevamo riferimento prima, è quella
di un'amicizia. Villeneuve in quel genere di cose, l'amicizia, la
parola, credeva molto, tanto che anni dopo il tradimento di Pironi lo
avrebbe distrutto. Hanno accusato Ferrari di non aver preso con
sufficiente forza posizione in favore di Gilles. Ma Ferrari sapeva bene
cos'è l'automobilismo e sapeva che in quel genere di cose
non può entrare un direttore sportivo. L'inerzia di una
squadra, se i piloti sono veloci e hanno classe, la fanno i piloti
stessi. Del proprio onore rispondono solo loro.
Gli anni '80 sono stati il periodo delle rivalità interne
più spettacolari: Mansell VS Piquet e Senna VS Prost. La
prima fu una rivalità lacerante perchè vide una
contrapposizione in seno al team. La seconda, invece, era semplicemente
il corollario della superiorità schiacciante dei
protagonisti rispetto agli altri.
|
|
La
rivalità Prost - Senna

Ron Denniis - Alain Prost - Ayrton Senna

Prost - Senna 1993
|
Senna arriva in McLaren nel 1988 dalla
Lotus e con lui arrivano anche i motori Honda. Ron Dennis ha voluto il
brasiliano ritenendolo il miglior talento in circolazione e lo affanca al
francese Prost, pilota storico della McLaren.
Prost riteneva che Senna
avesse un vantaggio dall'aver lavorato lungamente con la Honda negli anni
precedenti. Senna si rendeva conto che Prost non era una persona qualsiasi in
McLaren
e non solo per i tanti successi.
A proposito di Prost, è molto
interessante l'articolo che la rivista inglese Motorsport che dedica al pilota
francese incentrando l'articolo sulle opinioni di Cheever, allora compagno di
Prost alla Renault. Cheever ci spiega che Prost era un pilota maniaco del
dettaglio, aveva un talento 9 su 10 e soprattutto era un gran "politico", nel
senso che Alain sapeva sfruttare molto bene la propria posizione nel team,
sapeva imporsi.
Ai tempi in cui Lui e Prost correvano alla Renault non
esisteva la telemetria e quindi non poteva cercare di studiare Prost, come
invece fece Hill nel '93, quando da debuttante ebbe un grande vantaggio da poter
studiare la telemetria del Campione francese. Così, ciò che riusciva a fare
Prost con la Renault rimaneva un mistero per Cheever che infatti dice
letteralmente "He Prost was a magician".
Se Ayrton non era nella condizione
di Hill, di dover imparare a guidare una F1, comunque il brasiliano ebbe modo di
avvantaggiarsi della capacità di Prost di sistemare l'auto. Ovviamente lo
strumento era lo studio della telemetria. La situazione tra Prost e Senna era
potenzialmente esplosiva perchè tutti e due erano dei corridori affamati,
entrambi sapevano come essere leader del team. Prost aveva dalla sua molti anni
in McLaren ma ben presto capì che Ron Dennis stava dalla parte di Senna. |
Dopo
l'incidente a Monaco, quando Senna sbattè al Portier, Dennis al galà del team si
preoccupò unicamente di rincuorare Senna, forse colpito dalla reazione del
brasiliano dopo l'incidente. Senna, infatti, dopo aver sbattuto con l'auto,
perdendo un gp che stava dominando, si ritirò nel suo appartamento e cinque ore
dopo, quando finalmente Ramirez riuscì a parlare con Senna, Ayrton era ancora
disperato per quanto accaduto. Senna dirà di quell'incidente che lo ha reso più
forte, gli ha insegnato a mantenere più alta la concentrazione. Prost,
comunque, aveva nel team un punto di riferimento importante, Jo Ramirez. Jo era
molto amico di entrambi i piloti e Alain si fidava di lui, considerandolo leale
verso entrambi.
In generale, la lealtà è un tratto del carattere di Jo
Ramirez, una persona fantastica proprio perchè non volta mai le spalle ai suoi
amici senza però essere mai falso ma mettendo sempre la verità prima di tutto.
Quando la McLaren si presentò al via della stagione 1988 fu chiaro che
avrebbe dominato. Oltre ai due migliori piloti, schierava la miglior auto, con
il miglior motore. Già da tempo a Ron Dennis si era unito Mansour Ojjeh che
aveva apportato capitali e reso possibile il lancio della McLaren verso un'era
di successi. Inoltre, il team vantava anche un'organizzazione efficiente, grazie
a Jo Ramirez, già direttore sportivo della Fittipaldi, della Shadow e di altri
team.
Ciò che non era chiaro era con chi la McLaren avrebbe vinto. Ron
Dennis disse che non ci sarebbero stati ordini di scuderia ma che ci sarebbe
stata piena fiducia nei piloti. Un pò lo stesso che dicevano alla Williams ai
tempi di Piquet e Mansell. "Non si possono mettere due tori in un cortile", è
una famosa frase di Sir Frank Williams. La stagione 1988 termina con Senna
campione del mondo ... nonostante calcolando tutti i punti Senna avesse meno
punti di Prost, ma all'epoca esistevano gli scarti. Va detto, comunque, che
Senna aveva vinto più gare di Prost in quella stagione.
L'anno dopo, l'89,
vide un ulteriore deteriorarsi dei rapporti tra Prost e Senna e tra Prost e Ron
Dennis. Un giorno, Prost spiega a Ramirez che lascerà la McLaren per via non
della rivalità con Senna ma del clima creatosi. L'addio di Prost si consuma tra
polemiche interne al team, con il famoso contatto a Suzuka, la ripartenza di
Senna e la successiva assurda squalifica per taglio di chicane, con il titolo a
Prost.
|
|
|
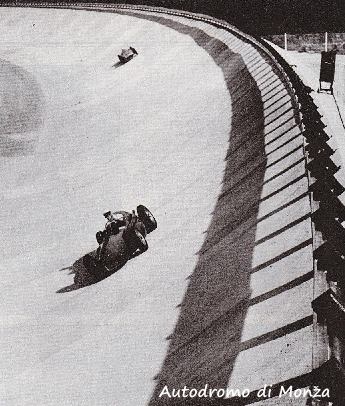 |
| Juan Manuel Fangio
(Balcarce, 24 giugno 1911 – Buenos Aires, 17 luglio 1995)
è stato un pilota automobilistico argentino, campione del mondo
di Formula 1 nel 1951, 1954, 1955, 1956 e 1957. Nella massima serie
automobilistica disputò un totale di 52 Gran Premi, vincendone
24 e salendo per 35 volte sul podio. Ottenne inoltre 29 pole-position e
un totale di 48 partenze dalla prima fila. Il suo record di 5 titoli
mondiali resistette per 48 anni e fu eguagliato e superato solamente
nel 2002 e 2003, da Michael Schumacher. |
Detiene a tutt'oggi la più alta percentuale di pole position realizzate in carriera, il pilota italo-argentino
è infatti partito in prima posizione nel 55,8% dei Gran Premi
disputati; a 46 anni e 41 giorni è inoltre il corridore più anziano ad
avere conquistato un titolo mondiale. |
Ayrton Senna e Gerhard Berger compagni di squadra
|
 |
|
Gerhard Berger nel 1989 lasciò la Ferrari passando alla McLaren, scambiando il suo sedile con Prost
ed affiancando Senna. Col campione brasiliano nacque una grande
amicizia, anche al di là delle corse, una sintonia che ricordò molto
quella di Jody Scheckter e Gilles Villeneuve.
Con la McLaren
trascorse tre anni, dal 1990 al 1992, ottenendo 3 vittorie, tra cui una
al Gp del Giappone 1991, quando Senna gli regalò la vittoria
all'ultima curva come premio per avergli coperto le spalle in tutto il
1991.
|
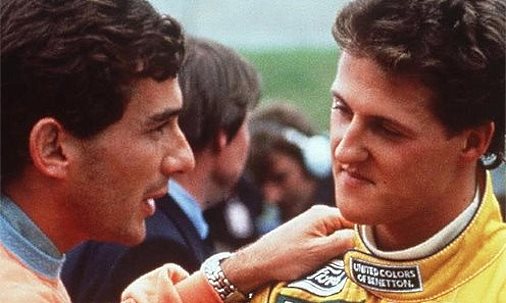 |
|
 |
| Francia 1992 |
|
Cina 2016 |
Sebastian Vettel come Ayrton Senna?
|
I duellanti: le grandi rivalità della Formula 1
“Oggi è il giorno più felice della mia vita”
Questa è la sintesi delle dichiarazioni di Alan Jones, dopo aver visto il suo compagno di scuderia Carlos Reutemann, perdere il Mondiale piloti nel 1981 contro Nelson Piquet per un solo punto.
Oggi i piloti sono molto più formali e difficilmente sentiremo
Hamilton o Rosberg, a fine anno, pronunciare una simile frase.
Sicuramente lo stato d’animo di uno dei due sarà però molto simile a
quello espresso all’epoca dal pilota britannico.
Che il compagno di squadra sia il primo avversario è una verità
accettata nel mondo della Formula 1 e quest’anno possiamo assistere a
una vaga rappresentazione di celebri duelli che in passato hanno
caratterizzato interi campionati mondiali.
La concorrenza interna è sovente un’ulteriore benzina per un pilota,
teso a superare il limite per dimostrare prima di tutto alla sua
scuderia di essere degno di indossare i galloni da capitano. A volte ,
però, come il caso Reutemann-Jones dimostra pienamente, si è
trasformata in una clamorosa faida interna che ha finito per nuocere in
primo luogo proprio alla casa costruttrice.
Negli occhi di tutti gli appassionati sono ancora vivide le immagini del
finale di campionato a Suzuka nel 1989, quando avvenne un controverso contatto fra Ayrton Senna e Alain Prost, grazie al quale il francese si laureò campione del Mondo.
La McLaren vinse il Mondiale, ma perse Prost che, complice
l’impossibile convivenza con il brasiliano, decise di migrare in
Ferrari. L’anno dopo, sempre a Suzuka, fu Senna a “vendicarsi” di Prost,
con una manovra
ai limiti del regolamento che eliminò il ferrarista dalla gara e dalla
lotta al titolo. Nel 1991, dopo il terzo titolo mondiale, il campione di
Sao Paulo ammise di averlo fatto deliberatamente. La contesa proseguì
oltre i cordoli e le tribune: come rivelato da Cesare Fiorio, anni dopo,
la Ferrari ottenne l’assenso di Ayrton Senna per un clamoroso passaggio
alla scuderia di Maranello, vanificato però dal veto assoluto posto
proprio da Alain Prost.
Il finale di una contesa tanto epica non poteva che essere struggente
e poetico. Dopo la pace ad Adelaide nel 1993, giorno del ritiro di
Prost, durante un giro di prova nel Gran Premio di Imola del 1994,
Senna, in collegamento con una TV francese, a sorpresa si rivolse al suo
rivale, presente come telecronista con un toccante “We all miss you, Alain” (ci manchi, Alain). Pochi giorni dopo, fra i piloti che condussero la bara del brasiliano fuori dalla Chiesa, figurava anche Alain Prost.
Il campione francese in carriera non ebbe mai idilliaci rapporti con i
compagni di squadra. A inizio anni ’80 diede vita in Renault a una
contesa tutta transalpina con René Arnoux; culminata
nel Gran Premio di Francia del 1982 in cui Arnoux arrivò primo al
traguardo e ignorò, secondo quanto sostenuto da Prost arrivato secondo,
gli ordini di scuderia.
In Ferrari invece si trovò a battagliare con Nigel Mansell
che, nel già ricordato Mondiale del 1990, non si prestò al ruolo di
gregario per aiutarlo a ottenere l’alloro Mondiale come molti tifosi
avrebbero voluto. La gara in Portogallo, con la manovra dell’inglese che
in partenza lo strinse contro il muretto, gli fece perdere punti
preziosissimi per il cammino mondiale.
Queste lotte trasversali palesano spesso il loro lato paradossale. Nel 1986,
infatti, fu anche grazie ai contrasti fra un giovane Mansell e un
esperto Piquet in seno alla Williams se Prost, come il “terzo incomodo”
del proverbio, potè godere i frutti dei loro litigi vincendo il secondo
Mondiale di fila.
Uno sport come la Formula 1, in cui l’individualismo del pilota è
costretto a convivere e a collidere con quello del compagno di squadra, è
destinato a fornire sempre esempi di contese e rivalità dentro e fuori
dalle piste.
Il compendio di ciò che esse dovrebbero essere si trova nella risposta che David Purley, dopo aver tentato invano di salvare dalle fiamme il suo compagno di squadra Roger Williamson davanti ai commissari impietriti dal terrore, diede a una domanda relativa al suo “amico” Williamson:
“Non era mio amico: la veritá era che Roger lo conoscevo appena, altro
che amico. Ma in quel momento, tentare di salvarlo era il mio dovere”
|
10 agosto 1986, GP Ungheria, è uno di quei giorni storici per la F1.
 |
 |

|
Il sorpasso capolavoro di Piquet su Senna
|
|
I
protagonisti sono un certo Ayrton Senna e Nelson Piquet: e proprio
quest'ultimo fa forse
il sorpasso più bello di sempre della Formula1!
Negli anni '70 nasce la stella di Lauda
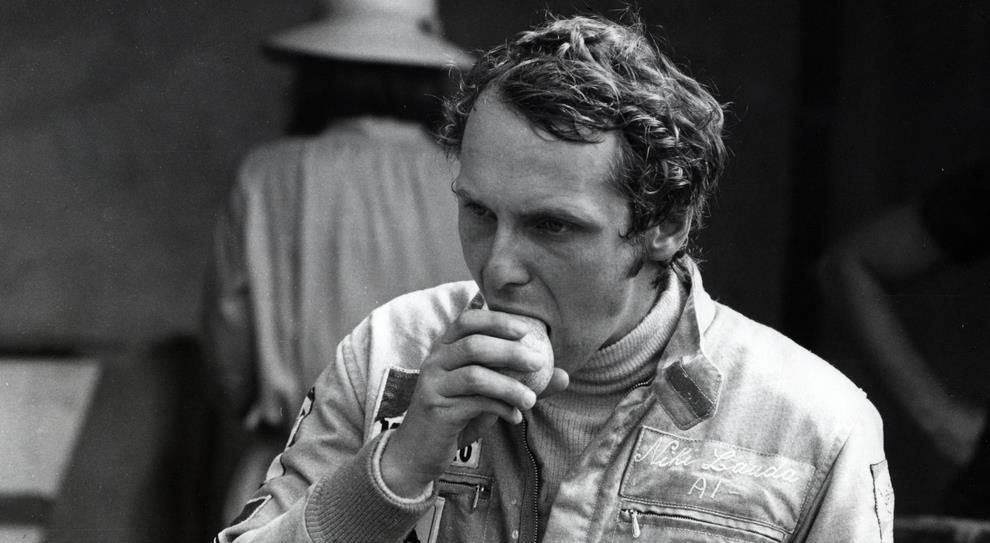
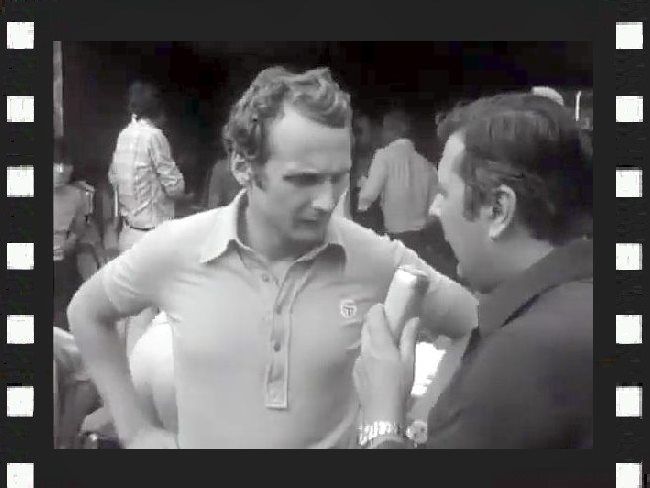
STORIA DI UN MITO

|
|
Nurburgring
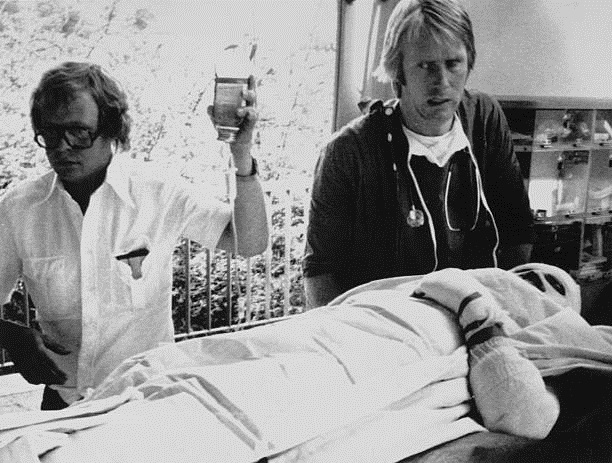 |
|
|
Il circuito
attuale non è lo stesso sul quale si
gareggiava negli anni cord-occidentale, a poche decine di chilometri da Spa sede
storica del Gran Premio del Belgio, era lungo in origine 22,810 km.
Costellato da una quantità incredibile di curve e controcurve (ben
174 ad ogni giro!), salite ripidissime alternate a discese mozzafiato,
tornantini da prima in porfido (come l'imitatissimo Karussell), il lunghissimo
rettilineo d'arrivo di quasi 4 km. a fianco del vecchio castello del Nürburg
spezzato dal 1966 da una chicane che portò la lunghezza della pista a 22,835
km., perfino punti dove le vetture spiccavano letteralmente il volo (come il
Flugplatz che non a caso in tedesco significa
aeroporto), il circuito Nord, come viene chiamato per distinguerlo da quello
odierno, è stata una vetrina unica al mondo nella quale soltanto i campioni con
la "C" maiuscola hanno saputo mettersi in mostra. Fino al 1969 fu la sede permanente del Gran Premio di Germania, fatta
eccezione per l'edizione del '59 disputata sul lungo ovale dell'Avus, poi nel
1970 i responsabili della Formula 1
trasferirono temporaneamente la gara tedesca ad Hockenheim per permettere ai
gestori del Ring di effettuare lavori di miglioramento della sicurezza dei
piloti, come ad esempio mitigare le rampe di lancio e aumentare le vie di fuga
in curva. Nel 1971 la corsa tornò nella sua sede storica ma si capì subito che
le misure di sicurezza adottate erano insufficienti; tuttavia si dovette
attendere fino al 1976, quando Niki Lauda ebbe il terribile incidente
che tutti ricordano, per decretare la definitiva morte (per quanto riguarda la
Formula 1) del vecchio Nürburgring e lo spostamento definitivo del GP tedesco
ad Hockenheim.
Nel frattempo gli
organizzatori si diedero da fare per costruire un nuovo tracciato
lungo poco più di 4,5 km., posto più a sud di quello classico, che
possedesse caratteristiche tali da permettergli di ospitare una gara
di Formula 1 moderna: ampie vie di fuga, chicane che limitassero la
velocità (ma anche le possibilità di sorpasso), posti a sedere
concepiti più come tribune da stadio calcistico piuttosto che da
autodromo; malgrado tutto, il fascino paesaggistico del vecchio
Ring, anche se ovviamente in misura minore, continua a rimanere
anche in quello attuale. Il Circus debuttò sul nuovo circuito in
occasione del Gran Premio d'Europa del 1984; l'anno successivo, ma
solamente per quell'anno, fu sede del Gran Premio di Germania, poi
un'attesa lunga 10 anni, infine nel 1995 la Formula 1 ha trovato nel
piccolo Ring una sede stabile del proprio calendario: da allora vi
si sono disputate le uniche due edizioni del Gran Premio del
Lussemburgo nel '97 e '98 e tre Gran Premi d'Europa. Qualche cifra per concludere. Sul circuito Nord si è corso 22
volte; solamente due piloti sono stati capaci di trionfare tre volte
su questa mitica pista: Juan Manuel Fangio e Jackie
Stewart; mentre Alberto Ascari, John Surtees e
Jacky Ickx si sono imposti in due occasioni; sul circuito di
oggi si sono svolte sette gare e l'unico a fare il bis, nel '96 e
'97, è stato Jacques Villeneuve. Complessivamente la marca
che ha vinto più gare sui circuiti del Nürburgring è la Ferrari.
Fino al 1969 fu la sede permanente del Gran Premio di Germania, fatta
eccezione per l'edizione del '59 disputata sul lungo ovale dell'Avus, poi nel
1970 i responsabili della Formula 1
trasferirono temporaneamente la gara tedesca ad Hockenheim per permettere ai
gestori del Ring di effettuare lavori di miglioramento della sicurezza dei
piloti, come ad esempio mitigare le rampe di lancio e aumentare le vie di fuga
in curva. Nel 1971 la corsa tornò nella sua sede storica ma si capì subito che
le misure di sicurezza adottate erano insufficienti; tuttavia si dovette
attendere fino al 1976, quando Niki Lauda ebbe il terribile incidente
che tutti ricordano, per decretare la definitiva morte (per quanto riguarda la
Formula 1) del vecchio Nürburgring e lo spostamento definitivo del GP tedesco
ad Hockenheim.
Nel frattempo gli
organizzatori si diedero da fare per costruire un nuovo tracciato
lungo poco più di 4,5 km., posto più a sud di quello classico, che
possedesse caratteristiche tali da permettergli di ospitare una gara
di Formula 1 moderna: ampie vie di fuga, chicane che limitassero la
velocità (ma anche le possibilità di sorpasso), posti a sedere
concepiti più come tribune da stadio calcistico piuttosto che da
autodromo; malgrado tutto, il fascino paesaggistico del vecchio
Ring, anche se ovviamente in misura minore, continua a rimanere
anche in quello attuale. Il Circus debuttò sul nuovo circuito in
occasione del Gran Premio d'Europa del 1984; l'anno successivo, ma
solamente per quell'anno, fu sede del Gran Premio di Germania, poi
un'attesa lunga 10 anni, infine nel 1995 la Formula 1 ha trovato nel
piccolo Ring una sede stabile del proprio calendario: da allora vi
si sono disputate le uniche due edizioni del Gran Premio del
Lussemburgo nel '97 e '98 e tre Gran Premi d'Europa. Qualche cifra per concludere. Sul circuito Nord si è corso 22
volte; solamente due piloti sono stati capaci di trionfare tre volte
su questa mitica pista: Juan Manuel Fangio e Jackie
Stewart; mentre Alberto Ascari, John Surtees e
Jacky Ickx si sono imposti in due occasioni; sul circuito di
oggi si sono svolte sette gare e l'unico a fare il bis, nel '96 e
'97, è stato Jacques Villeneuve. Complessivamente la marca
che ha vinto più gare sui circuiti del Nürburgring è la Ferrari.

Niki Lauda il vero eroe
della Formula 1
|
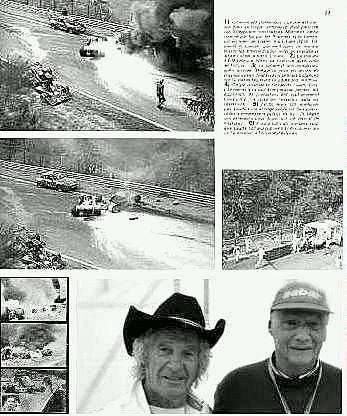
|

Merzario, il pilota che salvò la vita
a Lauda al Nurburgring
|
GP
di Germania dell’agosto 1976: Niki Lauda a sette gare dalla fine del
campionato ha 61 punti e ben 31 di vantaggio sul secondo, il titolo di
Campione del Mondo sembra vicinissimo, ma il dramma è in agguato.
Sul difficilissimo e lunghissimo circuito del Nurburgring Lauda parte
in prima fila al fianco di Hunt, grazie al secondo tempo ottenuto nelle
prove. Niki non effettua una buona partenza: fa pattinare troppo le
ruote sulla pista bagnata, e si ritrova al nono posto.
A quel punto,
poiché la pista si sta progressivamente asciugando, decide di fermarsi
ai box per cambiare le gomme. Al rientro in pista è scivolato agli
ultimi posti per cui si lancia a testa bassa, deciso a recuperare il
terreno perduto. Nel corso del terzo giro,il dramma.
L’austriaco perde
il controllo in una veloce curva a sinistra, più o meno a metà pista,
compie un testa coda e sbatte violentemente contro una roccia con la
fiancata sinistra e rimbalza al centro della pista, prendendo
immediatamente fuoco. Dopo Guy Edwards che riesce ad evitare la carcassa
infiammata della Ferrari arriva la Surtees di Brett Lunger che non
riesce ad evitarla e la urta violentemente. I piloti giunti sul posto
scendono dalle loro macchine e si prodigano a soccorrere lo sfortunato
pilota. In particolare è da ammirare il coraggioso Merzario,
che non
esita, rischiando la propria vita, a gettarsi in mezzo alle fiamme
riuscendo ad estrarre Lauda dall’abitacolo, salvandogli così la vita.
Niki Lauda con la moglie Birgit Wetzinger
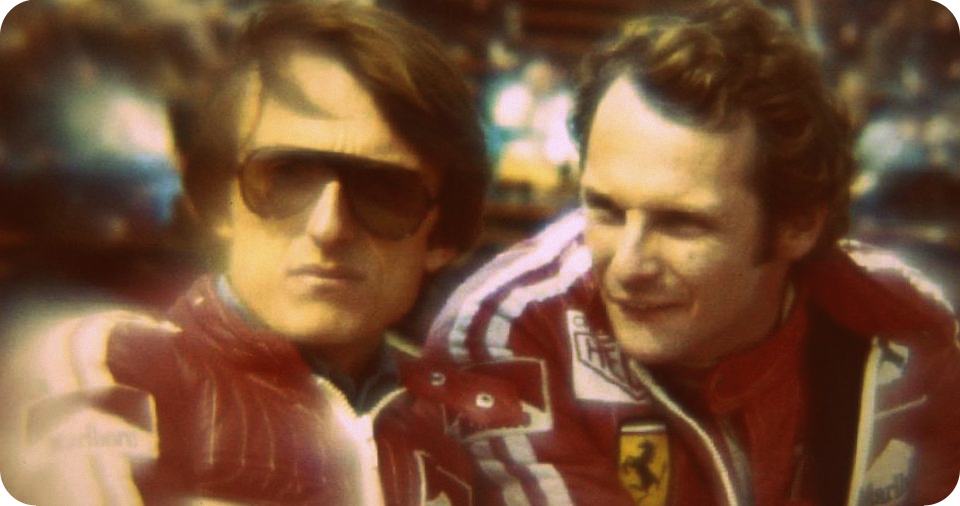
29 maggio 2019 - Luca Cordero di Montezemolo ex presidente della Ferrari, partecipa alla cerimonia funebre
del campione di Formula 1 Niki Lauda al Stephandsdom (cattedrale di Santo Stefano a Vienna)

|

Arturo Merzario, il pilota che ha tirato fuori Niki Lauda dalla macchina in fiamme al Nurburgring,
al funerale di Niki .
|

Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki (Vienna, 22 febbraio 1949 – Zurigo, 20 maggio 2019),
è stato un pilota automobilistico, imprenditore e dirigente sportivo austriaco.
|
Tre volte
campione del mondo di Formula 1 (nel 1975 e 1977 con la Ferrari, nel
1984 con la McLaren), come imprenditore ha fondato e diretto tre
compagnie aeree, la Lauda Air, la Niki
e la Laudamotion; come dirigente sportivo, dopo essere stato consulente
per Ferrari e avere diretto per due stagioni la Jaguar Racing, dal 2012
fino alla sua morte ha ricoperto la carica di presidente non esecutivo
della Mercedes AMG F1.
Ha disputato 171 Gran Premi,
vincendone 25, segnando 24 pole position e altrettanti giri veloci. Ha
avuto una carriera sportiva di grande livello guidando per March, BRM, Ferrari, Brabham e, infine, McLaren.
Considerato uno dei migliori piloti della storia, era soprannominato Il computer per via della sua freddezza al volante.
Nel 1976, sul circuito del Nürburgring, ebbe un grave incidente
che lo lasciò parzialmente sfigurato in viso; da ciò
l'abitudine di indossare un berretto rosso, un accessorio presto
divenuto iconico nella sua immagine pubblica.
1975: Lauda dopo 11 anni.
|
 Il GP d'Italia del
1975 potrebbe entrare nella storia: il
ferrarista Niki Lauda, in testa alla classifica, cerca
gli ultimi punti per conquistare matematicamente il titolo
mondiale. Il GP d'Italia del
1975 potrebbe entrare nella storia: il
ferrarista Niki Lauda, in testa alla classifica, cerca
gli ultimi punti per conquistare matematicamente il titolo
mondiale.
L'austriaco, scattato dalla pole arriva terzo alle spalle
del compagno Regazzoni e di Fittipaldi e conquista l'alloro a
undici anni dall'ultimo trionfo in rosso di John Surtees. Una
stagione da primattore per Niki, vincitore di ben cinque
Il suo antagonista, Emerson
Fittipaldi, alla fine della stagione viene staccato di quasi
venti punti (64,5 a 45) e si accontenterà della seconda
piazza.
Lauda dominò anche la stagione 1976 ma il
terribile incidente del Nuerburgring, lo privò del meritato bis.La causa
non fu, come tutti ricordano, la rinuncia dell'austriaco di correre
l'ultima gara ma, soprattutto, la remissività del suo compagno di
squadra, Clay Regazzoni, che si fece superare, nel corso dell'ultimo
giro, da James Hunt che conquista così il titolo. corse
(Montecarlo, Belgio, Svezia, Francia, Stati Uniti) e altri tre
piazzamenti sul podio.
1977: Lauda di nuovo re.
Niki Lauda nel 1977 conquista il suo
secondo titolo
mondiale al volante della Ferrari.Il pilota austriaco fece il bis iridato ma a fine stagione
divorziò dalla casa di Maranello che non gli aveva perdonato
il suo abbandono nel Gran Premio del Giappone del 1976 a causa
della pioggia battente, regalando il titolo alla McLaren di
James Hunt.
austriaco fece il bis iridato ma a fine stagione
divorziò dalla casa di Maranello che non gli aveva perdonato
il suo abbandono nel Gran Premio del Giappone del 1976 a causa
della pioggia battente, regalando il titolo alla McLaren di
James Hunt.
Dopo un ritiro nella prima gara dell’anno in Argentina,
Niki arriva terzo in Brasile, primo in Sudafrica e secondo a
Long Beach. In Spagna nuova decisione clamorosa dell’austriaco
che dopo il warm-up dichiara forfait a causa di un dolore alle
costole. Altre due piazze d’onore a Montecarlo e in Belgio,
ritiro in Svezia e quinto posto in Francia. Con quest’ultimo
piazzamento Lauda scavalca Scheckter in vetta alla classifica
mondiale; siamo metà campionato e Niki non mollerà più il
comando fino alla fine.
Nelle cinque gare successive l’austriaco arriva sempre sul
podio: è secondo in Gran Bretagna, primo in Germania (ad
Hockenheim, non al Nürburgring), secondo in Austria, primo in
Olanda e secondo a Monza. Nel Gran Premio degli Stati Uniti si
piazza quarto e conquista matematicamente il titolo iridato.
Quella però è l’ultima gara di Lauda al volante di una
Ferrari: infatti Niki se ne va sbattendo la porta e firmando
un accordo con la Brabham-Alfa Romeo: nelle ultime due gare,
in Canada e in Giappone, il suo posto verrà preso da un
giovanissimo canadese, Gilles Villeneuve.
|
|
|
|
 |
Monaco, 1955.
È l'edizione passata alla storia per il volo in acqua di
Ascari.
Dopo una partenza bruciante, Fangio, scattato
dalla pole position, è costretto al ritiro, mentre si trova in
testa, per la rottura di un ponte. La prima piazza è ceduta al
compagno di squadra, Stirling Moss, sempre su Mercedes, passato
alla storia come l'"eterno secondo": pilota dal talento
straordinario, mai in grado di portare a casa un alloro iridato.
Anche la Mercedes dell'inglese, tuttavia, è costretta al ritiro per
un problema al motore. Ascari, su Lancia, si trova, così, in testa
alla gara. È a questo punto che una delle immagini più vivide, fra
i ricordi degli appassionati, prende forma: il milanese, alla
chicane del porto, perde il controllo della vettura - forse per un
problema al freno anteriore destro, forse per la presenza di olio
perso proprio dalla vettura di Moss - e finisce clamorosamente in
mare. |
|
Il giovedì successivo non ascoltando né pareri
medici, né tanto meno la moglie Mietta, si presenta
all'Autodromo di Monza dove sta provando l'amico e allievo Castellotti.
Eugenio è al volante di una Sport della Casa di Maranello e
tra un giro e l'altro, Alberto gli chiede di potere effettuare alcuni
giri di pista, tanto per tenersi in esercizio. Chi lo conosce e lo vede
salire sulla vettura, capisce che c'è qualcosa che non va.
Alberto è in camicia e cravatta e non ha con sè
l'inseparabile caschetto azzurro e la maglietta anch'essa azzurra da
gara. Verso mezzogiorno schiaccia l'accelleratore puntando verso la
Curva Grande. Gli alberi si fanno sempre più veloci verso di
lui, arriva alle due Curve di Lesmo e si lancia verso il Serraglio e
quindi sul rettifilo che porta alla Parabolica per immetrsi nel
rettifilo dei box. E' talmente il gusto della velocità e
della rinata sicurezza in Lui, che decide di fare un altro giro,
passando davanti ai box e salutando l'amico fraterno Castellotti.
|
|
| La vettura era sostanzialmente integra... a parte la zona posteriore
sinistra. Per il resto ammaccata nelle parti laterali, come se avesse
rotolato trasversalmente per qualche giro. Il pilota è stato sbalzato fuori |
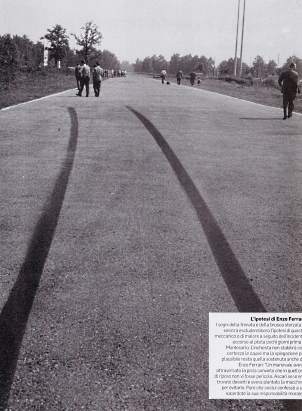 |
 |
|
Il punto dell'incidente
|
I due pali sulla destra sono ancora lì.....anche l'albero sulla sinistra è lo stesso! |
|
|
Il
motore si fa sempre più "grosso", le gomme stridono alla
secoda di Lesmo. Arriva alla curva a sinistra che prenderà
poi il suo nome, la passa e all'improvviso il motore si fa muto e
sull'Autodromo scende di colpo il silenzio. Ai box capiscono che
è successo qualcosa. I soccorsi partono immediatamente e
trovano il povero Alberto riverso a testa in giù, dopo una
strisciata di una cinquantina di metri. La Sport rovesciata
è un brutto segnale per i soccorritori. Le cause non furono
mai stabilite: embolia in seguto all'incidente di Montecarlo, o come si
sussurra, l'incidente fu dovuto all'improvviso attraversamente della
pista da parte di un manovale che credendo la pista libera per la pausa
di mezzogiorno, decise di attraversarla, obbligando Ascari ad una
improvvisa frenata per evitarlo, con il conseguente tragico
ribaltamento. |
Quattro giorni dopo, a Monza,
Ascari è di nuovo in piedi ad assistere alle prove di qualificazione a
Supercortemaggiore. Appena prima di tornare a casa con sua moglie per il
pranzo decide di fare qualche giro con la Ferrari del suo amico Castellotti. In camicia e pantaloni e indossando il casco di Castellotti
si avvia. Al 3° giro all'uscita da una curva l'auto imprevedibilmente
sbanda, capovolgendosi due volte dopo un testacoda. Sbalzato fuori dal
mezzo Ascari si ferisce gravemente e muore dopo pochi minuti.
La morte di Ascari venne accolta come una perdita
per l'intera nazione. Telegrammi di cordoglio vennero spediti da tutto il
mondo. Alle colonne della chiesa di San Carlo al Corso furono appesi
drappi neri e un'enorme scritta: "Accogli, o Signore, sul traguardo
l'anima di Alberto Ascari." Per i suoi funerali la piazza del Duomo, il
cuore pulsante di Milano, era invasa di gente. La piazza più rumorosa
d'Italia fu quel giorno così silenziosa che si potevano sentire i telefoni
squillare a vuoto nelle case.
Tre giorni dopo le esequie la Lancia
sospese ogni attività agonistica e a Luglio consegnò sei modelli D50, con
motori, progetti e ricambi, alla Ferrari.
|
Vittorio Brambilla
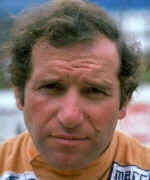 |
Vittorio Brambilla era, a suo modo, un personaggio singolare, uno di
quelli che si motori si intendevano davvero, così come il fratello Tino.
Aveva corso in moto, con i kart, con le monoposto di formula 3, fino al
grande salto nella Formula 1. Anno 1974, sulla March-Ford al fianco di
Stuck, dopo aver preso il posto del neozelandese Ganley.
Il suo anno d'oro fu il 1975, unica guida della March Ford
sponsorizzata Beta. Fu l'anno in cui ottenne una pole position sul
circuito di Anderstop, nel Gran Premio di Svezia, ma soprattutto vinse il
Gran Premio d'Austria all'Osterreichring, il 17 agosto. Una gara segnata
dalla morte di Mark Donohue nelle prove libere della domenica e poi
sospesa per la pioggia battente al 29° dei 54 giri previsti. Brambilla che
era in testa, con largo margine, portò a casa la vittoria e metà
punteggio. |
Fu l'unica volta che salì sul podio, anche se diverse altre volte andò
a punti, l'ultima nel 1978, ancora in Austria, con un sesto posto. E, in
un'altra drammatica giornata, il 10 settembre '78, Vittorio Brambilla
rischiò la vita nell'incidente in cui morì Ronnie Peterson. Colpito in
testa da una ruota, dovette essere ricoverato in ospedale.
Tornò sporadicamente in formula 1, sull'Alfa Romeo, in due gran premi
del 1979 (Italia e Canada) e del 1980 (Olanda e Italia). A carriera ormai
conclusa - a 42 anni, dopo 74 Gran Premi - era rimasto nel mondo dei
motori: aveva un'officina a Monza. E, in ossequio alla vecchia passione
per le due ruote, si era dilettato a fare per anni il motociclista al
seguito del Giro d'Italia.
Se ne è andato il 26 maggio 2001, un mese dopo Michele
Alboreto. E l'Italia della Formula 1 perde un altro di quei personaggi che
si erano ritagliati uno spazio nelle cronache del grande circus. A
differenza di Alboreto, Brambilla è morto fuori da quel mondo che gli
aveva dato notorietà, in un pomeriggio di sole nella sua Brianza, facendo
quello che il sabato fanno tanti uomini normali: stava tagliando l'erba
del prato di casa sua, è scivolato a terra e anche la vita gli è scivolata
via.
|
Gran Premio del Belgio 2018
Il Gran Premio del Belgio 2018
è stata la tredicesima prova del campionato mondiale di Formula
1 2018. La gara, corsa domenica 26 agosto sul circuito di
Spa-Francorchamps, è stata vinta dal tedesco Sebastian Vettel su
Ferrari, al cinquantaduesimo successo nel mondiale; Vettel ha preceduto
all'arrivo il britannico Lewis Hamilton su Mercedes e l'olandese Max
Verstappen su Red Bull Racing-TAG Heuer.
Per questa gara la Pirelli, fornitrice unica degli pneumatici, porta mescole di tipo medie, morbide e supermorbide.
La FIA stabilisce due zone per l'utilizzo del Drag Reduction System: la prima lungo il rettilineo del Kemmel,
con punto per la determinazione del distacco tra piloti posto prima
della seconda curva. La seconda zona è stabilita sul rettilineo dei box,
e detection point fissato prima della curva 18.
La Mercedes porta la terza evoluzione stagionale della power unit: Valtteri Bottas dispone di una power unit nuova in tutta e sei le componenti, mentre per Lewis Hamilton viene montato un nuovo motore termico, un nuovo turbo e una nuova MGU-H. Anche la Ferrari monta per la prima volta la terza evoluzione della power unit, che era stata già predisposta per Haas e Sauber, nel precedente Gran Premio d'Ungheria.
|
|
In
partenza Lewis Hamilton si difende dall'attacco di Sebastian Vettel e
mantiene la prima posizione; i due sono seguiti dai piloti della Force
India. Più dietro, Nico Hülkenberg sbaglia il tempo di frenata alla Source e colpisce in pieno la vettura di Fernando Alonso, che spicca il volo appoggiandosi sull'Halo
della Sauber di Charles Leclerc, mentre con il muso dell'ala anteriore
colpisce la parte posteriore della macchina di Daniel Ricciardo, che a
sua volta tocca la gomma posteriore destra di Kimi Räikkönen
causandogli una foratura. Alonso, Leclerc e Hülkenberg sono
costretti al ritiro.
Nel lungo rettilineo del Kemmel,
intanto, Sebastian Vettel si sbarazza di Hamilton e si pone al comando,
poco prima che i commissari decidono per l'utilizzo della safety car.
Anche i piloti della Force India attaccano, senza successo, il
britannico, con quattro vetture che praticamente si trovano sulla stessa
linea.
Tutti
i piloti vanno ai box per la sosta, mentre i meccanici Red Bull cercano
di riparare alla svelta la RB14 di Ricciardo. Al quinto giro
l'australiano ritorna in pista, con due giri di ritardo dal gruppo. La
gara riprende, con, dietro i primi due, Sergio Pérez, Esteban
Ocon, Max Verstappen e Romain Grosjean. All'ottavo giro Verstappen
supera Ocon per il quarto posto. Un giro dopo Kimi Räikkönen
è costretto al ritiro per via del DRS danneggiato dopo
l'incidente e dei danni al fondo provocati dalla foratura del primo
giro. Nel frattempo Verstappen supera anche Pérez per il terzo
posto, staccato però di 12,7 secondi dal secondo posto. Al
tredicesimo giro Valtteri Bottas entra in zona punti, scavalcando
Sergej Sirotkin.
Al
ventiduesimo giro si ferma Lewis Hamilton, che rientra terzo, alle
spalle di Max Verstappen. Un giro dopo entra ai box anche Sebastian
Vettel, che mantiene il comando, dopo la sosta. Qualche giro dopo
inizia la battaglia tra Marcus Ericsson e Brendon Hartley per la nona
piazza: il neozelandese supera la Sauber lungo il rettilineo del Kemmel,
ma lo svedese si riprende la posizione successivamente. Al trentesimo
giro va ai box anche Valtteri Bottas, per montare un treno di gomme soft. Intanto si ritira Daniel Ricciardo,
quando era a un giro dal penultimo posto. Negli ultimi giri Bottas
supera le due Force India, e coglie il quarto posto. L'altro pilota
della Mercedes, Hamilton, invece, rallenta e vede aumentare a oltre
dieci secondi il distacco dal leader di gara Vettel.
Sebastian
Vettel vince per la cinquantaduesima volta in carriera e per la
tredicesima con la Ferrari. Hanno colto più successi di lui con
la casa italiana solo Niki Lauda e Michael Schumacher. Riduce inoltre
il suo distacco dalla vetta della classifica a 17 punti.
|

Norman Graham Hill Hampstead, 15 febbraio 1929 Arkley , 29 novembre 1975)è stato un pilota automobilistico britannico, l'unico ad aver vinto la Triple Crown.
|

Il terribile incidente di Graham Hill - Stati Uniti 1969
|
Gareggiò nella Formula 1 tra il 1958 ed il 1975, divenendo campione nel mondo in due occasioni (nel 1962 e nel 1968)
prima della tragica morte avvenuta a causa di un incidente aereo. Era
particolarmente conosciuto anche per l'intelligenza e la regolarità
della sua condotta di gara.
Suo figlio, Damon, fu anch'egli pilota automobilistico ed inoltre campione del mondo di Formula 1 nel 1996.
Graham Hill era stato interessato inizialmente al motociclismo, ma nel 1954 notò una pubblicità dell'Universal Motor Racing Club a Brands Hatch, che offriva la possibilità di girare in circuito per cinque scellini. Fece così il suo debutto in una Cooper 500
di Formula 3, e da quel momento in poi si dedicò alle corse
automobilistiche. Hill entrò nella Lotus come meccanico, ma
arrivò rapidamente al posto di guida. La Lotus correva in
Formula 1 e questo permise a Graham di debuttare al Gran Premio di
Monaco 1958, dove si ritirò per la rottura di un semiasse. Nel
1960 passò alla BRM, con cui vinse il titolo mondiale nel 1962.
Hill fece anche parte della cosiddetta "invasione inglese" di piloti e
vetture alla 500 Miglia di Indianapolis a metà degli anni
Sessanta, vincendo nel 1966 con una Lola-Ford.
Nel 1967, tornato alla Lotus, Hill contribuì allo sviluppo della
Lotus 49, spinta dal nuovo motore Cosworth V8. Dopo la morte dei suoi
compagni di squadra, Clark e Spence, all'inizio del 1968, Graham prese
le redini della squadra, vincendo il suo secondo titolo. In quel
periodo, la Lotus aveva fama di vettura fragile e pericolosa,
specialmente con i nuovi dispositivi aerodinamici, che causarono
incidenti molto simili a Hill e Jochen Rindt nel corso del Gran Premio
di Spagna 1969. Un incidente al GP statunitense di quello stesso anno
gli provocò fratture alle gambe, interrompendo la sua carriera.
Dopo essersi ristabilito, Hill continuò a correre in Formula 1
per alcuni anni, senza però ottenere gli stessi successi. Colin
Chapman riteneva che Hill fosse ormai a fine carriera e lo
sistemò per il 1970 nella squadra di Rob Walker, fornendo anche, come parte dell'accordo, una delle nuove vetture modello 72.
Al primo Gran Premio in Sudafrica, Hill arrivò sorprendentemente
sesto, un ottimo piazzamento dato che ancora aveva bisogno di una
stampella per camminare. Ottenne poi un ottimo quarto posto in Spagna e
un quinto a Monaco. Dopo questo discreto inizio, la Lotus 49
cominciò a essere inadeguata ed anche la Lotus 72 promessa da
Chapman non venne consegnata al team di Walker fino a Monza, dove
però nessuna Lotus gareggiò dopo la scomparsa di Rindt.
Hill passò quindi alla Brabham per il 1971-1972: la sua ultima
vittoria in Formula 1 arrivò all'International Trophy di
Silverstone, nel 1971, gara non valida per il campionato, con la
Brabham BT34. La squadra era comunque in crisi, dopo il ritiro di Jack
Brabham e la vendita a Bernie Ecclestone da parte di Ron Tauranac; Hill
non riuscì a sistemarsi.
Pur concentrandosi sulla Formula 1, mantenne una presenza anche nelle
corse per vetture Sport, comprese due partecipazioni a Le Mans, con una
Rover-BRM a turbina. Con il declino della sua carriera in Formula 1,
entrò a far parte della squadra Matra di vetture Sport, vincendo
la 24 Ore di Le Mans nel 1972,insieme a Henri Pescarolo. Questa
vittoria completò la cosiddetta "Tripla Corona"
dell'automobilismo, in entrambe le definizioni che ne vengono date
(vittoria alla 500 miglia di Indianapolis,
alla 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco, oppure alla 500
Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e nel Campionato mondiale
di Formula 1). In entrambi i casi, Hill è ancora l'unica persona ad
aver ottenuto queste vittorie.
|
 |
Link:Curiosità
Elio De
Angelis: talento e sfortuna 
|
 Elio De
Angelis aveva talento ed era veloce, purtroppo si schiantò con uno spaventoso incidente, al Paul
Ricard, mentre testava la troppo avveniristica Brabham-BMW. Che fu subito
ribattezzata "sogliola", a causa dell'inclinazione data al motore dai
tecnici tedeschi per accontentare le bizzarre soluzioni pensate da Gordon
Murray per una Brabham che voleva fare dell'abbassamento del baricentro il
suo punto di forza.
Elio De
Angelis aveva talento ed era veloce, purtroppo si schiantò con uno spaventoso incidente, al Paul
Ricard, mentre testava la troppo avveniristica Brabham-BMW. Che fu subito
ribattezzata "sogliola", a causa dell'inclinazione data al motore dai
tecnici tedeschi per accontentare le bizzarre soluzioni pensate da Gordon
Murray per una Brabham che voleva fare dell'abbassamento del baricentro il
suo punto di forza.
Divenne, invece, lo strumento di morte per un pilota che aveva
mostrato tutto il suo valore in più occasioni. Ma ce n'è una in
particolare che viene subito in mente, la vittoria nel Gran Premio d'Austria del
1982 con pochi millesimi di vantaggio
sulla Williams di Keke
Rosberg.

Elio De Angelis con Ayrton Senna nel 1985
 |
 |
Dopo quell'affermazione, De Angelis si imporrà ancora una volta a Imola, nel Gran Premio di San Marino del
1985, sempre con la Lotus. Alla
fine di quella stagione, però, Elio abbandona il team che gli ha dato
tante soddisfazioni per approdare alla Brabham. Nella squadra che era
stata creata da Colin Chapman, era arrivato uno nuovo: un certo Ayrton
Senna. E Elio aveva capito immediatamente che per lui non ci sarebbe più
stato spazio lì. Alla
fine di quella stagione, però, Elio abbandona il team che gli ha dato
tante soddisfazioni per approdare alla Brabham. Nella squadra che era
stata creata da Colin Chapman, era arrivato uno nuovo: un certo Ayrton
Senna. E Elio aveva capito immediatamente che per lui non ci sarebbe più
stato spazio lì.
La sua carriera era stata rapida e ricca di soddisfazioni: nel '75 era
stato campione del mondo kart, poi aveva corso in F.3, con la quale si era
messo in luce nella gara di contorno a Montecarlo, e in F.2. L'approdo in
Formula 1 era arrivato nel '79 con la Shadow, per poi passare alla Lotus e
restarci per sei stagioni, fino al divorzio "necessario" e il conseguente
passaggio alla Brabham. Dove, De Angelis aveva trovato una vettura
"strana": Gordon Murray, il geniale progettista del team all'epoca ancora
di Ecclestone, aveva infatti disegnato una monoposto superpiatta, per
sfruttare meglio l'effetto suolo.
E' con questa monoposto - che tanti problemi aveva evidenziato nelle
prime gare della stagione '86 - che Elio De Angelis svolge alcuni test sul
circuito di Le Castellet, quando si verifica il terribile incidente.
Estratto ancora vivo dall'abitacolo, lo sfortunato pilota romano cessa di
vivere poco dopo.
E' il 15 maggio: poco meno di due mesi prima, aveva compiuto 28 anni.
|
|

Alan Stacey
(Broomfield, 29 agosto 1933 – Circuito di Spa-Francorchamps, 19
giugno 1960) è stato un pilota automobilistico britannico.
Nato
a Broomfield, presso Chelmsford (Regno Unito) da una famiglia di
allevatori, si era presto messo in luce ed era riuscito ad arrivare a
correre per la Lotus, nonostante avesse una protesi alla parte
inferiore della gamba sinistra, cosa che lo obbligava a usare, per
azionare la frizione, un comando di tipo motociclistico.
Morì durante il Gran Premio del Belgio 1960, in una delle
più tragiche edizioni di un GP che si ricordi: in quella stessa
corsa perse la vita anche Chris Bristow e chiuse la carriera un'altra
promessa dell'automobilismo britannico, Mike Taylor, mentre nelle prove il grande Stirling Moss si era fratturato entrambe le gambe.
L'incidente di Alan Stacey avvenne a Masta, su un rettilineo
velocissimo: un uccello aveva colpito Stacey in pieno volto, la macchina
impazzita uscì di strada. Il pilota, sbalzato fuori dall'abitacolo,
morì sul colpo.
|
|
Sono ormai passati ben 60 anni da questa entusiasmante gara eppure il
suo ricordo è ancora vivo nel cuore degli appassionati. Il Gran Premio
d’Argentina del 1953 fu la prima gara della stagione del campionato di Formula 1 e venne disputato il 18 Gennaio. L’anno precedente aveva dominato l’italiano Alberto Ascari.
Cerchiamo di ricostruire questa giornata a partire dalle novità che si presentarono: innanzitutto la Ferrari
che nella stagione scorsa non aveva avuto rivali in grado di competere
con le sue monoposto decise di rafforzare il suo team piloti siglando un
accordo con un giovane inglese, Mike Hawthorn. Questa scelta fu
obbligata in quanto la Maserati aveva riportato alla guida delle sue
monoposto Juan Manuel Fangio, il quale era stato assente dal mondo delle
corse per un periodo di ben 7 mesi a causa di un brutto incidente
avvenuto sul circuito di Monza; con il ritorno del pilota le motivazioni
della scuderia del tridente crebbero e si cercò di sviluppare un’auto
in grado di competere con quella del cavallino rampante, così si creò
una forte tensione ancor prima che il campionato potesse cominciare.
Con ben sei argentini tra le fila dei sedici partenti al GP, inclusi
Fangio e José Froilan Gonzalez entrambi su Maserati, il numero degli
spettatori crebbe esponenzialmente, favorito anche dall’iniziativa del
presidente Peron di non far pagare l’entrata al circuito, tanto che le
reti di sicurezza furono infrante da questa folla che si accampò lungo
tutto il tracciato senza la minima paura di essere travolta dalle
automobili in corsa: alla fine si contarono ben 400.000 persone
all’interno dell’autodromo di Buenos Aires. Resosi inutili tutti i
tentativi di placare i presenti si decise di dare il via alla
competizione, cosa che non fu gradita ai piloti i quali tentarono di
allontanare la folla dal perimetro del percorso gesticolando durante il
loro passaggio, ottenendo però risultati inefficaci. Al 32° giro si
verificò quello che tutti i piloti e gli organizzatori avevano previsto:
qualcuno tentò di attraversare il circuito mentre sopraggiungeva la Ferrari
di Nino Farina; l’italiano tentò di scansare all’ultimo la figura
presentatasi davanti ai suoi occhi e finì rovinosamente sugli spettatori
con un drammatico bilancio di 10 morti e oltre trenta feriti, mentre il
pilota se la cavò con qualche ferita agli arti inferiori. Un altro
episodio spiacevole fu quello di Alan Brown che a bordo di una
Cooper-Bristol colpì un ragazzino. La corsa tuttavia riprese.
 |
Al termine della gara, dopo ben 3 ore, a dominare fu come previsto
Alberto Ascari, il quale partito dalla pole position non perse mai il
primato e ciò fu dovuto anche al fatto che montava un 2.5 litri sotto il
cofano della sua Ferrari. Secondo fu il suo compagno di squadra Luigi
Villoresi con oltre un giro di distacco. Sul gradino più basso del podio
giunse Gonzales che ricevette un lungo applauso dalla folla locale
anche per il fatto di aver portato così in alto il ben più piccolo 2
litri di casa Maserati, mentre il molto atteso Fangio fu costretto al
ritiro a causa di alcuni problemi alla trasmissione. Al quarto posto si
piazzò il giovane Hawthorn, il che gli garantirà una certa fama ed un
brillante futuro nella scuderia del cavallino.
|
|
|

La BMW di Gerhard Mitter dopo l'incidente mortale del tedesco al Nurburgring..
Un
guasto alla sospensione o allo sterzo, la causa
dell'incidente durante le prove del Gran Premio di Germania
del 1969.
|
1966 James Garner - Film "Grand Prix"
Link: Grand Prix 1966
|
James Hunt, una vita spericolata
Il 15 giuno 1993 James Hunt fu
trovato morto nella sua casa londinese: ricordarlo significa ripercorrere,
seppur brevemente, una vita spericolata che ebbe il suo momento di gloria
proprio con quella McLaren che oggi, ancora una volta, rappresenta la maggiore
avversaria del Cavallino rampante.
 |
A Parigi, per ricevere il riconoscimento del titolo iridato conquistato, si
presentò in smoking e scarpe da ginnastica, anche se lui avrebbe preferito
andare scalzo, come spesso faceva. Era il 1976,
e James Hunt era il nuovo campione del mondo di F.1: alla fine l'aveva spuntata
su Niki Lauda, beffando con un solo punto di vantaggio, il rinunciatario
ferrarista nell'ultima corsa in Giappone.
Risultato ottenuto con la McLaren, che grazie al fortissimo pilota inglese
conquistava così il suo secondo titolo, dopo quello centrato due anni prima con
Emerson Fittipaldi. Ma la figura di Hunt, più che alla McLaren, resta legata a
quella di Lord Alexander Hesketh, un bizzarro rampollo della nobiltà inglese
innamorato delle auto da corsa.
|
Dopo aver sponsorizzato la March del debutto in F.1 del suo pupillo, Hesketh
realizzò un proprio team con una propria monoposto: un sodalizio che ebbe a
Zandvoort nel 1975 il suo momento più glorioso con la vittoria nel Gran Premio
d'Olanda: l'unica per il team Hesketh, e la prima delle dieci ottenute da Hunt
nella sua carriera.
Nel 1976, infatti, il pilota inglese accettò la corte della McLaren, alla
quale si legò fino al 1978. L'anno successivo, James passò alla Wolf rimasta
vedova di Scheckter. Ma la scarsa competitività della monoposto convinse Hunt a
maturare la decisione che già da tempo accarezzava: quella di abbandonare le
corse.
|
Come nel suo stile, James annunciò improvvisamente che quello di Montecarlo
sarebbe stato il suo ultimo Gran Premio: il 27 maggio 1979 si concluse quindi la
carriera di Hunt in F.1. Dopo un tentativo mal riuscito di fare l'agricoltore,
Hunt si diede alle telecronache dei Gran Premi per la BBC e per Eurosport, con
commenti che innescarono spesso polemiche roventi fra i suoi colleghi, spesso
giudicati con troppa disinvoltura dall'ex iridato.Nel suo mirino finì più volte Patrese: del resto, con il pilota padovano
c'era ancora ruggine per l'episodio monzese del 1978 sfociato nel dramma di
Peterson. Ma ai contrasti, alle prese di posizione, agli atteggiamenti
strafottenti, Hunt era abituato..
|
 |
La sua esistenza è sempre stata esagerata, a cominciare dal modo di vivere la
F.1, per finire all'uso e all'abuso di fumo, alcol, passando da una vita privata
perlomeno disordinata. E anche la sua morte, avvenuta improvvisamente a 45 anni
per arresto cardiaco, ha suscitato dubbi sull'effettiva causa del decesso.
|

1955 Tragedia a Le Mans


La Le Mans è la gara
automobilistica più vecchia del mondo. Dura 24 ore e mette a
dura prova efficienza e resistenza delle automobili e dei piloti, ma
non senza conseguenze; al primo giro della 24 ore di Le Mans del
1937, René Kippeurth viene catapultato fuori
dall’abitacolo della sua Bugatti 44 e centrato dalla BMW di Pat
Fairfild: muoiono entrambi. Nel 1949, all’ultima ora,
l’Aston Martin di Pierre Marechal sbaglia un sorpasso e si
schianta, uccidendolo. Nel 1951, la Ferrari 212 guidata da Jean
Lariviere vola fuori dal circuito, e Lariviere muore decapitato da ufn
cavo d’acciaio. Nel 1953 la Ferrari 340 di Tom Cole esce di
strada a 170 chilometri all’ora; lui viene sbalzato fuori
dall’abitacolo e si sfracella contro il muro di una casa.
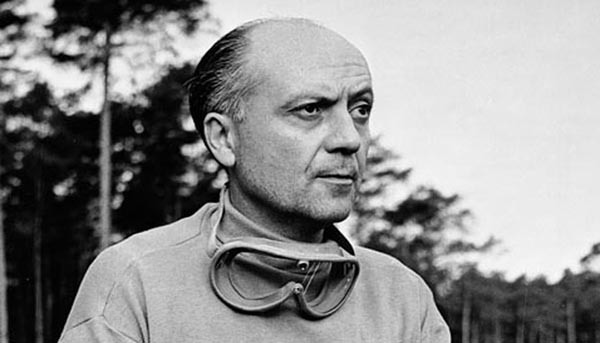
Pierre Lavegh
|
Nel 1955, la Mercedes 300 SLR di
Pierre Lavegh si scontra con l’Austin-Healey di Lance Macklin, si
solleva in aria e piomba tra gli spalti
a oltre 100 chilometri all’ora in una pioggia di schegge d’acciaio,
benzina e alluminio incandescente: muoiono i due piloti insieme a 83
spettatori.
Nel 1956 Louis Hery muore arso vivo nella sua Monopole X86, nel 1958 la
Jaguar di Jean Brussin sbanda per la pioggia, si capovolge e viene
centrata dalla Ferrari di Bruce Kessler; Brussin muore
nell’impatto. Al pubblico non importa, e aumenta ogni anno. Agli
inizi degli anni ’60, qualunque pilota partecipi alla Le Mans
entra nell’abitacolo consapevole che potrebbe morire. |
|
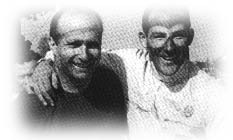 La
prima gara della stagione nel 1955 è il Gran Premio di Argentina.
Neubauer, sentendo la necessità di trovare un altro pilota del calibro
di Fangio da affiancargli, consulta la propria lista di piloti emergenti
e ingaggia Stirling Moss. Con Moss viene stabilito che nei Gran Premi
avrebbe funto da spalla per Fangio, mentre nelle altre gare
automobilistiche i due piloti sarebbero stati trattati in modo
paritario.
Jean Behra rimpiazza Moss alla Maserati mentre Hawthorn lascia la
Ferrari per entrare nella scuderia Britannica Vanwall. La
prima gara della stagione nel 1955 è il Gran Premio di Argentina.
Neubauer, sentendo la necessità di trovare un altro pilota del calibro
di Fangio da affiancargli, consulta la propria lista di piloti emergenti
e ingaggia Stirling Moss. Con Moss viene stabilito che nei Gran Premi
avrebbe funto da spalla per Fangio, mentre nelle altre gare
automobilistiche i due piloti sarebbero stati trattati in modo
paritario.
Jean Behra rimpiazza Moss alla Maserati mentre Hawthorn lascia la
Ferrari per entrare nella scuderia Britannica Vanwall.
Con una temperatura che raggiunge i 40 gradi all'ombra il Gran Premio si trasforma in una prova
più per il pilota che per la vettura. Sono solo due i piloti che
increduli riescono a concludere la gara, uno di questi è il vincitore,
Fangio. Sia Fangio che Moss si ritirano dalle gare al Gran Premio di
Monaco che vede vincitore Trintignant su Ferrari.
Monaco ci fa presagire ciò che sta per accadere quando Ascari esce di
pista finendo nelle acque del porto. Morirà quattro giorni dopo mentre
prova una macchina sportiva della Ferrari. La Lancia, senza il suo
pilota di punta e con forti problemi economici, è costretta a ritirarsi
dalle corse.
Nel frattempo Moss vince in maniera stupefacente la Mille Miglia,
diventando il primo vincitore non italiano dai tempi di Caracciola.
La Mercedes vince ancora a Spa conquistando sia la prima che la seconda
posizione.
A quei tempi la maggior parte dei grandi piloti si dilettava anche con
macchine da Granturismo e non c'era gara più importante della 24 ore di
Le Mans per condurre simili auto. La competizione diventa il luogo di
una sfida attesa da tempo fra la Jaguar britannica, l'italiana Ferrari e
la tedesca Mercedes.
Tutti e tre i piani di gara avevano come primo obiettivo quello di
sconfiggere gli altri due avversari.
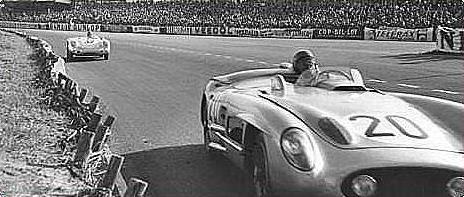
Alle 4 del pomeriggio dell'11 Giugno 1955 comincia la gara che porterà
alla peggiore tragedia che il mondo delle corse ricordi.
Castellotti su una Ferrari balza in prima posizione seguito dalla Jaguar
di Hawtorn. Fangio, che è partito male, sta correndo a tutta velocità
per risalire dalla quattordicesima posizione. Presto riaggancia Hawthorn
e lo supera per poi essere a sua volta risorpassato nel giro
successivo. Hawthorn e Fangio, superato Castellotti, ripropongono la
loro epica sfida di Reims del 1953. Alle 6 e mezza del pomeriggio scocca
l'ora della prima fermata ai box.
Dopo aver passato la Casa Bianca Hawthorn imbocca precipitosamente il
rettilineo principale e si lancia nei box.
 Questa manovra prende di
sorpresa Macklin, sulla sua più lenta Austin-Healy che viene così
costretto ad un brutto scarto a sinistra. Nel frattempo la Mercedes di
Pierre Levegh che sta sopraggiungendo si trova la strada sbarrata dalla
Austin-Healey. La tampona alla velocità di 250 km/h.
L'impatto é tale che l'auto prende il volo e si schianta contro la
barriera di protezione che separa gli spalti dalla pista. L'auto si
incendia e il motore ed una sospensione staccatisi durante l'urto
finiscono nella folla uccidendo 83 persone e ferendone più di 100.


Ivor
Bueb sostituisce Hawthorn, sconvolto dall'accaduto, mentre Moss prende
il posto di Fangio e la corsa non si interrompe. Dopo dieci ore arriva
dai direttori della Daimler Benz l'ordine di ritirare le ultime Mercedes
rimaste in gara, in quel momento al primo e al terzo posto. Finalmente,
alle quattro pomeridiane del giorno seguente, l'incubo finisce con la
vittoria di Hawthorn sulla sua Jaguar.
Il tragico incidente, del quale Hawthorn è stato involontario
responsabile,
ossessionerà il pilota inglese per il resto della sua vita. Nonostante
le
proteste dell'opinione pubblica, la settimana successiva si tiene il
Gran Premio
d'Olanda. Fangio e Moss si ripetono in un'altra doppietta, con primo e
secondo
posto. La gara seguente, invece, è il Gran Premio di Gran Bretagna, che
quell'anno si corre ad Aintree. La squadra Mercedes domina letteralmente
la
corsa, piazzando le sue quattro auto ai primi quattro posti, con la
prima
vittoria assoluta di Stirling Moss. Molte gare vengono cancellate a
causa
dell'incidente di Le Mans. Il Gran Premio d'Italia è l'ultima prova di
questo
Campionato del Mondo. Le Mercedes vincono ancora con Fangio e si
piazzano anche
seconde grazie a Taruffi, ma il pilota argentino dopo aver vinto la
Targa Florio
decide di ritirarsi dalle competizioni. Avendo vinto tutto il possibile
Fangio,
con quasi il doppio dei punti del secondo qualificato, si laurea
Campione del
Mondo per la terza volta.
|
|
1951

|
|
Gli anni Cinquanta: sono gli anni dei mitici piloti
Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Juan-Manuel Fangio, Gigi Villoresi,
José Froiland Gonzalez, Piero Taruffi, Eugenio Castellotti e
Stirling Moss. Le prestigiose Case Automobilistiche che partecipano
alle competizioni sono Alfa Romeo, Auto Union, Ferrari, Mercedes-Benz,
Maserati, Vanwall e Coope. Nel 1951 viene realizzata a Monza
l’avveniristica Tribuna Centrale, una costruzione che
farà Storia e caratterizzerà
l’impianto. Oltre alla pista stradale, il tracciato
comprendeva un anello di velocità (o catino
dell’alta velocità) lungo circa 4,5 chilometri con
due curve sopraelevate in terrapieno..
|
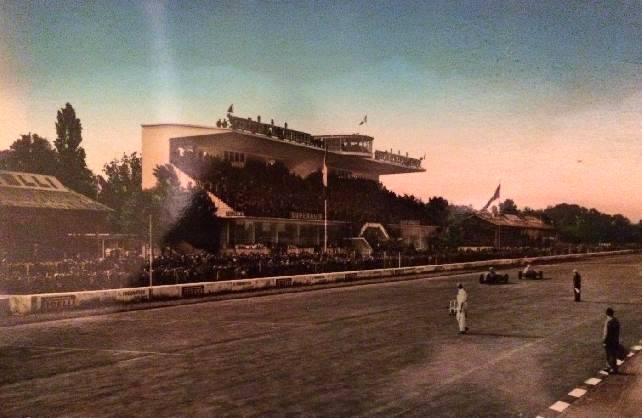 |
|
Gran Premio d’Italia 1951
a Monza, teatro di una
storica sfida tra Alfa Romeo e Ferrari.
Il Gran Premio d'Italia 1951
si è svolto ad una settimana di distanza dal GP delle Nazioni di
motociclismo che aveva occupato il circuito nella seconda domenica di
settembre, data abituale per questa gara di Formula 1.
La gara fu vinta da Alberto Ascari su Ferrari, davanti al compagno di
squadra José Froilán González; per la scuderia del
cavallino si trattò inoltre della prima doppietta nella sua
storia, oltre al primo successo sul circuito brianzolo.
|
Mario Andretti
Mario Gabriele Andretti (Montona, 28 febbraio 1940) è un ex pilota automobilistico italiano naturalizzato statunitense,
attivo sia negli Stati Uniti che in Europa.
|
 |
Nato nel 1940 a Montona nell'allora provincia di Pola,
all'epoca italiana, lasciò l'Istria nel dopoguerra quando la
famiglia, dopo l'assegnazione della regione alla Jugoslavia, fu
dislocata in un campo profughi di Lucca.
Prima di lasciare l'Italia svolse il lavoro di aiutante meccanico in
una officina di Lucca. Appassionato di automobilismo assistette alle
prime gare all'età di tredici anni e fu spettatore della Mille
Miglia.
Nel 1955 ottenne, insieme alla sua famiglia, il visto di ingresso per
gli Stati Uniti stabilendosi a Nazareth, in Pennsylvania, e nel 1964
divenne cittadino statunitense.
|
|
 |
 |
|
Nel
1977 la Lotus lanciò il modello 78, la prima vettura da Gran
Premio che sfruttava l'effetto suolo. Andretti conquistò 4
vittorie, 7 pole, 4 giri veloci e chiuse terzo nel campionato mondiale.
Con il modello 79 la Lotus diventò imbattibile l'anno seguente, che incoronò Andretti campione del mondo. Le 6 vittorie, i 3 giri più veloci e le 8 pole position
dimostrano la superiorità del pilota italoamericano (agevolata
anche dagli ordini di scuderia che imposero al suo compagno Ronnie Peterson di non attaccarlo) e della Lotus. La vittoria fu amara in quanto coincise con Gran Premio d'Italia durante il quale proprio il compagno Peterson morì per i postumi di un incidente al via della gara.
|
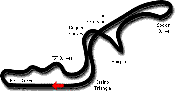 |
La pista dei campioni
|
|

|
1987:Mansell
KO nelle prove.
Il clima in casa Williams è teso.Piquet è in testa al mondiale e
Mansell ha 12 punti di svantaggio a due gare dalla fine.Il duello però
non inizia nemmeno perchè l'inglese, durante le prove, perde il
controllo della vettura e si schianta contro le protezioni riportando
lesioni alla colonna vertebrale che lo costringono a rinunciare alle
speranze iridate.
|
|

|
1988:Il primo
titolo di Ayrton.
E' il primo anno di convivenza fra Prost e Senna alla McLaren.Se il
brasiliano vince la gara conquisterà il suo primo agognato titolo.Al
via Ayrton parte dalla pole ma perde una decina di posizioni mentre
Prost scatta in testa.Il brasiliano inizia una mitica rimonta e già a
metà gara è in scia al francese che ben presto supera per involarsi
alla conquista del primo iride.
|
|

|
1989:Lo
scontro alla chicane.
Il secondo anno di convivenza tra Senna e Prost è caratterizzato da
un clima litigioso.Il brasiliano è protagonista di una stagione
sfortunata.Domina quasi tutti i gran premi ma l'unica McLaren con
problemi di affidabilità è risultata sempre la sua.Prost si trova
così con un vantaggio di 16 punti a due gare dalla fine.La gara vede
Prost al comando con Senna sempre in scia.A sei giri dalla fine tenta
l'attacco alla staccata della chicane, supera il francese ma questi lo
stringe fino a buttarlo fuori.Prost si ritira mentre il brasiliano
riparte, si ferma ai box per cambiare l'alettone, raggiunge e supera
Nannini tagliando per primo il traguardo.Viene in seguito squalificato
per un fantomatico taglio di chicane.Il titolo va a Prost e Senna non
glielo perdonerà mai.
|
|

|
1990:La
vendetta.
Prost è passato alla Ferrari ma l'avversario è sempre Senna.Il
francese deve vincere assolutamente.Senna parte dalla pole ma Prost
scatta meglio e si presenta davanti alla prima curva.Senna non ci pensa
due volte e, alla staccata, lo sperona volontariamente.Gara finita e
titolo a Senna che dichiara:"A volte le gare finiscono a sei
giri dalla fine, altre volte alla prima curva....".
|
|

|
1991:Nulla da
fare per Nigel.
A Suzuka Mansell deve assolutamente vincere se vuole
conquistare il titolo.Al via Senna lascia passare il compagno di squadra
Berger.Senna, in seconda posizione, controlla Mansell che prova
in tutti i modi di superarlo fino a commettere un errore che lo
toglie dalla corsa.A quel punto il brasiliano si scatena e in pochi giri
recupera dieci secondi a Berger fino a superarlo.Davanti al
traguardo, però, rallenta fin troppo platealmente lasciando
vincere il fedele compagno di squadra.
|
|

|
1996:Duello
fra figli d'arte.
Damon Hill e Jacques Villeneuve, sono compagni di
squadra nel team Williams.E' la prima volta che i figli di due campioni
(rispettivamente Graham e Gilles) si giocano il
titolo.Jacques parte male dalla pole e Damon va in fuga.Il canadese
rimonta ma al 36° giro, dopo il pit stop, perde una ruota e
il titolo che conquisterà comunque l'anno successivo.Damon Hill diventa
così campione del mondo come lo fu suo padre.
|
|

|
1998:Il primo
di Hakkinen.
Michael Schumacher su Ferrari e Mika Hakkinen su
McLaren, sono in lotta per la conquista del titolo.Il sogno ferrarista
finisce subito perchè Schumacher, dalla pole, fa spegnere il motore
e quindi parte dal fondo dello schieramento.Il tedesco è autore di una fantastica
rimonta che lo porta fino al secondo posto ma lo scoppio di un pneumatico
lo costringe al ritiro.Il finlandese, Mika Hakkinen, vince così la gara
ed il suo primo meritato titolo.
|
|

|
2000:Titolo
piloti alla Ferrari dopo ventuno anni.
Michael Schumacher concquista il suo terzo mondiale e riporta
il titolo piloti alla Ferrari dopo 21 anni.L'avversario è sempre
Mika Hakkinen con la McLaren.Fantastico il duello fra i due
contendenti, sempre al massimo dal primo all'ultimo giro.La svolta al
secondo pit-stop quando la McLaren, con una strategia
sconsiderata,permettono alla Ferrari di passare al comando e vincere.
|
|
|
Una Storia Italiana
Bandini
e la formula uno. Una storia come tante altre, uguale ad altre storie di altri
piloti che negli anni 60 avevano una voglia matta di emergere, di arrivare, di
dimostrare di che pasta erano fatti.
Di carattere calmo e molto serio, Lorenzo
rappresentava quello che in gergo si chiama "il bravo ragazzo", un ragazzo che
ha costruito il suo debutto in formula uno con tanti sacrifici.
Una storia la
sua, coltivata nel garage milanese del Sig.Freddi, che sarebbe poi diventato suo
suocero,
dopo avere sposato Margherita.
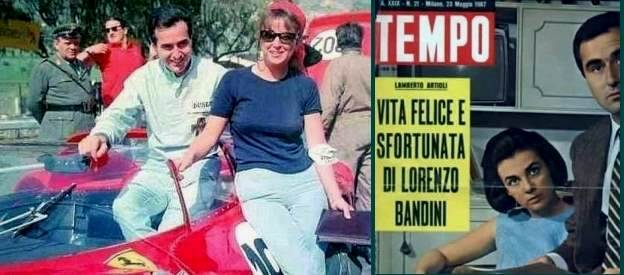 |
Bandini
raccontava che in Italia giunse da Bengasi, dove il padre gestiva
un'industria di macchine agricole. A quindici anni arrivò a
Milano in cerca di miglior fortuna, senza soldi e con tante speranze.
Iniziò come meccanico nel garage di Freddi e quindi la
passione per le auto da corsa lo contagiò, collaudando di
nascosto le auto dei clienti. Cominciò con una Fiat 1100 TV
nella Castell'Arquato - Vernasca e si classificò 15°
di classe. Lorenzo continuò con le gare in salita, fino a
"centrare" nel 1956 un primo posto nella Lessolo-Alice con una Fiat 8V
preparata da lui stesso. Nel 1958 acquista una formula Junior, una
Volpini e si iscrive al Gran Premio di Siracusa di quell'anno,
classificandosi al 3° posto. Dopo avere acquistato una
Stanguellini, vinse il Gran Premio Libertad a Cuba e
partecipò al corso indetto dalla Scuderia Centro-Sud di
Mimmo Dei, con un' insegnante d'eccezione: Piero Taruffi. Nel 1961
riceve la chiamata di Ferrari e a bordo di una Testa Rossa, vince il
Circuito di Pescara. Da quel momento in poi, le vittorie come stradista
si susseguono in modo costante, fino alla vittoria alla 24 Ore di Le
Mans. Vince l'unico Gran Premio di F1 nel 1964 in Austria. Nel 1967
vince in coppia con Amon la 24 Ore di Daytona, ma lui non si monta la
testa, rimane sempre con i piedi per terra. Lui non è una
prima donna, è solo un pilota che ama il suo mestiere. Poi
arriva il 7 maggio 1967, il Gran Premio di Monaco, la morte che prima
lo sfiora e poi lo prende definitivamente, il 10 maggio lasciandoci la
nostalgia di quel "bravo ragazzo".
Senza dubbio Bandini fu il pilota italiano
più amato dagli italiani degli anni '60. Iniziò a
correre per la Scuderia Centro Sud di Mimmo Dei, abbandonando il sogno
di esordire a bordo di una Ferrari messa a disposizione dalla FISA, che
preferì Giancarlo Baghetti. Esordì come pilota di
F.1 nel Gran Premio del Belgio del 1961. Enzo Ferrari lo
chiamò a Maranello nel 1962.
Lorenzo Bandini
|
7 maggio 1967
venticinquesima edizione del gran Premio di Monaco
 |
|
I principi regnanti Ranieri e Grace, come prassi
vuole, sono tra i numerosi spettatori disseminati lungo il tracciato
del circuito Monegasco.
E' domenica, la domenica del Grand Prix.
Gente dappertuttto: alle finestre delle case, sugli yachts, lungo la
pista che si snoda tra il mare e il celebre Casinò. Bandini è la grande speranza di tutti gli innamorati della
rossa e non vuole tradire le attese, sente la
responsabilità. Lorenzo Bandini sta ultimando gli ultimi preparativi prima di scendere
in pista.
Alle ore 15 va in scena il Gran Premio di Montecarlo. |
|
Un
pubblico numerosissimo fa da cornice allo svolgimento della gara
 Monaco è il salotto della F1, una gara
particolare, prestigiosa ma anche maledettamente difficile. Monaco è il salotto della F1, una gara
particolare, prestigiosa ma anche maledettamente difficile.
E' la sfida tra il pilota e il tracciato e le sue mille insidie.
Bandini quest'oggi è il personaggio. Il pronostico lo
dà favorito.
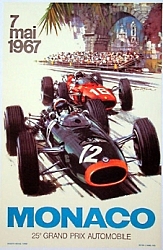 |
La gente grida "Lorenzo! Lorenzo!"
E' venuto il momento di dire addio al folklore.
Bisogna pensare solo ad andare forte.
A vincere.
|
|
|
I piloti si preparano, la tensione sale,
poi rombano i motori. Chiron piega una ad una le dita della mano sinistra. Nell'altra ha già pronta la bandiera che darà il
via alla corsa.
A quell'epoca non c'erano i semafori.
Il
tricolore di Francia s'abbassa e in una nube di fumo scattano prontea sparire dietro la curva.
 I piloti sono:
I piloti sono:
Bandini - Brabham - Hulme - Stewart - Clark - Hill - Amon - Surtees -
Rindt - McLaren -
Rodriguez - Gurney - Courage - Servoz Gavin - Siffert
- Spence
|
La sua Ferrari ha il numero 18 ed è subito al comando 
La partenza della vettura n°18, la
Ferrari di Bandini, è fulminea: prende subito il comando
sembra in grado di dominare la gara.
Sulla salita di St.Devote è prima la rossa Ferrari di
Bandini , così come
al "virage Massenet". che passa vicino al Casinò, e ancora
al "Mirabeau",
una curva in discesa che conduce alla vecchia stazione. Poi
c'è il " tunnel"
e all'uscita la "chicane", la "curva dei tabacchi" ed in ultimo la
"curva del
gasometro" che porta davanti ai box.
E' il primo giro e Bandini è sempre in testa con un secondo
e mezzo su
Denis Hulme |
|
 |
Al
secondo giro Jack Brabham "sbiella" il
motore Repco della sua Brabham, inondando la pista d'olio causando una
serie di testa coda e di uscite tra i piloti dietro di lui. |
|
 |
Quando Bandini passa in quel punto non
essendo stato segnalato l'olio in pista è ignaro di cosa lo
sta aspettando e colto di sorpresa si ritrova girato in un baleno. |
|
 |
Quando riesce a riprendere la corsa si
trova in terza posizione dietro a
Hulme e Stewart, ma l'auto è a posto e può
partire nella generosa rimonta. |
|
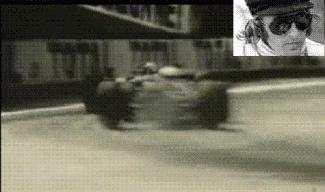 |
Stewart si ritira per problemi meccanici e
cosi Bandini è secondo tallonato da Surtees, ma Hulme
è lontano. |
|
 |
Una Ferrari e una Honda entrambe a 12
cilindri. Surtees
era il numero uno della Ferrari, ma ebbe dei dissensi e se ne
andò da Maranello.
Clark oggi è dietro, corre con un vero pezzo da museo una
Lotus Climax ma riesce sempre a dare spettacolo. |
|

L'uscita della Lotus 33 di Clark al
44°giro, testimonia le terribili
condizioni del tracciato monegasco e le primordiali barriere protettive |
|
 |
Al 42° giro Bandini ha un distacco
di 15"4 da Hulme.
A metà corsa, dopo 50 giri, solo 8"3 lo separano dal
neozelandese.
Dieci giri ancora e il distacco si è fatto più
piccolo 7"6 tra Bandini e Hulme.
La Ferrari n°20 di Chris Amon è lontana. |
|

 |
Amon ha un distacco di 25 secondi da Denis
Hulme.
Al box della Ferrari Margherita Bandini continua a segnare i tempi.
Bruce McLaren è in terza
posizione. |
|
 |
Sessantuno giri compiuti. Trentanove
ancora ne restano.
Ma succede qualcosa. |
|
 |
Un giro ancora il distacco sale a 11
secondi. 14"8 al 70° giro.
Bandini deve superare due doppiati Rodriguez e Hill.
Il primo Rodriguez, si lascia agevolmente superare,
ma il secondo Graham Hill, dà filo da torcere al pilota
della Ferrari. |
|
 |
Hill ha ancora infatti il dente avvelenato
per un fatto accaduto nel lontano Gran premio del Messico del 1964,
quando Bandini, per giochi di squadra, tenne dietro il pilota scozzere
seppur in procinto di essere doppiato. |
|

La Honda di Surtees cede.
|

Bandini impiega oltre due giri
per passare
Hill |
|
 |
Bandini supera Rindt (doppiato che poi
abbandana causa motore).
Decide di non accontentarsi della seconda posizione
cerca di agganciare Hulme. |
|

 |
Qui avviene la svolta della gara. Quando
Bandini riesce a superare Hill, sembra svuotato, sfinito. Dal
65° all'80° giro il distacco aumenta fino a 20 secondi.
Infine arriva l'82° giro. |
|
 |
All' 82° giro la Ferrari numero 18
entra nell' imbuto della chicane del porto ad una velocità
visibilmente superiore a quella degli altri piloti e a quella tenuta da
Bandini stesso fino a quel momento. La sua auto non tiene
più la strada, carambola da una parte all' altra della
curvetta d' immissione sulla banchina, si dirige con il muso contro una
bitta di ormeggio. E poi si solleva in aria per ricadere rovesciata con
il pilota tra le lamiere, ormai avvolto dalle fiamme, e percorre
impazzita trenta lunghissimi metri, con le ruote in aria. |
|
 |
Vede passare Hulme e conta. Dieci,
diciotto, venti.
Perche non passa? Sono passati venticinque secondi.
Ed è passato McLaren e Amon. Dov'è Lorenzo?
La voce dello speaker comunica:
Incidente a Bandini |
|

 |
Margherita Bandini afferra quella frase in
francese
ma sembra non capire. Ha sentito "Bandini".
Ma il resto? Dà un altro sguardo alla lancetta.
Passa veloce la verde Brabham di Hulme. Punta gli
occhi verso il mare, laggiù dove c'è la
"chicane".
E' un attimo. Si alza un pò verso l'alto e una indefinibile
inquietudine l'assale. Impallidisce di colpo, apre la mano e lascia
cadere il cronometro. |
|
Incomincia a tremare. Lo sguardo fisso
dove sale una densa
nuvola di fumo. I nervi le cedono. Ora trema tutta. Sono momenti
terribili, allucinanti. Il film di una vita si svolge di colpo.

In pochi minuti, davanti agli occhi di Margherita Bandini balenano gli
attimi più belli, quegli attimi
che da adesso sono solo un
ricordo.

Occorrono tre interminabili minuti ai
commissari di pista
per estrarre il corpo di Bandini dalla carcassa infuocata della Ferrari n°18.
La Signora Margherita rimane annientata.
È un momento drammatico: sulla carcassa della vettura in
fiamme intervengono con gli estintori i commissari di gara, convinti
che il pilota sia stato sbalzato via nell'impatto. Lo si cerca nella
banchina, c'è chi teme sia finito in mare, come Alberto
Ascari nel 1955. Quando poi, dopo circa 3 minuti e mezzo
dall'incidente, l'incendio della Ferrari è domato si scopre
l'orrenda verità: Bandini è ancora lì,
privo di conoscenza e col volto sfigurato. I commissari di gara e due
civili (il Principe di Borbone Parma e l'amico Giancarlo Baghetti)
ribaltano la vettura ed estraggono Bandini ormai in fin di vita, sotto
gli occhi attoniti della moglie Margherita, che pur rimane in un dolore
composto
(«In caso d'incidenti, non fate drammi» aveva
chiesto più volte Lorenzo).
Viene chiamata una Lancia, che lo trasporta al Nosocomio di Montecarlo,
dove viene immediatamente operato per asportargli la milza e tentare di
tamponare le gravissime lesioni: le lamiere gli hanno perforato il
fianco sinistro, danneggiandogli la milza e il polmone sinistro; ma
soprattutto l'intero corpo, per il 60%, è coperto da ustioni
gravissime. La situazione appare subito drammatica.
Lorenzo è gravissimo. Lo
apprende la sera quando un medico
la chiama, non importa se per tre giorni spererà, per lei
Lorenzo se ne è andato quando
le ha dato un bacio prima del via, quando le ha detto: Ciao, Gio'.
Sono state le ultime parole.
Poi è andato incontro al suo crudele destino.
Ogni tentativo dei medici risulta vano e Lorenzo Bandini muore, dopo
settanta ore di agonia,
il 10 maggio 1967. |
|
La monoposto del ferrarista verrà
trovata in 5° marcia quando avrebbe dovuto essere in
3°: la tesi più accreditata sarà quindi
quella della stanchezza del milanese, che aveva dato il massimo e forse
anche di più. Ma tutto ha congiurato per rendere
più terribile l'incidente. Per esempio, la presenza, alla
curva della chicane, di sbarre metalliche per l' attracco delle navi,
che impediscono alla vettura di finire in mare. La presenza di balle di
paglia ai lati della pista: sono le prime ad incendiarsi e ad
alimentare le fiamme all'interno della vettura. L' olio sparso
sull'asfalto dalla vettura di Brabham, che può aver favorito
la perdita di controllo. L'attrezzatura degli addetti ai servizi
antincendio, che non indossano le speciali tute in amianto, come
è invece diventerà obbligatorio di lì
a poco in Inghilterra, e che perciò hanno impiegato
più tempo per avvicinarsi alla vettura ad accorgersi del
corpo del pilota ancora incastrato. Per tre minuti e mezzo Bandini
rimane in balia delle fiamme, tanto che, esaurita la carica dei primi
estintori, i vigili devono correre a prenderne degli altri
più capaci, distanti qualche decina di metri: tutti preziosi
istanti persi.
|
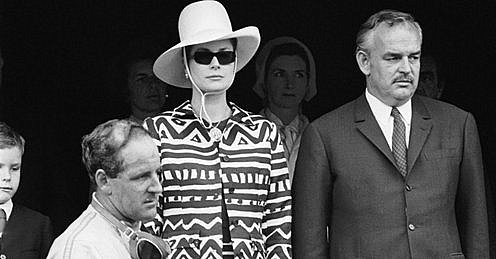 |
 |
1°
D.Hulme - Brabham Bt20 - Giri 100 2h34m,
2°
G.Hill - Lotus 43 - Giri 99 - 3° C.Amon Giri 98 |
Margherita Freddi Bandini vedova da
qualche mese viene nvitata alla premiazione del Gran Premio d'Italia vinto da John Surtees. |
|

La notizia dell’incidente di Bandini viene riportata dai giornali di tutto il mondo.
|

Lorenzo Bandini, per le gravi ferite riportate muore 3 giorni dopo, il 10 maggio 1967 all’ospedale di Montecarlo.
In suo omaggio, quando la salma rientra all’aereoporto di Linate, lungo
viale Forlanini, il viale che porta all’aereoporto, sono schierate due
file di auto disposte a spina di pesce, proprio come per la partenza di
una gara di Le Mans.
E narrano le cronache dei giornali dell’epoca che quando esce il carro
funebre con la sua salma dall’aereoporto, la folla che si è raccolta ad
attenderlo gli tributa un lungo applauso. Sembra che sia la prima volta
che in Italia, venga tributato onore ad un morto battendogli le mani.
Ai funerali di Lorenzo Bandini partecipano oltre 100.000 persone, la moglie Margherita si chiude in un doloroso riserbo
Stagioni in Ferrari:
Gran Premi disputati: 35 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 -
Pole position: 1
1966 G.P. di Francia - Giri Veloci: 2 - 1966: G.P. di Monaco - G.P. di
Francia Vittorie: 1
1964: G.P. d'Austria Secondi posti: 2 - 1965: G.P. di Monaco - 1966:
G.P. di Monaco - Terzi posti: 5
1962: G.P. di Monaco - 1964: G.P. di Germania - G.P.d'Italia - G.P. del
Messico
1966: G.P. del Belgio
Gran Premio d'Italia
10 Settembre 1967 - Monza 68 giri x 5.750 Km -
391.000 Km |
Griglia di Partenza
1. J.CLARK
Lotus Ford Cosworth
1'28''50 |
2. J.BRABHAM
Brabham Repco
1'28''80 |
3. B.McLAREN
McLaren BRM
1'29''31 |
|
4. C.AMON
Ferrari
1'29''35 |
5. D.GURNEY
Eagle Weslake
1'29''38 |
|
6. D.HULME
Brabham Repco
1'29''46 |
7. J.STEWART
BRM
1'29''60 |
8. G.HILL
Lotus Ford Cosworth
1'29''70 |
|
9. J.SURTEES
Honda
1'30''30 |
10. L.SCARFIOTTI
Eagle Weslake
1'30''80 |
|
11. J.RINDT
Cooper Maserati
1'31''30 |
12. M.SPENCE
BRM
1'32''10 |
13. J.SIFFERT
Cooper Maserati
1'32''30 |
|
14. J.BONNIER
Cooper Maserati
1'32''50 |
15. J.ICKX
Cooper Maserati
1'33''00 |
|
16. C.IRWIN
BRM
1'33''20 |
17. G.BAGHETTI
Lotus Ford Cosworth
1'35''20 |
18. G.LIGIER
Brabham Repco |
|
|

|
|
 Nel 1967 dopo la morte di Bandini
nell'incidente al Gran Premio di Montecarlo, Nel 1967 dopo la morte di Bandini
nell'incidente al Gran Premio di Montecarlo,
la Ferrari continuò la stagione con una sola vettura, nei Gran Premi del Nurburgring,
del Canada, del Gran Premio d'Italia, degli Stati Uniti e del Messico.
|
Quando chiesero a Ferrari di ricordarlo,
anch’egli non poté fare a meno di riandare
a
quell’ultima, orribile immagine:
"Ricordo quel giorno di maggio
del 1967. Ero nel mio studio di Maranello,
davanti al
televisore…Quando vidi il grosso fungo nero di fumo che
deturpava sinistramente la baia di Montecarlo…sentii
che
quella macchina in fiamme era una delle mie.
Ora non so dire
perché, ma intuii Bandini nel rogo e fui sicuro che non lo
avrei più visto”.
|
A causa dei numerosi incidenti.....
L'onorevole Loris Fortuna, del PSU,
presenta una interrogazione alla Camera
chiedendo che siano proibite le
corse in Italia.
I giornali si chiedono con angoscia se sia davvero
utile uno sport così rischioso.
Violente polemiche sorgono
in Francia e in Italia sull’opportunità di
organizzare competizioni automobilistiche.
Nei giorni successivi a questo doloroso evento Enzo
Ferrari disse che non avrebbe più sopportato veder morire
un
pilota italiano in una Ferrari. Fu poi il giovane pilota belga Jacky Ickx nella stagione 1968 a sostituire
Bandini.
|
|
|
|
Gran Premio di Monaco - 21 maggio 1950
|
Dopo
due sessioni di qualifica, come da tradizione al giovedì e al
sabato, dove Charles Pozzi, Yves Giraud-Cabantous, Pierre Levegh
e
Clemente Biondetti non partono, la griglia di partenza viene
condizionata pesantemente dal grave incidente occorso all'argentino
Alfredo Pián il quale, a causa di una macchia d'olio, va a
sbattere contro la tribuna con la Maserati fratturandosi una caviglia,
e non prenderà più parte a una gara di Formula 1. La
sessione del sabato viene sospesa definitivamente e le posizioni
vengono stabilizzate ai cinque migliori tempi ottenuti nella prima
sessione di prove: dalla sesta in avanti i tempi della seconda
sessione.
Questo sistema penalizzerà soprattutto Luigi Villoresi
che, pur avendo ottenuto il secondo tempo assoluto,
partirà
dalla terza fila in sesta posizione.
 |
Al primo giro della gara si verifica un rovinoso incidente multiplo
quando un'ondata improvvisa invade la curva del Tabaccaio. Fangio, già
in testa, riesce a evitarla e Nino Farina
in quel momento in seconda posizione, si scontra con la Maserati di
González che prende fuoco. L'argentino riesce in breve tempo a uscire
dalla vettura con qualche ustione, e altri piloti, tentando di evitare
le due vetture, effettuano collisioni tra loro. Luigi Fagioli, in quinta
posizione, sterza bruscamente, andando in testacoda e viene urtato dal
sopraggiungente Louis Rosier. Nella carambola si ritirano
complessivamente dieci piloti (tra un parco partenti di 19). Soltanto
Fangio riesce a evitarla restando in testa alla gara. Luigi Villoresi
viene attardato in maniera irreparabile al secondo giro dalla pista
ostruita dalle vetture incidentate.
Escono
subito di scena due grandi protagonisti del Gran Premio di Gran
Bretagna, Farina e Fagioli, mentre Villoresi tenta una rimonta
portandosi, al 55º giro, a 32 secondi da Fangio, prima di
arrendersi al 63º giro per problemi alla trasmissione. Prima,
al 36º giro, si era ritirato anche Philippe Etançelin per una perdita d'olio.
Alla fine Juan Manuel Fangio, dopo avere doppiato tutti, e senza grandi
problemi, riesce a conquistare la sua prima vittoria in Formula 1,
raggiunge Farina in testa alla classifica con 9 punti e ottiene il primo
“Grand Chelem” della storia: pole position, fastest lap,
vittoria della
gara condotta sempre in testa. Con la media oraria di 98,701 km/h, è il
Gran Premio più lento di sempre.
La Ferrari 125 non si è dimostrata
all'altezza delle Alfa Romeo,
e già Enzo Ferrari comincia a pensare ad
una vettura tutta nuova, con motore aspirato.
|
 |
|
 |
Lodovico
Scarfiotti classe 1933:"Gentleman driver".
Nell'ambiente delle corse, il
gentleman driver era colui che affrontava le stagioni agonistiche pagando di
tasca propria vettura, trasferte e tutto quant'altro orbitava nel mondo delle
quattro ruote.
Lodovico era uno di questi. Poco di lui si trova nei nuovi
libri dell'automobilismo sportivo, se non la bellissima vittoria al 37° Gran
Premio d'Italia a Monza nel 1966 con la Ferrari. Di famiglia facoltosa torinese,
nipote di uno dei fondatori della FIAT e parente stretto degli Agnelli,
trapiantato a Porto Recanati, ama i prototipi che senza ombra di dubbio
preferisce alla massima formula.Stradista perfetto si cimenta e vince molte
gare in salita, vincendo nel 1962 e 1965 il Campionato Europeo della Montagna.
Un fatto singolare da ricordare di questo pilota, risale al Giro di Calabria del
1958. Nelle vicinaze di Nicastro, Lulù arriva velocissimo prima di una curva in
discesa, che naturalmente affronta senza staccare il piede dall'accelleratore.
Risultato: volo in una scarpata e macchina rovesciata senza possibilità di
uscita del povero Scarfiotti. Uno spettatore che per puro caso passava nei
paraggi, aiuta Lodovico ad uscire da quella posizione insolita. Scarfiotti non
riportando nessuna ferita, fa amicizia con il suo "salvatore", godendosi assieme
il resto della gara seduti su di un muretto. |
Due anni dopo, Scarfiotti si
ripresenta la via del Giro di Calabria. Pronti-Via. Stesso punto, stessa curva,
stessa velocità e naturalmente stesso volo.
Da non credere, si presenta la
stessa persona che due anni prima lo aveva tolto dalla "scomoda posizione"
che
dopo averlo riconosciuto, lo porta all'ospedale.
Dal 1958 al quel 8 giugno
1968, giorno della sua morte avvenuta a Rossfeld in Germania in seguito a
incidente automobilistico,
Scarfiotti si alternò tra vetture a ruote coperte e
scoperte, riportando appunto la vittoria in due Campionati Europei della
Montagna,
la vittoria a Monza del 1966, dove il prescelto al podio dalla Casa di
Maranello era Bandini. Ma la sorte sorrise a Lodovico Scarfiotti
dopo avere
ingiustamente, causa il distacco del tubo dell'alimentazione, tolto di scena
Bandini.
Infine l'indimenticabile arrivo con il 2° posto in coppia con Parkes
alla 24 Ore di Daytona nel 1967.
|
|

Nel
1966, Schlesser entrò nella scuderia Matra di Formula 2 e corre
anche con la Ford GT40 nelle gare per prototipi. Durante la sua
permanenza alla Matra partecipò a diverse competizioni, comprese
le edizioni 1966 e 1967 del Gran Premio di Germania di Formula 1, dove
furono ammesse vetture di Formula 2 per riempire lo schieramento. Nel
1967 vinse la 12 Ore di Reims su una Ford GT40 MkII con il suo amico
Guy Ligier La Honda RA302, vettura a lui fatale..
Schlesser accettò nel 1968 l'invito della Honda di guidare la sperimentale RA302 al Gran Premio di Francia disputato sul circuito di Rouen.
La vettura era costruita con telaio in magnesio, materiale estremamente
infiammabile e la prima guida John Surtees la considerò troppo
pericolosa al punto di rifiutarsi di portarla in gara.
Schlesser invece accettò, ma rimase coinvolto in un incidente
all'inizio del terzo giro schiantandosi con la sua vettura alla curva Six Fréres
e morì nel furioso incendio che ne scaturì, alimentato
dal pieno di carburante e dalla struttura in magnesio del telaio.
In ricordo del pilota e amico tragicamente scomparso, Guy Ligier
denominò le vetture costruite dalla sua azienda con una sigla
alfanumerica che iniziava sempre con le letter JS, le iniziali di Jo
Schlesser.
|

La leggenda delle Frecce d'Argento -
1954
|
 |

L'avventura
delle Mercedes in F1 inizia nel 1954. Il 4 luglio del '54 la Mercedes è
finalmente pronta per disputare
il suo primo gran premio di F1. Il gran premio
di Francia, la gara del debutto per le Mercedes, è la seconda prova europea
del
mondiale di F1 e la quarta prova assoluta del mondiale dopo l'Argentina,
Indianapolis (che però nessun team
e pilota che corre per il mondiale di F1
disputa) e Spa. Fangio, che nel frattempo ha corso con la Maserati,
è il pilota
di punta della Mercedes in un team composto anche da Kling ed Herman.
A
quell'epoca nessuna regola imponeva di correre con le ruote scoperte. Così la
Mercedes presentò il modello w196
con le ruote incluse nella sagoma della
carrozzeria. Fangio definì la vettura "sensazionale e perfetta"
e in effetti in
gara le Frecce d'argento non hanno rivali: Fangio e Kling chiudono nelle prime
due posizioni.
 |
| Mercedes-Benz W196
Streamliner |
L'avventura delle Mercedes, guidata dal mitico Neubauer,
parte con il piede giusto, ma al successivo gp, quello di Silverstone, Fangio
deve accontentarsi di chiuedere al 4° posto (pur dopo una pole costruita con il
suo talento) perchè la macchina
non è adatta al tracciato. Così, Fangio
chiede delle modifiche: nuovi freni applicati al mozzo (per avere una migliore
aderenza anteriore) ed una versione non carenata della monoposto per il tortuoso
tracciato del Nurburgring.
Con queste modifiche, Fangio e la Mercedes
stravincono nella gara tedesca anche se per gli argentini è un momento
difficile
dopo la morte di Marimon. Fangio è distrutto dalla morte di quello che considera
il suo allievo.
Con il successo nel gran premio di Svizzera, Fangio si
laurea campione del mondo.
|
|
1955 - Il ritiro ufficiale dalle corse della Mercedes
 |
Alla fine della stagione 1955 la Mercedes si
ritirò dalle gare nello stesso modo fulmineo
com’era entrata.
Avevano provato la superiorità
della loro tecnologia, ma fu il terribile disastro di una delle sue
vetture sport, guidata da Pierre Levegh alla 24 Ore di Le Mans di
quell'anno, che provocò il decesso di 83 persone, a
comportare il ritiro dalle competizioni. La casa tedesca
resterà lontano dalla Formula 1 fino al termine della
stagione 1993. |
Dopo la tragedia di Le Mans, lo sport automobilistico ne
uscì totalmente sconvolto: tre Gran Premi ancora da
disputarsi vennero immediatamente cancellati e il governo svizzero
annunciò il bando totale alle corse automobilistiche
disputate sul suo territorio nazionale (tutt'ora in vigore.
Il gran
premio di Svizzera del 1982 fu disputato in Francia,a Digione).
|
|

La Maserari del pilota argentino Onofre Marimon al GP del Nurburgring del 1954.
La macchina in una curva sbanda e Marimon rimase ucciso all'istante. Il compagno di squadra Luigi Villoresi si è ritirato dalla gara
|
1961 - Tragedia a Monza, la corsa va avanti
|
Al secondo giro della gara e
all'altezza della curva Parabolica, la Ferrari 156 guidata da Wolfgang
Von Trips entrava in collisione con la Lotus di Jim Clark. Nel tremendo
impatto, l'auto come una bomba schizzava sulle tribune degli spettatori,
uccidendo all'istante 14 persone compreso lo sfortunato pilota. Il
barone Wolfgang von Trips, ultimo erede di una dinastia di nobili
tedeschi, aveva debuttato in Formula 1 nel 1957 al volante di una rossa
Ferrari, passando in seguito alla guida di vetture Porsche e Lotus per
ritornare poi nella scuderia di Maranello.
|
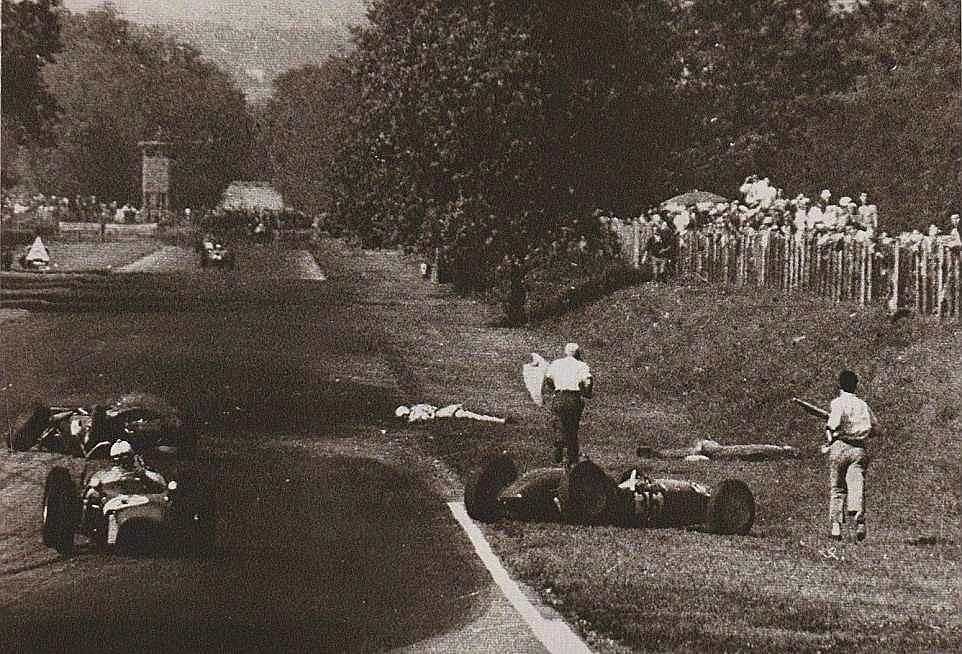
Wolfgang von Trips
 |
Storia di sfortuna e di morte quella di
Wolfgang von Trips,
sicuro vincitore del mondiale 1961 se non fosse arrivata la curva della
Paraboloca di Monza, e con essa, l'impatto fra la sua Ferrari e la Lotus di
Jim Clark: l'aggancio fra le due vetture, provocò la morte non solo di von
Trips, ma anche di tredici spettatori, che furono falciati dalla Ferrari
impazzita e dai suoi detriti.
|
Il
barone tedesco, innamorato della velocità, aveva debuttato in F.1 nel Gran
Premio di Argentina del '57 al volante di una vettura del Cavallino
rampante, poi aveva guidato anche per Porsche e Cooper, per tornare infine
con la scuderia di Maranello per la quale quel 10 settembre '61 guidava
una "156".
 |
In quello che sarebbe stato l'ultimo anno di corse e di
vita, von Trips era il candidato numero uno al successo finale, tanto che,
nonostante l'incidente di Monza lo abbia bloccato a 33 punti, dopo il Gran
Premio d'Italia e quello degli Stati Uniti, il barone tedesco alla fine
del mondiale risulterà comunque secondo nella classifica generale alle
spalle del suo compagno di squadra Phil
Hill.
Solo la morte ha potuto privare von Trips di un titolo
ampiamente meritato.
|
|
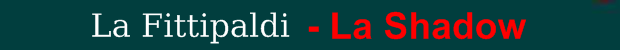 |
 |
Sulla
carta, il Team Fittipaldi non doveva essere un piccolo team, ma nei fatti lo è
stato. Spesso, nonostante l’impegno non arrivano i risultati e non sai spiegarti
il motivo ma nel caso del team dei Fittipaldi le ragioni dell’insuccesso sono
state ben chiare, almeno a chi ci ha lavorato all’interno: Jo Ramirez.
Ramirez parla della sua avventura brasiliana nel suo libro autobiografico,
“Un uomo da corsa”. Jo era sbarcato alla Fittipaldi nel 1974 quando il team
aveva fatto la sua comparsa sulle piste. Alle spalle della compagnia c’era la
Copersucar, ma nonostante questo non solo il team non navigava nell’oro ma non
era neppure agevolato nelle sue attività dallo stato brasiliano (tanti problemi
con le dogane). La progettazione della monoposto era affidata a Richard Divila,
un ragazzo promettente e di talento. Dopo una prima stagione non esaltante, nel
1976 il team doveva fare il suo salto di qualità grazie all’arrivo del campione
del mondo Emerson Fittipaldi. Emerson aveva deciso, alla fine, di firmare per il
proprio team, di correre in prima persone sulle proprie auto. Quello che sulla
carta doveva essere un vantaggio, un guadagno, si trasformò in una delle
principali cause della crisi. L’atteggiamento di Emerson infatti non fu quello
giusto. In primis, egli interferiva troppo con la parte progettuale imponendo le
sue idee tecniche. |
Emerson insisteva sulle sue idee anche se esse erano
sbagliate. Nel proseguo della stagione E. Fittipaldi, probabilmente perchè
abituato a competere con la possibilità concreta di vincere, perse le
motivazioni e iniziò a “vivacchiare”. Spesso se un top driver lo doppiava, lui
riusciva a stargli incollato per molti giri facendo fare un balzo in avanti al
proprio ritmo-gara. Alla fine proprio questo clima assurdo portò Jo Ramirez a
chiudere con la Fittipaldi e ad accettare la sfida della Shadow, che è proprio
la seconda storia che vi racconteremo oggi. La storia della Shadow è connessa ad
una faccenda di spionaggio. Infatti tutti i tecnici della Shadow si trasferirono
alla Arrows, portandosi dietro tutti i disegni. Così, la Shadow e la Arrows si
trovarono a schierare due auto esattamente identiche. Alla fine, quando il boss
della Shadow vinse la causa, la Arrows ormai aveva pronta una nuova vettura. Nel
frattempo Ramirez era riuscito a ricostruire un team sfasciato, partendo
pensate, dalla dote di “ben” due operai. Tra gli altri, pensate, fu ingaggiato
da Ramirez un certo Nigel Stepney un uomo che oggi si è rovinato pesantemente
l’immagine con la spy story del 2007, ma che è stato considerato per anni uno
dei grandi professionisti della f1. Alla fine, grazie agli sforzi di Ramirez il
team riuscì a partecipare il mondiale e a cogliere prestazioni dignitose.
|
|
| Sogni spezzati di grandi promesse |
 |
|
 |
|
 |
| Gartner |
|
Winkelhock |
|
Bellof |
Dopo alcuni anni difficili, nel 1983 l’Ats riuscì ad ottenere la
fornitura dei turbo Bmw e l’anno seguente la potenza del motore fece
emergere il talento di Winkelhock, anche se la cronica
mancanza di affidabilità finì per vanificare il tutto, come ad esempio a
Zolder, quando il tedesco fu costretto al ritiro mentre era in terza
posizione. Il rapporto tra le parti si chiuse nel peggiore dei modi:
Winkelhock lasciò il team e chiuse la stagione in Brabham, poi passò
alla modesta Ram con cui corse fino a metà del 1985, quando perse
tragicamente la vita durante la 1000 Km di Mosport valida per il
mondiale Endurance, categoria nella quale correva con successo
contemporaneamente alla F1.
Al debutto stagionale del 1984 sul circuito di Jacarepagua, tutti i
team si schierarono con il motore Turbo ad l’eccezione della Tyrrell,
ancora legata al vecchio Ford Cosworth: una vera e propria beffa per la
scuderia del “boscaiolo”, che negli anni settanta non accettò la
proposta della Renault di portare al debutto il proprio motore
sovralimentato. Nell’occasione fece il suo debutto il promettente Bellof,
testato anche dalla Mclaren ma “bloccato” dal suo sponsor Rothmans:
22esimo in prova a 8.2 sec. dalla pole di De Angelis, si ritirò dopo
soli 11 giri, mentre poche settimane dopo strabiliò tutti a Montecarlo
(oscurato in parte dalla prestazione incredibile di Senna) e per tutto
l’anno si dimostrò veloce e costante, pur limitato da una vettura poco
competitiva, poi squalificata per un’irregolarità di gestione del peso
della vettura. Pilota dal radioso avvenire, Bellof correva
contemporaneamente il mondiale endurance (vincendolo), dove trovò la
morte l’anno successivo durante la 1000 Km di Spa.
Nonostante corse spesso con vetture obsolete, Jo Gartner
si fece notare nelle formule minori, tanto da trovare uno sponsor che
gli permise di correre parte del 1984 con l’Osella, scuderia con la
quale centrò un quinto posto a Monza. Passato alle vetture sport, morì
durante lo svolgimento della 24 ore di Le Mans del 1986.
|
L’evoluzione del marchio Alfa e Alfa Romeo

1910 - Il primo manifesto pubblicitario dell'ALFA
|
|
 Alfa Romeo 158 "Alfetta" Alfa Romeo 158 "Alfetta"
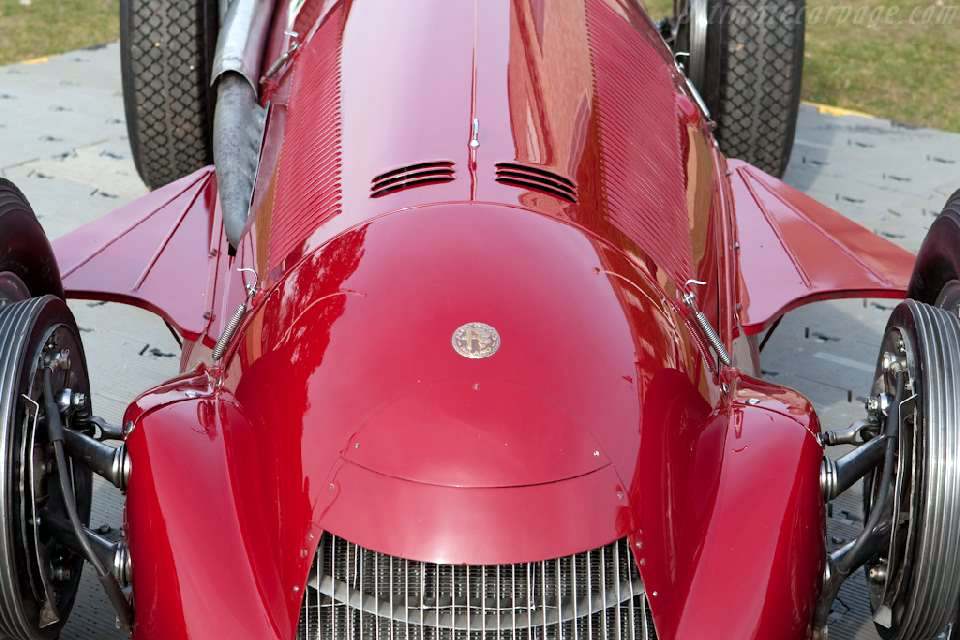
|
|
|
 |
|
 |
|
A
fare grande la Casa milanese in F.1 furono gli esordi del campionato
del mondo, quando Farina e Fangio svettarono nelle stagioni '50 e '51.
Poi l'Alfa decise di ritirarsi dalle competizioni della massima
categoria, ripresentandosi in pista nel '76 come fornitore di motori
per la Brabham prima di scendere in campo con unproprio team. Ma
più che successi, la squadra del Biscione accumulò
delusioni, fino a cedere il proprio materiale all'Euroracing e i motori
all'Osella: con la scuderia piemontese, i motori Alfa
«girarono» fino all'87. |
L'Alfetta 158 : un primato tutto italiano
Gli anni più gloriosi dell'Alfa Romeo sono legati alle prime due
stagioni del campionato del mondo di F.1, quando, per due anni di seguito,
Nino Farina prima e Juan Manuel Fangio poi, svettarono nei mondiali '50 e
'51. La prima stagione iridata fu caratterizzata dall'en plein messo a
segno dalla Casa milanese, che vinse tutti i Gran Premi in calendario ad
esclusione di Indianapolis, cui però i team europei non partecipavano.
L'arma formidabile che permise all'Alfa l'exploit del '50, fu la «158»,
meglio nota come «Alfetta», cui seguì la «159» - naturale evoluzione della
macchina campione del mondo - con la quale la Casa del Portello disputò il
mondiale '51. Ma quello fu l'ultimo anno in F.1 dell'Alfa: paga dei
successi ottenuti, la Casa milanese decise infatti di abbandonare le
competizioni per capitalizzare i risultati ottenuti. Una decisione cui
contribuì l'evidente crescita che stava caratterizzando un'altra scuderia:
la Ferrari. Che dimostrò appunto il suo potenziale vincendo il mondiale
'52, e ripetendosi in quello successivo con Ciccio Ascari.
Alfa Romeo 159 (Formula 1)
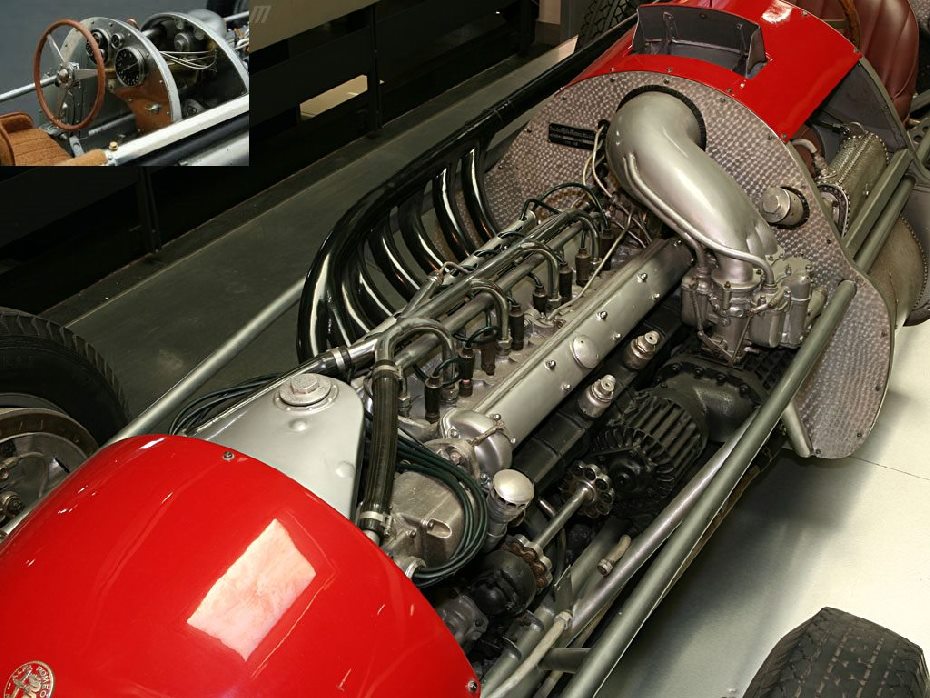
L'Alfa Romeo
159, si aggiudica i primi 3 Gran Premi del mondiale 1951 di Formula 1,
e cioè, il Gran Premio della Svizzera del 27 maggio, con Juan
Manuel Fangio, il Gran Premio del Belgio, del 17 giugno, con Nino
Farina, ed il Gran Premio di Francia del 1º luglio, ancora con
Fangio. Si aggiudicherà, infine, anche l'ultimo Gran Premio di
quell'anno, e cioè, il Gran Premio di Spagna del 28 ottobre. Da
notare che in tutti e 7 i Gran Premi di quell'anno (non considerando la
500 Miglia di Indianapolis) l'Alfa 159 si aggiudica il giro più
veloce in gara, 5 volte con Fangio, e 2 volte con Farina, dimostrando
notevolissime doti velocistiche e di guidabilità.
Altri Gran Premi vinti nel 1951, ma non validi per il mondiale, sono: il V Ulster Trophy del 2 giugno, con Farina; il V Gran Premio di Bari del 2 settembre, con Fangio, ed il IV Goodwood Trophy del 29 settembre, ancora con Farina.
Il ritorno con la «177»
Fino al 1976, non si sentì più
parlare di Alfa Romeo in F.1, finché, in quella stagione appunto, la Casa
del Biscione fornì i suoi dodici cilindri piatti alla Brabham, riuscendo a
spingerla alla vittoria in due occasioni nel '78 con Niki Lauda.
 Ma
l'Alfa stava pensando a ben altro che a una sola fornitura motoristica:
nel 1979 debuttò infatti la monoposto siglata «177», dotata di motore
boxer 12 cilindri. A pilotarla fu chiamato Bruno Giacomelli, che l'anno
prima aveva dominato in maniera clamorosa il campionato europeo di F.2 con
la March. Dal Gran Premio d'Italia, al pilota bresciano si affiancò
Vittorio Brambilla. Alla prima vettura seguì la «179» e nell'80 Vittorio
Brambilla venne sostituito da Patrick Depailler, sul quale l'Alfa contava
molto per le sue acclarate doti di collaudatore. I maggiori difetti della
macchina risiedevano in un peso elevato dovuto non solo al telaio, ma
anche a un motore che per esprimere tutta la sua potenza (520 CV a 12.400
giri) aveva bisogno di «bere» molta benzina. Ma Depailler aveva fiducia di
riuscire a sgrezzare la «179» e intensificò i test. In uno di questi, sul
circuito di Hockenheim, in preparazione del Gran Premio di Germania, il
pilota francese uscì però di strada per ragioni che sono rimaste
misteriose (come spesso accade nelle corse) schiantandosi in un terribile
impatto. Giacomelli restò solo, e nel Gran Premio che si disputò nove
giorni dopo, raccolse un quinto posto che, unito allo stesso risultato
ottenuto in Argentina, portò a quattro i punti conquistati dall'Alfa
nell'intera stagione. Sul finire dell'anno, Giacomelli dimostrò quanto
valesse quella vettura, realizzando ottimi tempi in prova e addirittura la
pole position a Watkins Glen: performance che però non trovarono poi
riscontro in corsa. Ma
l'Alfa stava pensando a ben altro che a una sola fornitura motoristica:
nel 1979 debuttò infatti la monoposto siglata «177», dotata di motore
boxer 12 cilindri. A pilotarla fu chiamato Bruno Giacomelli, che l'anno
prima aveva dominato in maniera clamorosa il campionato europeo di F.2 con
la March. Dal Gran Premio d'Italia, al pilota bresciano si affiancò
Vittorio Brambilla. Alla prima vettura seguì la «179» e nell'80 Vittorio
Brambilla venne sostituito da Patrick Depailler, sul quale l'Alfa contava
molto per le sue acclarate doti di collaudatore. I maggiori difetti della
macchina risiedevano in un peso elevato dovuto non solo al telaio, ma
anche a un motore che per esprimere tutta la sua potenza (520 CV a 12.400
giri) aveva bisogno di «bere» molta benzina. Ma Depailler aveva fiducia di
riuscire a sgrezzare la «179» e intensificò i test. In uno di questi, sul
circuito di Hockenheim, in preparazione del Gran Premio di Germania, il
pilota francese uscì però di strada per ragioni che sono rimaste
misteriose (come spesso accade nelle corse) schiantandosi in un terribile
impatto. Giacomelli restò solo, e nel Gran Premio che si disputò nove
giorni dopo, raccolse un quinto posto che, unito allo stesso risultato
ottenuto in Argentina, portò a quattro i punti conquistati dall'Alfa
nell'intera stagione. Sul finire dell'anno, Giacomelli dimostrò quanto
valesse quella vettura, realizzando ottimi tempi in prova e addirittura la
pole position a Watkins Glen: performance che però non trovarono poi
riscontro in corsa.
Dalle delusioni all'Euroracing
 C'era quindi da lavorare
sull'affidabilità, partendo da una base di prestazioni ottima: per la
stagione successiva l'Alfa immaginò ben altre situazioni nel mondiale di
quelle che invece si produrranno: Mario Andretti riuscì infatti a
raccogliere solo un quarto posto a Long Beach, per la restante metà della
stagione si accumularono delusioni su delusioni. Alla base c'era anche il
fatto che la «179 C» risentiva più di altre monoposto del divieto delle
«minigonne», una norma che aveva portato i tecnici di Arese a modificare
la conformazione aerodinamica della vettura. Come nell'anno precedente,
anche in questo 1981, Giacomelli riuscì a far alzare nuovamente la testa
all'Alfa proprio sul finire della stagione. C'era quindi da lavorare
sull'affidabilità, partendo da una base di prestazioni ottima: per la
stagione successiva l'Alfa immaginò ben altre situazioni nel mondiale di
quelle che invece si produrranno: Mario Andretti riuscì infatti a
raccogliere solo un quarto posto a Long Beach, per la restante metà della
stagione si accumularono delusioni su delusioni. Alla base c'era anche il
fatto che la «179 C» risentiva più di altre monoposto del divieto delle
«minigonne», una norma che aveva portato i tecnici di Arese a modificare
la conformazione aerodinamica della vettura. Come nell'anno precedente,
anche in questo 1981, Giacomelli riuscì a far alzare nuovamente la testa
all'Alfa proprio sul finire della stagione.
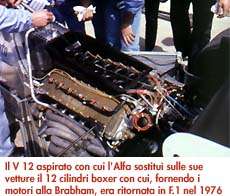 In quella successiva, Andrea
De Cesaris rilevò Mario Andretti, ma la nuova «182» non riuscì a
raccogliere punti fino al Gran Premio di Montecarlo, dove una corsa che
ridotta ad una vera e propria lotteria a causa degli scrosci di pioggia e
delle numerosissime uscite di pista, assegnò al pilota romano il podio con
il terzo posto. Mentre il motore 8 cilindri turbo veniva collaudato sulla
pista del Balocco da Giorgio Francia, Giacomelli e De Cesaris dovevano
combattere col 12 cilindri ormai superato rispetto alle motorizzazioni
turbo della Ferrari e della Renault. Anche il telaio, disegnato da
Ducarouge, non sembrava all'altezza della situazione: la stagione si
chiuse così col decimo posto nel mondiale costruttori, evidenziando una
situazione difficile nel team sia a livello tecnico sia gestionale. In
conseguenza di ciò, Ettore Massacesi, presidente dell'Alfa Romeo, decise
di cedere tutto il materiale all'Euroracing di Pavanello, che avrebbe
potuto contare sulla fornitura dei motori turbo 8 cilindri e
sull'assistenza tecnica dell'Autodelta. L'avventura Alfa sotto queste
insegne proseguì fino all'85, quando si concluse definitivamente, mentre i
motori vennero forniti all'Osella fino al
1987. In quella successiva, Andrea
De Cesaris rilevò Mario Andretti, ma la nuova «182» non riuscì a
raccogliere punti fino al Gran Premio di Montecarlo, dove una corsa che
ridotta ad una vera e propria lotteria a causa degli scrosci di pioggia e
delle numerosissime uscite di pista, assegnò al pilota romano il podio con
il terzo posto. Mentre il motore 8 cilindri turbo veniva collaudato sulla
pista del Balocco da Giorgio Francia, Giacomelli e De Cesaris dovevano
combattere col 12 cilindri ormai superato rispetto alle motorizzazioni
turbo della Ferrari e della Renault. Anche il telaio, disegnato da
Ducarouge, non sembrava all'altezza della situazione: la stagione si
chiuse così col decimo posto nel mondiale costruttori, evidenziando una
situazione difficile nel team sia a livello tecnico sia gestionale. In
conseguenza di ciò, Ettore Massacesi, presidente dell'Alfa Romeo, decise
di cedere tutto il materiale all'Euroracing di Pavanello, che avrebbe
potuto contare sulla fornitura dei motori turbo 8 cilindri e
sull'assistenza tecnica dell'Autodelta. L'avventura Alfa sotto queste
insegne proseguì fino all'85, quando si concluse definitivamente, mentre i
motori vennero forniti all'Osella fino al
1987.
|
 |
 |
Due foto a venti anni di distanza, due leggende della Formula 1
Frank Williams e Ron Dennis McLaren |
Gran Premio del Belgio 1960
|

Dopo un’altra edizione saltata (1959), il Circus ritorna in Belgio nel
1960, in quello che verrà ricordato come uno dei Gran Premi più tragici
della storia della F1. Già durante le prove, si verificano due incidenti
molto gravi, che vedono coinvolte due Lotus 18: Stirling Moss esce di
pista poco prima di Burnenville, a causa del distacco di una ruota,
andando a sbattere in modo molto violento, finendo catapultato fuori
dalla sua vettura e “cavandosela” con le gambe, il naso e tre costole
rotte, tornando alle corse dopo un anno; Mike Taylor, invece, esce di
pista a 260 km/h, a causa del cedimento del piantone dello sterzo, e
viene sbalzato fuori dalla sua Lotus, abbattendo un albero e
fratturandosi varie ossa; inizialmente resta paralizzato, ma dopo un
lungo periodo di riabilitazione torna a camminare. Quello che succede in
gara, quel 19 Giugno 1960, è degno di un film horror. Chris Bistrow,
alla guida di una Cooper 51, è in battaglia con il ferrarista belga
Willy Mairesse per la 6° posizione; siamo nel corso del 20° giro.
L’allora 22enne britannico sbanda, a circa 200 km/h, affrontando la
curva Burnenville, finendo contro il terrapieno, alto circa 1 metro,
posto all’esterno della curva; purtroppo, Bistrow, nell’impatto,
sbalzato dalla macchina, finisce in un campo adiacente, dove c’era del
filo spinato, e muore decapitato. 5 giri dopo, è il turno di Alan
Stacey, al volante anche lui di una Lotus 18. La dinamica del suo
incidente è assurda: in pieno rettilineo di Masta, Stacey viene centrato
alla testa da un uccello; la macchina, senza guida, si schianta e per
il giovane britannico non c’è nulla da fare. Un giovane Jim Clark,
allora 24enne e alla 4° gara in F1, rimane talmente scioccato da questi
eventi (in particolare dall’aver visto trascinare via il cadavere senza
testa di Bistrow come un manichino e dall’aver trovato macchie di sangue
sull’anteriore della sua Lotus) da pensare di farla finita con le
corse. Per la cronaca, la gara vede una tripletta della Cooper, con Jack
Brabham che precede Bruce McLaren ed il pilota locale Olivier
Gendebien.
|
Gran Premio del Canada
Il Gran Premio del Canada 2007
è stata la sesta prova del Campionato mondiale di Formula 1. Svoltasi il 10 giugno
sul Circuito di Montréal ha visto la prima vittoria in carriera
di Lewis Hamilton su McLaren, che, con questo successo, divenne pure
leader del mondiale. Alle sue spalle giunsero Nick Heidfeld, Alexander
Wurz, Heikki Kovalainen (per la prima volta in carriera a punti), Kimi
Räikkönen, Takuma Satō, Fernando Alonso e Ralf Schumacher. La
gara fu comunque caratterizzata dal terribile incidente occorso a
Robert Kubica, dal quale il pilota polacco è fortunatamente
uscito illeso, e dai quattro ingressi in pista della safety car.
Trionfa Hamilton pazzo GP, terrore Kubica
 |
 |
Gara
- Alla partenza Alonso esce fuori di pista alla curva 1 e rientra
dietro ad Heidfeld; intanto, Button non parte per un problema al
cambio. Qualche giro dopo Webber va in testacoda e perde posizioni. Al
giro 8 Speed tocca Wurz e si ritira. Mentre Hamilton rientra ai box,
Räikkönen supera Alonso. Al giro 21 Sutil sbatte sul muro e
si ritira. Al giro 26, alla curva 9, Kubica va a schiantarsi sul muro e
si ribalta; una botta molto violenta, ma il pilota non riporta ferite
gravi. Entra quindi la safety car
e non succede molto fino al giro 51, in cui Massa e Fisichella vengono
squalificati per non aver rispettato la chiusura della pit lane. Tre
tornate dopo, all'ultima chicane Liuzzi sbatte sul muro quando era in
quarta posizione. Negli ultimi giri, dopo aver superato Ralf
Schumacher, c'è un duello tra Sato
e Alonso che si risolve a favore del giapponese. Non succede
nient'altro e Hamilton festeggia la sua prima vittoria in F1 seguito da
Heidfeld, Wurz (che risale sul podio per la prima volta dopo il Gran
Premio di San Marino 2005), Kovalainen, Räikkönen, Sato,
Alonso e Ralf Schumacher. Per la Williams si tratta del primo podio dal
Gran Premio d'Europa 2005.
|
|
 |

GP DI BERNA, 17/05/1952. A CAUSA DEL BLOCCAGGIO DI UN FRENO
RUDOLF CARACCIOLA SI SCHIANTA CON LA SUA MERCEDES
- BENZ 300SL. E' LA FINE DELLA SUA CARRIERA AGONISTICA.
CARACCIOLA ENTRO' IN COLLISSIONE CON UN ALBERO.
|
| MONTECARLO |
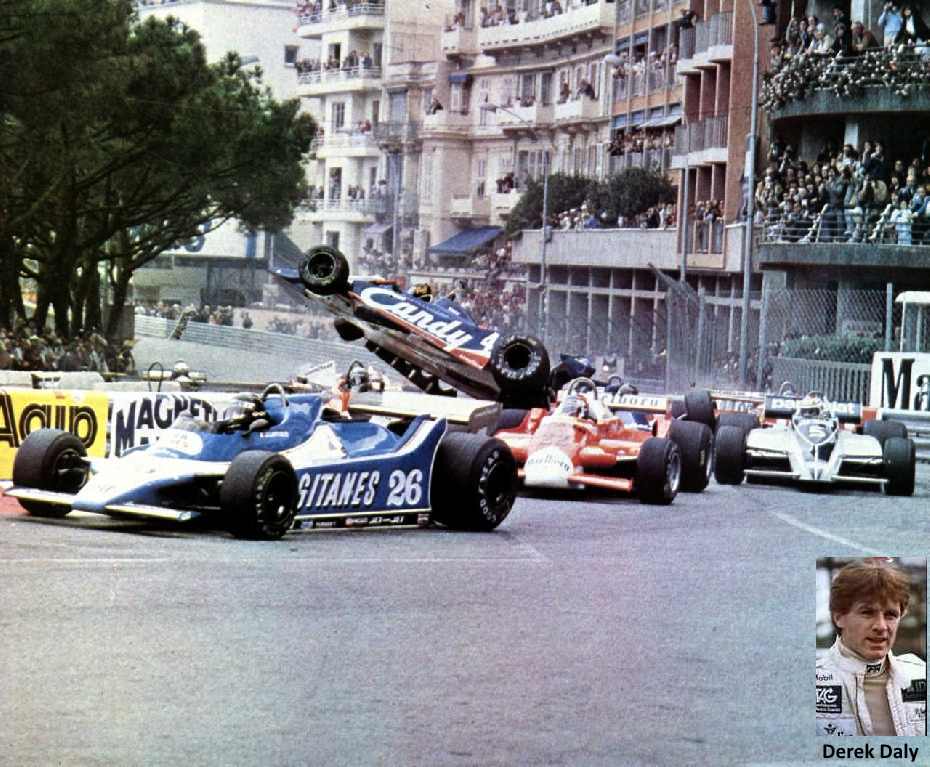 |
| 1980. Santa
Devota pensaci tu. Ci pensa sì, la santa alla quale è dedicata la cappella sulla
celebre curva: Derek Daly con la Tyrrell frena in ritardo, intercetta
violentemente l’Alfa Romeo di Giacomelli che fa da trampolino, decolla
strappando l’alettone alla McLaren di Prost e atterra sull’Alfa Romeo di Jarier.
Tutti illesi. |
 |
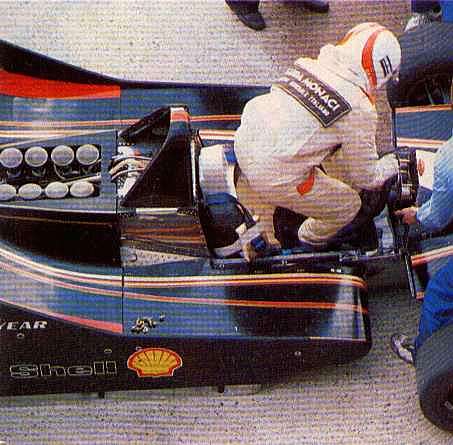 |
Negli
anni '70, l'ingresso in F1 era molto più semplice che oggi. Chiunque (ex piloti,
ricchi eccentrici) avesse la disponibilità di un telaio, poteva creare il suo
team.
A spingere le auto di questi team "garagisti", il motore Cosworth.
Tra coloro che tentarono in F1, in quegli anni, anche l'ex pilota Willibert
Kauhsen.
Kauhsen era stato pilota; nel suo palmares risaltava un secondo
posto nella 24 h di Le Mans. La prima avventura di Kauhsen come costruttore
aveva avuto per contesto la F2. Dopo questa prima esperienza (che aveva
fruttato il titolo del 1976), Kauhsen decide il grande salto in f1 nel 1978.
Come base, Kauhsen cerca di comprare le giapponesi Kojima, che avevano corso
una buona gara nei gp di casa del 1976 e 1977. L'accordo, però, non si trova e
così, Kauhsen decide di costruire le proprie monoposto. Come disegnatori
furono ingaggiati Klaus Kapitza e Kurt Chabek, rispettivamente di Ford e
Porsche. Oltre a tali progettisti, furono chiamati ad assistere il team i
professori Carl Cramer, Hans J. Gerhadt ed Eduard Jager dell'Università di
Aachen. Da un punto di vista tecnico, si scelse di seguire la strada della
Lotus modello 79 a effetto suolo.
Per realizzare tale progetto, il team
usufruì della galleria del vento dell'Università di Aachen. Kauhsen cercò di
acquisire i motori Alfa, ma la trattativa saltò quando l'Alfa decise di
impegnarsi direttamente in F1. Dunque, dovettero ripegare sul Cosworth. Il
cambio era un Hewland FGA a cinque marce, differenziale ZF e ammortizzatori
KONI.
Il primissimo prototipo realizzato, era una vettura a passo corto e
con un alettone posteriore molto avanzato.
Il primo a provare la vettura fu
G. Brancatelli, il quale si accorse di alcuni errori di progettazione. Il
team di progettisti, infatti, non aveva considerato i problemi connessi alla
frenata e all'accelerazione in riferimento all'incidenza sull'effetto suolo |
Per realizzare tale progetto, il team
usufruì della galleria del vento dell'Università di Aachen.
Kauhsen cercò di
acquisire i motori Alfa, ma la trattativa saltò quando l'Alfa decise di
impegnarsi direttamente in F1. Dunque, dovettero ripegare sul Cosworth. Il
cambio era un Hewland FGA a cinque marce, differenziale ZF e ammortizzatori
KONI.
Il primissimo prototipo realizzato, era una vettura a passo corto e
con un alettone posteriore molto avanzato.
Il primo a provare la vettura fu
G. Brancatelli, il quale si accorse di alcuni errori di progettazione.
Il
team di progettisti, infatti, non aveva considerato i problemi connessi alla
frenata e all'accelerazione in riferimento all'incidenza sull'effetto suolo. Un
altro aspetto che richiedeva una modifica era il serbatoio: troppo piccolo per
finire un GP. Dopo una serie di modifiche (tra cui, l'allungamento del
passo), si arrivò ad un secondo prototipo. Questa vettura era dotata anche
di un serbatoio più grande. Venne assunto Patrick Neve , il quale portò
anche uno sponsor. Tuttavia, anche questo secondo prototipo era ben lontano
da poter essere usato in un GP: si trattava di una vettura inguidabile e
comunque, lentissima. Basti pensare che in un test al Paul Ricard, Neve con
la Kauhsen girò a 6 secondi dai migliori.
Altri problemi venivano dal
versante "politico", poichè il team non era in grado di pagare la cauzione di
30000 dollari per la partecipazione, la FISA non voleva accettarli. Neve
lasciò il team, portandosi dietro gli sponsor, ma arrivò Brancatelli.
Il
debutto ufficiale della Kauhsen avvenne a Jarama, nel gp di Spagna del 1979,
dopo un pagamento della cauzione dell'ultimo minuto.
In teoria, alla Kauhsen
non spettava alcun box ma grazie all'aiuto di Ecclestone (e chi altri?!) la
squadra ebbe un suo spazio per lavorare, dividendo la piazzola ai box con la
Lotus. Il team, che non disponeva di gomme da qualifica, ottene l'ultimo
tempo con il suo unico pilota, Brancatelli.
A Zolder, Brancatelli risultò
oltre 13 secondi(!) più lento di Laffitte, che partiva in pole, 9 secondi oltre
il tempo di De Angelis, l'ultimo qualificato. Dopo due gare, Kauhsen decise
che l'avventura era finita: vendette
tutto all'ex pilota Merzario.
Merzario, comunque, pur modificando le vetture non riuscì mai a
qualificarsi.
|
|
Gran Premio di Monaco 1994
Martin Brundle
Qualifiche - GP Monaco 1994
Nella
prima giornata di prove, al giovedì, il più rapido fu
Michele Alboreto, che precedette Derek Warwick e Alain Prost. Il pilota
della Scuderia Ferrari utilizzò una particolare strategia con
gli pneumatici: prima utilizzando tre gomme morbide e una dura (al
posteriore sinistro), poi sostituendo solo le gomme di sinistra, e,
infine con altre due non utilizzate, invertendo le due gomme consumate.
Con questa conformazione ottenne il tempo da primo posto. La gomma
posteriore sinistra era la più sollecitata, per questa ragione
la Ferrari scelse di utilizzare la mescola più dura, per
garantire un maggior numero di giri.
L'altro
ferrarista, René Arnoux, rovinò il giro con le tre gomme
morbide e la sola dura con un testacoda, trovando poi traffico nel
tentativo con 4 gomme morbide. Furono in gravi difficoltà le due
Alfa Romeo, mentre più competitiva fu l'Osella, quattordicesima
con Piercarlo Ghinzani. Manfred Winkelhock distrusse la sua ATS contro il guardrail.
Il tedesco poté proseguire, nonostante una lesione ai legamenti della
scapola, grazie all'interessamento del fisioterapista di Lauda.
Al sabato Alain Prost fece sua la pole position,
abbassando il tempo dell'anno precedente di due secondi. Il francese
entrò in pista a mezz'ora dalla fine delle prove e compì solo i tre giri
necessari per far segnare un tempo. Fu la prima pole position per una vettura motorizzata TAG Porsche.
La prima fila venne conquistata anche da Nigel Mansell,
mentre le due Ferrari vennero relegate in seconda fila (con Arnoux che
sopravanzò Alboreto di 2 millesimi), davanti alle dueRenault.
L'altro pilota della McLaren, Niki Lauda fu solo ottavo, rallentato da
Mauro Baldi nel giro veloce. Alboreto, invece, ruppe la sospensione
alla Santa Devota e dovette cercare il tempo col muletto.
|
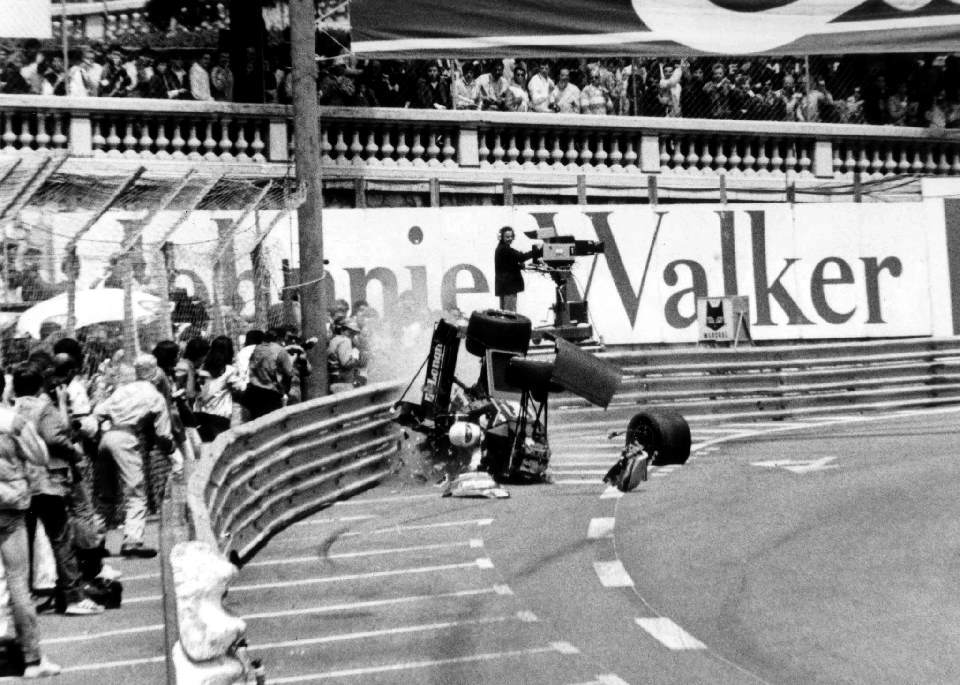 |
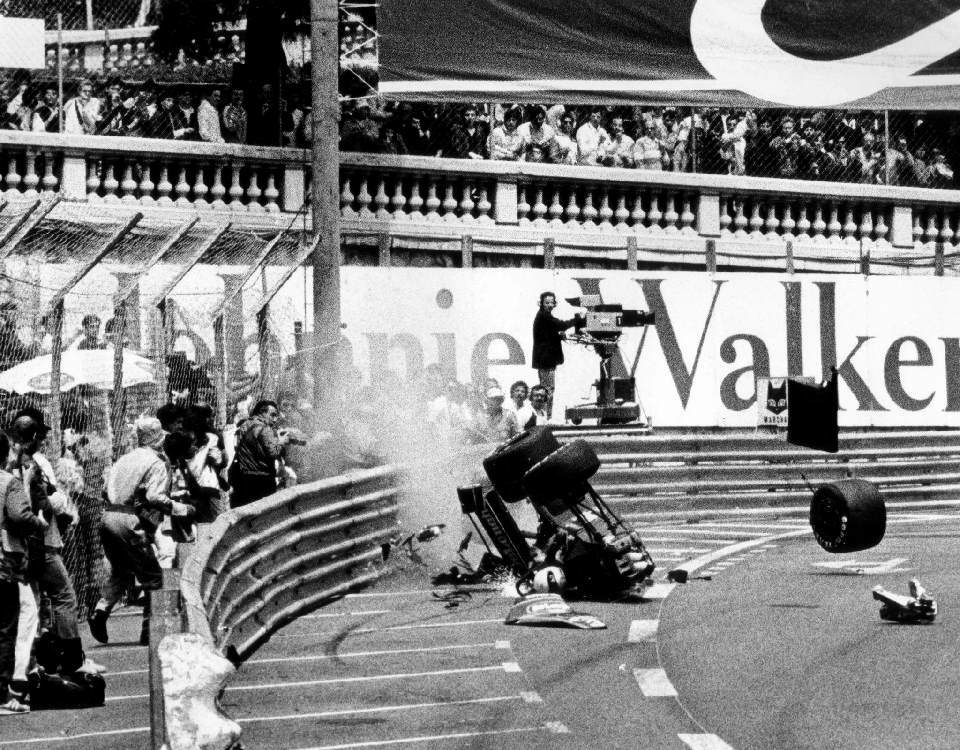 |
 |
 |
| Nelle qualifiche del sabato vi fu un brutto incidente per Martin Brundle
che finì contro le barriere alla curva del Tabaccaio. Il pilota
inglese, tra l'altro contuso, non riuscì a qualificarsi. Gli altri non
qualificati furono i due piloti dell'Arrows, i due della RAM, più Eddie Cheever e Mauro Baldi. |
| Andrea De Cesaris
|
|
Il 5 ottobre 2014 se n’è andato in
motocicletta, una delle sue passioni assieme alla F.1 e al windsurf. Andrea de
Cesaris ha sempre vissuto una vita alla Vasco Rossi, al massimo, per godere
appieno tutte le emozioni. Tragico destino il suo, di un ragazzo che amava la
velocità, che nella sua carriera ha sfidato la sorte con le F1 degli Anni ‘80,
quelle da mille cavalli dure e rudi che ti spaccavano le mani, ed è andato a
morire a 55 anni in un banale, maledetto e comune incidente stradale.
Era uno dei piloti della nazionale italiana di
kart: ragazzi che si sarebbero fatti le ossa in automobilismo: Roberto Ravaglia,
Corrado Fabi, Felice Rovelli (che vinse quel mondiale e si ritirò dall’attività
agonistica) e poi c’era lui: Andrea. Già allora aveva la grinta e
l’irriducibilità che lo avrebbe caratterizzato in F1: guidava tutto cuore e
aggressività. Finì fuori pista in quel mondiale karting, perché non voleva
accontentarsi del quarto posto e con un sorpasso impossibile cercò di salire in
posizione da podio. Quella sarebbe stata la sua ultima gara di karting: due mesi
dopo era già nella F3 inglese, a nemmeno 19 anni. Sempre appoggiato dalla
Marlboro che aveva un rapporto privilegiato con lui, fu l’unico italiano che
corse per ben due volte con Ron Dennis che con Andrea condivideva lo sponsor:
prima in F2 poi in F.1 con la McLaren nel 1981, al fianco di John Watson.
Ma il carattere irruento di Andrea mal si sposava
con l’atteggiamento pacato di Dennis e il legame non funzionò. I suoi tanti
incidenti nelle formule minori in Inghilterra gli valsero il soprannome di “De
Crasheris”, un po’ come James Hunt che era chiamato “Hunt the shunt” (lo
schianto). Solo che Hunt era inglese e quel vizietto di andare sempre al limite
e rompere spesso la macchina gli veniva perdonato e faceva un po’ glamour,
Andrea invece era italiano e nel panorama anglosassone sempre un po’ ipocrita
verso gli stranieri, lo stesso vizietto diventava una macchia per l’immagine
agonistica.
Spensierato, divertente, estroso. Sembrava un
gladiatore invincibile immune ai rischi di una F1 che all’epoca era ancora
maledettamente pericolosa. Eppure una mattina, aspettando un aereo al bar di un
aeroporto, mi confessò che mai e poi mai, quando avrebbe avuto un figlio, gli
avrebbe permesso di fare il pilota. Troppo pericoloso. Strano detto da lui, che
rischiava la vita e sembrava non avesse paura di niente.
Andrea amava la velocità, il brivido, le emozioni.
E soprattutto gli piaceva padroneggiare qualsiasi genere di veicolo. A motore o
a vela. Voleva migliorare la tecnica in windsurf e non si limitò a praticarlo
spesso, no: andò a vivere alle Hawaii surfando con Robby Naish, il più grande
campione della storia del surf. E divenne un maestro della tavola a vela.
Uguale con le moto: lo appassionavano, si mise a
correre in motocross, tanto che a un Motor Show di Bologna decise di sfidare in
gara i migliori crossisti del mondo e i piloti di velocità americani dell’epoca
a due ruote. Una pazzia. C’erano gente tipo Bob Hannah, Rick Johnson, Freddie
Spencer, Eddie Lawson. E i migliori crossisti italiani e… De Cesaris in mezzo a
loro! Come decidere di giocare a calcio contro Messi e il Barcellona in una
partita valida per gli europei. Ma Andrea in quella specialità che non era sua
ci mise grinta e fisico, e non sfigurò affatto. Era aiutato da un fisico
eccezionale e da una determinazione irriducibile. Era il pilota e lo sportivo
più eclettico che avessi mai visto. L’importante che come denominatore comune vi
fosse la velocità. Su due ruote, quattro o nella planata di una tavola da surf.
Aveva una predisposizione naturale per la guida, un piede pesante incredibile e
un coraggio (forse temerarietà) da vendere. Avesse fatto il pilota F1 all’epoca
di Fangio e Ascari avrebbe vinto tanto, ma forse non sarebbe sopravvissuto a
quella F1.
Amava sdrammatizzare situazioni e pericoli. Una
volta tornò con la tuta infangata e disse: “Che ho fatto? Me so’ girato!”. Si
era cappottato su un terrapieno con la Ligier. Nella sua testa si era girato sì,
ma la macchina aveva ruotato sull’asse longitudinale rovesciandosi, non era un
semplice testa-coda sull’asse verticale!
Andrea ha corso ininterrottamente in F1 per 15
anni, dal 1980 quando esordì con l’Alfa Romeo F1, fino al 1994, quando chiuse la
carriera prima con la Jordan e poi con la Sauber-Mercedes. Ha guidato un po’ di
tutto, ma sempre macchine di mezza classifica anche quando erano scuderie
prestigiose: dalla Ligier, alla Minardi, alla Rial, alla Brabham, alla Dallara,
alla Tyrrell. Finiva nelle squadre “giuste” sempre al momento sbagliato, ma non
per sua cattiva scelta. Era un duro, uno tosto, s’era fatto una grande
esperienza perché in carriera ha corso 208 gran premi F1, uno dei più longevi di
sempre; i team lo sapevano e ricorrevano a De Cesaris e alla sua capacità di
portare al limite anche macchine non competitive quando c’era da tirar su una
squadra dalle retrovie per mettersi in luce. Un po’ come quegli allenatori alla
Carletto Mazzone chiamati a riportare su dalla serie B ex squadre blasonate ma a
cui non viene mai affidata una squadra da scudetto.
Lo chiamò Minardi nel 1986 per svezzare l’acerba
Minardi con il turbo Motori Moderni di Chiti e Andrea alla prima gara quasi la
portò in zona punti prima che il V6 cedesse. Lo volle Ecclestone per far correre
la Brabham-Bmw nel 1987 e metterla in luce soltanto allo scopo di trovare un
compratore per una squadra allo sbando perché Bernie aveva ben altri interessi,
e De Cesaris portò quella macchina – che era la “sogliola” fatale a De Angelis
l’anno prima – a un fantastico terzo posto a Spa.

Secondo Gordon Murray, storico ingegnere Brabham,
era il pilota che aveva fatto più giri in testa senza vincere un Gp. Ma lo
diceva in forma di complimento, non in segno d’irriverenza.
Solo un paio di volte De Cesaris ha avuto davvero
in carriera una monoposto per vincere: l’Alfa Romeo 182 nel 1982 e forse la
Jordan-Ford del 1991. Quella verde con cui debuttò anche Schumacher. E c’è
andato vicinissimo. Con l’Alfa fece la pole a Long Beach 1982, due volte secondo
nel 1983. Con la Jordan fu sfortunato ma avrebbe probabilmente vinto proprio il
Gp del Belgio 1991 a Spa – quello dell’esordio di Schumacher – se il suo V8 Ford
non si fosse rotto nel finale di gara quando era secondo in rimonta. Pensate
alle sliding doors della F1: se con la stessa Jordan con cui debuttò Schumi quel
giorno in F1 Andrea fosse finito a podio, la prestazione del giovane Michael
all’esordio che tanto colpì gli esperti di F1 si sarebbe ridimensionata al
paragone col risultato del compagno di squadra. Invece il destino ha voluto
diversamente e ancora una volta Andrea rimase con le pive nel sacco.
Ma noi ricorderemo sempre Andrea come un vero
racer, come dicono gli inglesi, un corridore, uno dal piede pesante come nessun
altro. Uno che il piede destro dal gas non lo toglieva mai fino all’ultimo. In
fondo detiene ancora il platonico record di esser stato il primo a osare e
riuscire a fare in pieno il terribile curvone di Signes al Castellet con una F1.
E' scomparso il 5 ottobre del 2014 a causa di un incidente
motociclistico nella sua città Natale:
al funerale hanno partecipato
numerosi protagonisti della sua carriera in Formula 1, tra cui Niki
Lauda,
che ne ha ricordato con commozione le grandissime doti.
|
Romain Grosjean
|

Il
29 novembre 2020, nel corso del primo giro del Gran Premio del Bahrein
il pilota è protagonista di un violento incidente: in seguito a
un contatto con il pilota dell’AlphaTauriDaniil Kvjat, la sua
Haas colpisce un guardrail ad alta velocità, spezzandosi in due
e prendendo immediatamente fuoco. Il troncone con la cellula di
sicurezza dell'abitacolo rimane incastrato nella barriera metallica,
avvolto dalle fiamme. Grosjean riesce comunque ad uscire dalla
monoposto sulle proprie gambe, venendo immediatamente soccorso
dall'equipaggio della medical car. Successivamente il pilota, che non
ha mai perso conoscenza, viene trasferito in ospedale per ulteriori
esami che accertano la presenza di alcune ustioni agli arti
che gli impediranno la partecipazione ai due Gran Premi successivi (in
occasione dei quali viene sostituito da Pietro Fittipaldi, terzo
pilota).
Conclude così prematuramente la sua ultima stagione in Formula 1,
conquistando 2 punti e classificandosi al diciannovesimo posto in
classifica generale.
|
|
Circuito
stradale del Mugello - per dare prestigio e spazio, per ovvi motivi
politici, alla "Coppa Ciano" la corsa toscana venne interrotta nel '28
e riprese solo nel '55 su un circuito ridotto che si sviluppava solo
intorno al paese di Barberino con solo un breve tratto in
comune al circuito originale di 66 Km che sarebbe tornato
a disputarsi solo dal '64 al
'70.
Il Mugello, alle pendici dell’Appennino Tosco-Emiliano, è una zona della Toscana
ancora poco turistica e ricca di un fascino ancora intatto. Tra fitti boschi,
laghi e fiumi, passi montuosi di aspra bellezza, spuntano antiche ville
appartenute ai Medici e borghi incantevoli immersi nella natura.
Tra questi, da
segnalare certamente Barberino, Vicchio (dove visse il pittore Cimabue)
e
Firenzuola. Per quanto riguarda le ville medicee, la più celebre è senz’altro la
villa di Cafaggiolo.
|
|
|
Piers Raymond Courage (Colchester, 27 maggio 1942 – Zandvoort, 21 giugno 1970) è stato un pilota di Formula 1 inglese, deceduto sul circuito di Zandvoort durante il Gran Premio d'Olanda 1970.
Figlio di uno dei maggiori industriali inglesi della birra (la Courage), studiò a Eton, nel più famoso ed esclusivo dei collegi, dove apprese le prime nozioni di meccanica.
|
 |
|
Durante il GP d'Olanda ottenne un buon nono posto in prova, ma
durante la gara, al 23º giro, prese una curva a velocità eccessiva, la
vettura uscì di strada, urtò un terrapieno e nell'impatto si incendiò
sviluppando delle fiamme così intense da costringere i commissari di
percorso a sotterrare la vettura con all'interno il pilota per poter
spegnere l'incendio. Con la morte di Piers Courage, l'evoluzione della De Tomaso si interrupp
|
 |
 |
A metà
degli anni '60, in Nord America nasceva una delle categorie di maggior successo
del periodo: la Can-Am, acronimo di "Canadian American Challenge Cup". Una delle
caratteristiche che rendeva questa serie particolarmente interessante da un
punto di vista tecnico è la quasi totale libertà nei regolamenti tecnici, che
consentiva ai costruttori di inventare qualsiasi soluzione, a patto di
rispettare le sole regole delle ruote coperte e un cockpit con due sedili e due
aperture. Oltre a queste, giusto qualche regola di sicurezza. La serie, grazie
ai ricchi premi in palio, riusciva a richiamare piloti da tutto il mondo, così
anche piloti di f1 e costruttori o team che lavoravano in f1 si interessarono
alla serie. Il Can-Am, raccoglieva molti spettatori e divenne una delle serie di
maggior popolarità in quel periodo.
Il team che più di ogni altro ha legato
il suo nome al Can-Am è la McLaren, la quale con Bruce McLaren e Denny Hulme
("the Bruce and Danny Show"), prima e Peter Revson poi, scrisse tra le pagine
più importanti della storia della categoria. La prima edizione del Can-Am si
corse nel 1966, prima gara a Mosport, in Canada. La seconda edizione, del 1967,
fu dominata dal team McLaren, un dominio che si spinse sino al 1972, anno in cui
la Porsche divenne il team punto di riferimento nella serie.
Come dicevamo,
l'aspetto più interessante del Can-Am è la libertà progettuale pressochè
assoluta. Fu in questo ambito che nacque un'idea interessante, ripresa poi anche
in f1. La Chaparral 2J: dotata di due motori, uno, un Chevrolet, che svolgeva un
compito "tradizionale" e poi un secondo che svolgeva lo strano compito di dare
moto a due ventole che aspiravano l'aria sotto la vettura. Questa vettura, non
ebbe molto successo nella serie, ma ispirò Gordon Murray che riprese l'idea per
la f1, con la versione B della bt-46, del 1978, anche questa un'auto non molto
fortunata, non perchè non fosse veloce (anzi) ma fu rapidamente messa fuori
legge.
Il principio della Chaparral 2J era semplice: le ventole, aspirando
aria, creavano deportanza incollando la vettura all'asfalto.
Anche gli
alettoni furono introdotti nel mondo delle corse proprio nella serie Can-Am.
L'interesse per la serie era alto per le case europee: Ferrari tentò
l'avventura ma senza riscontri degni di nota; la Porsche, invece, raccolse il
testimone dalla McLaren come team di riferimento.
La partecipazione della
Porsche al Can-Am risale al 1969 ma fu nel 1972 che avvenne il salto di qualità.
La Porsche affidò la preparazione della vettura a Penske e la 917/10k portò al
successo in campionato Follmer (dopo l'incidente a Donohue, che stava dominando
il campionato, sempre con la Porsche).
Sempre nel 1972, la Porsche presentò
la 917/30 che si rivelò una vettura assolutamente dominante, una vettura
potentissima, la più potente vettura da competizione mai realizzata.
Oltre
alla Porsche, alla McLaren, alla Chapparal, alla serie Can-Am si lega il nome
della Lola, che vinse il primo campionato della serie con Surtees.
Gli
elevati budget richiesti portarono alla fine della serie nel 1974. Si tentò di
reintrodurre la serie nel 1977 ma senza grande successo.
Il successo
della serie Can-Am fu dovuto da un mix di cose: grandi piloti, auto potenti e
interessanti sul piano tecnico, circuiti affascinanti e famosi, come Laguna Seca
o Mosport
|
29 LUGLIO 1973.
ROGER WILLIAMSON, IL GIORNO DELLA VERGOGNA DELLA F.1
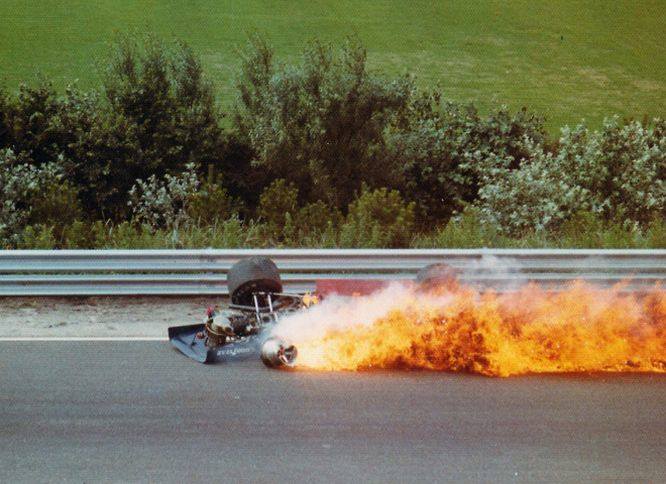
Williamson vinse nel 1971 e 1972 il campionato britannico di Formula 3 prima di esordire
in F1 nella stagione 1973 con la March
|
Durante la corsa, un improvviso sgonfiamento ad uno pneumatico spinse Williamson contro le barriere ad alta velocità
catapultando
la vettura per quasi trecento metri sulla barriera stessa. La macchina
di Williamson si rovesciò
e prese fuoco con il conducente incapace di
districarsi.

Tristemente,
con questa vettura ebbe appena il tempo di completare una gara: alla
sua seconda apparizione, sul circuito di Zandvoort
durante il Gran
Premio d’Olanda (un evento atteso dopo un’assenza di un
anno a causa della messa in sicurezza dell’autodromo
con asfalto
nuovo, l’installazione di barriere e la costruzione di una torre
di controllo), trovò la morte in uno
degli incidenti più
tragici della storia della Formula uno.
|
|
|
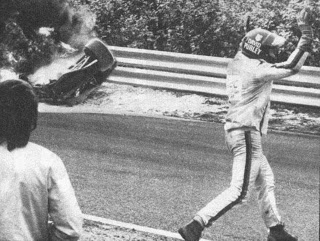 |
| David Purley chiede inutilmente aiuto |
|
 |
La statua di Roger a Donington
|
Roger Williamson, il pilota
inglese vittima certo della pericolosità delle corse ma anche e soprattutto,
quella domenica del Gp di Olanda 1973 sulla pista di Zandvoort, della codardia di
quanti non fecero nulla per tentare di salvarlo. Tranne David Purley. La
dinamica dell’incidente è nota, ripresa e irradiata in diretta dalla
televisione in tutta la sua raccapricciante evoluzione. La March di Williamson, alla
sua seconda gara in F.1 (al precedente GP d’Inghilterra era incappato senza
conseguenze nella carambola di 11 vetture dovuta all’errore di Scheckter in
pieno rettilineo), esce fuori pista a causa dell’afflosciamento di uno
pneumatico. Dopo l’impatto, la macchina si rovescia e striscia per centinaia di
metri prendendo fuoco. Purtroppo, arrestatasi affianco ad un terrapieno, resta
ribaltata mentre le fiamme cominciano a divampare più violentemente. Si accorge
di tutto il compagno di marca (ma non di team) David Purley che non ci pensa
due volte: “parcheggia” la sua March Lec e corre in suo aiuto. Prova a
rimettere sulle quattro ruote la monoposto ma nessuno lo aiuta.
I commissari si
limitano ad osservare, impauriti dal globo di fuoco che ormai avvolge la
monoposto. Allora Purley si procura un estintore, ma la sua azione è
insufficiente. Chiede disperatamente una mano senza ottenere nulla ma, anzi,
viene invitato ad allontanarsi. Si ribella, davanti a tanta disumana ritrosia. Vorrebbero
intervenire degli spettatori ma vengono respinti con i cani. Purley riprova a
raddrizzare quella maledetta macchina. “Lo sentivo gridare, chiedere aiuto, ma
non riuscivo a farcela”, dirà poi. Alla fine, lacrime agli occhi, dovrà
desistere anche lui, impotente davanti ad un ammasso incandescente dentro al
quale muore asfissiato Roger Williamson. Il mezzo antincendio, arriverà solo a
distanza di minuti. Tutto questo è avvenuto senza che la corsa sia stata
interrotta, senza che nessun’altro pilota abbia minimamente pensato di imitare
Purley (alcuni, con tanto di bandiera gialla, alla curva dell’incidente
tentavano ancora sorpassi), senza che gli altri “colleghi” si rendessero conto
di aizzare le fiamme al loro passaggio.
Per
la cronaca, quella gara fu vinta da Stewart davanti a Cevert e Hunt. Roger
Williamson era un fulgido talento, nato il 2 febbraio 1948 (aveva quindi 25
anni) a Leicester. Si svezzò sui kart e poi in gare club su Ford Anglia, nel
1971 era già campione del campionato inglese di F.3 (13 vittorie), poi subito
in F.2, la bellissima vittoria al “lotteria” di Monza e finalmente l’agognata
F.1.La sua carriera fu favorita da un mentore che credeva ciecamente in lui:
Tom Weathcroft, proprietario della pista di Donington Park. “Il giorno più
triste della mia vita”, disse poi di quella tragica domenica. In occasione del
trentennale della scomparsa, nel 2003, fece erigere all’interno dell’autodromo
una statua che raffigura lo sfortunato amico pilota e che, almeno, ne conserva
o propaga il ricordo a tutti gli appassionati.
 |
 |
Williamson resta intrappolato e muore asfissiato
|
Il triste epilogo
|
|
|
Le sfide (quasi) impossibili: aerei contro macchine, da Nuvolari a Schumacher
|
Non ci sono segreti, l’ha sempre sostenuto Bill Vukovich:
“Semplicemente, si spinge a fondo l’acceleratore”. A prescindere da
quello che guidi. Per dire: 8 dicembre 1931, si sfidano in accelerazione
l’Alfa Romeo 8C 2300 di Tazio Nuvolari e il biplano Caproni CA-100
di Vittorio Suster al Littorio di Roma.
C’è un circuito, bisogna fare cinque giri, 17 chilometri in totale.
L’aereo deve seguire in volo l’andamento della pista. Le cronache non
sono proprio precisissime. Comunque vince l’aereo, ci mette 6 minuti e
12, batte di qualche metro la macchina.
|
Gilles Villeneuve, l’Aviatore della Formula 1
Gilles Villeneuve e quel modo di correre aggressivo, tutto pericolo e spettacolo.
Il pilota canadese, nato a Saint-Jean-sur-Richelieu il 18 gennaio 1950, è
stato uno degli sportivi più amati dal pubblico della Formula Uno.
Nonostante non abbia mai vinto un titolo Mondiale, è ricordato come
un’icona per il suo modo arrembante di correre in pista. Morì a bordo
della Ferrari 126 C2 in uno schianto a 227 km/h causato da un contatto
con la March di Jochen Mass durante le qualifiche per il Gran Premio del
Belgio. Era l’8 maggio 1982.
|
La
sfida si rinnova cinquant’anni dopo: 22 novembre 1981, aeroporto
di Istrana ni pressi di Trieste, stavolta a terra c’è Gilles Villeneuve
sulla Ferrari 126 CK senza ali. Lo sfidante è un F-104 dell’Aeronautica
Militare in diverse configurazioni, quella più pesante con quattro
serbatoi supplementari, pesa oltre dieci tonnellate, quella media con
due serbatoi alari e quella leggera in configurazione pulita, comunque
otto tonnellate.
Si parte da fermi e si coprono mille metri. Vince Villeneuve. E forse
non è un caso che lo chiamassero l’aviatore.
Fa 17.80, batte di un
decimo l’aereo in configurazione più scarica.
|
Gran Premio di Spagna 1990
Il Gran Premio di Spagna 1990 è stato un Gran Premio di Formula 1 disputato il 30 settembre 1990 al Circuito di Jerez.
La gara è stata vinta da Alain Prost su Ferrari.
|
 |
 |
| Durante le qualifiche del venerdì, a Jerez,
Martin Donnelly fu vittima di un grave incidente: il pilota
nordirlandese finì con una ruota sul cordolo nella curva detta
"Ferrari"; la sua Team Lotus, lanciata in 6ª a 240 km/h,
finì contro un guardrail andando in pezzi. Il pilota
riportò fratture a gambe e clavicole, rimanendo in prognosi
riservata. Seppur scampato alla morte, Donnelly (che nelle qualifiche
aveva ottenuto il quattordicesimo tempo) dovette - in seguito -
abbandonare le corse, poco più che venticinquenne. |
 |
| AUTODROMO SANTA MONICA - MISANO
ADRIATICO |
 |
|
Il
Misano World Circuit è ubicato nel piccolo centro di Santamonica, frazione della
vicina Misano Adriatico.
Questo paesino deve il suo nome agli alleati
americani che, durante la seconda guerra mondiale, vi insediarono una loro base
militare denominandola probabilmente come la famosa città americana. Nel 1972,
durante la costruzione del celeberrimo autodromo, furono rinvenute importanti
capanne del Neolitico medio-superiore che oggi sono conservate nel Museo del
territorio di Riccione.
|
Clay Regazzoni.
|
|
Gian Claudio Regazzoni, detto Clay, nato a Lugano
in Svizzera il 5/9/1939, e' stato sicuramente il campione Ferrari piu' amato dai
tifosi nei primi anni settanta per la sua generosita' e quella carica di
immediata simpatia che emanava. Dopo aver frequentato le scuole e lavorato nella
carrozzeria del padre, nel 1963 inizia a correre con una Austin Sprite e poi con
una Morris Cooper. Nel 1965 fa esperienza in F3 con una scuderia di Lugano, per
poi firmare un contratto con la Tecno l’anno successivo (disputando anche
qualche gara in F2). Nel 1967 partecipa alla Temporada Argentina e coglie il suo
primo successo in F3 a Jarama. Pilota ufficiale della Tecno nel 1968, vince a
Vallelunga, partecipa con continuita' e discreti risultati alle gare di F2 e
alla fine di quell’anno firma un contratto per correre in F2 con la Ferrari, ma
gli scarsi risultati lo fanno tornare alla Tecno. Nel 1970 Clay si rifa'
vincendo il campionato europeo di F2.
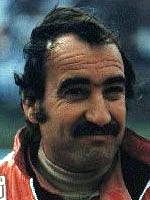 |
Regazzoni e' lanciato in Formula 1 all’eta' di 31 anni nel corso della stagione
1970 da Enzo Ferrari che lo ha apprezzato nelle formule minori. Clay e' al
volante di una rossa dal GP d’Olanda, dove debutta e stupisce tutti con il 6°
posto in griglia e il 4° in gara, risultato ripetuto nel seguente GP di Gran
Bretagna. La sua prima vittoria arriva gia' nello storico GP d’Italia, sua
quinta gara in F1. Il ticinese sa interpretare meglio di tutti il gioco delle
scie sull’impegnativo tracciato di Monza e va a vincere la gara, davanti a
campioni del calibro di Stewart e Hulme. Il bilancio del campionato 1970,
assegnato postumo a Jochen Rindt (morto proprio a Monza nel corso delle prove
del sabato), e' di una vittoria, 3 podi, una pole e il terzo posto nel mondiale,
a soli 7 punti dal suo compagno di squadra Jackie Ickx, secondo in classifica,
avendo disputato solo 8 gare sulle 13 in calendario. |
Regazzoni e' lanciato in Formula 1 all’eta' di 31 anni nel corso della stagione
1970 da Enzo Ferrari che lo ha apprezzato nelle formule minori. Clay e' al
volante di una rossa dal GP d’Olanda, dove debutta e stupisce tutti con il 6°
posto in griglia e il 4° in gara, risultato ripetuto nel seguente GP di Gran
Bretagna. La sua prima vittoria arriva gia' nello storico GP d’Italia, sua
quinta gara in F1. Il ticinese sa interpretare meglio di tutti il gioco delle
scie sull’impegnativo tracciato di Monza e va a vincere la gara, davanti a
campioni del calibro di Stewart e Hulme. Il bilancio del campionato 1970,
assegnato postumo a Jochen Rindt (morto proprio a Monza nel corso delle prove
del sabato), e' di una vittoria, 3 podi, una pole e il terzo posto nel mondiale,
a soli 7 punti dal suo compagno di squadra Jackie Ickx, secondo in classifica,
avendo disputato solo 8 gare sulle 13 in calendario.
Chissa' cosa avrebbe potuto
fare con una partecipazione completa al campionato… La stagione 1971 vede
risultati invece sensibilmente diversi. La nuova 312 B2 non e' all’altezza delle
aspettative né degli avversari, e i risultati non sono quelli sperati. Clay sale
sul terzo gradino del podio solo 3 volte, ma nella classifica finale e' comunque
davanti al compagno di squadra (e futuro campione del mondo 1978) Mario
Andretti.
Regazzoni vince inoltre con i prototipi la 9 ore di Kyalami. La stagione 1972
ricalca le medesime deludenti orme dell’anno precedente, e soltanto un 2° e un
3° posto danno qualche soddisfazione a Clay (anche se i prototipi gli regalano
un’altra vittoria alla 9 ore di Kyalami e il successo nella 1000 km di Monza).
Al termine dell’anno la Ferrari non gli rinnova il contratto, lo svizzero passa
alla BRM, squadra giunta alla frutta ma con cui ottiene ugualmente una pole in
Argentina, ma e' destinato a tornare alla rossa dal 1974.
La stagione 1974 inizia bene per Clay, con vari podi. Il campionato e'
equilibrato, e i punti equamente divisi tra la coppia Ferrari Regazzoni-Lauda e
Fittipaldi sulla McLaren. Nel Gran Premio di Monaco, pero', il “Rega” getta
definitivamente al vento la possibilita' di porre una seria ipoteca sulla
conquista del Mondiale. Pressato da vicino dal compagno Lauda quando era in
testa, incappa in un banale testacoda, che lo relega al quarto posto. Una
giornata disastrosa per Clay, che per l’unica volta nella sua carriera esagera
con l’istintivita' e compromette la scalata a quel titolo che aveva sempre
inseguito.
|
 |
La vittoria in Germania sembra rilanciare le speranze di vittoria
finale per lo svizzero ma, dopo il successo tedesco, la lotta tra i due piloti
della Scuderia non viene disciplinata al meglio dai box: nonostante Clay fosse
in testa non gli venne assegnato un vero e proprio ruolo di prima guida, che
senza dubbio meritava anche per il suo lungo passato in rosso.La mancanza di
affidabilita' nelle ultime gare esclude definitivamente Regazzoni dalla
battaglia per il titolo, e Fittipaldi ne approfitta per laurearsi campione
all’ultima gara. L’anno successivo Lauda e' irresistibile, e Regazzoni si deve
accontentare di fare la seconda guida, anche se la sua vittoria a Monza
contribuisce sensibilmente alla conquista del titolo costruttori.
Nel 1976 la
Ferrari ha ancora la monoposto migliore del lotto: lo confermano i due successi
in apertura di campionato in Brasile e Sud Africa, mentre Clay si impone a Long
Beach. Niki Lauda mette pero' in discussione la vittoria dello svizzero nel GP
degli USA Ovest: secondo lui il nuovo responsabile della gestione sportiva
Audetto avrebbe favorito lo svizzero indicando a Lauda di non attaccarlo. I
rapporti di Regazzoni con la Ferrari iniziano a peggiorare, finché il gravissimo
incidente al Nurburgring in cui Lauda rischia la vita crea uno sconvolgimento
notevole a Maranello: in particolare Ferrari non perdona a Clay di aver
disertato il GP d’Austria per un suo incidente durante una partita a tennis. La
Ferrari conquista ugualmente il titolo costruttori, ma nel 1977 si conclude il
capitolo Ferrari per Regazzoni, che viene sostituito da Reutemann, gia'
ingaggiato l’anno precedente per sostituire l’infortunato Lauda. Le annate
successive sono anonime: il 1977 alla Ensign, il ’78 alla Shadow, con povero
bottino di 9 punti e soli piazzamenti nelle due stagioni.
Nel 1979 Regazzoni e'
ingaggiato da Frank Williams, che puo' contare su ingenti finanziamenti
dall’Arabia. Regazzoni dovrebbe fare il secondo di Alan Jones, ma lo svizzero
che rompe invece le uova nel paniere portando il 14 luglio a Silverstone la
prima vittoria della storia, salutato anche dalla Ferrari, ad una Williams
dall’entusiasmo moderato per l’insuccesso personale del suo alfiere Jones.
Dopo l’ulteriore podio sul terzo gradino a Monza,
Clay, destinato ad essere sostituito in Williams ancora una volta da Reutemann,
e' ad un passo dal contratto con la competitiva Brabham per il 1980, ma gli
accordi saltano all’ultimo momento e Regazzoni deve accontentarsi della Ensign.
È proprio con la Ensign che Regazzoni corre l’ultima gara della sua carriera: il
30 marzo a Long Beach, nonostante l’inferiorita' del mezzo, e' al quinto posto e
in piena lotta quando, al 50° giro, Clay cerca in staccata i freni, ma non li
trova; si appoggia cosi' al muretto per tentare di frenare la vettura, ma contro
il muro e' posteggiata la Brabham di Zuniño. Lo scontro e' inevitabile e Clay,
gravemente infortunato alla spina dorsale, rimane paraplegico e non recuperera'
mai l’uso degli arti inferiori. Clay e' comunque un tipo che non si arrende:
perseguisce impegni sociali per la difesa dei diritti dei disabili, scrive libri
e diventa commentatore televisivo. La sua passione per le corse non si era
ancora spenta: con vetture a comandi al volante ha corso ancora in pista e su
sterrato: Raid Panama-Alaska, Carrera Panamericana storica.
Muore in un incidente stradale il 15 dicembre 2006.
|
|
Gran Premio di Russia 2018
Il Gran Premio di Russia 2018
è stata la sedicesima prova della stagione 2018 del campionato
mondiale di Formula 1. La gara, corsa domenica 30 settembre sul
circuito di Soči, è stata vinta dal britannico Lewis Hamilton su
Mercedes, al settantesimo successo nel mondiale; Hamilton ha preceduto
all'arrivo il suo compagno di team, il finlandese Valtteri Bottas e il
tedesco Sebastian Vettel su Ferrari.
Per questo gran premio la Pirelli offre la scelta tra gomme di mescola soft, ultrasoft e hypersoft.
Sono due le zone indicate dalla Federazione Internazionale dell'Automobile ove i piloti possono usare il Drag Reduction System:
la prima zona è posta tra la curva 1 e la curva 2, con punto per la
determinazione del distacco fra piloti posto dopo la curva 18, mentre la
seconda zona è stabilita tra le curve 10 e 13, con detection point fissato prima della curva 10.La prima zona è allungata di 95 metri, rispetto alla configurazione usata fino al 2017.
La Red Bull
Racing decide di utilizzare la vecchia versione del motore Renault
(anche se marchiato TAG Heuer), già in uso prima della gara di
Monza. I piloti della scuderia subiranno così delle
penalizzazioni sulla griglia di partenza
La Honda porta una nuova specifica di power unit per la Scuderia Toro Rosso, coi piloti che subiranno la stessa sorte di quelli della Red Bull.
La McLaren sostituisce vari elementi sulla power unit di Fernando Alonso, che sarà perciò penalizzato sulla griglia di partenza.
Un incendio
scoppiato nella notte tra venerdì e sabato, all'interno del box
della Haas, distrugge due set di gomme allocate per Kevin Magnussen. Il
team ha chiesto due set nuovi alla Pirelli.
|
Sfida alla Ferrari, vince l'aereo
Nella base di Grosseto finisce 2-1 per l'Eurofighter di Cheli il
confronto con la F2003-GA di Schumacher.
Michael: "Che esperienza!".
M.
Schumacher - M-Cheli |
Schumacher Ferrari F1 2300 GA - EuroFighter 2000 Typhoon
GROSSETO, 11 dicembre 2003 - Alla fine ha vinto l'aereo, come da
pronostico. L'Eurofighter Typhoon, pilotato dall'astronauta
Maurizio
Cheli, si è aggiudicato la sfida con la Ferrari F2003-GA di Michael
Schumacher andata in scena sulla pista dell'aeroporto militare di
Grosseto. Il tedesco ha fatto suo il primo confronto di accelerazione
sui 600 metri, mentre il suo avversario si è imposto sulle distanze dei
1.200 e 900 metri. Sono state parecchie le sfide che, in passato, hanno messo di fronte
vetture automobilistiche e velivoli. Le più famose sono quelle che hanno
visto opposte l'Alfa Romeo 8C 2300 di Tazio Nuvolari contro il Biplano
Caproni, nel 1931 a Roma, e la Ferrari 126 di Gilles Villeneuve e l'F104
Starfighter a Istrana (vinta dal pilota canadese sulla distanza di un
chilometro).
|
 |
| 1988 - Visita di Papa Giovanni II a Maranello |
|
|
Michele Alboreto
Michele Alboreto debutta in Formula 1, nel 1981 a San Marino al
volante della Tyrrell-Ford. Gli sono sufficienti due anni per mostrare
agli addetti ai lavori le qualità che
lo renderanno, qualche anno dopo, uno dei più maturi candidati al titolo
iridato. Il matrimonio tra Alboreto e la scuderia britannica porta a due
vittorie, le ultime della gloriosa Tyrrell, entrambe negli Stati Uniti, e
ad un settimo e un dodicesimo posto in classifica generale. Il suo stile di guida,
veloce e grintoso, piace molto
a Enzo Ferrari che, per lui, fa cadere il veto sui
piloti italiani e lo ingaggia nel 1984.
 |
L'anno dopo
è già in lotta per il titolo che, solo sconsiderate
scelte tecniche della Ferrari, glielo fanno perdere.
Alboreto rimarrà l' ultimo pilota italiano ad essere stato scelto
personalmente da Enzo Ferrari, il quale morirà nello stesso anno in cui si
interromperà l' idillio tra la scuderia di Maranello ed Alboreto, il 1988.
Comunque, dopo una prima promettente stagione chiusa al quarto posto in
classifica generale, Michele apre un 1985 nel modo in cui, a Maranello, tutti si
auguravano: dopo il Nuerburgring, nona prova del campionato mondiale, Alboreto
è primo in classifica iridata in virtù delle vittorie in Canada e Germania
e dei numerosi piazzamenti a punti ma, sulla distanza, emerge la maggior
esperienza dell' inseguitore Alain Prost in più, lo stop dello sviluppo da
parte dei tecnici Ferrari, il quale ribalta la situazione e il francese della
McLaren, vince il suo primo titolo mondiale. |
L'anno dopo
è già in lotta per il titolo che, solo sconsiderate
scelte tecniche della Ferrari, glielo fanno perdere.
Alboreto rimarrà l' ultimo pilota italiano ad essere stato scelto
personalmente da Enzo Ferrari, il quale morirà nello stesso anno in cui si
interromperà l' idillio tra la scuderia di Maranello ed Alboreto, il 1988.
Comunque, dopo una prima promettente stagione chiusa al quarto posto in
classifica generale, Michele apre un 1985 nel modo in cui, a Maranello, tutti si
auguravano: dopo il Nuerburgring, nona prova del campionato mondiale, Alboreto
è primo in classifica iridata in virtù delle vittorie in Canada e Germania
e dei numerosi piazzamenti a punti ma, sulla distanza, emerge la maggior
esperienza dell' inseguitore Alain Prost in più, lo stop dello sviluppo da
parte dei tecnici Ferrari, il quale ribalta la situazione e il francese della
McLaren, vince il suo primo titolo mondiale. La delusione in casa Ferrari è
tanta e ancora più grande è l' amarezza di Alboreto: egli non riuscirà
più, negli anni seguenti, a rinverdire i fasti di quella stagione e si troverà
sempre a gareggiare per la conquista di una posizione
secondaria. I risultati parlano di un 8°, di un 7° e di un 5° posto nelle
successive tre annate al volante della "Rossa" e a fine 1988,
nonostante sia già dato per scontato l' arrivo di Nigel Mansell a Maranello, Enzo
Ferrari convoca per l' ultima volta il pilota milanese al fine di chiedergli
le sue intenzioni: Alboreto ritiene che andarsene sia la scelta migliore
e così viene messa la parola fine ad un matrimonio durato cinque anni. Michele
chiuderà la sua carriera passando, nell' arco di tre stagioni, dalla Tyrrell
alla Lola, dalla Footwork alla Minardi, restando però sempre a lottare nelle
retrovie. Dopo la F.1, si dedica alle vetture
sport, vince la 24 ore di Le Mans nel 1997 su
una Porsche in coppia con Johansson, già suo compagno alla
Ferrari. Nonostante i 44 anni e un conto in banca notevole, la febbre per
le corse non l'abbandona e inizia il 2001 con la scuderia AUDI che
corre nella categoria sport. L'obbiettivo è, rivincere la mitica 24 Ore di Le
Mans. Proprio durante le prove in vista di questa gara, Alboreto perde la
vita sul circuito di Dresda.
| La delusione in casa Ferrari è
tanta e ancora più grande è l' amarezza di Alboreto: egli non riuscirà
più, negli anni seguenti, a rinverdire i fasti di quella stagione e si troverà
sempre a gareggiare per la conquista di una posizione
secondaria. I risultati parlano di un 8°, di un 7° e di un 5° posto nelle
successive tre annate al volante della "Rossa" e a fine 1988,
nonostante sia già dato per scontato l' arrivo di Nigel Mansell a Maranello, Enzo
Ferrari convoca per l' ultima volta il pilota milanese al fine di chiedergli
le sue intenzioni: Alboreto ritiene che andarsene sia la scelta migliore
e così viene messa la parola fine ad un matrimonio durato cinque anni. Michele
chiuderà la sua carriera passando, nell' arco di tre stagioni, dalla Tyrrell
alla Lola, dalla Footwork alla Minardi, restando però sempre a lottare nelle
retrovie. Dopo la F.1, si dedica alle vetture
sport, vince la 24 ore di Le Mans nel 1997 su
una Porsche in coppia con Johansson, già suo compagno alla
Ferrari. |
 |
Nonostante i 44 anni e un conto in banca notevole, la febbre per
le corse non l'abbandona e inizia il 2001 con la scuderia AUDI che
corre nella categoria sport. L'obbiettivo è, rivincere la mitica 24 Ore di Le
Mans. Proprio durante le prove in vista di questa gara, Alboreto perde la
vita sul circuito di Dresda. Era il 25 aprile 2001. Con lui se ne và
non solo un grande uomo, sempre disponibile e molto acuto nei suoi commenti sul
mondo dell'automobilismo, ma anche un grande pilota, purtroppo poco
apprezzato in patria, che fece parte dell'ultima generazione di grandi
piloti italiani, insiema a Elio de Angelis e a Riccardo Patrese.
A
tutti i suoi tifosi, comunque, resterà negli occhi e nel cuore
quella stupenda
vittoria in Germania, che permise di coltivare il sogno di un titolo, e
la
cocente delusione che derivò dal vederlo svanire. Voglio infine
ricordare che è stato l'unico pilota italiano, dopo Ascari, a
lottare per il titolo mondiale.
|
Il 10 marzo 1971, al salone dell'auto di
Ginevra, Nina Rindt e la piccola Natascia, figlia di Jochen, ritirano
il "Casco d'oro" della rivista Autosprint.
Natascia volle subito solo per sè il riconoscimento vinto
dal papà.
La nuova Lotus
72 a cuneo era una macchina molto innovatrice, caratterizzata dalla
flessibilità delle sospensioni, barra del fascio di
torsione, radiatori montati, freni anteriori interni e l’ala
posteriore sporgente. I problemi originari della 72 erano dovuti alle
sospensioni, ma una volta risolti la vettura dimostrò la sua
superiorità e la nuova prima guida della Lotus,
l’austriaco Jochen Rindt, dominò il campionato
prima di morire a Monza a causa dell’improvvisa rottura
dell’albero del freno prima di affrontare la Parabolica
durante la sessione di qualifiche.
Fu l’unico a conquistare
il titolo postumo per la Lotus.
|
|
|
Tyrrell
L'ultimo titolo iridato targato Tyrrell fu quello del 1973, anno in
cui Jackie Stewart conquistò per la terza volta il campionato del mondo
dopo i successi ottenuti nel '71 e nel
'69.
 Lo scozzese e la scuderia
di Ockham in quegli anni offuscarono marchi ben più blasonati,
rappresentando di fatto il binomio col quale dovevano fare i conti tutti
quelli che nutrivano ambizioni iridate. Ancora una volta, la storia delle
corse aveva messo in scena un duo formidabile, come era accaduto in
passato con il sodalizio Clark-Lotus che solo la disgrazia di Hockenehim
aveva tragicamente interrotto nel '68. Anche quel '73 della Tyrrell
comunque fu caratterizzato da una tragedia: nell'ultima gara in programma
a Watkins Glen, infatti, Francois
Cévert, destinato a rilevare il posto di
caposquadra lasciato libero da Jackie Stewart, subì un incidente mortale in prova, azzerando di fatto il
team campione del mondo. Da quel momento, la scude Lo scozzese e la scuderia
di Ockham in quegli anni offuscarono marchi ben più blasonati,
rappresentando di fatto il binomio col quale dovevano fare i conti tutti
quelli che nutrivano ambizioni iridate. Ancora una volta, la storia delle
corse aveva messo in scena un duo formidabile, come era accaduto in
passato con il sodalizio Clark-Lotus che solo la disgrazia di Hockenehim
aveva tragicamente interrotto nel '68. Anche quel '73 della Tyrrell
comunque fu caratterizzato da una tragedia: nell'ultima gara in programma
a Watkins Glen, infatti, Francois
Cévert, destinato a rilevare il posto di
caposquadra lasciato libero da Jackie Stewart, subì un incidente mortale in prova, azzerando di fatto il
team campione del mondo. Da quel momento, la scude ria inglese non riuscirà
mai più a ripetere gli antichi fasti, avviandosi lentamente, fra alti e
bassi, ad una penombra che la relegò ai livelli medio-bassi del circus.
Dal 1999 la Tyrrell non esiste più, è stata
rilevata da
Craig Pollock che l'ha ribattezzata BAR. ria inglese non riuscirà
mai più a ripetere gli antichi fasti, avviandosi lentamente, fra alti e
bassi, ad una penombra che la relegò ai livelli medio-bassi del circus.
Dal 1999 la Tyrrell non esiste più, è stata
rilevata da
Craig Pollock che l'ha ribattezzata BAR.
I magici
anni 60
La storia della Tyrrell nasce nella seconda metà degli
anni Sessanta, quando Ken Tyrrell, ex commerciante di legname (da cui il
soprannome di "boscaiolo"), allestisce una scuderia. Alla sua corte arriva
Jackie Stewart e inizia così una collaborazione che darà ad entrambi le
più grandi soddisfazioni. Inizialmente, Tyrrell scende in campo con
monoposto di altri costruttori, mentre la motorizzazione è assicurata da
quel Cosworth che all'epoca equipaggia la maggior parte delle F.1.
Nel
'68, la squadra si presenta ai nastri di partenza iridati con le
Matra-Cosworth affidate a Jackie Stewart e Johnny Servoz-Gavin, e lotta
per il titolo fino all'ultima gara, anche se il campionato sarà poi
conquistato da Graham Hill e dalla sua
Lotus. Il titolo non le sfuggirà
invece nella stagione successiva: Jackie Stewart diventa campione del
mondo utilizzando sempre l'accoppiata Matra-Cosworth. La battuta d'arresto
del '70 coincide con il passaggio dalla Matra alla neonata March, in
attesa che Derek Gardner realizzi la 001: la prima Tyrrell. Una macchina
tanto nuova quanto vincente, visto che, dopo i primi passi stentati
avvenuti nell'ultima parte del campionato '70, è con essa che lo scozzese
ritorna al vertice della F.1 nel '71.
Dalla sei ruote
alla decadenza
 Perso il proprio campione e il suo
sostituto più naturale, come detto, Tyrrell si affida alla coppia Scheckter-Depailler, con Derek Gardner a mantenere ben saldo il timone
tecnico della squadra. Il geniale ingegnere stupisce il Circus nel '76,
quando fa debuttare la sua ultima nata: la P34, la cui caratteristica è
quella del tutto originale di montare sei ruote: due dietro e quattro, più
piccole, davanti. La "sei ruote" come fu subito battezzata la P34, fu
inquadrata dall'ambiente più come una trovata pubblicitaria Perso il proprio campione e il suo
sostituto più naturale, come detto, Tyrrell si affida alla coppia Scheckter-Depailler, con Derek Gardner a mantenere ben saldo il timone
tecnico della squadra. Il geniale ingegnere stupisce il Circus nel '76,
quando fa debuttare la sua ultima nata: la P34, la cui caratteristica è
quella del tutto originale di montare sei ruote: due dietro e quattro, più
piccole, davanti. La "sei ruote" come fu subito battezzata la P34, fu
inquadrata dall'ambiente più come una trovata pubblicitaria che una
monoposto con soluzioni tecniche d'avanguardia (soluzioni sperimentate
anche dalla March, che realizzò anch'essa una monoposto - mai però
utilizzata in corsa- a sei ruote, con la differenza rispetto alla Tyrrell
di avere le quattro ruote sull'asse posteriore anziché su quello
anteriore). Sta di fatto che questa "trovata pubblicitaria", vinse il GP
di Svezia del '76 con una doppietta firmata Scheckter-Depailler. Ma, al di
là di questo successo, proprio questo progetto fu la causa della rottura
del sodalizio storico fra Tyrrell e Gardner. Negli anni successivi,
il team che aveva nel suo palmarès tre titoli iridati, dovette
accontentarsi di tre vittorie, ottenute da Depailler nel '78 a Montecarlo,
e da Alboreto nell'82 e nell'83 a Las Vegas e a Detroit. Da quel momento,
il team non vincerà mai più una corsa, barcamenandosi nel mondiale come
una delle tante squadre spesso sull'orlo della chiusura. Chiusura
puntualmente arrivata, come detto, nel 1999, quando la British American
Racing, rilevò tutto il materiale della Tyrrell per dar vita a una
nuova scuderia. che una
monoposto con soluzioni tecniche d'avanguardia (soluzioni sperimentate
anche dalla March, che realizzò anch'essa una monoposto - mai però
utilizzata in corsa- a sei ruote, con la differenza rispetto alla Tyrrell
di avere le quattro ruote sull'asse posteriore anziché su quello
anteriore). Sta di fatto che questa "trovata pubblicitaria", vinse il GP
di Svezia del '76 con una doppietta firmata Scheckter-Depailler. Ma, al di
là di questo successo, proprio questo progetto fu la causa della rottura
del sodalizio storico fra Tyrrell e Gardner. Negli anni successivi,
il team che aveva nel suo palmarès tre titoli iridati, dovette
accontentarsi di tre vittorie, ottenute da Depailler nel '78 a Montecarlo,
e da Alboreto nell'82 e nell'83 a Las Vegas e a Detroit. Da quel momento,
il team non vincerà mai più una corsa, barcamenandosi nel mondiale come
una delle tante squadre spesso sull'orlo della chiusura. Chiusura
puntualmente arrivata, come detto, nel 1999, quando la British American
Racing, rilevò tutto il materiale della Tyrrell per dar vita a una
nuova scuderia.
|
|
|
|
 |
Il Gran Premio di Francia 1968 fu una gara
di Formula 1, disputatasi il 7 luglio 1968 sul Circuito di Rouen. Fu la
sesta prova del mondiale 1968 e vide
la vittoria di Jacky Ickx su
Ferrari, seguito da John Surtees e da Jackie Stewart. La gara venne funestata da un incidente mortale che coinvolse
il pilota francese Jo Schlesser, perito nell'incendio della sua Honda dopo uno schianto contro le barrerie di protezione.
La Liegi-Roma-Liegi, storica e prestigiosa manifestazione automobilistica iniziata ben
80 anni fa nel 1931.
l |
| 1931 |
l |
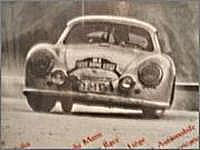 |
 |
 |
 |
| 1950 |
1952 |
1953 |
1953 |
1954 |
Sin dalla sua prima edizione, la
corsa era stata organizzata dall’Automobil Club di Liegi Motor Union ma,
per reinventare il mito e riportarlo nel calendario storico internazionale del
Motorsport, un accordo è stato
trovato fra il Royal Automobil Club del Belgio
(RACB) e la Classic Events, già organizzatrice
di numerose gare riservate a
vetture d’epoca.
Piloti di fama internazionale come Pat Moss, Erik Carlson, Jack Ixck, Eugen
Bohringer hanno avuto l’onore di tagliarne per primi il
traguardo.
| Gran Premio d'Argentina 1996 si è svolto il 7 aprile sul Circuito di Buenos Aires. |
|
Ha vinto Damon Hill su Williams, precedendo il compagno di squadra Jacques Villeneuve e Jean Alesi su Benetton.
Al 24º passaggio Diniz tenta di doppiare Badoer, ma i due vengono a contatto e la Forti
dell'italiano decolla, atterrando a ruote all'aria; Badoer è illeso, ma
la direzione gara manda in pista la safety car. Alcuni piloti, tra cui
lo stesso Diniz, ne approfittano per effettuare il rifornimento; sulla Ligier
del brasiliano, però, il bocchettone del carburante rimane aperto e
della benzina finisce sul motore e sugli scarichi, prendendo fuoco.
La
vettura si incendia, ma Diniz esce illeso dall'abitacolo.
|
 |
| La strage del 1952 al Grenzlandring (costruito prima della Seconda
Guerra Mondiale (nel 1938 o 1939) per scopi militari e rimasto
sconosciuto. Durante la guerra è rimasto intatto e nel 1947 è stato
"scoperto" casualmente ed usato fino al 1952): Helmut Niedermayr con la sua Reif/Veritas-Meteor
Formula 2 va a sbatere alla Roermonder Kurve alla velocita' di 200km/h
uccidendo 14 persone e ferendo ne altre 42... Mi pare che al epoca il
fatto sia stato volontariamente censurato dai media, anche se, dopo un
po' il governo ha deciso che non ci sarebbero state piu' corse sul
circuito...
|
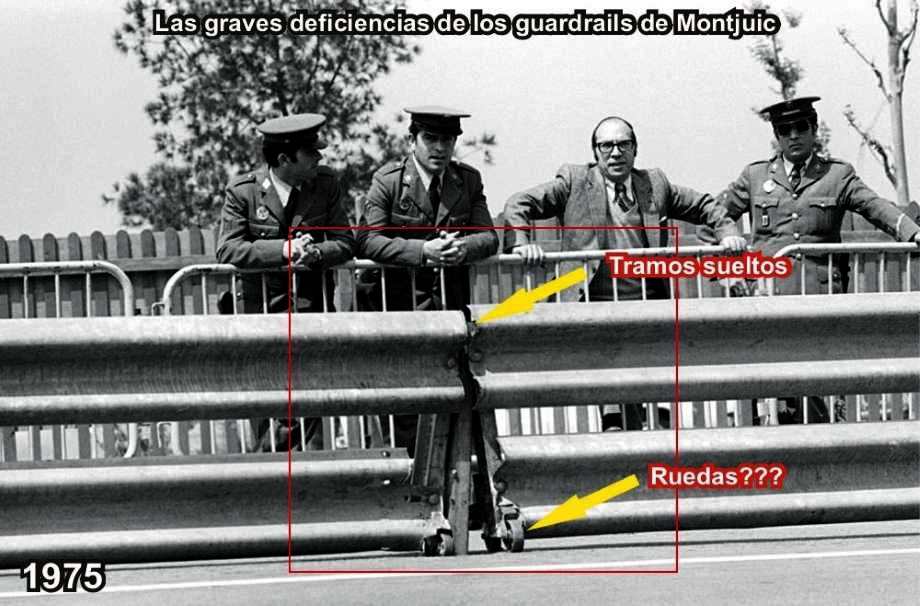
|
Le F1
hanno corso su diversi tracciati cittadini o semi-permanenti nel corso della
storia di questo sport. Uno dei tracciati cittadini su cui le F1 corsero fu il
GP del Montjuich. Parliamo dell'edizione 1975 di questa corsa: l'ultima edizione
di questa gara. Il tracciato del Montjuich già di per sè, come molti cittadini,
non era particolarmente sicuro ma l'edizione '75 risultò particolarmente mal
organizzata. Un'immagine particolarmente eloquente di questo sono i guard-rail
fissati male.
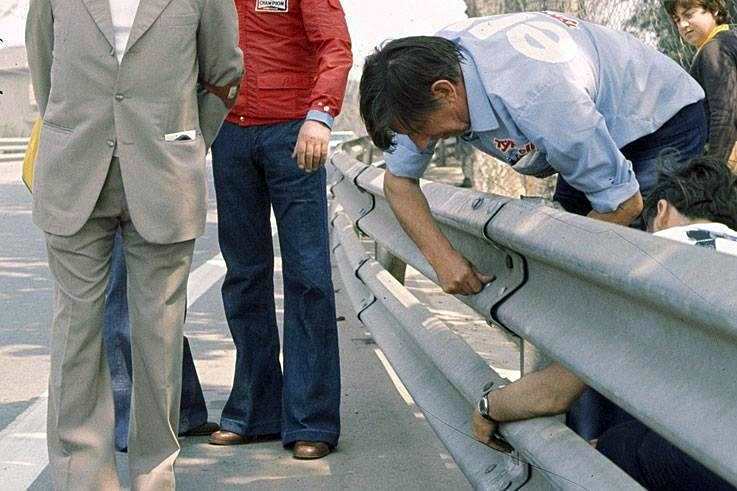 |
| Il guard-rail viene ripristinato da Ken Tyrrell..... (proprietario del Team TYRRELL) |
Emerson Fittipaldi saluta la compagnia il sabato: si rifiuta di
correre in quelle condizioni. Il fratello di Emerson segue il suo esempio. Sono
in molti a voler imitare Fittipaldi: era una F1 più abituata al rischio, ma i
piloti non erano dei pazzi incoscienti e si resero conto subito che correre in
quelle condizioni non aveva senso. Alla fine però gli organizzatori hanno la
meglio e si corre (senza prendere in considerazione le richieste dei piloti) ma
sarebbe stato decisamente meglio annullare la gara. Al via le Ferrari si
auto-eliminano; ad un certo punto, incidente dopo incidente, a guidare la gara
si trova Rolf Stommelen alla guida di una lola del team Hill.
La Lola di
Rolf Stommelen, però, perde l'ala posteriore e vola tra il pubblico. Muoiono 4
persone, si salva invece il pilota Stommelen.
La gara è interrotta e la vittoria
va a Mass. Dopo quella terribile edizione il Montjuich sparisce dal calendario
della F1.
 La Lola di Rolf Stommelen dopo il volo....
La Lola di Rolf Stommelen dopo il volo....
|

Paul Hawkins - Monaco - 1965
|
|
|
Robert Paul Hawkins
(Melbourne, 12 ottobre 1937 – Oulton Park, 26 maggio 1969) è stato un pilota di Formula 1
australiano, morto in un incidente durante la gara automobilistica del
Tourist Trophy sul Circuito di Oulton Park nel 1969 |
Figlio di un pilota motociclistico
dedicatosi poi alla religione, Hawkins cominciò a correre con le berline
in Australia, per poi trasferirsi in Europa insieme all'amico Frank
Gardner in F3 inglese negli anni sessanta.
Nel 1965 fece il
suo debutto in Formula 1 al Gran Premio del Sudafrica non andando oltre
il nono posto. Al successivo appuntamento di Monaco fu protagonista di
un singolare incidente divenendo l'unico pilota insieme ad Alberto
Ascari a cadere nelle acque del porto con la propria vettura. Prese
parte alla sua ultima gara in Formula 1 in Germania, ritirandosi.
Dopo questa esperienza si dedicò alle gare per vetture sport,
ottenendo diversi successi tra cui il più importante fu la vittoria
della Targa Florio nel 1967. Morì però nel 1969 durante il Tourist
Trophy schiantandosi contro un albero.
|
 2001:L'ultima di Hakkinen. 2001:L'ultima di Hakkinen.
|
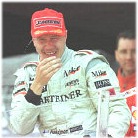 Il
30 Settembre 2001 Mika Hakkinen ha messo a segno la ventesima e ultima vittoria
della sua brillate carriera; ad Indianapolis, a bordo di una Mclaren MP4-16 ha
battuto tutti, sbucando quasi dal nulla: nessuno avrebbe scommesso su questo
risultato, le caratteristiche del circuito sembravano favorevoli alla Ferrari e
alla Williams BMW, in casa McLaren non si pensava quindi che quello di
Indianapolis sarebbe stato un pomeriggio da ricordare; oltretutto il "Finlandese
Volante" aveva annunciato alcuni giorni prima che avrebbe preso un anno di pausa
... Il
30 Settembre 2001 Mika Hakkinen ha messo a segno la ventesima e ultima vittoria
della sua brillate carriera; ad Indianapolis, a bordo di una Mclaren MP4-16 ha
battuto tutti, sbucando quasi dal nulla: nessuno avrebbe scommesso su questo
risultato, le caratteristiche del circuito sembravano favorevoli alla Ferrari e
alla Williams BMW, in casa McLaren non si pensava quindi che quello di
Indianapolis sarebbe stato un pomeriggio da ricordare; oltretutto il "Finlandese
Volante" aveva annunciato alcuni giorni prima che avrebbe preso un anno di pausa
...
Non si trattava un appuntamento atteso da Mika con
ansia: quando a Monza ha avuto l'incidente alla Lesmo (durante le qualifiche) ha
iniziato a pensare se fosse il caso di non correre le ultime gare, quasi il
botto di Monza fosse un campanello d'allarme; gli dispiaceva inoltre che non ci
sarebbe stato con lui il suo ingegnere di pista, Mark Slade, rimasto in
Inghilterra per stare accanto alla compagna in attesa. L'avrebbe sostituito Mark
Williams, una persona molto competente ma non sarebbe stata comunque la stessa
cosa ... oltretutto l'atmosfera che avrebbero trovato ad Indianapolis, dopo
quello che era accaduto a New York ... si può affermare che non si trattava del
GP a cui Mika e gli altri piloti avrebbero voluto partecipare ...
Questa di Indianapolis era l'ultima gara di Jo
Ramirez, coordinatore del team McLaren, quindi nel paddock l'atmosfera era quasi
da "ultimo giorno di scuola"; era uno splendido pomeriggio, dove quelli che non
sarebbero andati in Giappone facevano a gara per avere una foto assieme a Mika.
Il Venerdì, dopo le libere Mika ha avuto buone e
cattive notizie: era il più veloce, la macchina era ben bilanciata ma aveva
grossi problemi di blistering sulle Bridgestone posteriori, la mescola più dura
sembrava la meno stabile; insieme ai suoi ingegneri ha osservato i dati della
telemetria e ha optato per la mescola più morbida, anche una volta individuati i
punti del circuito dove avrebbe potuto risparmiare i pneumatici dosando al
meglio l'accelleratore o convivendo con un po' più di sottosterzo.
Il Sabato in qualifica è quasi riuscito a dare la
zampata vincente, e si è ritrovato in prima fila a 0"2 da Michael Shumacher, che
era invece sulle Bridgestone dure; il fatto di partire davanti lo rendeva
ovviamente molto felice.
Il giorno dopo il warm-up si è svolto regolarmente
sino a quando il BMW di Montoya non ha inondato la pista d'olio ... la sessione
è stata interrotta per 10'; quando è ripartito ha lasciato sulla sua destra una
fila di monoposto ferme, convinto che dovessero provare una partenza, ma così
non ha visto il semaforo rosso.
 La macchina era perfetta, eveva più carburante del
compagno di squadra, ma comunque si sentiva molto veloce; poi, senza nessuna
avvisaglia, all'ingresso di una curva gli anteriori si sono bloccati: ha cercato
di riprendere il controllo, senza riuscirci, e la macchina ha sbattuto contro le
barriere di protezione. La macchina era perfetta, eveva più carburante del
compagno di squadra, ma comunque si sentiva molto veloce; poi, senza nessuna
avvisaglia, all'ingresso di una curva gli anteriori si sono bloccati: ha cercato
di riprendere il controllo, senza riuscirci, e la macchina ha sbattuto contro le
barriere di protezione.
Così si è ritrovato ai box assieme ai suoi
meccanici: il telaio è risultato perfetto, nonostante l'incidente, così la
monoposto è stata riassemblata in fretta dai suoi ragazzi; poco dopo ha avuto
comuncazione della penalità inflittagli dai commissari, che non stettero a
sentire le sue spiegazioni: era uscito dalla pit lane con il rosso, avrebbe
quindi preso il via con il suo secondo miglior tempo, ovvero dalla quarta
piazza.
Si arriva così al via: dopo una partenza regolare
si è concentrato per percorrere il primi giri come stabilito: dosava
l'accelleratore, senza strafare in modo da risparmiare più a lungo possibile i
pneumatici posteriori. Ferrari e Williams intanto erano sempre in vista, non
stavano prendendo il largo.
Ralf Shumacher si è fermato presto per il pitstop,
Barrichello poco dopo; Montoya, che aveva appena superato Shumacher, ha
parcheggiato la monoposto lungo il rettilineo nel 38° giro.
Michael è rientrato, lasciando a Mika il comando;
aveva ancora carburante per alcuni giri e i pneumatici ancora perfetti: ha
letteralmente volato prima del pitstop, sfruttando al massimo le Bridgestone,
accuratamente preservate nella prima parte di gara, guadagnando così un margine
sufficiente su Michael Shumacher.
A questo punto Rubens era di nuovo al comando, ma
doveva effettuare una nuova sosta; una volta effettuata è rientrato a 5" da Mika
mentre Michael, terzo, sembrava innoquo: forse la scelta delle Bridgestone più
dure si stava rivelando un errore ...
Mika ha guidato con la massima cautela possibile,
cercando di non commettere errori, mentre il vantaggio su Rubens si riduceva a
2"; si aspettava dei giri piuttosto tirati, conscio della necessità di
concentrarsi al massimo, ma ad un certo punto Rubens è sparito dai suoi
specchietti.
Dai box è stato avvertito via radio che Rubens si
era ritirato per un problema al motore, ed è stato invitato a rallentare,
consiglio che lui ha puntualmente seguito ...
Dopo aver tagliato il traguardo Michael l'ha
affiancato e l'ha applaudito; lui ha portato le mani al cielo: quel che si dice
una condotta di gara perfetta ...
|
|
|
Morto Cooper, padre geniale della Mini
All'età di 77 anni si è spento ieri a Londra il creatore di uno dei simboli
degli anni Sessanta,
l'utilitaria snob
LONDRA - E' stata un mito degli anni Sessanta. Una leggenda pari a qualla
dei Beatles. Amata da più di tre generazioni di automobilisti, la Mini ha perso
ieri uno dei suoi più geniali 'trasformatori': John Cooper, colui che all'umile
modello madre della Mini, creata da Sir Alec Issigonis nel 1959, tolse l'aspetto
di semplice utilitaria per donarle, con ritocchi al motore e al design, un
destino di auto 'cult' nel mondo dell'automobilismo da corsa.
Cooper, malato da tempo di cancro, è morto ieri all'età di 77 anni a Londra,
lasciando la moglie Paola e la figlia Sally. Doug Nye, scrittore esperto di gare
automobilistiche e amico di famiglia Cooper, ha detto che con la morte del padre
della Mini si è perso un uomo che era "una rarità nel mondo delle auto da corsa,
uno che non aveva rivali. Cooper piaceva ed era rispettato da tutti e
sicuramente le sue conquiste in questo campo sono state enormi".
 |
|
Il Gran Premio d'Argentina 1958
fu la prima gara della stagione 1958 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 19 gennaio sul Circuito di Buenos Aires.La corsa vide
la vittoria di Stirling Moss su una Cooper T43
iscritta dal Rob Walker Racing Team.
Fu la prima vittoria per una
squadra privata e per un'automobile a motore posteriore.
Secondi e
terzi classificati i ferraristi Luigi Musso e Mike Hawthorn.
|
La Cooper Car Company fu infatti la prima casa britannica di motori da corsa a
vincere il campionato dei costruttori di Formula 1. Furono loro ad avere l'idea
di mettere il motore dietro la carlinga e tutte le auto da Formula 1 seguirono,
con successo, l'esempio di Cooper. Trasformazioni quelle fatte da Cooper sulla Mini che l'hanno resa la beniamina
di almeno tre generazioni di automobilisti. Patito delle auto che pensava ai
motori anche di notte, John Cooper riuscì a proporre una variante da mito
dell'utilitaria diventata uno dei simboli dei "Roaring Sixties" e della
"Swinging London".
Truccò il motore, modificò la carrozzeria, si inventò
una vernicatura bicolore verde e bianca: la Cenerentola della strada diventò
così una reginetta della velocità che fece innamorare migliaia di appassionati
di guida sportiva. Per le sue dimensioni contenute e la sua tenuta di strada nei
rally e in certe competizioni era un bolide imprendibile e i piloti che ne hanno
preso il volante hanno trionfato in innumerevoli gare.
Da insaziabile
amante dei motori quale era, John Cooper fondò e diresse anche una scuderia di
Formula Uno sotto i cui colori hanno gareggiato personaggi del calibro di
Stirling Moss e Jack Brabham.
 |
FEBBRAIO 1962
Nei test di Goodwood, con la Lotus T18 Climax, Moss e vittima di un
terribile incidente che pone fine alla sua carriera.
|
|
 |
|
|
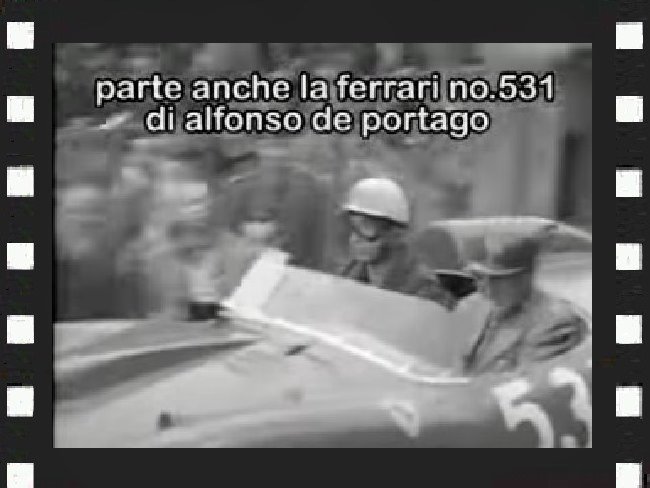
1957 Mille Miglia - la morte Alfonso De Portago
De Portago 1000 Miglia 1957, l’ultimo rettilineo.
Corte Colomba la fine del mito
Alfonso de Portago (a sinistra) assieme al navigatore Edmund Nelson
alla partenza della Mille Miglia 1957
L’uscita della curva è veloce e davanti si apre il lungo rettifilo nel mezzo della pianura.
Al lato esterno una fila di alberi precede il fosso che scorre vicino
alla banchina di terra prima di raggiungere l’asfalto tra Cerlongo e
Guidizzolo.
Uguale dalla parte opposta.
Il dodici cilindri della rossa Ferrari n. 531 si apre
ad urlo su questa strada che va via come una fucilata per quasi 5 km. In
leggera discesa prima di raggiungere le case del paese. La mano di De
Portago lascia meccanicamente la leva del cambio e ritorna sul volante
serrando le dita per fronteggiare meglio le solite vibrazioni dello
sterzo ormai affaticato dai tanti chilometri percorsi. Le
dita stringono il volante mentre un sospiro di tensione percorre il
corpo. Il piede destro con decisione preme l’acceleratore. Sa che
mancano ormai pochi chilometri all’arrivo e forse il sorpasso a
Gendebien si sta concretizzando. Qui la 335 S è molto più veloce della
250 GT del compagno di squadra. Gli occhi stanchi ed arrossati fissano
il sottile filo nero dell’asfalto cercando un riferimento negli alberi
che si aprono sempre più velocemente. Occorre stare al centro della
strada tenendo “giù” il piede fino all’apparire delle prime case dove
bisogna passare al freno. Fino alle case però la strada è dritta e si
deve spingere al massimo. |
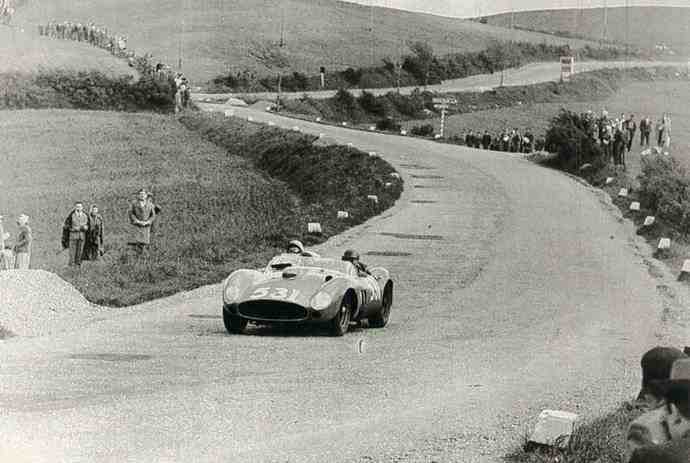
Loro, gli altri, gli spettatori, sono fermi lungo il ciglio della
strada con il giornale tra le mani per cercare di leggere il numero
dipinto sulle macchine che passano. E’ gente semplice, contadini
che, lasciata la vita dei campi in questo giorno di festa, si sono
assiepati in piccoli gruppi lungo il rettifilo che porta a
Guidizzolo.Quello con il giornale legge ad alta voce i nomi dei piloti
e i modelli delle macchine. Battono le mani, salutano, ridono, si
stupiscono.
I bambini hanno gli occhi grandi ed ogni tanto si
“beccano” qualche rimprovero se non qualche
“scappellotto” perché si muovono troppo
pericolosamente lungo la strada. Le madri non sono tranquille. Questa
modernità così tanto lontana e sconosciuta, le rende
apprensive, timorose. L’urlo del motore possente si avverte da
lontano.La Ferrari…..arriva la Ferrari…… la
Ferrari…….ma ecco il diverso rumore, il sibilo ferreo di
qualche cosa che stride, poi…….la modernità piomba
urlante dentro gli occhi grandi pieni di terrore……. |
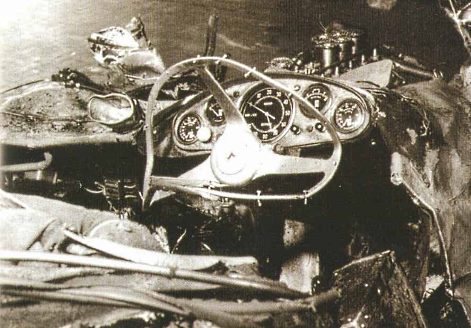 |
|
 |
 |
|
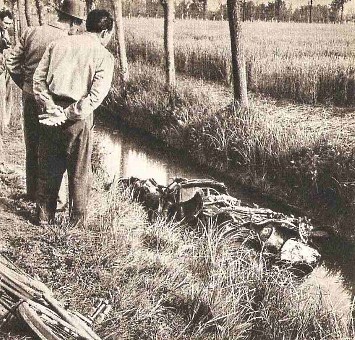 |
|
All’altezza del km. 21 in località Corte Colomba di Cavriana, è
scoppiata la gomma anteriore sinistra. Sono circa le 16.03. La Ferrari
Sport 335 S numero di gara 531, prosegue la sua corsa
per altri 28 metri spostandosi leggermente verso sinistra.
De Portago fa
una prima correzione ma a circa 38 metri dal punto dello scoppio, la
Ferrari punta decisamente il ciglio di sinistra e lo taglia a una
distanza di 92,50 metri.Il pilota fa una nuova correzione ma la macchina
non risponde e va dritta verso un paracarro di sasso posto a 118,90
metri.
L’impatto è terrificante. Il grosso paracarro viene tranciato di
netto e la parte superiore vola a 36 metri di distanza.Considerato il
peso del paracarro di circa 40 kg. si calcolerà che l’impatto è avvenuto
attorno ai 200 km/orari. |
La Ferrari si alza da terra spezzando un successivo palo telefonico ad
un altezza di 160 cm. dal suolo. A questo punto la vettura,
probabilmente capovolta, inizia la sua tragica scia di sangue falciando
le persone che sostano sulla riva del fosso e nello spiazzo all’ingresso
della Corte strisciando sull’erba fino ad un nuovo urto che la proietta
per aria facendole attraversare tutta la sede stradale. Lo scontro con
un secondo paracarro posto 10 metri più avanti la fa girare su se stessa
prima di terminare la corsa dentro al fosso di destra dopo aver
travolto altri spettatori.
I rumori, le urla, gli schianti.
Sul terreno resta la festa di una tragedia……………
Il ventottenne Alfonso de Cabeza de Vaca, 17° marchese De Portago ed il giornalista americano Edmund Gurner Nelson
muoiono sul colpo mentre restano sull’asfalto in un tributo di carne le
piccole vite di Virginia Rigon, Carmen Tarchini, Bernardino Rigon,
Anita Boscaini, oltre a diversi feriti.E’ il secondo grave incidente e l’ultimo che la Mille Miglia paga dopo il dramma del 1938 a Bologna dove la Lancia Aprilia di Bruzzo-Mignanego sbandando sui binari del tram, investì ed uccise dieci spettatori tra cui sette bambini.
Corte Colomba segna la fine della più grande corsa su strada,
criminale come dicono i suoi detrattori, fantastica e travolgente come
sostengono gli estimatori.
Dopo la tragedia di questa soleggiata domenica 12 maggio 1957 la bufera
si abbatte sull’automobile e su Enzo Ferrari. Imputato di omicidio
colposo e lesioni personali verrà assolto il 26 luglio 1961 per non aver
commesso il fatto.
Molte sono le supposizioni e le spiegazioni del tragico evento di Corte Colomba.
Sul luogo della strage fu successivamente eretto un monumento commemorativo sulla SS236.
Corte Colomba segna la fine della più grande corsa su strada,
criminale come dicono i suoi detrattori, fantastica e travolgente come
sostengono gli estimatori.
Dopo la tragedia di questa soleggiata domenica 12 maggio 1957 la bufera
si abbatte sull’automobile e su Enzo Ferrari. Imputato di omicidio
colposo e lesioni personali verrà assolto il 26 luglio 1961 per non aver
commesso il fatto.
Molte sono le supposizioni e le spiegazioni del tragico evento di Corte Colomba.
Sul luogo della strage fu successivamente eretto un monumento commemorativo
sulla SS236.
|
 Monumento ai Caduti della Mille Miglia situato
Monumento ai Caduti della Mille Miglia situato
sul punto in cui avvenne l'incidente
|
|

 |
Piero
Taruffi si appresta a partire da Brescia per la XXIV Mille Miglia, che
lo vide vincitore in quella sfortunata edizione conclusasi con la morte
di Alfonso De Portago e del copilota Ed Nelson.
L'Ingegnere come veniva
chiamato nel mondo delle corse, era un ottimo stradista ed abile
collaudatore. Si racconta che un giorno provando una vettura sport a
300 km/h, si accorse che un cuscinetto della ruota anteriore
"fischiava". Dopo la vittoria alla Mille Miglia, come promesso alla
moglie e a Ferrari, Taruffi si ritirò dal mondo delle corse
lasciando un segno indelebile di un gentleman di altri tempi.
Qui lo vediamo alla partenza con la sua vettura da gara, una Ferrari
315 S, mentre attende il finale del conto alla rovescia prima del via.
De Portago è partito da 4 minuti verso la sua ultima
"cavalcata".
|
|
|
Gran Premio di Tripoli 1938
|
Tra i piloti della categoria GP, c'era anche Eugenio Siena, 33 anni,
con un passato di collaudatore all'Alfa Romeo e cugino del grande
Giuseppe Campari. Fu anche meccanico di Enzo Ferrari quando il futuro
Drake era pilota della Casa milanese.
Eccolo ai box di Tripoli.
 |

All'ottavo giro , l'appuntamento col destino.
|
Dopo l'interminabile rettilineo dei box, Siena si trovò a dover doppiare
un'auto, forse la piccola Maserati 6CM di Franco Cortese.
L'alfista si
portò sulla sinistra, ma le ruote finirono oltre il ciglio della strada.
Dalle tracce che vennero rilevate sull'asfalto, sembra che il pilota
tentò disperatamente di riportare la macchina sull'asfalto, sterzando
bruscamente verso l'interno della curva, ma l'auto, dopo aver percorso
una dozzina di metri di traverso, finì sulla sabbia volando su una duna e
sbattendo violentemente contro una casa.
Eugenio morì sul colpo.
|
Da Lauda a Montoya: come si costruisce un campione.
La storia della formula 1, è piena di piloti promettenti che si perdono dopo
poche gare e di altri che, invece ottengono più di quello che realmente
meritano.
Nello sport come nella vita, il carisma, la capacità di comunicare, sono fondamentali per il successo.
Oggi, un giovane che voglia intraprendere la carriera di pilota, prima di
dimostrare il suo valore in pista deve sapersi circondare di persone che lo
spingano nella direzione giusta, che riescano ad imporlo come personaggio.
 Il
pioniere di questo modo di intendere le corse, è sicuramente Niki
Lauda. Prima di approdare alla Ferrari, era un perfetto sconosciuto, non
aveva mai vinto nulla ed era sempre più lento dei suoi compagni di squadra. Il
pioniere di questo modo di intendere le corse, è sicuramente Niki
Lauda. Prima di approdare alla Ferrari, era un perfetto sconosciuto, non
aveva mai vinto nulla ed era sempre più lento dei suoi compagni di squadra.
Ronnie Peterson
era regolarmente più veloce di almeno cinque decimi al giro ma, lo
svedese, pensava solo a guidare senza curare le pubbliche relazioni e,
infatti, non ebbe mai l'opportunità di guidare una vettura competitiva.
Niki, invece, ha sfruttato il fatto di essere stato scelto da Ferrari,
per attirare su di sé l'attenzione degli sponsor e di tutto il
team, proteso a dimostrare che il Drake aveva visto giusto.
Quando lascia la Ferrari per un team meno competitivo è in
difficoltà e, di nuovo, stenta a tenere il passo dei compagni
e dell'astro nascente Nelson Piquet, tanto da ritirarsi.
E' poi richiamato da Ron Dennis che ha bisogno di un uomo immagine per risollevare il marchio McLaren.
I tifosi di Niki sostengono che sia stato lui l'artefice della rinascita del team
McLaren. In realtà la maggior parte del merito è da attribuire all'altro
pilota dell'epoca, John
Watson.
Lauda è stato un grande maestro. Piquet, suo compagno alla Brabham, è sempre riuscito ad avere una scuderia che lavorasse solo per lui,
Prost
era un pilota velocissimo ma inconcludente e solo dopo essere stato
compagno di Niki, ha iniziato a vincere titoli mondiali e ad avere un
notevole peso politico.
Michael Schumacher
si è mosso in questo senso fin dall'inizio
e, guidato dal manager Willy Weber, è riuscito ad avere sempre un team
costruito su misura per lui. I successi sono, di conseguenza, arrivati
subito.
Basta vedere i nomi dei suoi compagni di squadra o leggere le dichiarazioni di Herberth al riguardo per averne la prova.
Per favorire un pilota rispetto ad un altro, basta "giocare" con
l'elettronica. La stagione 1999 è un esempio evidente. Dopo l'incidente
di Schummy,
Eddie Irvine
è diventato all'improvviso, un pilota vincente quel tanto che basta per
conquistare il titolo costruttori, non quello piloti, quello doveva
assolutamente vincerlo Schumacher.
 Ora,
il nuovo astro nascente, sembra essere il colombiano Juan Pablo Montoya. Ora,
il nuovo astro nascente, sembra essere il colombiano Juan Pablo Montoya.
Nel 1999, si diceva che Zanardi
non valeva niente perchè era più lento di Ralf
Schumacher di 3 - 4 decimi al giro, Montoya è più lento di 6 decimi
ed è un campione? Credo che questo sia veramente il colmo e la dimostrazione di
quanto affermo.
Tutto questo per far capire quanto sia relativo stabilire se un pilota è migliore di un altro e non per sminuire le doti
dei piloti che ho citato che, sicuramente, sono stati fra i più forti della
storia. Molti sono spariti proprio perchè non hanno saputo gestire
questo aspetto della carriera. Oltre al già citato Peterson, mi viene in mente Alboreto
che rifiutò la McLaren per la Ferrari, Alesi
che rifiutò la Williams. Quanto sarebbe cambiata la loro storia se fossero
stati indirizzati meglio? Frentzen
era considerato il pilota tedesco più veloce, persino di Schumacher. Luca
Badoer ha vinto tantissimo nelle formule minori e batteva regolarmente Damon
Hill e Coulthard
eppure, questi piloti, non sono riusciti ad imporsi.
riusciti ad imporsi.
Permettetemi di escludere da questo discorso un pilota che, come
risultati, non può essere paragonato con nessuno. Prima di arrivare in
formula uno, vinse il
70% delle corse disputate e si parlava di lui come di un futuro campione, già
nel 1981 quando correva in F.Ford.
Poteva vincere la sua prima gara già al sesto gran premio con una vettura che, prima del suo arrivo, a stento si qualificava. La vittoria gli fu rubata per i motivi
politici e di sponsor.
Malgrado questi risultati, ha avuto la prima vettura competitiva solo al quinto anno di F.1, è stato osteggiato dalla
F.I.A., perché osava criticarla e offuscava la fama del suo pilota prediletto, Alain
Prost.
Il suo nome, per chi non lo avesse capito, era Ayrton Senna da
Silva.
|
|
|
Il 1937 è un anno tragico per Nuvolari.
Poche corse, una sola vittoria, la morte del primogenito Giorgio e un brutto incidente a Torino
|

Gran Premio della Repubblica Ceca del 1937 - L'incidente di Hermann Lang, causò la morte di 2 spettatori e 12 feriti.
|
 La tragedia di Monza. La tragedia di Monza.
|
MONZA - (10 Settembre 2000)
 Si temeva la prima variante ma è alla Roggia che si scatena il
finimondo.Barrichello tenta il sorpasso ai danni di Trulli, ma il
brasiliano viene toccato da Frentzen che, dopo il contatto con il
ferrarista, si gira e va a toccare Trulli. A questo punto il caos diventa
totale: si alza un polverone enorme, macchine incontrollabili che si incastrano,
detriti che vengono "sparati" ovunque. Si temeva la prima variante ma è alla Roggia che si scatena il
finimondo.Barrichello tenta il sorpasso ai danni di Trulli, ma il
brasiliano viene toccato da Frentzen che, dopo il contatto con il
ferrarista, si gira e va a toccare Trulli. A questo punto il caos diventa
totale: si alza un polverone enorme, macchine incontrollabili che si incastrano,
detriti che vengono "sparati" ovunque.
La Arrows di De La Rosa, che giunge dalle retrovie, si ritrova nel pieno
della confusione e, al contatto con un cordolo, si stacca da terra e comincia
una terribile serie di giravolte in aria, finendo addosso a Barrichello ormai
fermo nella sabbia.
Alla fine le macchine coinvolte nel terribile incidente sono 5: Barrichello,
Coulthard, Trulli, Frentzen e De La Rosa. Esce la safety car, macchine
superstiti e piloti in fila indiana. Alla fine i coinvolti escono sulle proprie
gambe da quanto rimane delle vetture, ma chi ha la peggio e’ un uomo del
servizio antincendio, colpito da un detrito impazzito.Le sue condizioni
purtroppo peggioreranno rapidamente fino alla inutile, disperata corsa in
ospedale.
L’addetto al servizio antincendio, Paolo Gislimberti 33 anni di
Trento, si trovava a lato della pista dove si è verificato l’incidente.Il
volontario è stato colpito da una serie di detriti schizzati letteralmente
dalla pista e ha riportato importanti ferite alla testa e alla scatola toracica.
La situazione è apparsa immediatamente grave, i medici di soccorso hanno
praticato allo sfortunato un massaggio cardiaco ma si capiva chiaramente che la
situazione era grave.Trasportato d’urgenza all’ospedale di Monza, pareva
avere superato il momento critico ma purtroppo il sopraggiungere di una nuova
crisi è risultata fatale.
Heinz Harald Frentzen risponde al coro di critiche che lo accusano di
essere l’unico responsabile dell’incidente della Roggia, nel quale ha perso
la vita il giovane addetto antincendio Paolo Gislimberti. In particolare
era stato Rubens Barrichello, speronato dalla Jordan del tedesco,
a scagliarsi contro di lui con violenza, accusandolo e proponendone la
sospensione per dieci gran premi. Da una ricostruzione dell’accaduto tramite
immagini televisive si è accertato che è stata una ruota del tedesco a colpire
lo sventurato ragazzo, ma Frentzen non ci sta a sentirsi incolpato addirittura
di omicidio.
"Io penso che chi mi conosce sa che nella mia carriera non sono mai
andato a cercare rischi inutili alla partenza - risponde il pilota della Jordan
- non ho certo la fama di uno che rimane coinvolto spesso negli incidenti. Il
primo giro è sempre la parte più rischiosa di una gara ed è inevitabile che
se diverse circostanze accadono, i rischi di una collisione sono molto alti. Ma
così come hanno dimostrato le indagini fatte dopo la gara, si è trattato
unicamente di un incidente di corsa, come ne accadono tanti, solo che questa
volta ha portato conseguenze tragiche. Il mio dolore è enorme ma non ho ucciso
io quel povero ragazzo".
Il tedesco non se la sente di condannare neanche il comportamento di
Barrichello, davvero infuriato con lui durante e dopo la gara."Ho sentito
che Rubens mi ha accusato di tutto l’incidente. Nel suo caso, posso capire i
suoi sentimenti perché guidare una Ferrari a Monza è una
situazione molto particolare ed essere usciti al primo giro è una delusione. Ma
le responsabilità negli incidenti non sono così semplici da attribuire come
vorrebbe far credere lui".
|
|
| Gran Premio di Spagna 1969 |

Jochen Rindt
 |
Il Gran Premio di Spagna 1969, XV
Gran Premio de España di Formula 1 e seconda gara del campionato
di Formula 1 del 1969, si è disputato il 4 maggio sul Circuito
del Montjuïc ed è stato vinto da Jackie Stewart su
Matra-Ford Cosworth.
La gara sarà caratterizzata da un proliferare di alettoni sempre più
grandi sulle vetture. Il cedimento dei supporti dell'alettone posteriore
sulle due Lotus di Hill e Rindt, nello stesso punto porterà la
Commissione sportiva internazionale a intervenire con un repentino
cambio di regolamento a partire dalla seconda giornata di prove del
successivo Gran Premio di Monaco.
|
|
 |
Ignazio Giunti
Ignazio Giunti nacque a Roma il 30 agosto
1941. Iniziò
a correre nel 1961 con un’Alfa Romeo Giulietta TI. Dopo il debutto con la Giulietta iniziò a
correre con le GTA. L’anno determinante per Giunti fu il 1966,
quando la scuderia Jolly Club di Milano gli mise a disposizione una GTA
per il campionato assoluto. Gli ottimi risultati conseguiti gli permisero, l’anno
successivo, di entrare all’Autodelta, il distaccamento sportivo
dell'Alfa Romeo. Qui Giunti si dimostrò pilota valido
sia con la nuova vettura sport-prototipo, la 33, sia con la GTA. E proprio
con la GTA si aggiudica il campionato europeo della montagna categoria
Turismo.
 |
Nel 1968 gli viene affidata una nuova
versione della 33 con la quale, insieme a Nanni Galli, corre nel
Campionato mondiale Marche. In quell’anno si laurea campione italiano
della categoria Sport – Prototipi.
Per tutto il 1969 la
laboriosa messa a punto della nuova 33-3 pregiudicò anche le prestazioni
del pilota romano. A fine stagione tuttavia lo chiama Ferrari per
ingaggiarlo come pilota ufficiale.
Nel 1970, le
notevoli affermazioni di Giunti nel Campionato mondiale Marche con la
Ferrari 512S, segnarono la sua definitiva affermazione fra i piloti di
fama mondiale. Ciò convinse Ferrari ad affidargli anche una F.1 e a fine
anno Giunti è campione italiano assoluto. |
Nel 1971 il pilota romano avrebbe dovuto gareggiare,
oltre che nel Campionato mondiale Marche con la nuova 312 P, anche in
qualche prova di formula 1. Invece trovò la morte il 10 gennaio di
quell’anno sul circuito di Buenos Aires, mentre dominava
Giunti tallonava la Ferrari 512 del doppiato Mike Parkes,
quando la pista venne inspiegabilmente occupata dalla Matra in avaria di
Beltoise, che il pilota francese stava spingendo a mano verso i box!
Parkes evitò l’ostacolo mentre Giunti non fece in tempo: la sua Ferrari si
schiantò contro la Matra. con la Ferrari
312 P la "1000 Km". |
 |
|
|
AUTODROMO di
MODENA
Modena
ed i motori, un connubio che viene da lontano, ancor prima che in città si
pensasse
di costruire delle strutture destinate alla corse
automobilistiche.
Le prime gare si
svolsero su tracciati stradali, come era uso all’epoca; infatti il Circuito di
Modena, che fu organizzato dal 1927 al 1947, si svolse sulle strade cittadine.
Le prime due edizioni si corsero su un tracciato extraurbano di 12 km (Via
Emilia-Via Scartazza-Via Vignolese ritornando sulla Via Emilia per Via Sabatini)
da percorrere trenta volte e furono entrambe vinte da Enzo Ferrari su Alfa. Le
successive edizioni del Circuito di Modena si svolsero nel cuore della città,
sull’anello dei Viali (3,2 km per 40 volte), con tre vittorie consecutive
di
Tazio Nuvolari e due di Franco Cortese.
L’ottava e ultima edizione, del 28
settembre 1947, fu interrotta prima del termine a causa di un brutto incidente.
Da quel momento in poi, cominciò a farsi strada l’esigenza di avere una vera
pista, ove fosse possibile gareggiare
con le moderne vetture e
motociclette.
Era il 7 marzo 1948,
data in cui l’Automobil Club d’Italia si riunì a Milano. In quella sede
l'avvocato Camillo Donati, vice presidente dell'ACI di Modena illustrò in tutti
i particolari l’importanza della realizzazione di un impianto sportivo nella
città di Modena, presentando il progetto
realizzato dal geometra Enzo Dalaiti.
L'area destinata alla
costruzione dell'impianto venne identificata in quel terreno che anche oggi
ritroviamo parallelo allavia Emilia e che già dal 1910 ospitava una pista
d’atterraggio per aerei e un attracco per dirigibili. La zona era delimitata a
nord dalla via Emilia, a sud dalla via San Faustino, a ovest dalla via Formigina
(che nel tratto parallelo all’impianto, e oggi al parco, divenne Viale
dell’Autodromo) e a est dal muro perimetrale del complesso militare una volta noto come Ottavo Artiglieria e ancora oggi come 6° Campale.
|
Galleria
Fotografica
Il via ufficiale ai lavori
di costruzione venne dato il 28 marzo 1949 con un contributo comunale di 15
milioni in tre anni, assegnati ai presidenti dell'Aereo Club e ACI. Già il 12
dicembre successivo la pista d’aviazione era operativa e venne inaugurata. Per
le gare automobilistiche si dovette attendere la primavera dell’anno successivo,
ma il primo traguardo era già stato tagliato. L'Aerautodromo fu inaugurato il 7
maggio 1950 e misurava 2,306 km. che potevano diventare 3,800 con l'inserimento,
nelle gare, della pista di aviazione (da cui il nome). Con la nascita
dell'Aerautodromo finì l'epopea delle corse su strada della città come il Record
Mondiale del Miglio sulla Via Nonantolana nel 1909 e nel 1910. La prima
edizione, vinta da De Zara a oltre 141 Km orari aveva registrato anche la
partecipazione di modenesi illustri, come Guido Corni, Claudio Sandonnino e
Francesco Stanguellini.
|

Gran Premio di Modena disputato l'8 settembre 1950
|
Il circuito, fortemente
voluto da Modena e dai modenesi, venne usato: per gare di auto e moto, come
pista di prove dai costruttori di vetture sportive modenesi, come aeroporto, e
talvolta fu impiegato anche dai militari della vicina Caserma del 6° Campale.
Non mancava l’utilizzo turistico e commerciale, con voli destinati al trasporto
veloce della frutta e della verdura prodotta a Modena ed inviata nei paesi del
nord Europa. Un insieme di esigenze davvero eterogeneo, ma che dimostrò la
vitalità della struttura da poco sorta in città.
|
Con i suoi undici anni di
attività agonistica l'Aerautodromo fu il fulcro ed il cardine del binomio
Modena-Automobilismo Sportivo, con il costante avallo organizzativo dell'A.C.
cittadino. Vi si corsero, dal 1950 al 1961, sette edizioni del Gran Premio di
Modena di automobilismo per monoposto di F2 che videro le vittorie di Alberto
Ascari, Gigi Villoresi, Manuel Fangio, Jean Behra, Joachim Bonnier e Stirling
Moss. L’attività agonistica ed i grandi nomi dell’automobilismo sportivo
presenti in città per le gare contribuirono alla fama dell'Aerautodromo portando
a Modena vantaggi anche di tipo turistico e commerciale; infatti, al seguito del
dilagante successo dell'automobilismo modenese giunse, inevitabilmente, tutto il
jet-set internazionale: oltre che “capitale dei motori” Modena diventò così anche “capitale del bel mondo”.
All’Aerautodromo di Modena
si tennero anche ventidue edizioni del Gran Premio di Modena di motociclismo
fino al 1975 e due edizioni del Gran Premio di Modena di ciclismo. Purtroppo però già alla fine
degli anni ’60 l’Aerautodromo non soddisfaceva più quei criteri di sicurezza che
di lì a poco sarebbero diventati prescrittivi. Enzo Ferrari, che per il
collaudo delle sue vetture aveva esigenze sempre crescenti, si risolse a
costruire il circuito privato di Fiorano, non senza aver tentato la strada di
coinvolgere l’amministrazione della Città nella costruzione di un nuovo e
moderno impianto nei pressi di Marzaglia. Iniziò così un lento declino e sul
finire degli anni ‘70 l’Aerautodromo fu chiuso.
Per capire quella che è
stata l'importanza dell'Aerautodromo per la città di Modena si pensi che ad
alcune di queste manifestazioni parteciparono anche più di 50.000 spettatori,
l'equivalente di metà della popolazione di allora.
Oggi il nuovo Autodromo di
Modena, si appresta a raccogliere il testimone di questa illustre storia,
diventando,
anch’esso un importante patrimonio della città di
Modena.
EUGENIO CASTELLOTTI VITTORIE, AMORE, MORTE
Castellotti, il pilota-playboy che morì
nel mistero.
Il 14 marzo 1957, moriva Eugenio Castellotti in un
incidente durante una seduta di prove all' aerautodromo di Modena.
Quella sera Delia Scala recita al teatro
Verdi di Firenze: lo spettacolo ha le sue regole inflessibili.

1953 Coppa Inteuropa -
Castellotti su Lancia Aurelia B20 Gran Turismo Coupè |
Il
pilota della Ferrari, nato il 10 ottobre 1930 a Milano, erede di un'
agiata famiglia lodigiana, debutta nel 1951 alla guida di una Ferrari
sport di sua proprietà. Già l' anno dopo ottiene
i primi successi in Italia e all' estero, sempre con vetture sport
Ferrari. Quando Castellotti è ormai un affermato pilota
dilettante viene ingaggiato nel 1953 dalla Lancia.Inizialmente
soltanto per le corse di durata ma in seguito arriva pure l' esordio
con le monoposto, subito in Formula 1, nel GP Argentina 1955.Pochi
mesi dopo, però, la casa torinese si ritira dalle
competizioni e Castellotti passa alla Ferrari come pilota ufficiale.
Eugenio si laurea campione italiano assoluto e termina al terzo posto
nel Mondiale F.1. |
Ormai è un pilota affermato. Nel 1956,
sempre con la Ferrari, il milanese ottiene il trionfo più
grande con il successo nella Mille Miglia. Sono 1.600 chilometri da
Brescia a Roma e ritorno, percorsi in meno di 12 ore sotto una pioggia
continua e battente precedendo di oltre 12 minuti il compagno rivale
Peter Collins e di oltre 34 l' amico Luigi Musso, che completa un podio
tutto di piloti Ferrari.
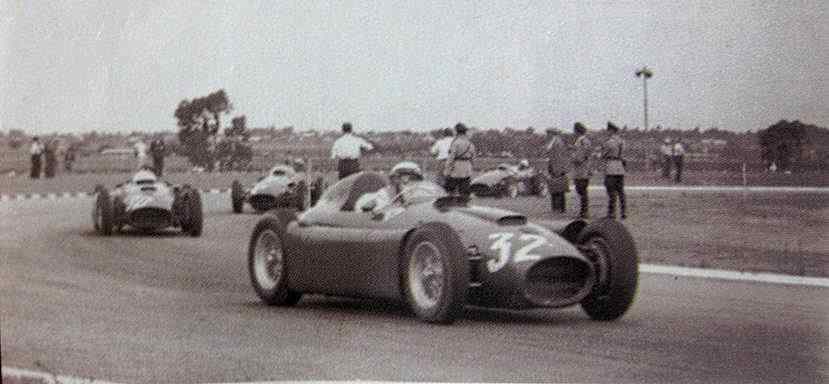 |
| Gran Premio di Argentina 1956 - Castellotti Lancia /Ferrari D50 |
Eugenio Castellotti è anche un
personaggio da cronaca rosa. Dopo i flirt con Edy Campagnoli e Sandra
Milo, entra stabilmente nella vita del campione l' attrice Delia Scala. Così nel marzo 1957, mentre Castellotti
è a Firenze, dove la sua compagna recita con Walter Chiari,
arriva la convocazione della Ferrari per i test del giorno 14 con una
F1.
Eugenio Castelloti. Segni particolari: veloce.
velocissimo di bella presenza, molto ricco, il "ragazzo di Lodi" faceva
parte di quella primavera Ferrari che oltre a lui vedeva schierati per
il Cavallino rampante piloti del calibro di Musso, von Trips e Collins.
Amico di Alberto Ascari fu testimone diretto della sua morte sulla
pista di Monza, morte che segnò profondamente il suo animo.
Con la soubrette Delia Scala, visse momenti travagliati, fino al punto
di decidere di smettere con le corse dopo il matrimonio. Quel 14 marzo
1957, Eugenio lo passò all'Aerautodromo di Modena sotto gli
occhi attenti di Ferrari, cercando di migliorare giro dopo giro il
record della pista conteso a Jean Behra. La pista scivolosa, i pensieri
rivolti verso Delia, verso il futuro matrimonio, verso l'obbligata
rinuncia alle corse. Alla "S" Stanguellini Castellotti ritarda
all'ultimo la staccata per guadagnare una manciata di centesimi di
secondo, butta il muso della sua Ferrari all'interno della esse e tocca
il cordolo della pista sbandando paurosamente e toccando ancora il
cordolo, si dirige verso il prato con la vettura quasi ingovernabile,
attraversandolo tutto e finendo capottato.
E' la fine di questo amato pilota, morto all'età di 27 anni,
sicura promessa dell'automobilismo sportivo Italiano.
|
|
|
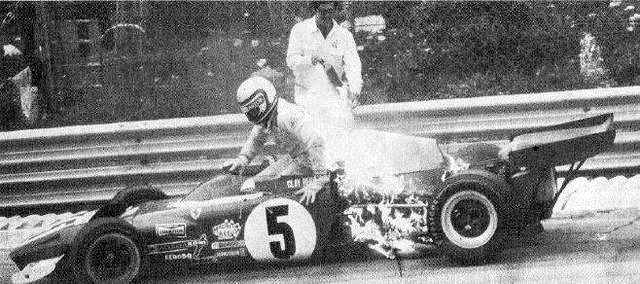
Fuoco !
Un'immagine tristemente comune
nelle corse anni'70: una monoposto in fiamme.
Qui siamo a Monza e Clay
Regazzoni è fortunato e abile a uscire in tempo dall'abitacolo della sua
Ferrari, ma purtroppo non sempre c'era il lieto fine
|
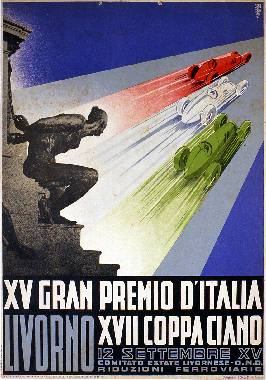 |
|
 |
Con il 1937 la “XVII Coppa Ciano” veniva eletta a “XV Gran Premio
d’Italia”. La massima competizione automobilistica nazionale abbandonava
così l’Autodromo di Monza, tempio della velocità, per approdare in riva
al Tirreno sperando che sulle più tortuose strade livornesi le vetture
italiane potessero riscattarsi dallo strapotere messo in mostra nella
stagione dalle argentee vetture tedesche; d’altra parte Nuvolari non
aveva già messo in ginocchio le Auto Union su queste strade l’anno
prima? Ma questa volta San Tazio ed i suoi miracoli non sarebbero stati
sufficienti. Alla corsa su 50 giri del circuito di 7218 metri la
Mercedes arrivò con l’ultimo velocissimo modello, la W125 di 5660cc,
mentre l’Auto Union poteva contare sul modello C dell’anno precedente,
non più in grado di competere con le rivali di Stoccarda. L’Alfa Romeo,
sempre rappresentata dalla Scuderia Ferrari, poteva contare sulle
vecchie 8C35 e 12C36 schierando anche la nuovissima 12C37 di 4500cc,
ancora acerba, che venne affidata a Guidotti. Infatti in prova Nuvolari
aveva provato la nuova vettura ma pur girando 2” più veloce, preferiva
puntare sulla più affidabile 12 cilindri dell’anno precedente. Già dalle
prove i tedeschi strapazzarono le auto italiane monopolizzando le prime
due file, con la migliore Alfa, quella di Nuvolari, solo in terza fila.
La partenza venne data, dopo il rituale degli inni e la sfilata delle
auto e dei campioni, alle 15 in punto, davanti ad una folla
strabocchevole che aveva occupato ogni metro del circuito, in
particolare le tribune che per l’occasione avevano 2000 posti in più
rispetto al consueto affiancando alle vecchie tribune in legno anche
delle nuove tribune in ferro fatte venire da Milano apposta per
l’occasione. Subito le macchine tedesche balzarono in testa, con
Caracciola (Mercedes) davanti a tutti per tre giri poi superato da Lang
(Mercedes) al comando fino al ventitreesimo giro. Nulla potevano fare le
Alfa Romeo: Guidotti con la nuova 12C37 si ritirava al ventiquattresimo
giro, Nuvolari pur scatenato come sempre, si fermava stanchissimo al
trentunesimo giro per cedere il volante a Nino Farina. Le due Mercedes
di Caracciola e Lang duellarono per tutta la gara vicinissime, arrivando
quasi appaiate al traguardo dove Caracciola beffava il più giovane Lang
di 2/5 di secondo. Terza l’Auto Union di Rosemeyer e la prima delle
auto italiane, l’Alfa Romeo di Farina-Nuvolari, solo settima ad un giro.
|
|
Il Gran Premio di Germania è la nona prova del mondiale 1994 di Formula 1, un mondiale certamente segnato per la prematura scomparsa di Ayrton Senna a Imola.
|
 |
|
Il Gran Premio di Germania 1994 si svolse il 31 luglio 1994 sull'Hockenheimring e fu il nono appuntamento mondiale della stagione 1994.
La gara segnò il ritorno alla vittoria della Ferrari dopo quasi
quattro anni di assenza dal gradino più alto del podio.
Tra gli episodi salienti della gara, ci fu un incendio che scoppiò sulla Benetton di Jos Verstappen al momento del pit-stop.
Il pilota olandese riportò, fortunatamente, solo alcune piccole ustio |

|
|
Alla partenza avviene un primo incidente nelle retrovie che coinvolge
quattro monoposto, ma il peggio accade qualche istante dopo: alla fine
del rettilineo, Hakkinen stringe verso il centro della pista e causa un contatto con la Williams-Renault di Coulthard.
Il pilota della Mclaren perde il controllo della vettura, che si gira
ed esce di pista tagliando la strada alle monoposto che sopraggiungono.
Altre sei vetture vengono coinvolte in questo incidente e sono costrette
al ritiro, mentre altre, essendo danneggiate, rientrano ai box il giro
seguente. Per fortuna non c'è nessuna conseguenza fisica per nessuno dei
piloti coinvolti. Intanto anche Alesi
è costretto a ritirarsi poche centinaia di metri più avanti per
problemi all'elettronica della monoposto. Nonostante il pericolo di
detriti in pista e di vetture ferme in vari punti del tracciato, la gara
non viene interrotta.
Le due Williams di
Coulthard e Hill rientrano ai box dopo l'incidente e finiscono nelle
retrovie perdendo più di un giro nei confronti degli avversari e
non potendo più lottare per posizioni importanti. Dunque la gara
continua con Berger, sulla Ferrari, in prima posizione, seguito a pochi
decimi da Schumacher.
Il tedesco della Benetton si rivela nettamente più veloce sul
giro, tuttavia non riesce a superare il ferrarista: sui rettilinei si
palesa la superiorità del motore V12 della Ferrari, rispetto al
Ford V8 della Benetton.
|
 |
|
Al quindicesimo passaggio il secondo pilota Benetton Jos Verstappen
rientra ai box per il pit stop. Nel completare le operazioni tuttavia i
meccanici sfilano troppo rapidamente il bocchettone di rifornimento del
carburante: tale manovra impropria, complice la particolare soluzione
implementata dalla scuderia britannica sulla valvola d'immissione del
liquido (priva di filtro, in modo tale da velocizzare il travaso nel
serbatoio e rendere l'operazione più veloce), causa una copiosa
fuoriuscita di benzina
che inonda la monoposto e, a contatto con il retrotreno rovente,
s'incendia. Le fiamme vengono rapidamente domate e l'olandese riesce a
mettersi in salvo autonomamente, riportando solo alcune lievi ustioni
Nel frattempo la gara continua con Berger e Schumacher in lotta, seguiti a lunga distanza dalle Ligier di Panis e Bernard
(avvantaggiate dalla bontà dei propulsori Renault, rispetto alle altre
vetture). Il tedesco della Benetton decide di anticipare il pit-stop,
cercando di avvantaggiarsi nei confronti di Berger, tuttavia al
ventesimo giro è costretto al ritiro a causa della rottura del
propulsore della sua Benetton.
Nelle battute finali della gara si scatena un
duello tra Gianni Morbidelli ed Érik Comas per la conquista
della quinta posizione, vinto infine dal pilota italiano.
Berger mantiene il
comando della gara e vince; la Ferrari torna alla vittoria dopo quasi 4
anni di digiuno, ovvero dal Gran Premio di Spagna 1990. Completano il
podio Olivier Panis ed Éric Bernard; la Ligier piazza due
vetture sul podio a quasi 9 anni di distanza dall'ultima volta, ossia
dal Gran Premio d'Australia 1985. È la quarta ed ultima volta
che ciò accade nella storia della casa francese, destinata a
cessare l'attività da lì a due anni.
|
 |
| Dicembre 1978 - Prima Parigi-Dakar - 182 veicoli alla partenza, ne arriverano a Dakar 74 |
|
F1 Storia: GP Italia 1988, un trionfo dedicato al Drake
|
 |
| L’antefatto della gara è il Leitmotiv
della stagione 1998, uno scontro che ha un’unica, grande e indiscussa
protagonista: la McLaren MP4/4, un vero e proprio missile affidato alla
coppia che ciascun team manager vorrebbe avere… o forse no: Alain Prost e
Ayrton Senna. E chi, molto probabilmente non li voleva era proprio Enzo
Ferrari, ben abituato a gestire con sapiente maestria le rivalità, ma
che quasi sicuramente avrebbe avuto più di qualche grattacapo con quei
due piloti. Ma le loro capacità di guida in quel 1988 esplosero in modo
deflagrante, tant’è che fino a quella gara vinsero in tutti i circuiti
del Mondiale 1988. E anche a Monza non vollero assolutamente cedere,
andando a prendersi la prima fila dello schieramento, mettendosi dietro
le Ferrari di Berger e Alboreto.
Sulle
tribune c’è uno striscione che sembra quasi profetico: “Gerhard –
Alboreto, lassù il Drake vi guarda”. Lui che a Monza di gioie ne ha
vissute tante e anche tanti dolori forse è veramente stato l’artefice di
qualcosa di incredibile che si sarebbe consumato di lì a poco. La gara è
tra Senna e Prost, per gli altri non c’è scampo, il loro vantaggio
cresce a dismisura… fino al giro 30. Prost fa segnare un tempo assurdo:
1’36″672, chiaro segno che c’è qualcosa che non va. Infatti, 4 giri più
tardi, il francese rientra ai box con il motore rotto e si ritira. Un
sospiro di sollievo per Senna, che sembra al sicuro della vittoria e va
piano come da istruzioni del box McLaren. Ma al giro 49 ecco che quello
che sembrava impensabile alla vigilia: Senna deve doppiare Jean-Louis
Schlesser, ma alla prima variante i due non si capiscono e finiscono
entrambi fuori! Un errore che spalanca la strada del successo alle due
Ferrari, che percorrono due giri in parata osannate dal pubblico e la
gara finisce come forse lo stesso Ferrari avrebbe voluto. Alboreto
rivela in conferenza stampa che alla fine lui e il compagno di squadra
erano persino giunti a spingere, per omaggiare degnamente il Drake sulla
pista di casa, là dove molte delle pagine del mito Ferrari sono state
scritte e molti campioni hanno trovato la loro consacrazione.
|
 Causa un problema ai freni la BRM di Dan Gurney esce di pista e ferisce mortalmente uno spettatore.
Causa un problema ai freni la BRM di Dan Gurney esce di pista e ferisce mortalmente uno spettatore.
|
Carrera Panamericana
 |
1952-1953. Mercedes Benz Typ 300 SL.
(W.194-M. 194) 175 PS.
Tra le proposte prese in esame nel 1951 dopo la ricostituzione del
reparto corse, vi è quella di ammodernare il motore da 1500
cmc. sovralimentato ( due W. 165 erano sopravvissuti in Svizzera), e di
iniziare la progettazione di un 12 cilindri aspirato di 4500 cmc.,
soluzione alternativa contemplata dalla formula in vigore, ma prossima
ad una variazione nel regolamento.
Su idea dell’ingegner Fritz Nallinger, responsabile del
settore si decide di abbandonare il progetto F1 per dedicarsi alle
corse di durata, nelle quali si poteva mettere in evidenza la
robustezza e la validità del proprio prodotto.
L’ingegner Uhlenhaut, partendo
dall’unità motrice della 300 S., costruisce un
telaio a tralicci in tubi sottili e intrecciati, disposti in maniera
tale da lavorare solo a trazione o compressione, ma mai a torsione.
Il motore, derivato dall’M. 188 della 300 S., è un
6 cilindri 2996 cmc. con un nuovo carter per la lubrificazione a secco,
che permette di inclinare il monoblocco di 40º verso sinistra
con lo scopo di ridurre la sezione frontale, tanto da poter avere un cx
di 0,38 e di superare i 240 km/h. L’alimentazione
è assicurata da tre carburatori Weber 40 DCOE e, in seguito,
da un Solex 40 PBIC.
Il telaio è rivestito da una carrozzeria in alluminio e, per
la sua forma strutturale, dotato di portiere incernierate sul tetto,
apribili ad ali di gabbiano. |

19/23 novembre 1952. 3a Carrera Panamericana. Tuxtla. Messico.
Per questa gara, molto considerata per i riflessi che può avere sul
mercato statunitense, la Mercedes allinea due Coupè 300 SL. e uno Spider: i
primi per le coppie Lang-Krupp e Kling-Kleng, mentre la Spider è per l'americano
John Fitch e il tedesco Eugen Geiger.
Una gara massacrante di
3113 km. divisi in otto tappe, per la quale occorre pianificare una logistica
perfetta per quanto riguarda l'assistenza alle vetture, abituale lavoro di
Neubauer. Nella prima tappa, mentre la vettura di Lang-Kleng fila
a 200 km/h., un uccello sfonda il parabrezza dalla parte del copilota ferendolo
lievemente.
Nell'immagine vediamo i due piloti (nei rifornimenti
di tappa solo loro potevano provvedere alle operazioni), che stanno per
ripartire e, sul vetro, è evidente il danno prodotto dall'impatto con il
volatile.
|
|
John Love (Bulawayo, 7 dicembre 1924 – Bulawayo, 25 aprile 2005) è stato un pilota automobilistico zimbabwese.
Dopo aver cominciato a correre nella natia
Rhodesia, Love si trasferì in Europa nei primi anni sessanta a
correre per la squadra di Formula Junior di Ken Tyrrell,
ma per vari motivi (tra cui un incidente) non riuscì ad ottenere
grandi risultati nelle gare di Formula 1. Si impose però nel1962
nel campionato turismo britannico. Ritornò allora in Sudafrica
dove si dedicò alle gare di Formula 1 locali, allora frequenti, che si
alternavano a gare internazionali quando le principali scuderie si
spostavano in Africa per il Gran Premio del Sud Africa o le gare di contorno non valide per il campionato mondiale.
|
Vinse
per ben sei volte il Campionato sudafricano di Formula 1. Nel Gran
Premio del Sud Africa 1967 Love si trovò a guidare una Cooper di
due anni prima modificata con un motore "Tasman" Climax FPF da
2700 cc, vettura adatta per gare locali ma non all'altezza dei
migliori piloti della Formula 1 al volante di monoposto da
3000 cc. Ciò nonostante, e a 42 anni, Love si
qualificò quinto e in gara si ritrovò in testa quando al
61º giro sia Jack Brabham che Denny Hulme si ritirarono a causa
delle condizioni torride del circuito di Kyalami.
Love dovette però fermarsi ai box per un rifornimento di carburante
(la sua vettura non aveva l'autonomia di un intero Gran Premio) e così
terminò al secondo posto dietro Pedro Rodríguez in una Cooper ufficiale a motore Maserati,
un grosso risultato per un privato in una vettura antiquata. L'anno
successivo Love salì di nuovo all'onore della cronaca per aver corso in
una Brabham colorata con le insegne della marca di sigarette Gunston, il primo esempio di sponsorizzazione professionale nella Formula 1.
|

Gran Premio d'Austria 1987
Stefan Johansson, compagno di Prost, fu vittima di un violento incidente, quando investì un cervo
incredibilmente entrato in pista a tutta velocità. In questo modo si
distrusse la sospensione della McLaren e Johansson andò a sbattere
violentemente contro le barriere,
rompendosi anche una costola.
|
|
Ricordo di Depailler
 |
 L’1
agosto 1980 Patrick Depailler viene chiamato dall' Alfa Romeo, la
scuderia per la quale corre, sul circuito tedesco di Hockenheim per prove di
motore in un’annata nella quale la scuderia del Biscione non ha raccolto
granchè nelle otto gare del mondiale disputate fino a quel momento (sette
ritiri e un non classificato). L’1
agosto 1980 Patrick Depailler viene chiamato dall' Alfa Romeo, la
scuderia per la quale corre, sul circuito tedesco di Hockenheim per prove di
motore in un’annata nella quale la scuderia del Biscione non ha raccolto
granchè nelle otto gare del mondiale disputate fino a quel momento (sette
ritiri e un non classificato).
Parte il test, il francese va forte, ma una curva beffarda non dà scampo e
si porta via la vita di Patrick. Nato il 9 agosto 1944, Depailler dedica quasi
interamente la sua carriera automobilistica alla Tyrrell
per la quale corre dal 1972 al 1978, poi si trasferisce una stagione alla Ligier
e nell’80 finisce all’Alfa Romeo disputando in tutto 95 GP. Due
vittorie al suo attivo (Montecarlo '78 e Spagna
'79), 10 secondi posti, sette terzi e una pole in Svezia nel 1974.
Pilota che ha dedicato la sua vita alle macchine, ha corso e vinto il titolo
in F2 e vinto il G.P. di Monaco di F3, Patrick viene ricordato pure per avere
guidato la mitica Tyrrell a sei ruote che non ha raccolto grande
successo.
Personaggio spericolato, vide interrotta la carriera sul più bello per un
incidente in deltaplano (!) che gli provocò due fratture ad entrambe le
gambe e parecchi mesi di inattività. Ritornato, salì sull' Alfa ma i suoi guai
non erano ancora finiti..
|
|
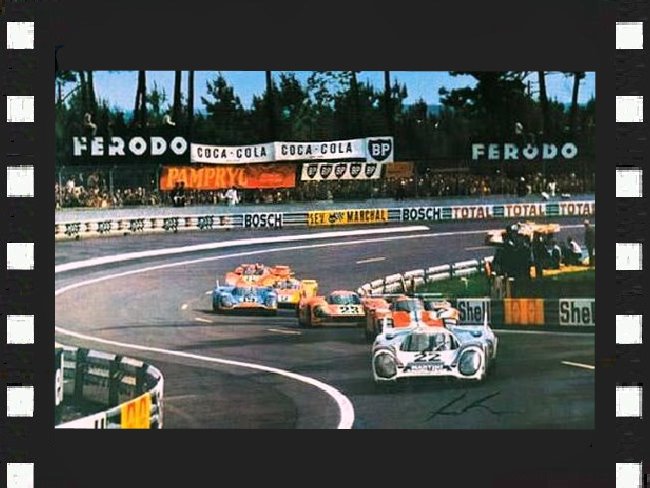
Le Mans START OF THE RACE. Steve McQueen
 |
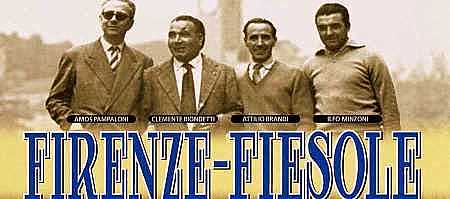 |
 |
| Piazza della Signoria -
Firenze |
|
Fiesole - Firenze |
 |
 |
 |
| Firenze Fiesole
25/4/1948 |
Firenze Fiesole
Partenza dal
Mulino Biondi |
Firenze Fiesole
Partenza di
Benedetti
|
 |

|
 |
|
Firenze Fiesole 20/4/1952
Ilfo Minzoni su Nardi Danese
|
Firenze Fiesole 25/4/1948 -
Fiat
|
Firenze Fiesole 16/4/1950
Siro Sbracci su Fiat Ermini 1100 s
|
|
La storia della gara Firenze -
Fiesole |
Nel 1948
Amos Pampaloni, indimenticabile Direttore Generale dell'Automobile Club di
Firenze, insieme ad altri due dirigenti particolarmente votati allo sport
automobilistico, Roberto Quentin ed il Comm. Sergio Sguanci, dopo aver
organizzato con successo l'anno prima il “Circuito delle Cascine” per vetture
della categoria sport, ritenne giunto il momento di organizzare anche una
cronoscalata.
In quel momento la tradizionale Coppa della Consuma
appariva una soluzione ancora impraticabile per le condizioni della strada che a
pochi anni dal termine della guerra rimaneva a dir poco disastrata. Si pensò
dunque ad un percorso ancor più a portata di mano che consentisse agli
appassionati di recarsi ad assistere alla corsa pur con gli scarsissimi mezzi
del momento, quasi una sorta di gara nel salotto di casa: la Firenze – Fiesole.
Tracciare oggi la storia di questa corsa non è facile dal momento che
sono poche le notizie disponibili anche se risulta che la gara, in alcuni anni
fosse titolata per il Campionato sociale dell'Automobile Club Fiorentino.
La prima edizione della Firenze – Fiesole si disputò il 17 Luglio 1938,
ma fu riservata alle sole motociclette, oltretutto in versione di serie, e ad un
gruppo di piloti non in possesso della licenza di conduttore. La manifestazione
aveva infatti l'intento di dare sfogo alla passione velocistica di molti giovani
e di avvicinarli allo sport. Per questo fu definita “leva motociclistica”. La
gara ebbe un notevole successo anche se pare che nessuno dei valorosi novizi
abbia coltivato in seguito l'attività agonistica. La prima edizione
automobilistica di disputò invece il 25 aprile 1948 in una splendida giornata
primaverile. Il percorso prevedeva la partenza in viale A. Volta all'incrocio
con via della Piazzola nei pressi del mulino Biondi; l'arrivo in Piazza Mino da
Fiesole. Tuttavia poiché il tempo veniva rilevato in Piazza Edison la base
cronometrata era lunga 4,250 Km.
34 concorrenti con vetture appartenenti
alle categorie turismo e sport ricevettero il via dall'Onorevole Arrigo
Paganelli, allora presidente dell'Aci Firenze, e dallo stesso Amos Pampaloni in
veste di direttore di gara. Vincitore assoluto fu Pasquino Ermini alla guida di
una barchetta di sua costruzione con il tempo di 2' e 55” alla media di 80,891
kmh., secondo con sette secondi di distacco fu Aldo Benedetti su una Fiat 1100
sport, terzo Giorgio Castelnuovo.
Un anno dopo, il 26 giugno 1949 la
ripetizione sullo stesso percorso, ma con il tempo rilevato dal Mulino Biondi
per una lunghezza effettiva di una competizione di Km. 5,350. Vinse questa volta
Siro Sbraci, valente gentleman fiorentino a bordo di una Fiat 1100 sport con la
quale raggiunse piazza Mino da Fiesole in 3' e 15” alla media di 75,594 kmh.
Secondo con un ritardo di 5' si classificò Bartolozzi con una Fiat, terzo Aldo
Benedetti questa volta con una Alfa Romeo 2500 SS.
Il 16 Aprile 1950 fu
invece la Fiat 1100 sport di Otello Biagiotti ad imporsi in 3' e 31” sulle
vetture uguali di Siro Sbraci e Bernardo Duse.
L'edizione del 1951,
corsa del 22 Aprile, fu la quinta in generale, ma la quarta dedicata alle auto.
Quell'anno fra i 68 iscritti risaltò la partecipazione del campione fiorentino
Clemente Biondetti con la sua potente Jaguar 3500. Biondetti vinse senza
problemi stabilendo in 2'53” e 4 decimi il record della salita rimasto
imbattuto, secondo distanziato di oltre 14” fu Renato Nocentini a bordo di una
Ferrari marca della quale diventerà concessionario per Firenze e la Toscana;
terzo Terigi con la Fiat 1100 S. Sesto assoluto risulta essere stato Carlo Chiti
che diventerà direttore tecnico prima della Ferrari e più tardi della Autodelta.
Nel 1952, il 20 aprile, il canto del cigno, contemporamente però alla
rinascita di una gara mitica, la Coppa della Consuma. In una tiepida domenica di
aprile Attilio Brandi ai comandi di una scattante Ermini 1100, con Biondetti
presente solo nella veste di spettatore, sbaragliò l'agguerrita concorrenza
tutta fiorentina: secondo fu infatti Ilfo Minzoni sulla Nardi Danese 1500 che
oggi appartiene a Marco Masini,terzo fu Siro Sbraci alla guida di una Ferrari
2600, quarto Consolazio con una Fiat 1100 sport. |
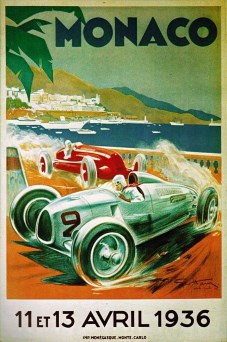 |
|
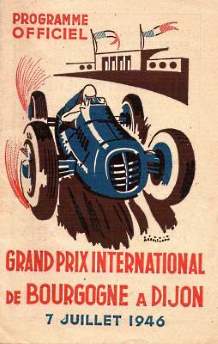 |
INCIDENTI MORTALI DELLA FORMULA UNO
| Raymond Sommer |
francese |
10 di settembre 1950 |
GP della Alta Garonna (Cadours)F. |
Cooper |
Gara
|
| Chet Miller |
Americano
|
15 di maggio 1953 |
500 miglia di Indianápolis |
Kurtis Kraft |
Prove
|
| Carl Scarborough |
Americano
|
30 di maggio 1953 |
500 miglia di Indianapolis |
Kurtis Kraft |
Gara
|
| Charles de Tornaco |
Belga |
18 di settembre 1953 |
(Modena Aerautodromo) |
Ferrari |
Prove
|
| Onofre Marimón |
Argentino
|
31 di Luglio 1954 |
Gran Premio di Germania |
Maserati |
Prove
|
| Manny Ayulo |
Americano |
16 di maggio 1955 |
500 miglia di Indianapolis |
Kuzma |
Prove
|
| Bill Vukovich |
Americano
|
30 di maggio 1955 |
500 miglia di Indianapolis |
Kurtis Kraft |
Gara
|
| Eugenio Castellotti |
Italiano
|
14 di marzo 1957 |
(Modena Autodrome) |
Ferrari |
Prove
|
| Keith Andrews |
Americano |
15 di maggio 1957 |
500 miglia di Indianapolis |
Kurtis Kraft |
prove
|
| Pat O'Connor |
Americano |
30 di maggio 1958 |
500 miglia di Indianapolis |
Kurtis Kraft |
Gara
|
| Luigi Musso |
Italiano |
06 di Luglio 1958 |
Gran Premio di Francia |
Ferrari |
Gara
|
| Peter Collins |
Britannico |
03 di agosto 1958 |
Gran Premio di Germania |
Ferrari |
Gara
|
| Stuart Lewis-Evans |
Britannico |
19 di settembre 1958 |
Gran Premio di Marrocco |
Vanwall |
Gara
|
| Jerry Unser |
Americano |
17 di maggio 1959 |
500 miglia di Indianapolis |
Kurtis Kraft |
Prove
|
| Bob Cortner |
Americano |
19 di maggio 1959 |
500 miglia di Indianapolis |
Cornis |
Prove
|
| Ivor Bueb |
Britannico |
01 di agosto 1959 |
(Circuit di Charade) |
Cooper |
Prove
|
| Harry Schell |
Americano |
13 di maggio 1960 |
International Trophy (Silverstone) |
Cooper |
Qualifica
|
| Chris Bristow |
Britannico |
19 di Giugno 1960 |
Gran Premio del Belgio |
Cooper |
Gara
|
| Alan Stacey |
Britannico |
19 di Giugno 1960 |
Gran Premio del Belgio |
Lotus |
Gara
|
| Giulio Cabianca |
Italiano |
17 di febbraio 1961 |
(Modena Autodrome) |
Cooper |
Prove
|
| Wolfgang von Trips |
Tedesco |
10 di settembre 1961 |
Gran Premio d'Italia |
Ferrari |
Gara
|
| Ricardo Rodríguez |
Messicano |
01 di novembre 1962 |
Gran Premio del Messico |
Lotus |
Prove
|
| Carel Godin de Beaufort |
Olandese |
02 di agosto 1964 |
Gran Premio della Germania |
Porsche |
Prove
|
| John Taylor |
Britannico |
07 di agosto 1966 |
Gran Premio della Germania |
Brabham |
Gara
|
| Lorenzo Bandini |
Italiano |
07 di maggio 1967 |
Gran Premio di Monaco |
Ferrari |
Gara
|
| Bob Anderson |
Britannico |
14 di agosto 1967 |
(Silverstone) |
Brabham |
Prove
|
| Mike Spence |
Britannico |
07 di maggioo 1968 |
(Indianapolis) |
Lotus |
Prove
|
| Jo Schlesser |
Francese |
07 di luglio 1968 |
Gran Premio di Francia |
Honda |
Gara
|
| Gerhard Mitter |
Tedesco |
02 di agosto 1969 |
Gran Premio de Alemania |
BMW |
Prove
|
| Piers Courage |
Britannico |
07 di giugno de 1970 |
Gran Premio d' olanda |
De Tomaso |
Gara
|
| Jochen Rindt |
Austriaco |
05 di settembre 1970 |
Gran Premio d' Italia |
Lotus |
Qualifica
|
| Jo Siffert |
Svizzero |
24 di ottobre 1971 |
Brands Hatch Victory Race |
BRM |
Gara
|
| Roger Williamson |
Britannico |
29 di luglio 1973 |
Gran Premio di Olanda |
March |
Gara
|
| François Cevert |
Francese |
07 di ottobre 1973 |
Gran Premio degli USA |
Tyrrell |
Qualifica
|
| Peter Revson |
Americano |
30 di marzo 1974 |
Gran Premio del Sudafrica |
Shadow |
Prove
|
| Helmuth Koinigg |
Austriaco |
06 di ottubre de 1974 |
Gran Premio degli USA |
Surtees |
Gara
|
| Mark Donohue |
Americano |
19 di agosto 1975 |
Gran Premio d' Austria |
Penske |
Prove
|
| Tom Pryce |
Britannico |
05 di marzo 1977 |
Gran Premio del Sudafrica |
Shadow |
Gara
|
| Ronnie Peterson |
Svedese |
11 di settembre 1978 |
Gran Premio d' Italia |
Lotus |
Gara
|
| Patrick Depailler |
Francese |
01 di agosto 1980 |
(Hockenheimring)Germania |
Alfa Romeo |
Prove
|
| Gilles Villeneuve |
Canadese |
08 di maggio 1982 |
Gran Premio del Belgio |
Ferrari |
Qualifica
|
| Riccardo Paletti |
Italiano |
13 di Giugno 1982 |
Gran Premio del Canada |
Osella |
Gara
|
| Elio de Angelis |
Italiano |
15 di maggio 1986 |
(Paul Ricard) |
Brabham |
Prove
|
| Roland Ratzenberger |
Austriaco |
30 di aprile 1994 |
Gran Premio di San Marino |
Simtek |
Qualifica
|
| Ayrton Senna |
Brasiliano |
01 di maggio 1994 |
Gran Premio di San Marino |
Williams |
Gara
|
| Maria de Villota |
Spagnola |
11 di ottobre 2013 |
Hotel di Siviglia Spagna. |
Marussia |
Prove
|
| Jules Bianchi |
Francese |
17 di Luglio 2015 |
Nell'Ospedale, di Nizza Fr. |
Marussia |
Gara
|
COPYRIGHT
Questo è un blog
(Album foto e testi) esclusivamente personale non a scopo di lucro. Parte dei
testi foto loghi e filmati sono stati tratti
da alcuni siti web.
L'autore ritiene di non aver leso il Copyright e di aver rispettato i
diritti di proprietà intellettuale dei Terzi.
Se qualcuno crede siano stati violati i propri diritti, per la rimozione scrivere:mondogaref1@yahoo.it
Riproduzione vietata
|

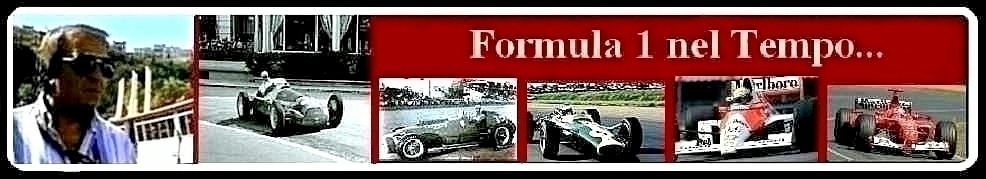



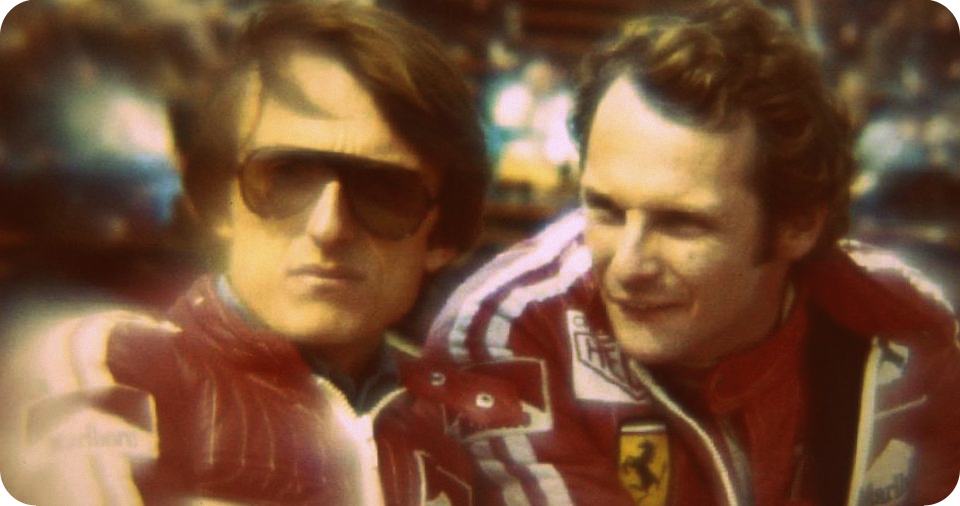

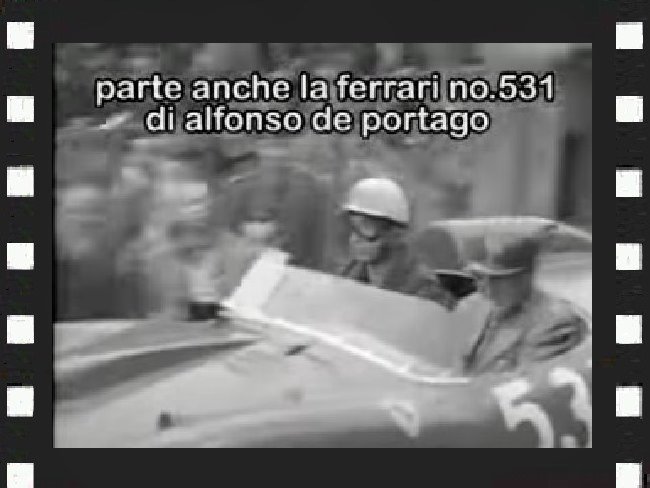
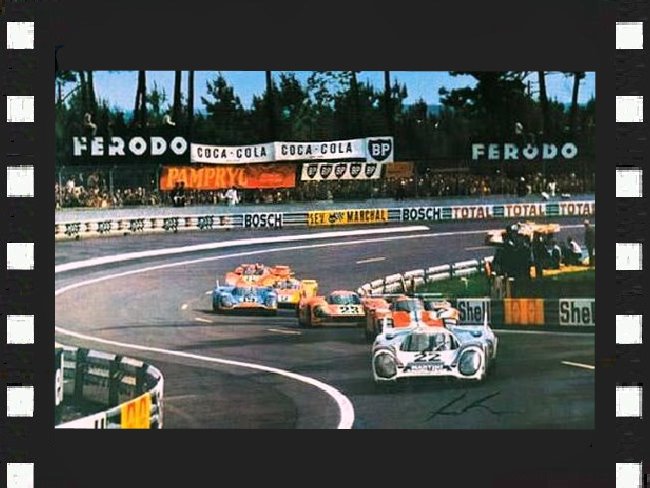



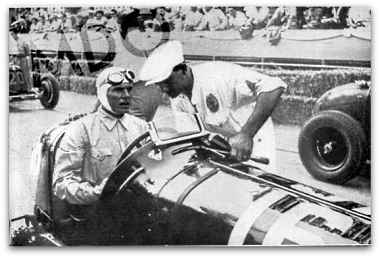
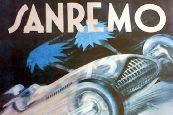


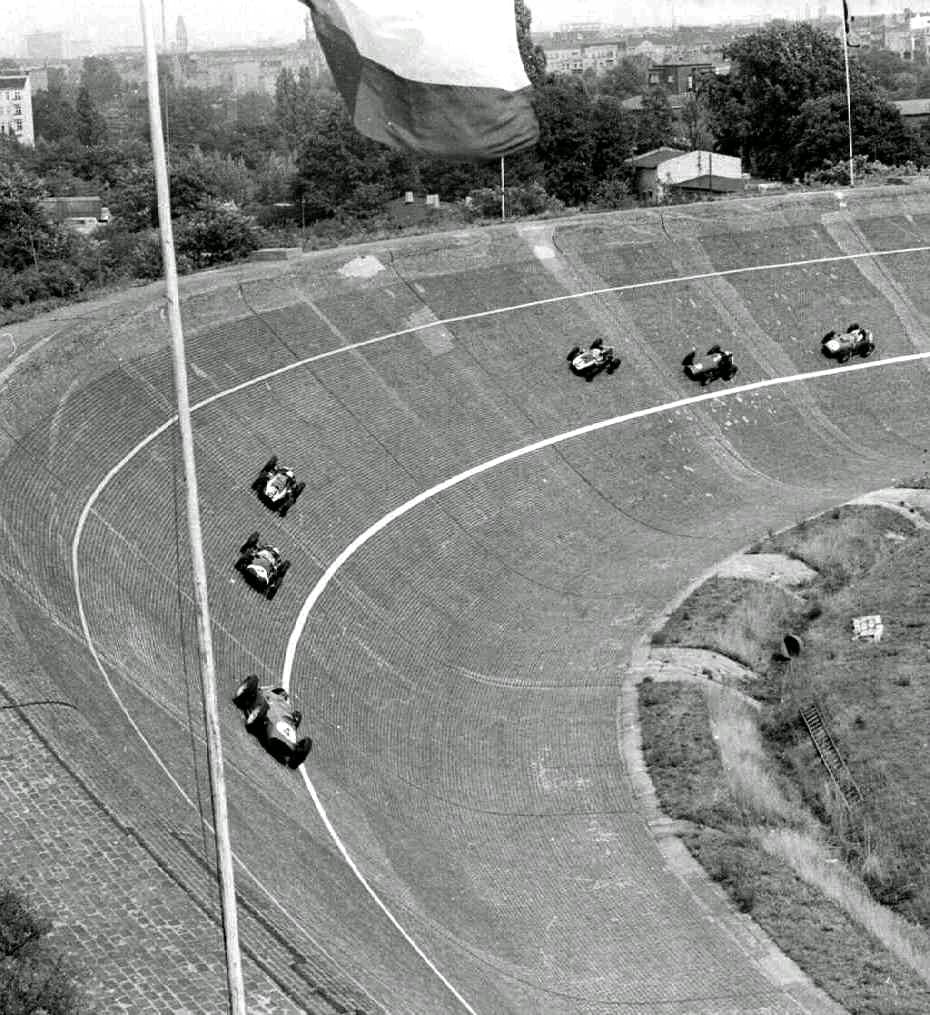

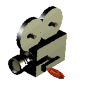



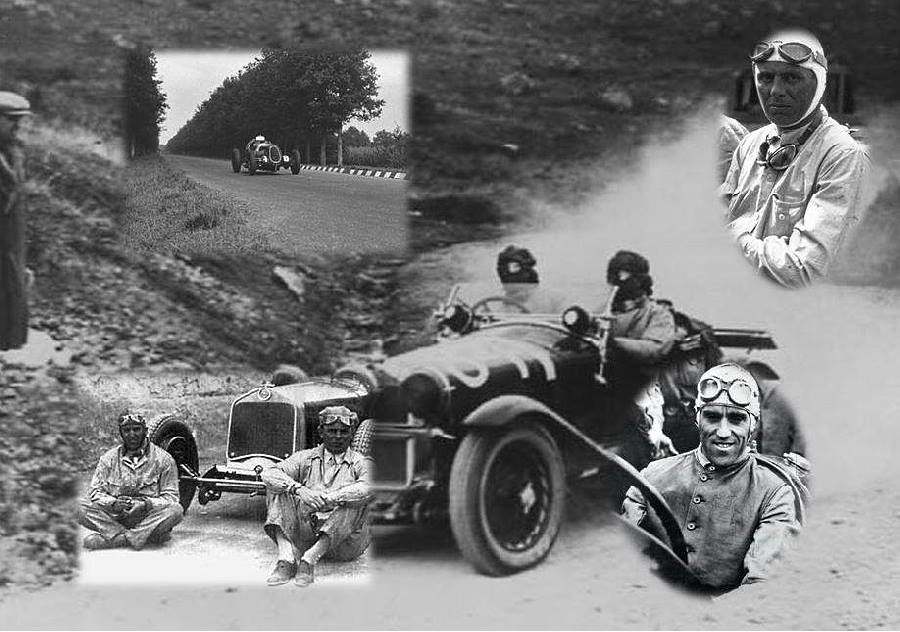
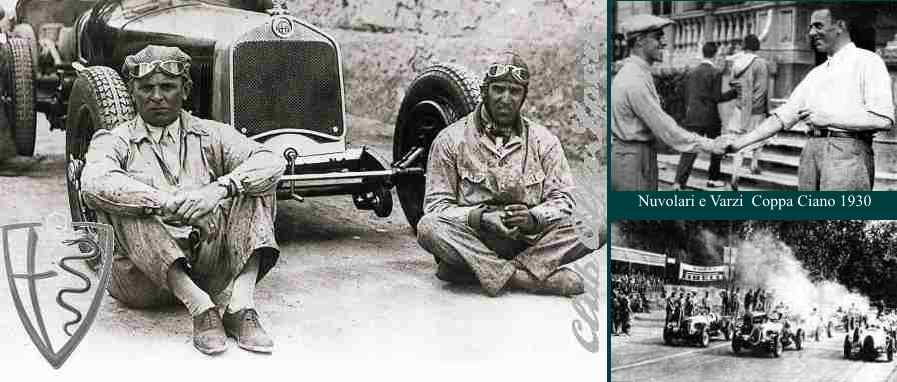
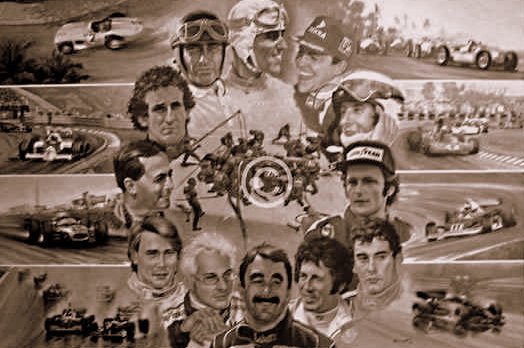






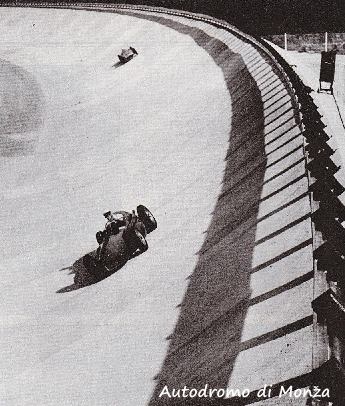

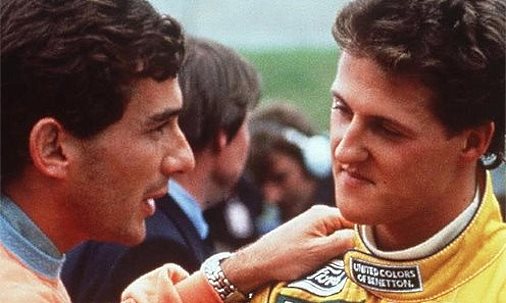




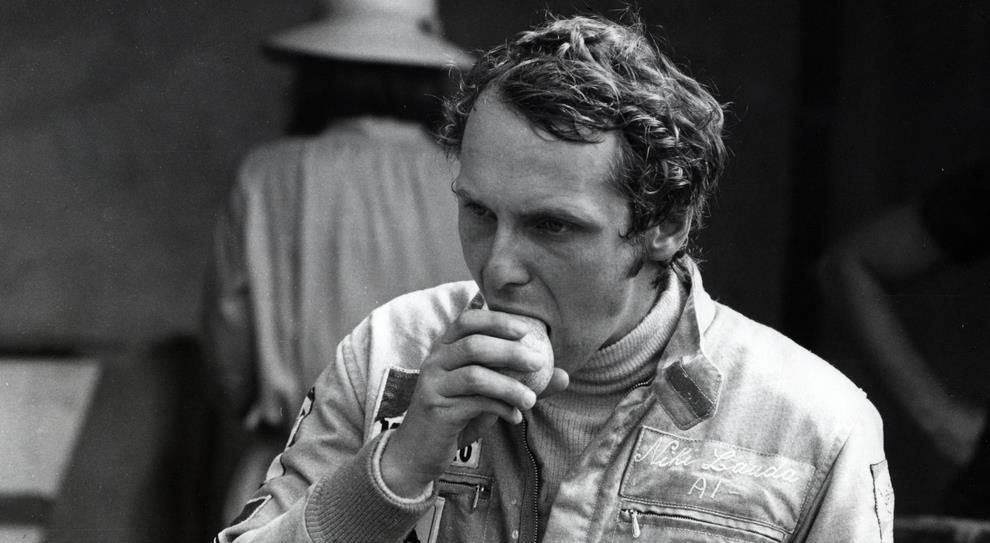
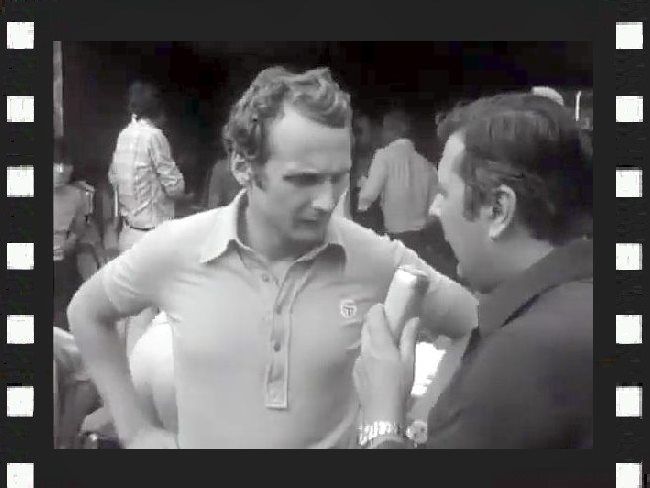



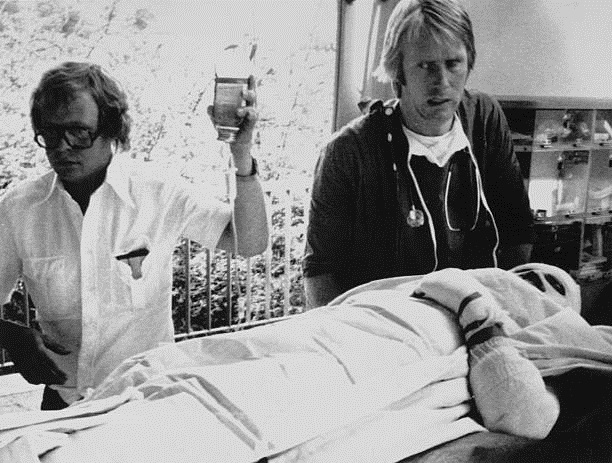

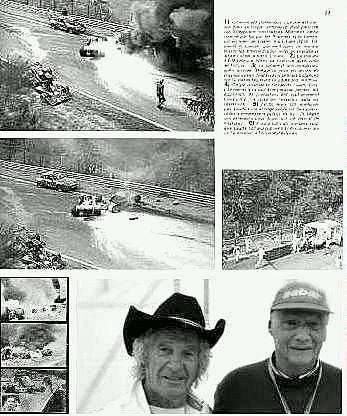

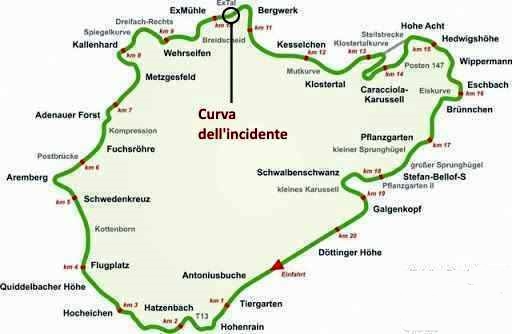




 Il GP d'Italia del
1975 potrebbe entrare nella storia: il
ferrarista Niki Lauda, in testa alla classifica, cerca
gli ultimi punti per conquistare matematicamente il titolo
mondiale.
Il GP d'Italia del
1975 potrebbe entrare nella storia: il
ferrarista Niki Lauda, in testa alla classifica, cerca
gli ultimi punti per conquistare matematicamente il titolo
mondiale. austriaco fece il bis iridato ma a fine stagione
divorziò dalla casa di Maranello che non gli aveva perdonato
il suo abbandono nel Gran Premio del Giappone del 1976 a causa
della pioggia battente, regalando il titolo alla McLaren di
James Hunt.
austriaco fece il bis iridato ma a fine stagione
divorziò dalla casa di Maranello che non gli aveva perdonato
il suo abbandono nel Gran Premio del Giappone del 1976 a causa
della pioggia battente, regalando il titolo alla McLaren di
James Hunt.

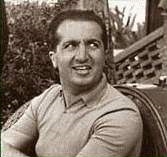
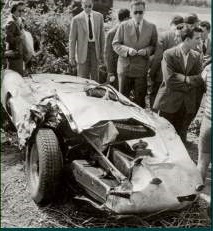
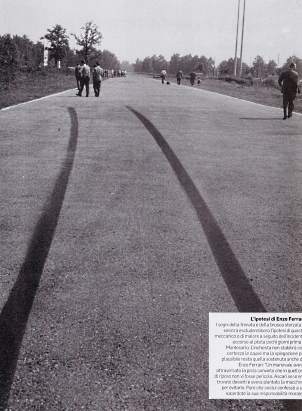

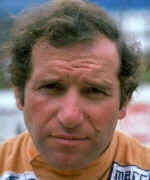
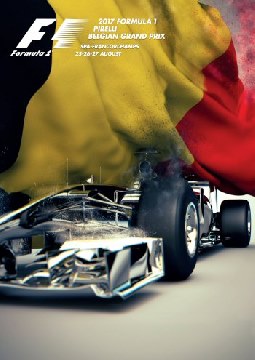







 Elio De
Angelis aveva talento ed era veloce, purtroppo si schiantò con uno spaventoso incidente, al Paul
Ricard, mentre testava la troppo avveniristica Brabham-BMW. Che fu subito
ribattezzata "sogliola", a causa dell'inclinazione data al motore dai
tecnici tedeschi per accontentare le bizzarre soluzioni pensate da Gordon
Murray per una Brabham che voleva fare dell'abbassamento del baricentro il
suo punto di forza.
Elio De
Angelis aveva talento ed era veloce, purtroppo si schiantò con uno spaventoso incidente, al Paul
Ricard, mentre testava la troppo avveniristica Brabham-BMW. Che fu subito
ribattezzata "sogliola", a causa dell'inclinazione data al motore dai
tecnici tedeschi per accontentare le bizzarre soluzioni pensate da Gordon
Murray per una Brabham che voleva fare dell'abbassamento del baricentro il
suo punto di forza.


 Alla
fine di quella stagione, però, Elio abbandona il team che gli ha dato
tante soddisfazioni per approdare alla Brabham. Nella squadra che era
stata creata da Colin Chapman, era arrivato uno nuovo: un certo Ayrton
Senna. E Elio aveva capito immediatamente che per lui non ci sarebbe più
stato spazio lì.
Alla
fine di quella stagione, però, Elio abbandona il team che gli ha dato
tante soddisfazioni per approdare alla Brabham. Nella squadra che era
stata creata da Colin Chapman, era arrivato uno nuovo: un certo Ayrton
Senna. E Elio aveva capito immediatamente che per lui non ci sarebbe più
stato spazio lì.
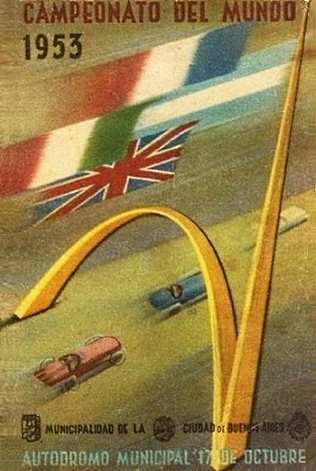









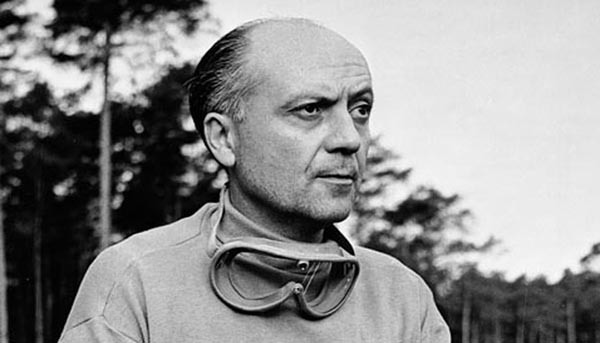
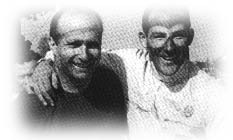 La
prima gara della stagione nel 1955 è il Gran Premio di Argentina.
Neubauer, sentendo la necessità di trovare un altro pilota del calibro
di Fangio da affiancargli, consulta la propria lista di piloti emergenti
e ingaggia Stirling Moss. Con Moss viene stabilito che nei Gran Premi
avrebbe funto da spalla per Fangio, mentre nelle altre gare
automobilistiche i due piloti sarebbero stati trattati in modo
paritario.
Jean Behra rimpiazza Moss alla Maserati mentre Hawthorn lascia la
Ferrari per entrare nella scuderia Britannica Vanwall.
La
prima gara della stagione nel 1955 è il Gran Premio di Argentina.
Neubauer, sentendo la necessità di trovare un altro pilota del calibro
di Fangio da affiancargli, consulta la propria lista di piloti emergenti
e ingaggia Stirling Moss. Con Moss viene stabilito che nei Gran Premi
avrebbe funto da spalla per Fangio, mentre nelle altre gare
automobilistiche i due piloti sarebbero stati trattati in modo
paritario.
Jean Behra rimpiazza Moss alla Maserati mentre Hawthorn lascia la
Ferrari per entrare nella scuderia Britannica Vanwall.
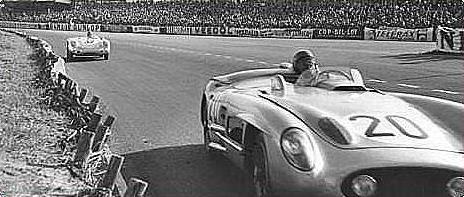




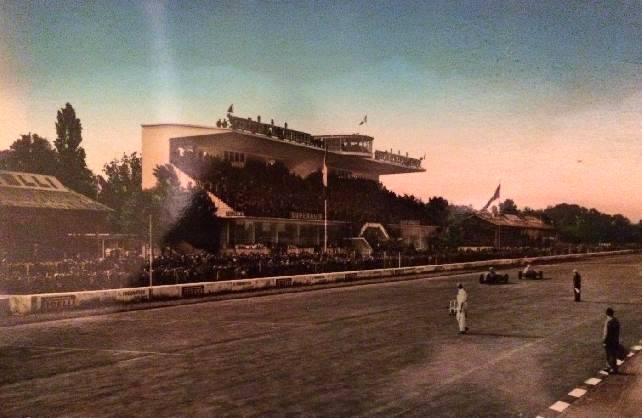



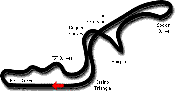








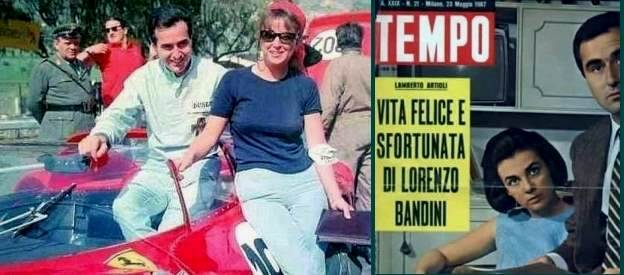



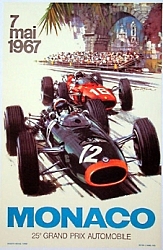


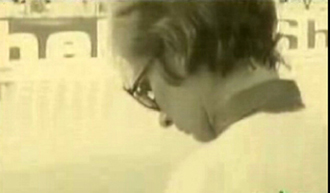

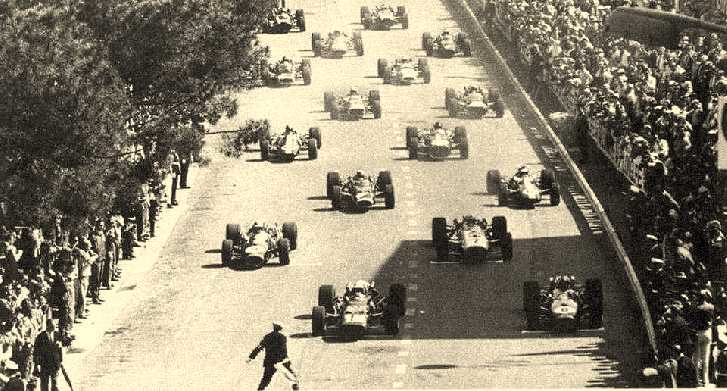





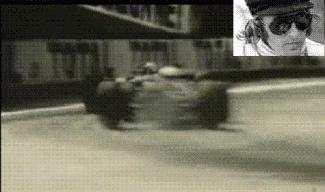
















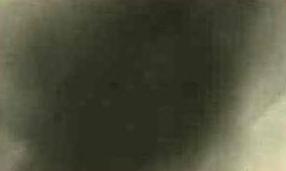



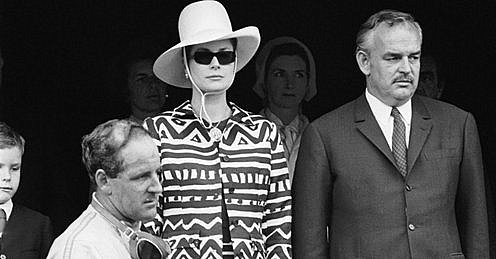














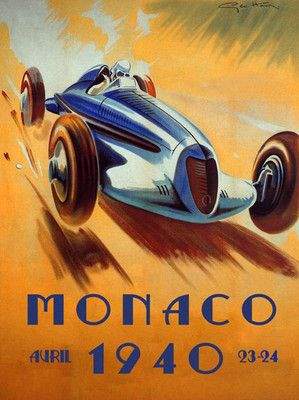


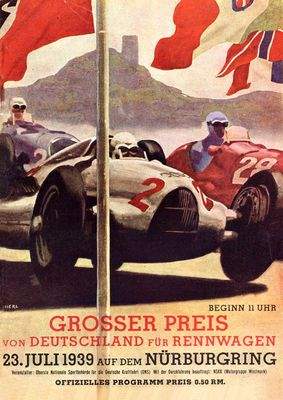
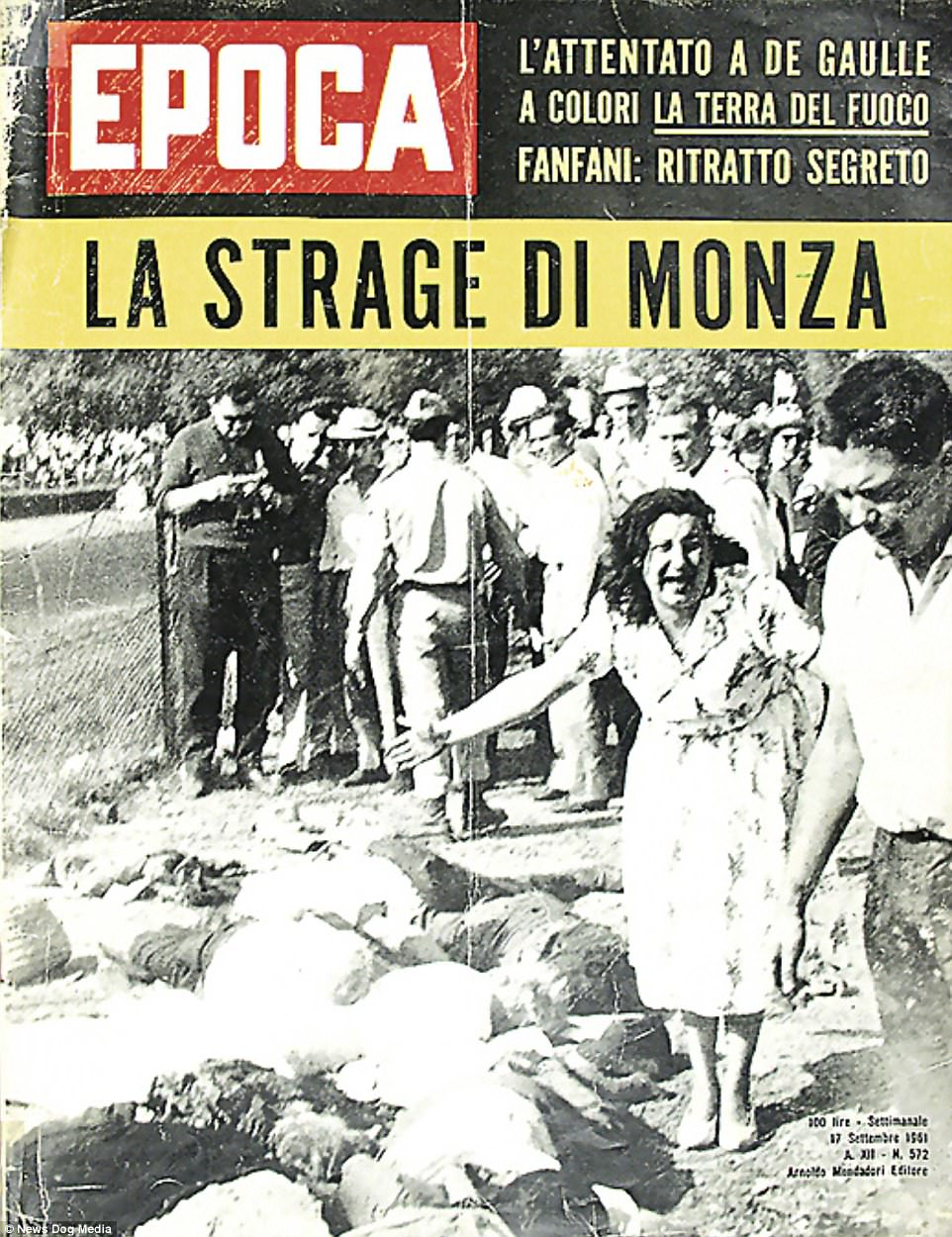

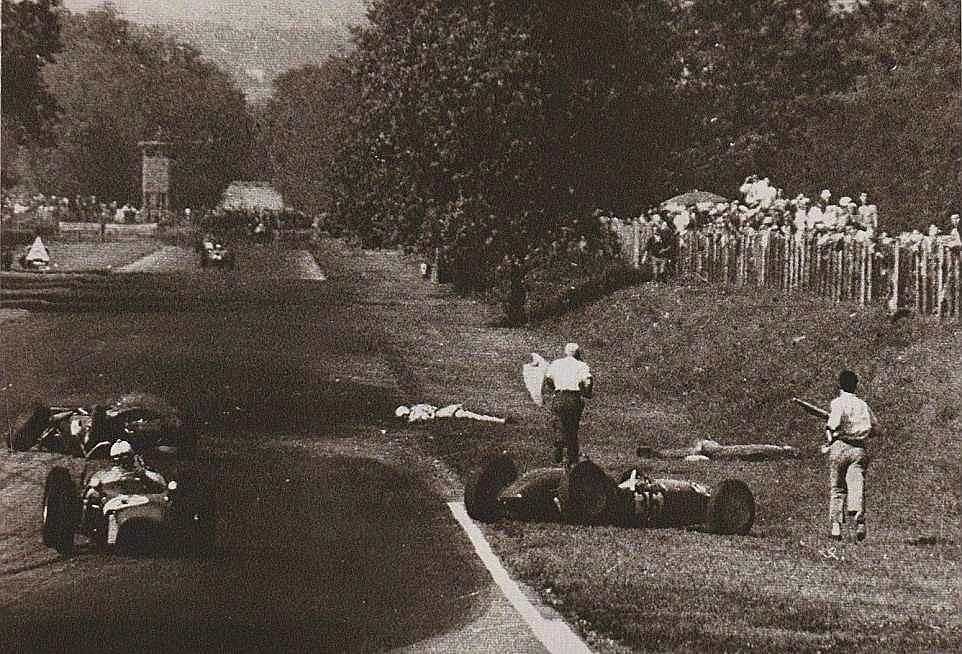


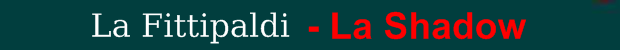








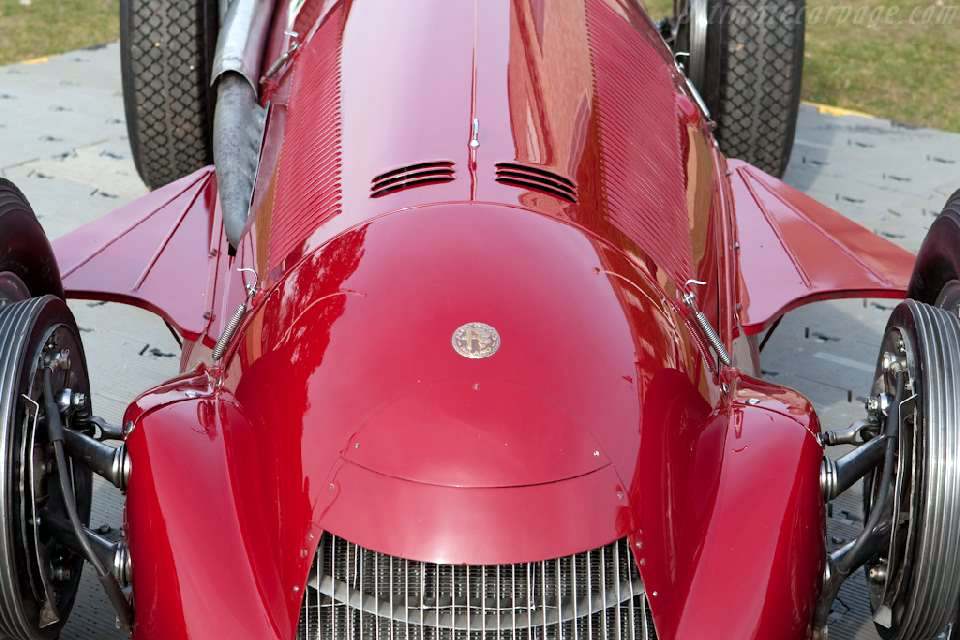
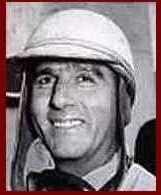
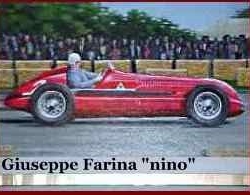
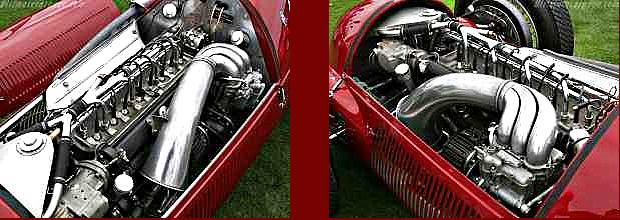


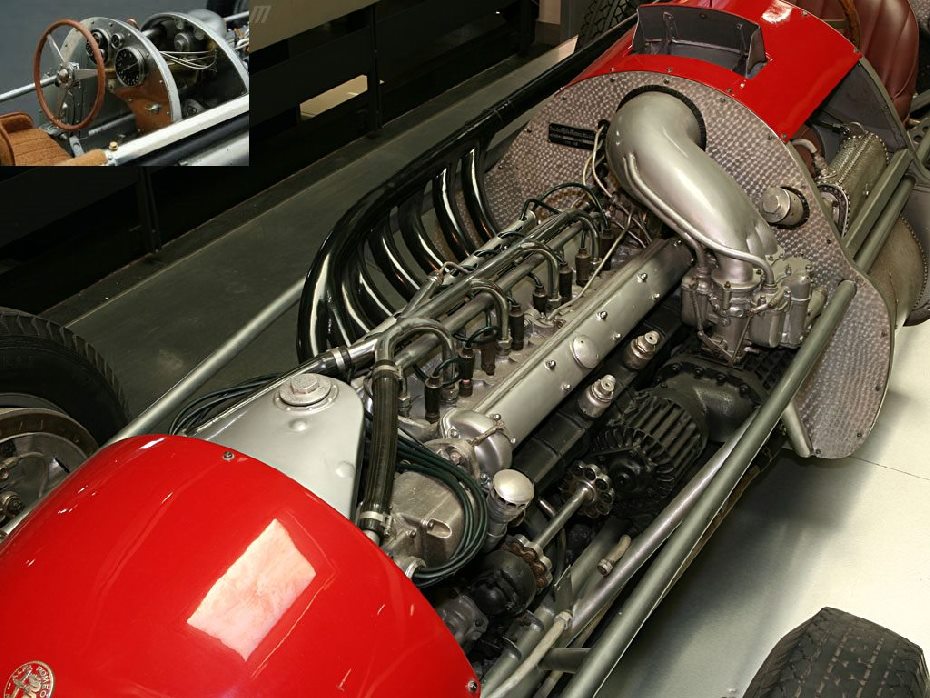
 Ma
l'Alfa stava pensando a ben altro che a una sola fornitura motoristica:
nel 1979 debuttò infatti la monoposto siglata «177», dotata di motore
boxer 12 cilindri. A pilotarla fu chiamato Bruno Giacomelli, che l'anno
prima aveva dominato in maniera clamorosa il campionato europeo di F.2 con
la March. Dal Gran Premio d'Italia, al pilota bresciano si affiancò
Vittorio Brambilla. Alla prima vettura seguì la «179» e nell'80 Vittorio
Brambilla venne sostituito da Patrick Depailler, sul quale l'Alfa contava
molto per le sue acclarate doti di collaudatore. I maggiori difetti della
macchina risiedevano in un peso elevato dovuto non solo al telaio, ma
anche a un motore che per esprimere tutta la sua potenza (520 CV a 12.400
giri) aveva bisogno di «bere» molta benzina. Ma Depailler aveva fiducia di
riuscire a sgrezzare la «179» e intensificò i test. In uno di questi, sul
circuito di Hockenheim, in preparazione del Gran Premio di Germania, il
pilota francese uscì però di strada per ragioni che sono rimaste
misteriose (come spesso accade nelle corse) schiantandosi in un terribile
impatto. Giacomelli restò solo, e nel Gran Premio che si disputò nove
giorni dopo, raccolse un quinto posto che, unito allo stesso risultato
ottenuto in Argentina, portò a quattro i punti conquistati dall'Alfa
nell'intera stagione. Sul finire dell'anno, Giacomelli dimostrò quanto
valesse quella vettura, realizzando ottimi tempi in prova e addirittura la
pole position a Watkins Glen: performance che però non trovarono poi
riscontro in corsa.
Ma
l'Alfa stava pensando a ben altro che a una sola fornitura motoristica:
nel 1979 debuttò infatti la monoposto siglata «177», dotata di motore
boxer 12 cilindri. A pilotarla fu chiamato Bruno Giacomelli, che l'anno
prima aveva dominato in maniera clamorosa il campionato europeo di F.2 con
la March. Dal Gran Premio d'Italia, al pilota bresciano si affiancò
Vittorio Brambilla. Alla prima vettura seguì la «179» e nell'80 Vittorio
Brambilla venne sostituito da Patrick Depailler, sul quale l'Alfa contava
molto per le sue acclarate doti di collaudatore. I maggiori difetti della
macchina risiedevano in un peso elevato dovuto non solo al telaio, ma
anche a un motore che per esprimere tutta la sua potenza (520 CV a 12.400
giri) aveva bisogno di «bere» molta benzina. Ma Depailler aveva fiducia di
riuscire a sgrezzare la «179» e intensificò i test. In uno di questi, sul
circuito di Hockenheim, in preparazione del Gran Premio di Germania, il
pilota francese uscì però di strada per ragioni che sono rimaste
misteriose (come spesso accade nelle corse) schiantandosi in un terribile
impatto. Giacomelli restò solo, e nel Gran Premio che si disputò nove
giorni dopo, raccolse un quinto posto che, unito allo stesso risultato
ottenuto in Argentina, portò a quattro i punti conquistati dall'Alfa
nell'intera stagione. Sul finire dell'anno, Giacomelli dimostrò quanto
valesse quella vettura, realizzando ottimi tempi in prova e addirittura la
pole position a Watkins Glen: performance che però non trovarono poi
riscontro in corsa. C'era quindi da lavorare
sull'affidabilità, partendo da una base di prestazioni ottima: per la
stagione successiva l'Alfa immaginò ben altre situazioni nel mondiale di
quelle che invece si produrranno: Mario Andretti riuscì infatti a
raccogliere solo un quarto posto a Long Beach, per la restante metà della
stagione si accumularono delusioni su delusioni. Alla base c'era anche il
fatto che la «179 C» risentiva più di altre monoposto del divieto delle
«minigonne», una norma che aveva portato i tecnici di Arese a modificare
la conformazione aerodinamica della vettura. Come nell'anno precedente,
anche in questo 1981, Giacomelli riuscì a far alzare nuovamente la testa
all'Alfa proprio sul finire della stagione.
C'era quindi da lavorare
sull'affidabilità, partendo da una base di prestazioni ottima: per la
stagione successiva l'Alfa immaginò ben altre situazioni nel mondiale di
quelle che invece si produrranno: Mario Andretti riuscì infatti a
raccogliere solo un quarto posto a Long Beach, per la restante metà della
stagione si accumularono delusioni su delusioni. Alla base c'era anche il
fatto che la «179 C» risentiva più di altre monoposto del divieto delle
«minigonne», una norma che aveva portato i tecnici di Arese a modificare
la conformazione aerodinamica della vettura. Come nell'anno precedente,
anche in questo 1981, Giacomelli riuscì a far alzare nuovamente la testa
all'Alfa proprio sul finire della stagione.
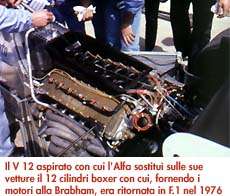 In quella successiva, Andrea
De Cesaris rilevò Mario Andretti, ma la nuova «182» non riuscì a
raccogliere punti fino al Gran Premio di Montecarlo, dove una corsa che
ridotta ad una vera e propria lotteria a causa degli scrosci di pioggia e
delle numerosissime uscite di pista, assegnò al pilota romano il podio con
il terzo posto. Mentre il motore 8 cilindri turbo veniva collaudato sulla
pista del Balocco da Giorgio Francia, Giacomelli e De Cesaris dovevano
combattere col 12 cilindri ormai superato rispetto alle motorizzazioni
turbo della Ferrari e della Renault. Anche il telaio, disegnato da
Ducarouge, non sembrava all'altezza della situazione: la stagione si
chiuse così col decimo posto nel mondiale costruttori, evidenziando una
situazione difficile nel team sia a livello tecnico sia gestionale. In
conseguenza di ciò, Ettore Massacesi, presidente dell'Alfa Romeo, decise
di cedere tutto il materiale all'Euroracing di Pavanello, che avrebbe
potuto contare sulla fornitura dei motori turbo 8 cilindri e
sull'assistenza tecnica dell'Autodelta. L'avventura Alfa sotto queste
insegne proseguì fino all'85, quando si concluse definitivamente, mentre i
motori vennero forniti all'Osella fino al
1987.
In quella successiva, Andrea
De Cesaris rilevò Mario Andretti, ma la nuova «182» non riuscì a
raccogliere punti fino al Gran Premio di Montecarlo, dove una corsa che
ridotta ad una vera e propria lotteria a causa degli scrosci di pioggia e
delle numerosissime uscite di pista, assegnò al pilota romano il podio con
il terzo posto. Mentre il motore 8 cilindri turbo veniva collaudato sulla
pista del Balocco da Giorgio Francia, Giacomelli e De Cesaris dovevano
combattere col 12 cilindri ormai superato rispetto alle motorizzazioni
turbo della Ferrari e della Renault. Anche il telaio, disegnato da
Ducarouge, non sembrava all'altezza della situazione: la stagione si
chiuse così col decimo posto nel mondiale costruttori, evidenziando una
situazione difficile nel team sia a livello tecnico sia gestionale. In
conseguenza di ciò, Ettore Massacesi, presidente dell'Alfa Romeo, decise
di cedere tutto il materiale all'Euroracing di Pavanello, che avrebbe
potuto contare sulla fornitura dei motori turbo 8 cilindri e
sull'assistenza tecnica dell'Autodelta. L'avventura Alfa sotto queste
insegne proseguì fino all'85, quando si concluse definitivamente, mentre i
motori vennero forniti all'Osella fino al
1987.


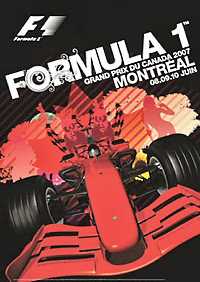







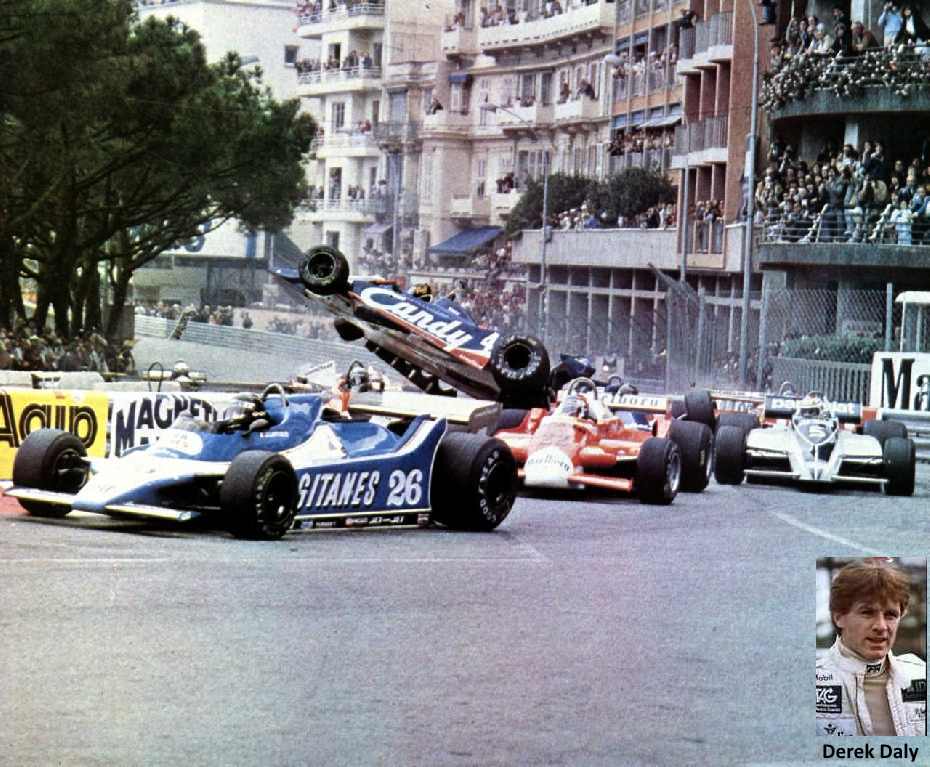

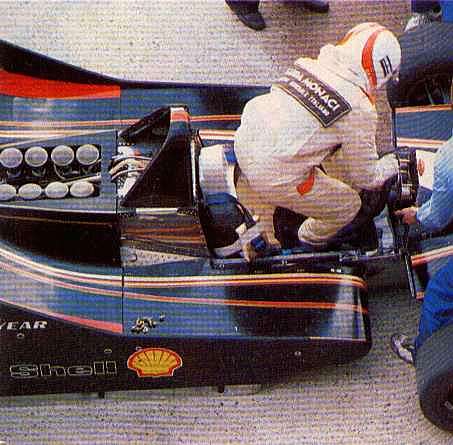

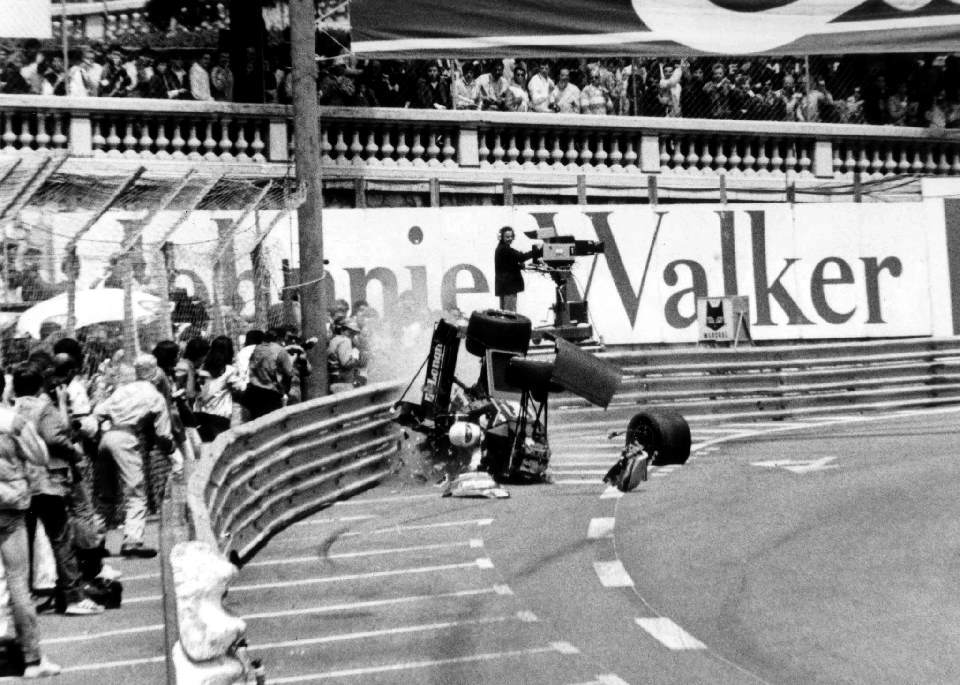
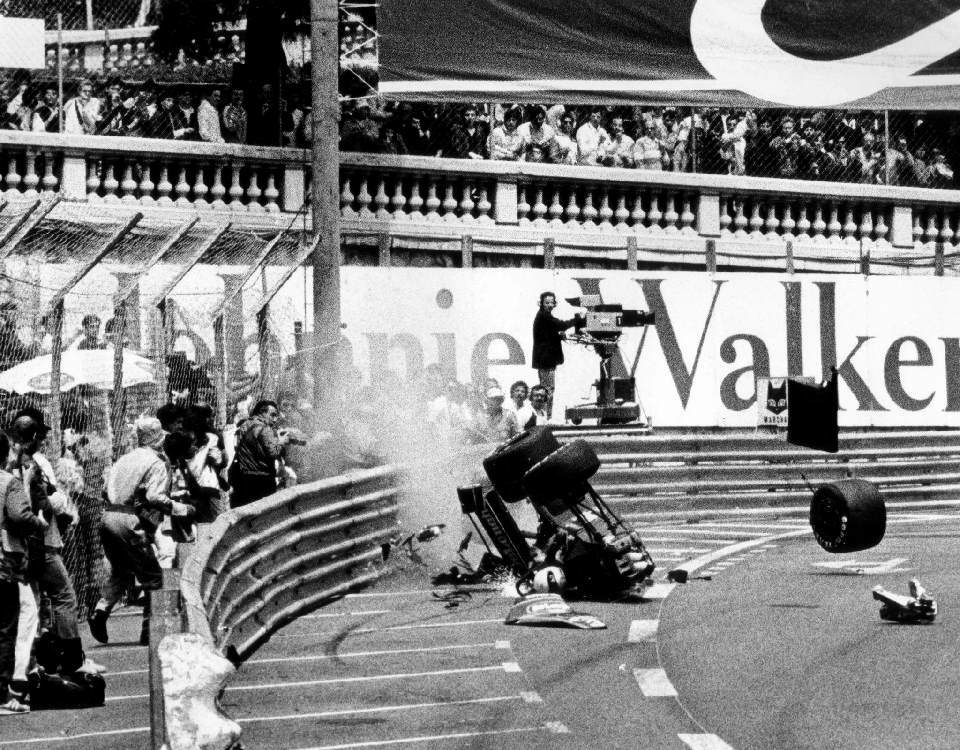











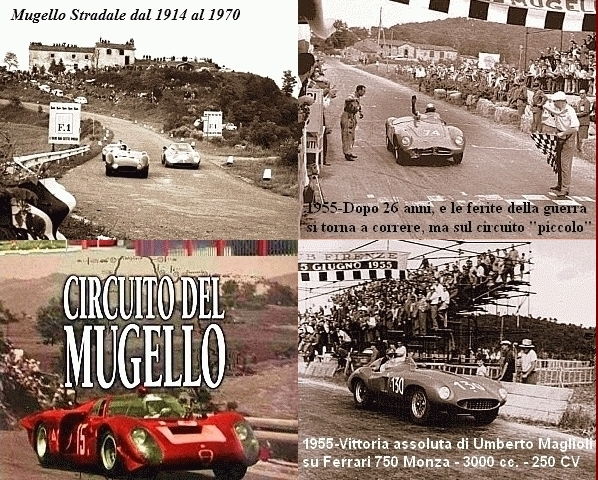







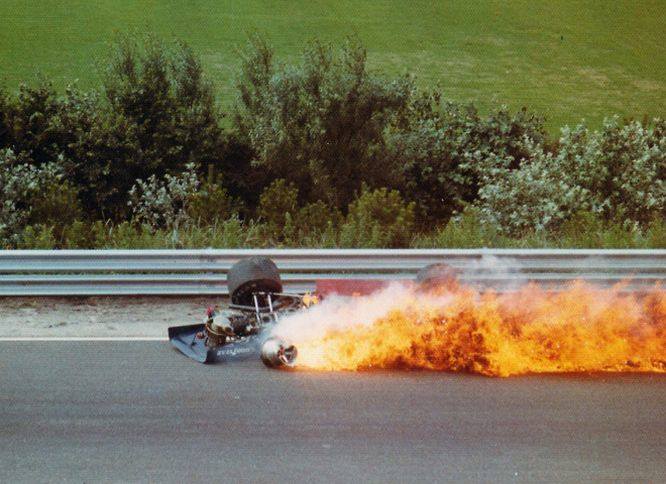

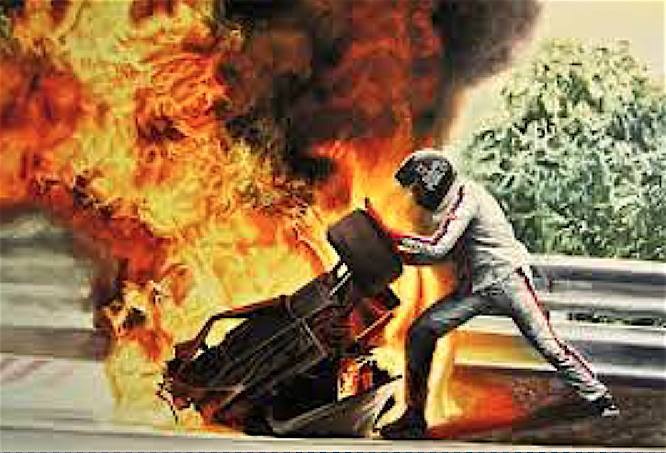


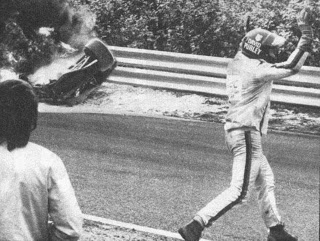





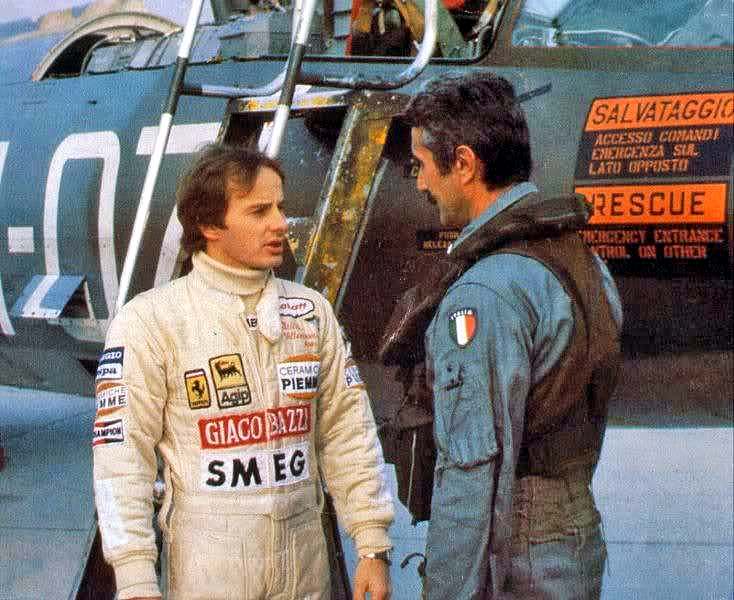






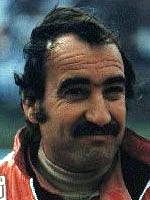














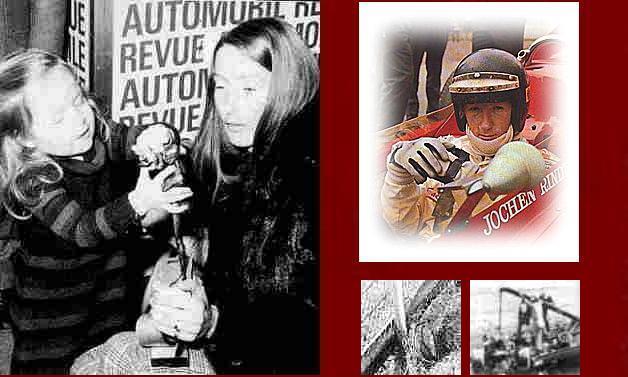
 Lo scozzese e la scuderia
di Ockham in quegli anni offuscarono marchi ben più blasonati,
rappresentando di fatto il binomio col quale dovevano fare i conti tutti
quelli che nutrivano ambizioni iridate. Ancora una volta, la storia delle
corse aveva messo in scena un duo formidabile, come era accaduto in
passato con il sodalizio Clark-Lotus che solo la disgrazia di Hockenehim
aveva tragicamente interrotto nel '68. Anche quel '73 della Tyrrell
comunque fu caratterizzato da una tragedia: nell'ultima gara in programma
a Watkins Glen, infatti, Francois
Cévert, destinato a rilevare il posto di
caposquadra lasciato libero da Jackie Stewart, subì un incidente mortale in prova, azzerando di fatto il
team campione del mondo. Da quel momento, la scude
Lo scozzese e la scuderia
di Ockham in quegli anni offuscarono marchi ben più blasonati,
rappresentando di fatto il binomio col quale dovevano fare i conti tutti
quelli che nutrivano ambizioni iridate. Ancora una volta, la storia delle
corse aveva messo in scena un duo formidabile, come era accaduto in
passato con il sodalizio Clark-Lotus che solo la disgrazia di Hockenehim
aveva tragicamente interrotto nel '68. Anche quel '73 della Tyrrell
comunque fu caratterizzato da una tragedia: nell'ultima gara in programma
a Watkins Glen, infatti, Francois
Cévert, destinato a rilevare il posto di
caposquadra lasciato libero da Jackie Stewart, subì un incidente mortale in prova, azzerando di fatto il
team campione del mondo. Da quel momento, la scude ria inglese non riuscirà
mai più a ripetere gli antichi fasti, avviandosi lentamente, fra alti e
bassi, ad una penombra che la relegò ai livelli medio-bassi del circus.
Dal 1999 la Tyrrell non esiste più, è stata
rilevata da
Craig Pollock che l'ha ribattezzata BAR.
ria inglese non riuscirà
mai più a ripetere gli antichi fasti, avviandosi lentamente, fra alti e
bassi, ad una penombra che la relegò ai livelli medio-bassi del circus.
Dal 1999 la Tyrrell non esiste più, è stata
rilevata da
Craig Pollock che l'ha ribattezzata BAR.
 Perso il proprio campione e il suo
sostituto più naturale, come detto, Tyrrell si affida alla coppia Scheckter-Depailler, con Derek Gardner a mantenere ben saldo il timone
tecnico della squadra. Il geniale ingegnere stupisce il Circus nel '76,
quando fa debuttare la sua ultima nata: la P34, la cui caratteristica è
quella del tutto originale di montare sei ruote: due dietro e quattro, più
piccole, davanti. La "sei ruote" come fu subito battezzata la P34, fu
inquadrata dall'ambiente più come una trovata pubblicitaria
Perso il proprio campione e il suo
sostituto più naturale, come detto, Tyrrell si affida alla coppia Scheckter-Depailler, con Derek Gardner a mantenere ben saldo il timone
tecnico della squadra. Il geniale ingegnere stupisce il Circus nel '76,
quando fa debuttare la sua ultima nata: la P34, la cui caratteristica è
quella del tutto originale di montare sei ruote: due dietro e quattro, più
piccole, davanti. La "sei ruote" come fu subito battezzata la P34, fu
inquadrata dall'ambiente più come una trovata pubblicitaria che una
monoposto con soluzioni tecniche d'avanguardia (soluzioni sperimentate
anche dalla March, che realizzò anch'essa una monoposto - mai però
utilizzata in corsa- a sei ruote, con la differenza rispetto alla Tyrrell
di avere le quattro ruote sull'asse posteriore anziché su quello
anteriore). Sta di fatto che questa "trovata pubblicitaria", vinse il GP
di Svezia del '76 con una doppietta firmata Scheckter-Depailler. Ma, al di
là di questo successo, proprio questo progetto fu la causa della rottura
del sodalizio storico fra Tyrrell e Gardner. Negli anni successivi,
il team che aveva nel suo palmarès tre titoli iridati, dovette
accontentarsi di tre vittorie, ottenute da Depailler nel '78 a Montecarlo,
e da Alboreto nell'82 e nell'83 a Las Vegas e a Detroit. Da quel momento,
il team non vincerà mai più una corsa, barcamenandosi nel mondiale come
una delle tante squadre spesso sull'orlo della chiusura. Chiusura
puntualmente arrivata, come detto, nel 1999, quando la British American
Racing, rilevò tutto il materiale della Tyrrell per dar vita a una
nuova scuderia.
che una
monoposto con soluzioni tecniche d'avanguardia (soluzioni sperimentate
anche dalla March, che realizzò anch'essa una monoposto - mai però
utilizzata in corsa- a sei ruote, con la differenza rispetto alla Tyrrell
di avere le quattro ruote sull'asse posteriore anziché su quello
anteriore). Sta di fatto che questa "trovata pubblicitaria", vinse il GP
di Svezia del '76 con una doppietta firmata Scheckter-Depailler. Ma, al di
là di questo successo, proprio questo progetto fu la causa della rottura
del sodalizio storico fra Tyrrell e Gardner. Negli anni successivi,
il team che aveva nel suo palmarès tre titoli iridati, dovette
accontentarsi di tre vittorie, ottenute da Depailler nel '78 a Montecarlo,
e da Alboreto nell'82 e nell'83 a Las Vegas e a Detroit. Da quel momento,
il team non vincerà mai più una corsa, barcamenandosi nel mondiale come
una delle tante squadre spesso sull'orlo della chiusura. Chiusura
puntualmente arrivata, come detto, nel 1999, quando la British American
Racing, rilevò tutto il materiale della Tyrrell per dar vita a una
nuova scuderia.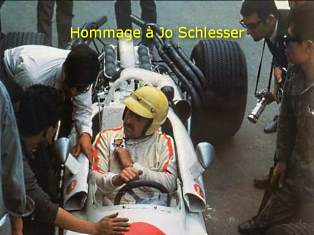
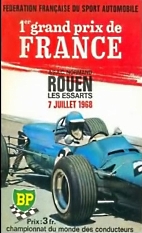





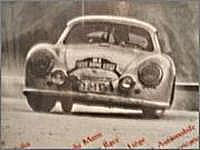




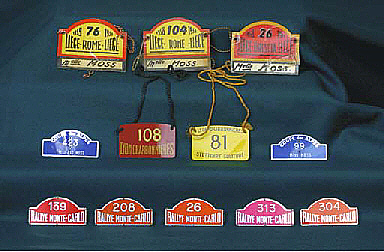





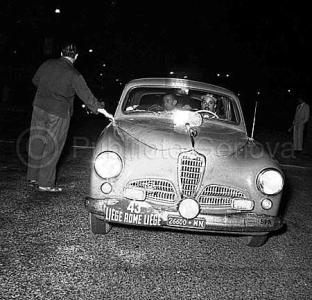
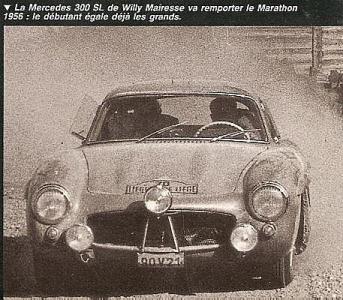
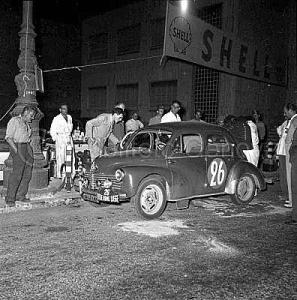

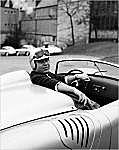







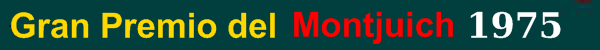
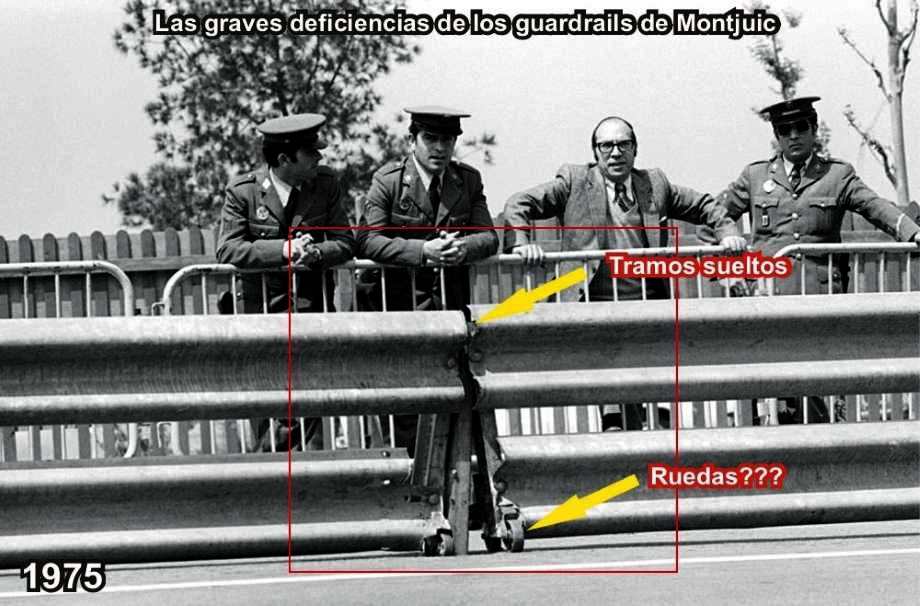
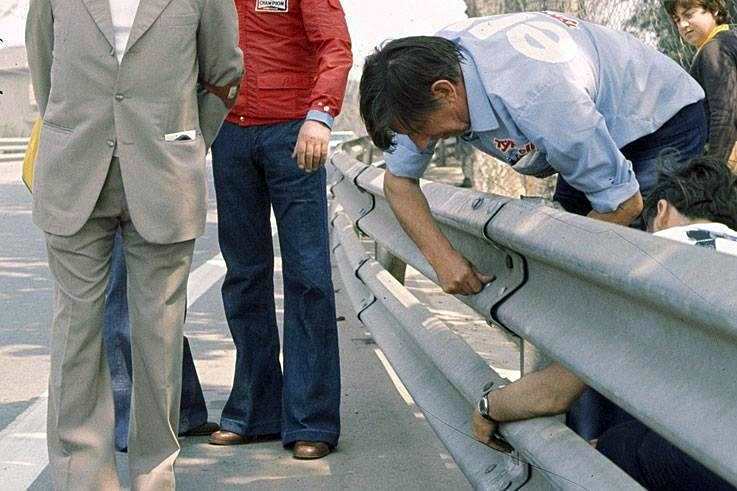





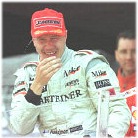 Il
30 Settembre 2001 Mika Hakkinen ha messo a segno la ventesima e ultima vittoria
della sua brillate carriera; ad Indianapolis, a bordo di una Mclaren MP4-16 ha
battuto tutti, sbucando quasi dal nulla: nessuno avrebbe scommesso su questo
risultato, le caratteristiche del circuito sembravano favorevoli alla Ferrari e
alla Williams BMW, in casa McLaren non si pensava quindi che quello di
Indianapolis sarebbe stato un pomeriggio da ricordare; oltretutto il "Finlandese
Volante" aveva annunciato alcuni giorni prima che avrebbe preso un anno di pausa
...
Il
30 Settembre 2001 Mika Hakkinen ha messo a segno la ventesima e ultima vittoria
della sua brillate carriera; ad Indianapolis, a bordo di una Mclaren MP4-16 ha
battuto tutti, sbucando quasi dal nulla: nessuno avrebbe scommesso su questo
risultato, le caratteristiche del circuito sembravano favorevoli alla Ferrari e
alla Williams BMW, in casa McLaren non si pensava quindi che quello di
Indianapolis sarebbe stato un pomeriggio da ricordare; oltretutto il "Finlandese
Volante" aveva annunciato alcuni giorni prima che avrebbe preso un anno di pausa
... La macchina era perfetta, eveva più carburante del
compagno di squadra, ma comunque si sentiva molto veloce; poi, senza nessuna
avvisaglia, all'ingresso di una curva gli anteriori si sono bloccati: ha cercato
di riprendere il controllo, senza riuscirci, e la macchina ha sbattuto contro le
barriere di protezione.
La macchina era perfetta, eveva più carburante del
compagno di squadra, ma comunque si sentiva molto veloce; poi, senza nessuna
avvisaglia, all'ingresso di una curva gli anteriori si sono bloccati: ha cercato
di riprendere il controllo, senza riuscirci, e la macchina ha sbattuto contro le
barriere di protezione.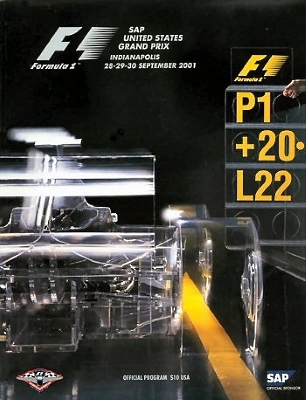










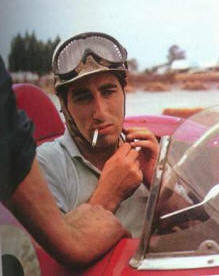


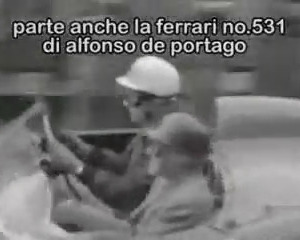
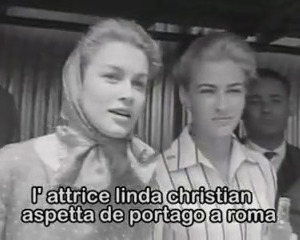
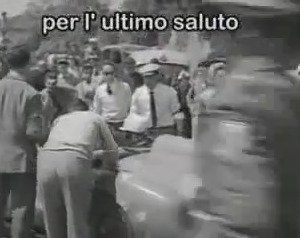

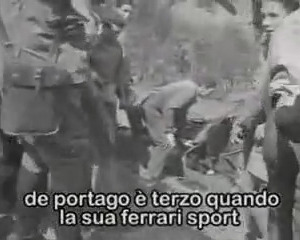
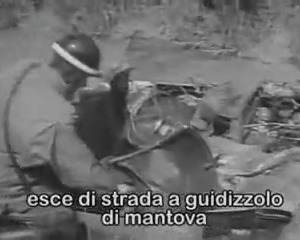
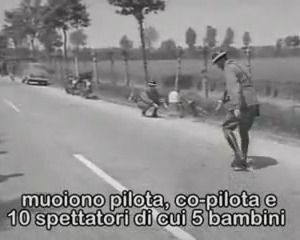

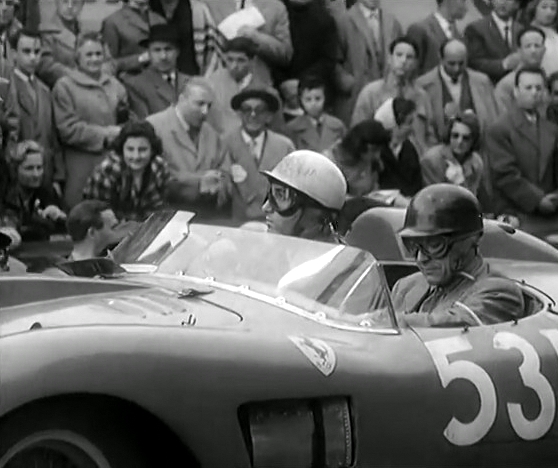





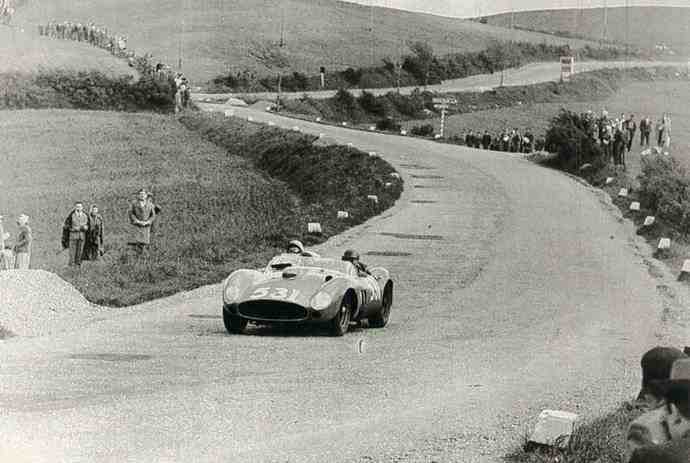
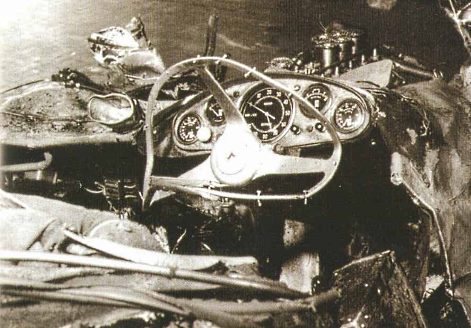


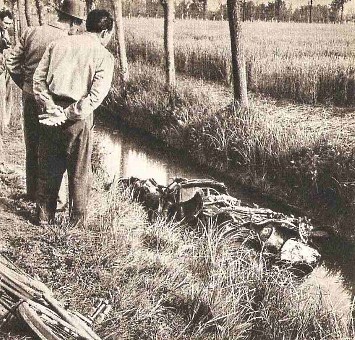





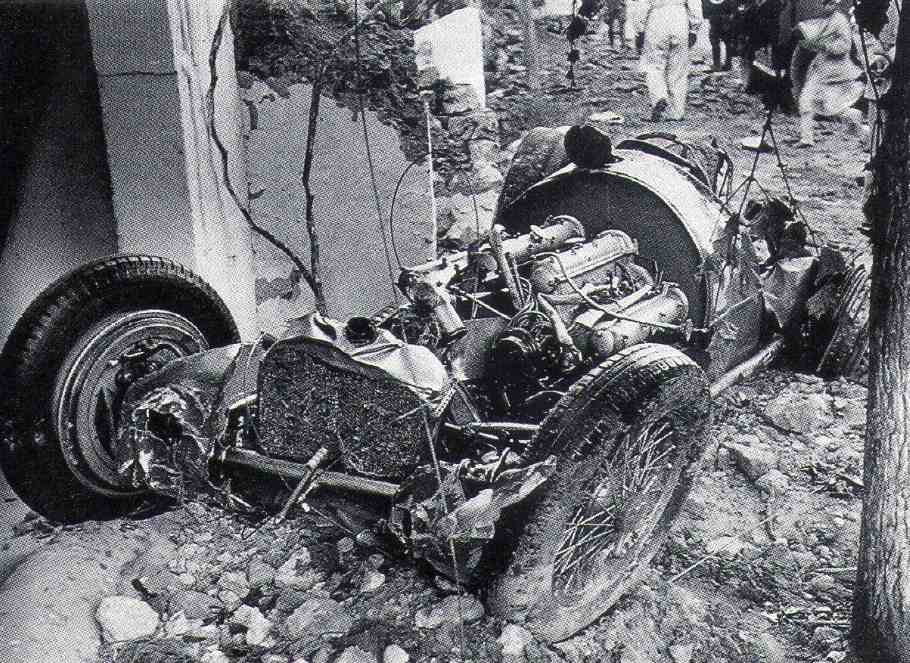

 Ora,
il nuovo astro nascente, sembra essere il colombiano Juan Pablo Montoya.
Ora,
il nuovo astro nascente, sembra essere il colombiano Juan Pablo Montoya. riusciti ad imporsi.
riusciti ad imporsi.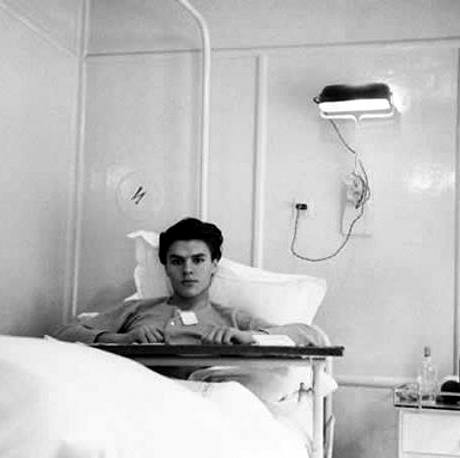


 Si temeva la prima variante ma è alla Roggia che si scatena il
finimondo.Barrichello tenta il sorpasso ai danni di Trulli, ma il
brasiliano viene toccato da Frentzen che, dopo il contatto con il
ferrarista, si gira e va a toccare Trulli. A questo punto il caos diventa
totale: si alza un polverone enorme, macchine incontrollabili che si incastrano,
detriti che vengono "sparati" ovunque.
Si temeva la prima variante ma è alla Roggia che si scatena il
finimondo.Barrichello tenta il sorpasso ai danni di Trulli, ma il
brasiliano viene toccato da Frentzen che, dopo il contatto con il
ferrarista, si gira e va a toccare Trulli. A questo punto il caos diventa
totale: si alza un polverone enorme, macchine incontrollabili che si incastrano,
detriti che vengono "sparati" ovunque.





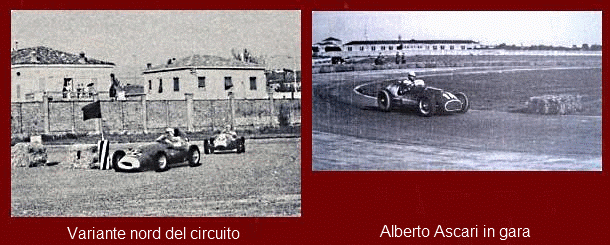
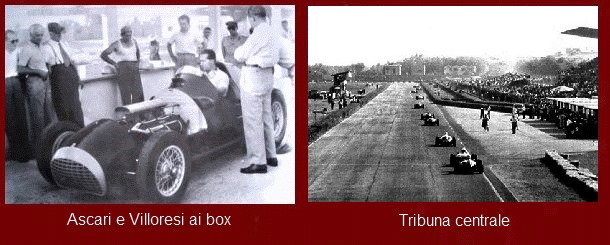



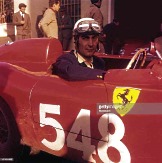


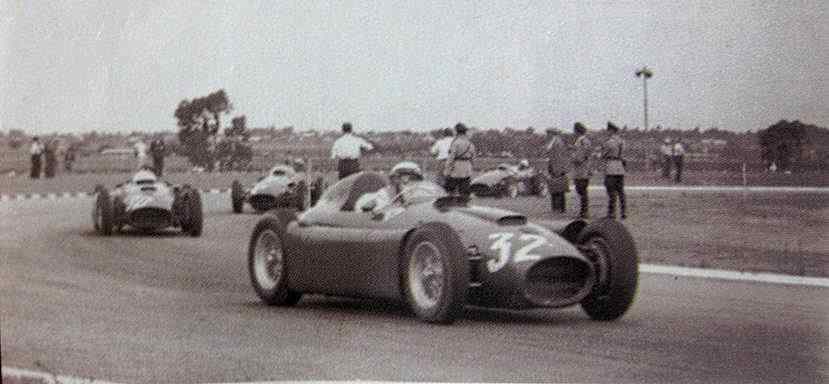
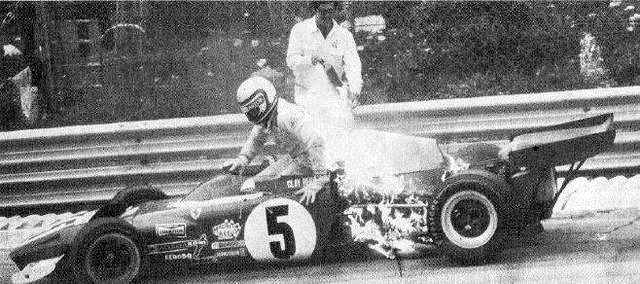
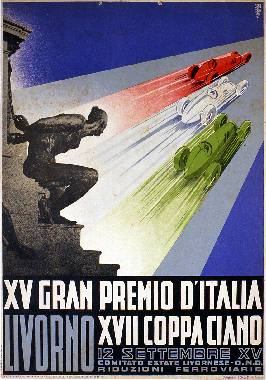







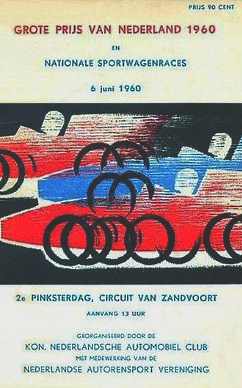






 L’1
agosto 1980 Patrick Depailler viene chiamato dall' Alfa Romeo, la
scuderia per la quale corre, sul circuito tedesco di Hockenheim per prove di
motore in un’annata nella quale la scuderia del Biscione non ha raccolto
granchè nelle otto gare del mondiale disputate fino a quel momento (sette
ritiri e un non classificato).
L’1
agosto 1980 Patrick Depailler viene chiamato dall' Alfa Romeo, la
scuderia per la quale corre, sul circuito tedesco di Hockenheim per prove di
motore in un’annata nella quale la scuderia del Biscione non ha raccolto
granchè nelle otto gare del mondiale disputate fino a quel momento (sette
ritiri e un non classificato).