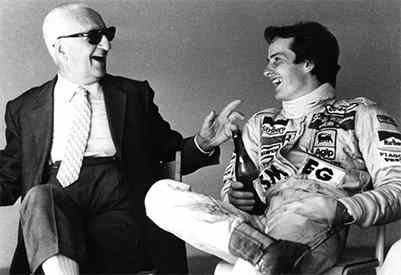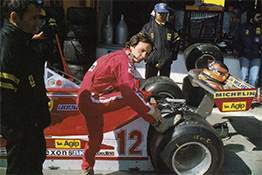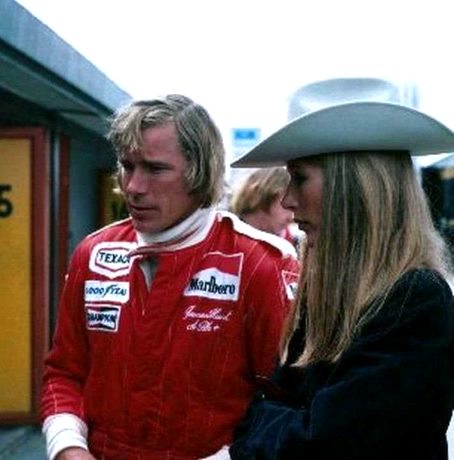Curiosità - Personaggi Mito
La dinamica
dell’incidente non ce l’ha chiara nemmeno Enzo Ferrari. Che
scrive: “È difficile sapere con esattezza ciò che
accadde.
I pochi
testimoni e gli ufficiali di gara fecero un racconto in cui lo spavento
prevalse sulla fedeltà della cronaca”.
Gran Premio di Francia, 6 luglio del 1958, mentre lotta con Mike Hawthorn si schianta e muore Luigi Musso sulla Ferrari
alla curva del Calvaire di Reims.
“E finisce – sempre Ferrari che scrive – il bello stile italiano”.
Educato, acculturato, figlio di un diplomatico e bello come un divo,
eroe intrepido e dannato, corre per mestiere e corre pure – lo confessa
ad Antonio Ghirelli – perché ha bisogno “di guadagnare molto”, prova a farlo “attraverso un rischio calcolato”.
È una faccenda enigmatica, ci sono di mezzo i debiti di gioco. Musso
nel 1957 nel volo verso l’Argentina ha perso 12 milioni di lire a poker.
E allora le corse, il Gran Premio di Francia che assegna un premio
dieci volte più grande rispetto a tutte le altre tappe del mondiale.
Lui
è deciso a vincere.
Come Hawthorn e Collins che pure guidano la Ferrari
e secondo Fiamma Breschi, l’ultima compagna di Musso, hanno un patto
per ostacolarlo:
Chiunque dei due avesse vinto, avrebbe diviso i soldi con
l’altro. L’unione fa la forza. E loro erano in due contro Luigi che non
faceva parte dell’accordo. Era una rivalità che avrebbe anche favorito
Ferrari anziché danneggiarlo.
Più veloci andavano, più probabilità
c’erano di vincere.
Insomma Musso quando arriva al Calvaire si gioca tutto per tutto:
“Sono convinto – svela Ferrari – che la foga della gara
gli fece tenere
il piede giù a fondo”.
Come gli aveva detto Fangio, per guadagnare mezzo
secondo.
Fangio che dall’inizio del campionato già sta meditando il
ritiro e dopo la tragedia decide di smettere.


Fiamma Breschi Enzo Ferrari
|
CHI ERA FIAMMA BRESCHI
LA MUSA MISTERIOSA CHE COLORAVA LA VITA DI ENZO FERRARI
|
L'ultimo, straordinario, saluto firmato Giorgio Terruzzi a Fiamma
Breschi, la “bellissima signora” del Cavallino - Dopo la morte del
compagno Luigi Musso, pilota romano della Rossa, tentò il suicidio ma fu
salvata dalla donna di Fangio - Fu allora che Ferrari cominciò a
scriverle, a chiederle consigli: "Si affidò a me - disse lei - gli
inventai quello che poi è diventato il suo modo di vestire”...
|
|
Luigi Musso
|
Musso non sopravvisse alle ferite riportate nella celebre
Curva del Calvaire
del Circuito di Reims.
|
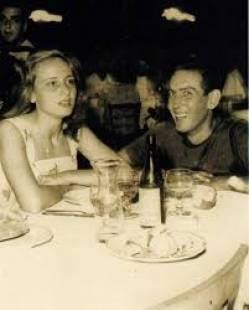 |
Fiamma Breschi - Luigi Musso
|
|
|
|
«L' ingegnere Mauro Forghieri e Gaetano Passarelli con dolore
partecipano alla scomparsa della signora Fiamma Breschi, ricordando con
tristezza e rammarico quando le gare si vivevano e vincevano con grande
spensieratezza e allegria e con la presenza ai box di signore
bellissime». Il necrologio è apparso ieri sul Corriere . Poche righe
delicate e romantiche che contengono una storia intensa e sommersa.
Protagonisti: Fiamma Breschi, la «bellissima signora», ed Enzo Ferrari.
Lei, ultraottantenne e malata, è scomparsa venerdì a Firenze. Lui,
signore e padrone della leggenda più straordinaria del motorismo, se n' è
andato il 14 agosto 1988. Si conobbero nel cuore degli anni Cinquanta.
Fiamma, giovane e attraente, era la compagna di Luigi
Musso, pilota romano del Cavallino, disposto a lasciare moglie e due
figli pur di averla accanto ogni giorno, sino all' ultimo, 6 luglio
1958, quando morì, a Reims, dopo l' ennesimo incidente di un' epoca da
stragi in pista. Appena lo seppe, Fiamma cercò di gettarsi dalla
finestra dell' hotel. Bloccata dalla compagna di Juan Manuel Fangio,
Beba, e dalla moglie di Maurice Trintignant, Lulù.
Fu
allora che Ferrari cominciò a scriverle, a frequentarla, a chiederle
consigli, preso da una docilità inattesa: «Si affidò a me, gli inventai
quello che poi è diventato il suo modo di vestire - disse in una rara
intervista -. Già nel 1962 mi voleva sposare, mi ha chiesto di sposarlo
sino a quando è morto». Si telefonavano. Ore ed ore di conversazioni.
Si scrivevano. Una lettera al giorno, secondo chi viveva vicino a
Ferrari. Si vedevano. A Firenze, forse altrove: «Veniva a mangiare a
casa mia. Fece coniare una coppa con il Cavallino dedicata a mia madre,
la cuoca più brava del mondo».
Abbastanza per far scattare pettegolezzi insistenti lungo quel crinale
delicato che fu la vita privata del Grande Vecchio di Maranello, sposato
con Laura, legatissimo a Lina, mamma di Piero. Del resto, Fiamma
Breschi cercò sempre di allontanare ogni ambiguità: «Eravamo amici, era
qualcosa di grande ma di platonico».
Questo disse e scrisse nel libro «Il mio Ferrari» (Mursia) del 1998. Una musa, dunque.
Intelligente al punto da farsi nominare dal capo, inviata speciale
alle corse: «Ferrari aveva sempre bisogno di controllare tutto e lei era
una donna piacevole, abile nel parlare e nel fare» racconta Forghieri,
il tecnico che ha accompagnato il decollo del mito di Maranello: «Capace
di convincerlo a presentare la prima Ferrari gialla, una 275 GTB 4 del
1966». Chissà, forse Fiamma, riuscì a sfiorare un lato debole e nascosto
di quell' uomo così geniale, così feroce, così difficile da trattare.
Del quale disse molto e disse molto poco,
conservando, insieme al casco giallo di Musso, ogni sua lettera, ogni
segreto, dentro una cassetta blindata. Ma ogni curiosità pare, adesso,
un' invadenza. Meglio lasciar correre l' immaginazione e una nostalgica
tenerezza.
Sentimenti nel vento, a
bordo di automobili preziose. Immagini di un uomo e una donna che volano
via, con i loro misteri,
dentro un tempo magnifico e perduto.
|
 |
 |
|
La carriera di Fittipaldi è una giostra
circense, un saliscendi di emozioni e di scelte non sempre felici ma
perseguite con tenacia e determinazione fino in fondo. Pilota coraggioso
e appassionato, talento precocissimo con una straordinaria pulizia
nella guida in pista. Legatissimo alla sua terra di origine, quel
Brasile che porterà alla ribalta altri grandi campioni
dell’automobilismo mondiale di cui Emerson è fiero precursore. Un
Brasile tormentato dalle dittature militari che attraverseranno gli anni
Settanta e Ottanta, lasciando scie di contrasti e delusioni sociali
molto forti favorendo la creazione di nuovi miti. Emerson sarà appunto
uno di questi per il popolo brasiliano, un eroe in cui identificarsi per
sognare ed immaginare un mondo diverso in cui l’eroe permette di
sfuggire alla dura realtà quotidiana.
Personaggio tipico, inoltre, di un periodo della Formula 1, quello degli
anni Settanta, in cui si affacciano per la prima volta le
sponsorizzazioni libere per le squadre e per i driver. Nuove occasioni di business
per i protagonisti delle corse si profilano all’orizzonte prepotenti ed
impetuose come i fiumi di denaro che ricopriranno i piloti da lì in
avanti.
La storia di Fittipaldi ruoterà sempre intorno a questi due poli, la sua
terra d’origine e l’ambizione economica legata alla inevitabile
ricchezza.
Giovanissimo, Emerson partecipa ad alcune gare di motociclette (peraltro
senza soddisfazioni) per approdare ai go-kart, ambito in cui si cimenta
con grande passione ed entusiasmo arrivando, insieme al fratello Wilson
Júnior, a costruirne di suoi.
Gli inizi
La “Fitti-karts” inizia l’attività nel
1964 e ben presto Emerson decide di scendere in pista direttamente per
dare maggior visibilità al marchio. Grazie ai risultati agonistici le
ordinazioni delle vetture decollano consentendo ai due fratelli di
autofinanziarsi e iniziare a coltivare il sogno della vita: trasferirsi
in Europa per correre in maniera seria. Nel 1968 il momento tanto
sognato con l’arrivo in Inghilterra dove gareggia in Formula Ford
trovando un ambiente decisamente più ostile rispetto a quello
brasiliano: piloti agguerriti che non si tirano indietro per nulla al
mondo davanti alla possibilità di arrivare primi sul traguardo. Il
passaggio alla Formula 3 è dietro l’angolo e Emerson ci arriva nel 1969,
anno in cui trionfa con la Lotus 59 di Jim Russell. Si vede subito che
il ventitreenne paulista ha carattere da vendere e una determinazione
fuori dal comune per l’età. Ciò che colpisce è lo stile di guida pulito
ed estremamente incisivo perché capisce l’inutilità di rischiare sempre e
comunque a favore di una tattica più accorta ed attendista. A tutto
questo si aggiunge una straordinaria visione della gara.
|
|
Fittipaldi viene contattato, nel 1970,
da colui che risulterà per certi versi essere stato il suo mentore:
Colin Chapman, patron della Lotus. L’inglese capisce al volo il talento
che ha di fronte e non se lo lascia certamente sfuggire tanto da
sottoporgli un contratto per guidare la Lotus in Formula 2. Emerson
sente che il suo momento sta per arrivare, ne sente il profumo e ne
percepisce chiaramente tutti i dettagli.
Il debutto in Formula 1
Il debutto in Formula 1 avviene nello
stesso anno, il 18 luglio a Brands Hatch, nel GP d’Inghilterra con un
ottavo posto, pur non disponendo, ovviamente, della Lotus ufficiale. Il
ragazzo è carico di entusiasmo e preoccupazione allo stesso tempo, le
responsabilità diventano sempre più grandi anche per via di un episodio
determinante che segna, probabilmente, la sua carriera: la morte di
Jochen Rindt, prima guida della Lotus, a Monza nel settembre 1970.
Quando ti trovi di fronte alla morte di un pilota resti sempre
scioccato, pieno di dubbi e angosce su ciò che stai facendo, ti metti
prepotentemente in discussione, pensi di smettere, poi però si va avanti
inesorabilmente e la adrenalina delle corse (come scrisse Jackie
Stewart nel suo libro Faster: «Perché non smetto? Non lo
so, veramente non lo so. Forse perché lo sport automobilistico è
infettivo come una malattia, ti entra nel corpo e ti conquista con tale
violenza che è come se cadessi in coma») prende il sopravvento.
|

Emerson Fittipaldi in Formula Ford (1969)
|
In seguito all’incidente la Lotus
rinuncia alle successive due gare per arrivare a Watkins Glen, ultima
prova del Mondiale, con lo scomparso Rindt ancora in testa alla
graduatoria. Chapman prende in disparte Emerson e gli dice che deve fare
tutto quanto possibile per rimanere davanti nientemeno che a Jacky
Ickx. Solo in questo modo si potrebbe assegnare il titolo al pilota
scomparso. Carico di responsabilità, Fittipaldi compie una rimonta
fantastica che si conclude con la vittoria ai danni di Pedro Rodríguez. È
la sua prima affermazione in una gara di Formula 1, vittoria che vale
doppio proprio perché consente l’assegnazione (unico caso nel Mondiale)
del titolo al pilota scomparso.
Il boss inglese decide di rinnovare il contratto a Emerson anche se con
qualche dubbio in relazione al fatto di affidargli il ruolo di prima
guida. Di Chapman Fittipaldi dice:«È un vulcano di idee. Abbiamo
avuto delle divergenze all’inizio ma ora siamo in equilibrio, io guido a
modo mio e, in cambio, non chiedo particolari modifiche all’auto».
Dopo un 1971 del tutto transitorio e con parecchi problemi di messa a
punto (dovuti principalmente alla scelta di sperimentare il motore
sovralimentato) che non consentono prestazioni brillanti in gara, il
1972 è l’anno della consacrazione. |
|
“El rato” (soprannome dovuto alla particolare dentatura) è alla guida di
una evoluzione della già eccellente Lotus 72 con la nuova livrea
nero-oro (dovuta alla sponsorizzazione della multinazionale del tabacco
John Player Special). Macchina potente, ottima tenuta di strada e con
una affidabilità prima sconosciuta. I successi arrivano in serie fino a
quello memorabile a Monza con la conquista del primo titolo mondiale. A
25 anni, 9 mesi e 26 giorni diventa il campione del mondo più giovane in
assoluto. Emerson ricorda sempre con commozione un particolare di
quella gara: la telecronaca per il Brasile, quel giorno, fu fatta da
papà Wilson che potè annunciare con orgoglio la vittoria del figlio.
In patria viene accolto trionfalmente, lo chiamano “O’ rey” e,
probabilmente, sostituisce Pelè nel cuore dei brasiliani. Fittipaldi
ricorda con soddisfazione quei momenti tanto da dire, in seguito, di
aver aggiunto la sua immagine ai più comuni simboli del Brasile.
Arrivano, inevitabilmente, impegni mondani e sponsorizzazioni a tutto
tondo che permettono a Emerson di guadagnare cifre importanti che
investe in possedimenti terrieri in Brasile, dimostrando anche in questo
campo una notevole abilità unita ad un fiuto particolare.
La stagione 1973 parte con la caccia a Fittipaldi. È lui l’uomo da
battere, il campione giovane ed agguerrito che tutti vogliono
spodestare. In squadra arriva un pilota svedese, Ronnie Peterson,
animato da una smodata ambizione e “cattiveria” agonistica non
indifferente. La prima parte della stagione vede ulteriori conferme del
talento di Emerson soprattutto grazie a prove convincenti sul rivale più
accreditato, Jackie Stewart.
|
 |
|
Da metà stagione in poi però il calo.
Pochi piazzamenti e pochi punti tanto da consentire allo scozzese di
scalare la vetta della classifica. In casa Lotus si paga pesantemente la
lotta fratricida tra Fittipaldi e Peterson e la scellerata conduzione
manageriale di Chapman culminata nel famoso episodio di Monza dove non
viene imposto a Peterson di farsi da parte per dare spazio a Emerson,
alla conquista disperata di punti per restare in corsa per il titolo.
Fittipaldi le prova tutte per superare il compagno di squadra che
chiude, però, tutti i varchi possibili. Al rientro ai box la tensione
esplode anche perché Chapman, a richiesta di spiegazioni da parte di
Fittipaldi, si limita a dire di essersi dimenticato di esporre il
cartello con le indicazioni. Il litigio con il patron segnerà il
divorzio del brasiliano dalla Lotus alla fine della stagione. Non sarà
mai ben chiaro il motivo del comportamento del manager inglese: due le
probabili risposte, una avente a che fare con la mancata firma del
rinnovo del contratto sottoposto al brasiliano (presumibilmente già in
contatto con la Marlboro, sponsor della McLaren) e l’altra con la scelta
di incassare i soldi della vittoria del Mondiale costruttori per non
pagare il probabilissimo aumento di ingaggio a Fittipaldi qualora avesse
vinto il secondo titolo. Strategia comunque perdente perché il pilota
se ne andò sbattendo la porta.
Ancora Campione!
Nel 1974 inizia un mondiale tormentato
dalla situazione internazionale. Crisi petrolifera e conseguente
razionamento di carburante pongono seri dubbi sulla utilità delle corse
automobilistiche. Con qualche ritardo si comincia, alla fine, una
stagione molto incerta dal punto di vista agonistico data dal ritiro di
Stewart e dal conseguente aumento dei papabili alla vittoria finale. “El
rato”, dopo un esordio infelice in Argentina, umilia Peterson ad
Interlagos facendo presagire ad una stagione in discesa con la nuova
vettura. Non sarà così, invece, perché i due piloti Ferrari, l’esperto
Clay Regazzoni e il giovane Niki Lauda, gli daranno filo da torcere fino
alla fine del campionato che si risolverà all’ultima gara a favore del
brasiliano su Regazzoni. Secondo titolo mondiale per Emerson grazie
ancora una volta ad una condotta di gara accorta e pulita unita alla
straordinaria pulizia ed efficacia della guida in pista.
La stagione successiva si apre con il tema della sicurezza in pista.
Frequenti sono i richiami dei piloti all’organizzazione internazionale
affinchè si presti maggiore attenzione alle misure di prevenzione degli
incidenti. Soprattutto nel GP di Spagna si capisce come il denaro e gli
interessi politici la facciano da padroni nel Circus: circuito di
Montjuïc assolutamente inadeguato per quanto riguarda sicurezza ed
organizzazione. Piloti che si riuniscono per decidere di non scendere in
pista e vengono obbligati dalle minacce delle scuderie che impongono la
corsa ad ogni costo. Solo Fittipaldi porterà fino in fondo, nonostante
un titolo da difendere e interessi economici personali in gioco, la sua
decisione di non gareggiare. Puntuale, infatti, la tragedia durante la
corsa con spettatori coinvolti pesantemente. La Formula 1 deve quindi
darsi una nuova immagine davanti all’opinione pubblica e per questo
vengono decise nuove e più efficaci misure di sicurezza nelle successive
gare. In pista è l’anno dell’avvento di Lauda e la sua Ferrari.
Fittipaldi è costretto ad inseguire per gran parte della stagione (dopo
un avvio folgorante) e si ricorda solo una gara memorabile (come
strategia) a Monza quando riesce a superare l’austriaco con una frenata
azzardata per far capire, probabilmente, che il leone abdicava ma con
onore e orgoglio. È vicecampione del mondo con un netto distacco da
Lauda.
|

Monza 1971 - Fittipaldi Lotus 56B
|
|
|
Oramai Emerson è un personaggio noto in tutto il mondo, un vero business man
con sponsorizzazioni e contratti in ogni settore.
Vende la sua immagine
molto abilmente anche grazie ai consigli di Stewart, rivale in pista ma
amico fuori dai circuiti. Fittipaldi ricorda:
«Nei miei riguardi
Jackie si è sempre comportato come un amico dandomi preziosi
suggerimenti sulla nostra attività e su come gestire
la propria immagine
con gli sponsor. I piloti, d’altronde, sono i principali protagonisti
del Circus ed è giusto che siano pagati per questo.
La nostra carriera è
per sua natura più breve di altre attività sportive, se la nostra
immagine fa vendere o genera benefici a qualche azienda
è logico che
anche noi ne otteniamo dei vantaggi». Chiaro e lucido come sempre, Emerson.
|
La Copersucar
Le sorprese non sono finite in quel
1975. Fittipaldi annuncia in maniera clamorosa il suo addio alla
McLaren. Scelta davvero azzardata per alcuni ma non per il talento
brasiliano che vuole inseguire un ambiziosissimo progetto: un brasiliano
alla guida di una macchina brasiliana.
L’idea è in realtà già partita con il fratello Wilson qualche anno prima. Il vero nome del team
era Fittipaldi Automotive che correva con il nome Copersucar. La
squadra godeva di importanti appoggi da parte della Copersuc, l’azienda
di stato saccarifera. Dopo i deludenti risultati del fratello,
Fittipaldi, allettato sicuramente dai forti guadagni offerti, decide di
scendere in pista personalmente per dare lustro alla scuderia. Emerson
dirà: «Non mi aspetto chiaramente di arrivare subito primo nel
Mondiale, ci mancherebbe. Sono convinto che nel giro di uno-due anni
sarà possibile ammirare un team interamente brasiliano tra i migliori del mondo».
Mai proclama fu più sbagliato e distante dalla realtà dei fatti. Nei
quattro anni successivi la Copersucar non otterrà mai risultati degni di
nota tranne un secondo posto nel 1978 nel GP di casa a Rio de Janeiro.
L’ultima stagione di Fittipaldi in Formula 1 è quella del 1980. Nel
frattempo la Copersucar si è ritirata dalle corse non finanziando più la
scuderia. Questo fa si che il team acquisti la denominazione
di Fittipaldi Team Racing fondendosi con la Wolf da cui eredita il
pilota, un certo Keke Rosberg che tanto bene farà parlare di sé in
seguito. A fine anno Emerson annuncia il suo ritiro dalle corse per
dedicarsi alla carriera manageriale. Carriera che si arresterà l’anno
successivo per mancanza di fondi e risultati disastrosi.
La prima parte della carriera agonstica del “rato” finisce quindi
ingloriosamente con un progetto sportivo-imprenditoriale miseramente
fallito. Le qualità del pilota comunque non sono mai state messe in
discussione.
|
 |
| |
 |
|
Fittipaldi rientra nel giro delle corse
alla metà degli anni Ottanta nelle competizioni USA. La voglia di
sedersi su una monoposto, infatti, non lo abbandona mai. Un richiamo
forte e impetuoso a continuare a gareggiare, a sfidare i propri limiti e
gli avversari in un nuovo contesto.
Nel 1989 vince il campionato CART e la 500 Miglia di Indianapolis con il team
Penske diretto da Pat Patrick. Resta al comando per 158 giri su 200
totali aggiudicandosi parecchi duelli in pista come ai bei tempi della
Formula 1. Nel 1993, infine, rivince la corsa questa volta davanti a
Nigel Mansell. Insieme a Jim Clark, Mario Andretti e Graham Hill,
Emerson è l’unico pilota ad aver vinto il Mondiale di Formula 1 e la
gara di Indianapolis.
Un incidente nel 1996, all’età di cinquant’anni,
metterà definitivamente fine alla carriera di Fittipaldi.
Carriera straordinaria e molto rapida. Palmares ricco di successi e
titoli che lo ha fatto definire “il pilota dei due mondi” per la
capacità di conseguire risultati sia in formula 1 che in USA. Carriera
che sarebbe stata più vincente se Emerson non avesse dato retta ad un
sogno lautamente remunerato come quello di guidare una vettura
brasiliana senza motori brillanti. |
|
Da come Fittipaldi descrive la sua gente si capisce anche parte della
sua motivazione nell’intraprendere quell’avventura: «Amo
il Brasile e la sua gente. Mi piace il loro modo di affrontare la vita e
la gioia di vivere tipica del popolo brasiliano. Mi piacciono perché
sono degli estroversi che scherzano, senza cattiveria, su tutto e tutti».
Questo è Emerson Fittipaldi, un pilota che ha segnato un’epoca e che ha
fatto sentire orgogliosa una nazione intera. Un pilota che ha esportato
il Brasile in tutto il mondo e che dai brasiliani è stato sempre molto
amato.
Obrigado Emerson! |
|

|
|

 |
nasce a Montona, Italia, il 28 Febbraio 1940. Al termine della
seconda guerra mondiale, la famiglia capisce che il paese in cui abitano è destinato a passare sotto la
Jugoslavia.
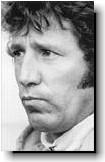 Decidono quindi di andarsene e passano diversi anni in un campo di profughi in
Toscana. Nel 1954 l’interesse di Mario alle gare di velocità lo porta a Monza
dove vede il grande Ascari competere nel Gran Premio d’Italia. L’anno successivo
emigra insieme con la famiglia negli Stati Uniti e trovano casa a Nazareth in
Pennsylvania.
Decidono quindi di andarsene e passano diversi anni in un campo di profughi in
Toscana. Nel 1954 l’interesse di Mario alle gare di velocità lo porta a Monza
dove vede il grande Ascari competere nel Gran Premio d’Italia. L’anno successivo
emigra insieme con la famiglia negli Stati Uniti e trovano casa a Nazareth in
Pennsylvania.
Nel 1959 inizia a gareggiare sugli ovali
intorno a Nazareth con vecchia Hudson, insieme al suo gemello Aldo
che, però, è meno fortunato di lui in quanto un incidente sancisce la
fine prematura della sua carriera. Mario, comunque, prosegue. In un solo
giorno dell’autunno 1963 vince tre diverse gare su due piste differenti! Nel
1964 inizia a correre nella gare USAC con macchine sprint e nelle gare
Indy. Ma
deve ancora maturare e la 500 miglia di Indianapolis di quell’anno gli conferma
che ha bisogno di più esperienza di guida. Mario si mette d'impegno e quando
compete nella stessa gara l’anno successivo termina terzo e gli viene consegnato
il premio "Rookie dell’anno". |
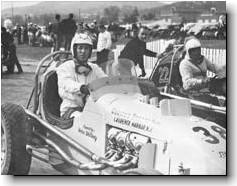 |
Andretti raggiunge il successo ad
Indianapolis molto presto vincendo la gara nel 1969 alla sua quinta
partecipazione ma, per quanto provi per oltre 20 anni, non riuscirà più a
vincerla. La carriera ad Indianapolis quindi non merita
certo di essere messa in evidenza ma è una dichiarazione precisa di quanto Mario
sia un pilota versatile. Nel corso di tutta la sua carriera è riuscito a vincere in
quasi tutte le competizioni su quattro ruote. Quando sale per la prima
volta su di una monoposto di Formula Uno, Andretti è già vincitore della 24
ore di Daytona, vincitore della Coppa Sebring, due volte campione USAC e
quattro volte corridore alla 500 miglia di Indianapolis. L’occasione è a Watkins Glen nel
1968
su di una Lotus 49B e promette grandi cose. Col disappunto dei suoi avversari
guadagna la pole. Certo, dicono in molti, è il suo circuito di casa.... Ma in
realtà Andretti non ha mai corso a Glen prima. Sfortunatamente la gara lo vede
arrancare a causa di problemi meccanici della sua Lotus. Per le tre gare
rimanenti accusa sempre problemi meccanici ma le soddisfazioni se le prende,
sempre quell’anno, vincendo la 500 miglia di Indianapolis, il campionato USAC
per la terza volta e la famosa gara in salita di Pikes Peak!
|
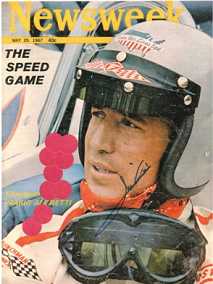 |
 |
 |
| 1967 |
Mario Andretti, winner
of the Indy 500 in 1969 |
STP Lotus - Ford 64
(1969) |
Il nuovo Presidente americano appassionato di belle auto
 |
 |
Donald Trump su una vettura
Indicar... |
 |
|
Donald Trump è il 45° Presidente degli Stati Uniti
d’America. Al di là del risultato politico americano, a noi, essendo un
sito automotive, piace ricordare la forte passione che Trump nutre nei confronti delle automobili, o meglio, delle belle automobili.
Difatti non tutti sanno che al tycoon americano, considerato da Forbes
nel 2015 il 405° uomo più ricco del mondo e con un patrimonio stimato
nel 2016 di 3,7 miliardi di dollari, piacciono le automobile lussuose e
sportive, d’epoca e non.
Tra i modelli conosciuti che fanno parte del garage “presidenziale” infatti, fanno parte ben due Rolls Royce, una Silver Cloud degli anni ’50 ed una Phantom attuale, una Maybach S600 Sedan del 2015, una Lamborghini Diablo, una Mercedes SLR McLaren ed una Chevrolet Camaro realizzata in un unico esemplare ed impiegata come Pace Car ad una delle ultime 500 Miglia di Indianapolis.
Mario Andretti, vincitore del Campionato del Mondo di Formula 1 nel 1978 e di quattro campionati Indycar, andò a prendere Donald Trump sotto la Trump Tower per “un giro in città” nel corso della nota serie TV “The Apprentice” in cui lo stesso Trump era protagonista.
|
|
Durante la
maggior parte dei suoi anni in Formula 1, Andretti è un pendolare d’eccezione ed
il suo vertiginoso avanti e indietro sull’atlantico fa sì che egli competa sia
nei Gran Premi che nelle gare USAC. Nel campionato di
Formula 1 del 1970 corre in 5 gare con la March e riesce a finire solo una gara
arrivando terzo in Spagna. In Sudafrica nel 1971, nella prima uscita con la
Ferrari, vince la sua prima gara. A questo fa seguire la vittoria di entrambe la
prove del Gran Premio, non valido per il campionato, di Ontario, una gara ibrida
che vede le vetture di Formula 1 confrontarsi con quelle di Formula 5000
statunitense. Nel corso delle stagioni 1971 e 1972 corre in altre 9 gare con la
Ferrari portando a casa solamente risultati mediocri.
 Si sarebbe potuto scommettere che, entro il
1976, Andretti sarebbe stato destinato a fare grandi cose in Formula 1 e,
considerando l’estrema velocità di questo pilota, sarebbe diventato il cavallino
rampante di Maranello. Tuttavia questa previsione non si sarebbe mai avverata.
Lascia la Ferrari al termine della stagione del 1972 e per due anni corre con
l’ormai dimenticata scuderia Parnelli fino al suo scioglimento nel 1976 (salta
la stagione 1973 per concentrarsi sul campionato USAC). In quell’anno ritorna
alla Lotus che gli offre un’ulteriore possibilità in Formula 1. L’accordo tra
Andretti e Colin Chapman è un dono del cielo per entrambi, per Andretti che si
ritrova con la famosa Lotus 79 "effetto suolo" che gli consentirà di vincere il
Campionato del 1978, e per Chapman che ha bisogno di un pilota di esperienza e
con grinta per studiare e sfruttare a fondo la vettura. Si sarebbe potuto scommettere che, entro il
1976, Andretti sarebbe stato destinato a fare grandi cose in Formula 1 e,
considerando l’estrema velocità di questo pilota, sarebbe diventato il cavallino
rampante di Maranello. Tuttavia questa previsione non si sarebbe mai avverata.
Lascia la Ferrari al termine della stagione del 1972 e per due anni corre con
l’ormai dimenticata scuderia Parnelli fino al suo scioglimento nel 1976 (salta
la stagione 1973 per concentrarsi sul campionato USAC). In quell’anno ritorna
alla Lotus che gli offre un’ulteriore possibilità in Formula 1. L’accordo tra
Andretti e Colin Chapman è un dono del cielo per entrambi, per Andretti che si
ritrova con la famosa Lotus 79 "effetto suolo" che gli consentirà di vincere il
Campionato del 1978, e per Chapman che ha bisogno di un pilota di esperienza e
con grinta per studiare e sfruttare a fondo la vettura.
Nel 1977 Chapman tira fuori dal cilindro la macchina
vincente con la V maiuscola: si tratta della Lotus 78. Con questa vettura
Andretti vince subito il Gran Premio di Long Beach e mette una seria ipoteca sul
mondiale anche se la stagione è minata da parecchi problemi dovuti alla nuova
versione del motore Cosworth.
|
 |
|
Nella stagione
1978 Andretti e la Lotus agguantano una sola vittoria nelle prime 5 gare e a
Zolder fa il suo debutto la Lotus 79, l’ultima evoluzione del famoso effetto
suolo. Come una reminiscenza della Lotus 49 a Zandvoort 11 anni prima, la 79
agguanta la pole e vince la gara alla sua prima uscita. Con questa vettura
Andretti vince anche in Spagna, Francia, Germania e Olanda. Con una macchina
così superiore alle altre, l’unico e vero avversario di Andretti per la stagione
1978 è il suo compagno di squadra, lo svedese Ronnie
Peterson. Andretti arriva a Monza con un vantaggio di
12 punti su Peterson. Alla partenza la vettura di James Hunt viene spinta contro
la Lotus di Peterson da un’altra monoposto. Peterson sbatte violentemente contro
la barriera Armco e la sua vettura si incendia e la gara viene interrotta con
bandiera rossa mentre Hunt, Patrick Depailler, Clay Regazzoni ed i commissari di
percorso lottano contro le fiamme ed il tempo per liberare Peterson. L’incidente è spaventoso ma Peterson
viene ricoverato all'ospedale con solo alcune fratture agli arti e qualche piccola
bruciatura. Andretti fa la seconda partenza sperando in cuor suo che il compagno
di squadra stia bene. Dopo aver inseguito e sorpassato Gilles
Villeneuve ed aver vinto la gara, Andretti viene però relegato al sesto
posto per partenza anticipata. Questa posizione è comunque sufficiente per vincere il Campionato.
|
| |
 |
Ma le condizioni di Peterson diventano gravi, le fratture agli arti gli provocano un'embolia: muore la
mattina successiva. Naturalmente questa notizia spegne subito la voglia di
festeggiare di Andretti per la conquista del titolo di Campione del Mondo. Con
il passare del tempo, comunque, nonostante Monza 1978 venga sicuramente ancora
ricordata come una delle pagine più nere della storia dell’automobilismo, a
tutt’oggi è più conosciuta come la giornata in cui Mario Andretti diventa il
secondo - e ultimo - statunitense a conquistare il titolo di Campione del Mondo
di Formula 1.
Andretti ha comunque vinto la sua ultima
gara di Formula 1. Corre ancora per altre 4 stagioni, 2 con la Lotus, una con
Alfa Romeo, 3 gare nel 1982 con la Williams e, ancora, con la Ferrari.
Quell’anno a Monza, nella sua ultima gara in Formula 1, agguanta prepotentemente
la pole per la gioia dei tifosi, inserendosi tra i più titolati piloti della
stagione e nel più classico stile Andretti: uscire con classe.
A 42 anni Andretti è ormai vecchio per la
Formula 1, ma la sua carriera agonistica è ben lungi dall’essere terminata. Per
più di dieci anni cerca nuovamente di vincere la 500 miglia di Indianapolis ed
ha il privilegio di correre ruota a ruota con suo figlio in Formula Indy. Nel 1992, all’età di
52 anni, si prende la pole al Michigan International Speedway
con una media superiore ai 350kmh!
|
|
 Guidare vetture da corsa a prestazioni
elevate richiede uno sforzo fisico e psicologico non indifferente. Guidare vetture da corsa a prestazioni
elevate richiede uno sforzo fisico e psicologico non indifferente.
Il solo
viaggiare a velocità così elevate stressa l’intero corpo del pilota e sono molte
le persone chesi chiedono come possa ancora continuare Andretti alla sua
età.
L’italo americano Mario Andretti, con la sua pronuncia
strascicata e la sua leggendaria calma, dietro al volante di una monoposto
esprime un fiero spirito competitivo. Probabilmente nessun altro pilota nella
storia dell’automobilismo ha mai avuto così tanti successi simultaneamente su
tracciati totalmente diversi tra di loro e forse nessun altro pilota ha mai
avuto, come Andretti, una coesione così perfetta tra mente e fisico al servizio
delle gare. Nel corso di tutti questi anni Andretti non è mai stato petulante,
scriteriato o psicologicamente indifeso, cosa che non si può dire di molti
piloti di punta messi sotto pressioneper la lotta per il titolo.
Dopo una carriera incredibile che ha
interessato cinque decadi, Andretti non è, alla fine, scomparso nel buio. Non
l’avrebbe mai tollerato.
Ha vinto ancora a 53 anni a Phoenix nel 1993, l’anno in cui il figlio faceva la sua disastrosa stagione di Formula 1.
Questa è stata la sua ultima vittoria in Formula Indy.
|
 |
|
|
|
|

 era nato a Milano il 13 Luglio 1918. Suo padre Antonio era stato il
più grande pilota italiano dei suoi tempi e aveva l'abitudine di portare
spesso suo figlio con sé alle corse cui partecipava. Due settimane prima era nato a Milano il 13 Luglio 1918. Suo padre Antonio era stato il
più grande pilota italiano dei suoi tempi e aveva l'abitudine di portare
spesso suo figlio con sé alle corse cui partecipava. Due settimane prima
che Alberto compisse sette anni, Antonio Ascari rimase ucciso mentre stava
conducendo il Gran Premio di Francia a Montlehry.
Da quel momento il
desiderio di Alberto fu quello di diventare un pilota di macchine da corsa
proprio come il padre. Fu così preso
da questo suo sogno che scappò ben
due volte da scuola e appena poté si comprò una motocicletta. La sua prima
gara fu la Mille Miglia del 1940 e la macchina che guidò una Ferrari. Nel
1940 sposò una ragazza di Milano ed ebbero due bambini. Il maschio
venne
chiamato Antonio, in ricordo del nonno, e la femmina Patrizia. Ascari era
molto legato alla famiglia.
Alberto riprese a gareggiare nel 1947.
Comprò una Maserati 4CLT dai nuovi proprietari, la famiglia Orsi. Racimolò
tre milioni
di lire e il suo caro amico Gigi Villoresi lo aiutò dandogli
altri due milioni. Ascari e Villoresi corsero con successo sui circuiti
del Nord Italia, e la folla milanese soprannominò Alberto "Ciccio". Il
1948 si rivelò un altro anno di successi per la coppia di amici
alla guida
delle più evolute Maserati San Remo. Ascari gareggiò su un'Alfa 158,
finendo terzo nel Gran Premio di Francia a Reims, dietro ai compagni
di
squadra Wimille e Sanesi. Enzo Ferrari, che era stato un
grande amico e compagno di squadra del padre di Alberto, si era
appassionato ai successi
di Alberto e aveva messo sotto contratto Ascari e
Villoresi nel 1949. Quell'anno Ascari vinse sei volte, una delle quali a
Buenos Aires nel Gran Premio di Peron.
|
Nel 1950 ottenne nove vittorie
con la Ferrari e nel 1951 sei, nonostante la Ferrari rivestisse un ruolo
di secondo piano rispetto alle più rodate Alfa Romeo 158/159, ma fu il
1952 la sua stagione più ricca con addirittura 12 vittorie.

Alberto Ascari - Il pilota del destino
|
|
|
 da sinistra Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Mike Hawthorn e Luigi Villoresi da sinistra Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Mike Hawthorn e Luigi Villoresi
|
|
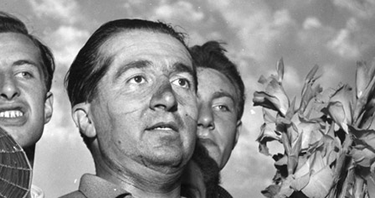 |
| Ascari trionfatore a Monza nel 1952 |
La prima gara
alla quale non partecipò fu nel 1952, il Gran Premio di Svizzera, essendo
impegnato nelle qualificazioni di Indianapolis con la Ferrari 45OO, con la
quale forò una gomma nella 500 miglia, ma per quanto riguarda le altre
gare ebbe vita relativamente facile in quanto Fangio, della squadra rivale
Maserati, fu messo fuori gioco per gran parte della stagione in seguito ad
un incidente nel Gran Premio di Monza a Giugno. Ascari vinse tutte
le 6 gare a cui prese parte e il
Campionato del Mondo.Si ripete nel 1953
vincendo le prime 3 gare e stabilisce il record di vittorie consecutive:9.
Ascari era più tranquillo
quando si trovava in testa alla corsa e, diversamente da molti altri
piloti, sembrava non dare il suo meglio quando stava dietro. Come Enzo
Ferrari più tardi ricordò: "Quando guidava, non poteva essere sorpassato
tanto facilmente, anzi di fatto era impossibile farlo".
Non era un
pilota sereno. Con la sua smorfia e lo sguardo fisso sembrava frustasse la
sua auto e che le sue mani sensibili tormentassero il volante.
Quando aveva fretta
affrontava le curve con una serie di rischiose sterzate piuttosto che con
un unico fluido movimento. Avere Ascari alle spalle era un'esperienza
davvero snervante. La sua mente era ossessivamente impegnata a cercare il
sorpasso ad ogni costo.
Il 1954 era stato un anno molto deludente per il campione del mondo
del '52 e del '53. Ascari era uscito dalla Ferrari alla fine del 1953 e il
1° Gennaio del 1954 aveva firmato per l'ambiziosa azienda Lancia,
che aveva progettato e costruito la sua prima e alquanto innovativa
macchina da Gran Premio.
La messa a punto del mezzo però procedeva con
lentezza e il suo debutto in pista veniva continuamente rimandato. Nel
frattempo la Mercedes Benz annunciò che le Silver Arrows (le frecce
d'argento), dalla rivoluzionaria aerodinamica, sarebbero state pronte per
gareggiare nel Gran Premio di Francia a Luglio.Fu così che, per
fronteggiare la minaccia al primato italiano, la Lancia permise ad Alberto
e al suo amico e guida Luigi Villoresi di passare al volante delle
Maserati 250 F. Ma fu inutile.
Fangio e Kling sulle loro
W196 seminarono tutti gli avversari. Solo sei concorrenti su
ventuno terminarono la gara e Alberto, come molti altri, fuse il motore al
2° giro, nel tentativo di mantenere il passo delle Mercedes.
Dopo
alcune gare decisamente sfortunate con la Maserati, ad Ascari venne
generosamente prestata una Ferrari per correre il Gran Premio d'Italia.
Alberto riuscì a conquistare la prima fila della griglia di partenza e al
6° giro era in testa. La corsa finì per diventare una sfida tra Ascari e
Moss, sulla sua Maserati personale, ma al 49° giro Alberto fu costretto a
ritirarsi per noie al motore. Alla fine accadde proprio ciò che gli
italiani avevano più temuto: Fangio vinse alla guida della tedesca
Mercedes, ma solo dopo che la coppa dell'olio di Moss si fu spaccata.
|
Bisognava
fare qualcosa e così due Lancia rosso porpora nuove fiammanti furono
messe a punto in fretta e furia per debuttare nell'ultima gara del 1954,
il Gran Premio di Spagna, che si corse il 24 Ottobre nel circuito
Pedralbes.
Alberto partì alla grande e già all'8°giro aveva
accumulato un grosso vantaggio. Al nono giro però un gemito di
costernazione si sollevò non appena fu costretto a fermarsi per problemi
alla frizione.
Ascari corse un altro giro lentamente e poi si ritirò. Villoresi si era
già ritirato al quarto giro. Anche se la Ferrari di Hawthorn vinse la
competizione, fu Fangio a conquistare il Campionato del Mondo del 1954,
grazie alla Mercedes Benz W 196, ma anche grazie al fatto che la Lancia
ritardò la messa a punto della sua D50.
Benché tutte e tre le Lancia
si fossero ritirate nel Gran Premio di Argentina del 16 Gennaio del 1955,
le D50 vinsero due gare minori di F1 e con la formidabile squadra degli
italiani, Ascari, Gigi Villoresi e il giovane Eugenio Castellotti, la
Lancia era pronta a misurarsi con i tedeschi, finora trionfatori, e a
batterli.
E' il 22 Maggio del 1955 e il
Gran Premio di Monaco e d'Europa sta tenendo tutti col fiato
sospeso.
Alberto Ascari sulla sua Lancia D50 è autore di una rimonta
incredibile, per raggiungere in testa alla corsa la Mercedes Benz W196 di
Stirling Moss. E' il 77° giro di pista e sta recuperando due o tre secondi
per giro. Possiamo capire da un rapido calcolo che se Moss rallentasse la
velocità di un secondo per giro Ascari lo raggiungerebbe e lo
sorpasserebbe all'ultimo giro...
All'81°giro Moss finisce fuori pista con la Mercedes
fumante. I pistoni non hanno retto alle sollecitazioni della corsa.
Siccome Fangio si è già ritirato per la rottura di una trasmissione al 50°
giro le speranze dei tedeschi svaniscono definitivamente, lasciando il
campo libero alla Lancia e alla sua prima vittoria di Gran Premio.
Non
appena Ascari si avvicina al Casino, in quel fatidico 81° giro, gli
altoparlanti stanno informando gli spettatori di ciò che lui ancora non
può sapere, e cioè che Moss è uscito di pista e che i meccanici stanno
fissando impotenti il motore
|
|
Conducendo la sua Lancia nel dedalo di curve, proprio mentre
affronta la svolta del Casinò, Alberto all'altezza della stazione si
accorge che la folla sta cercando di richiamare la sua attenzione. Lui non
può immaginare che ciò che stanno cercando di dirgli è che non appena
raggiungerà gli spalti sarà lui il vincitore.
La sua ferma concentrazione,
tesa a mantenere il controllo della sua Lancia alla maggiore velocità
possibile, viene meno. Ha la sensazione che qualcosa non stia andando per
il verso giusto non appena infila la curva della stazione e imbocca la
Corniche. Guizza nel tunnel e poi fuori in pieno sole per trovarsi ancora
faccia a faccia con la folla esultante e in preda all'entusiasmo. Ciò
distoglie la sua attenzione proprio mentre deve affrontare la discesa che
porta alla chicane e la curva gli diventa impossibile. Sceglie quindi
l'unica via di fuga e si scaraventa in acqua oltre le barriere di
protezione. Nascosto tra le balle di fieno c'è un pilastro di ferro.
L'auto lo manca per soli trenta centimetri.
Il vapore prodotto dal motore
rovente mischiato alla polvere e ai frammenti della paglia si diffonde
nell'aria. Per tre lunghissimi secondi tutti smettono di respirare. Poi un
casco azzurro appare balenando sulla superficie dell'acqua. Ascari viene
tratto in salvo da una barca prima ancora che i sommozzatori possano
raggiungerlo.
Vince la gara su una Ferrari Trintignant che ha condotto
una corsa veloce ma regolare, assistendo alla progressiva uscita di scena
di tutti i piloti che aveva davanti a sé alla fine del 10° giro. Nel
frattempo Alberto giace in un letto d'ospedale con il naso rotto e sotto
shock. Un vero miracolo.
|

|
Quattro giorni dopo, a Monza,
Ascari è di nuovo in piedi ad assistere alle prove di qualificazione a
Supercortemaggiore. Appena prima di tornare a casa con sua moglie per il
pranzo decide di fare qualche giro con la Ferrari del suo amico Castellotti. In camicia e pantaloni e indossando il casco di Castellotti
si avvia. Al 3° giro all'uscita da una curva l'auto imprevedibilmente
sbanda, capovolgendosi due volte dopo un testacoda. Sbalzato fuori dal
mezzo Ascari si ferisce gravemente e muore dopo pochi minuti.
La morte di Ascari venne accolta come una perdita
per l'intera nazione. Telegrammi di cordoglio vennero spediti da tutto il
mondo. Alle colonne della chiesa di San Carlo al Corso furono appesi
drappi neri e un'enorme scritta: "Accogli, o Signore, sul traguardo
l'anima di Alberto Ascari." Per i suoi funerali la piazza del Duomo, il
cuore pulsante di Milano, era invasa di gente. La piazza più rumorosa
d'Italia fu quel giorno così silenziosa che si potevano sentire i telefoni
squillare a vuoto nelle case.
Tre giorni dopo le esequie la Lancia
sospese ogni attività agonistica e a Luglio consegnò sei modelli D50, con
motori, progetti e ricambi, alla Ferrari.
|
|
|
|

|
|
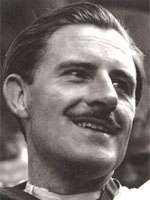

E’
l’unico pilota nella storia a conquistare l’ambito tris:
Campione
Mondiale F.1, 24 ore di Le Mans e 500 Miglia di Indianapolis
|
 |
| Monaco '58 - Graham Hill al debutto con la Lotus-Climax 12 |
|
Graham Hill era stato interessato inizialmente al motociclismo, ma nel 1954 notò una pubblicità dell'Universal Motor Racing Club a Brands Hatch, che offriva la possibilità di girare in circuito per cinque scellini. Fece così il suo debutto in una Cooper 500
di Formula 3, e da quel momento in poi si dedicò alle corse
automobilistiche. Hill entrò nella Lotus come meccanico, ma
arrivò rapidamente al posto di guida. La Lotus correva in
Formula 1 e questo permise a Graham di debuttare al Gran Premio di
Monaco 1958, dove si ritirò per la rottura di un semiasse. Nel
1960 passò alla BRM, con cui vinse il titolo mondiale nel 1962.
Hill fece anche parte della cosiddetta "invasione inglese" di piloti e
vetture alla 500 Miglia di Indianapolis a metà degli anni
Sessanta, vincendo nel 1966 con una Lola-Ford.
Nel 1967,
tornato alla Lotus, Hill contribuì allo sviluppo della Lotus 49,
spinta dal nuovo motore Cosworth V8. Dopo la morte dei suoi compagni di
squadra, Clark e Spence, all'inizio del 1968, Graham prese le redini
della squadra, vincendo il suo secondo titolo. In quel periodo, la
Lotus aveva fama di vettura fragile e pericolosa, specialmente con i
nuovi dispositivi aerodinamici, che causarono incidenti molto simili a
Hill e Jochen Rindt nel corso del Gran Premio di Spagna 1969. Un
incidente al GP statunitense di quello stesso anno
gli provocò fratture alle gambe, interrompendo la sua carriera.
Dopo essersi ristabilito, Hill continuò a correre in Formula 1
per alcuni anni, senza però ottenere gli stessi successi. Colin
Chapman riteneva che Hill fosse ormai a fine carriera e lo
sistemò per il 1970 nella squadra di Rob Walker, fornendo anche, come parte dell'accordo, una delle nuove vetture modello 72.
Al primo
Gran Premio in Sudafrica, Hill arrivò sorprendentemente sesto,
un ottimo piazzamento dato che ancora aveva bisogno di una stampella
per camminare. Ottenne poi un ottimo quarto posto in Spagna e un quinto
a Monaco. Dopo questo discreto inizio, la Lotus 49 cominciò a
essere inadeguata ed anche la Lotus 72 promessa da Chapman non venne
consegnata al team di Walker fino a Monza, dove però nessuna
Lotus gareggiò dopo la scomparsa di Rindt. Hill passò
quindi alla Brabham per il 1971-1972: la sua ultima vittoria in Formula
1 arrivò all'International Trophy di Silverstone, nel 1971, gara
non valida per il campionato, con la Brabham BT34. La squadra era
comunque in crisi, dopo il ritiro di Jack Brabham e la vendita a Bernie
Ecclestone da parte di Ron Tauranac; Hill non riuscì a
sistemarsi.
Pur
concentrandosi sulla Formula 1, mantenne una presenza anche nelle corse
per vetture Sport, comprese due partecipazioni a Le Mans, con una
Rover-BRM
a turbina. Con il declino della sua carriera in Formula 1, entrò
a far parte della squadra Matra di vetture Sport, vincendo la24 Ore di
Le Mans nel 1972,insieme a Henri Pescarolo. Questa vittoria
completò la cosiddetta "Tripla Corona" dell'automobilismo, in
entrambe le definizioni che ne vengono date (vittoria alla 500 miglia di Indianapolis,
alla 24 Ore di Le Mans e al Gran Premio di Monaco, oppure alla 500
Miglia di Indianapolis, alla 24 Ore di Le Mans e nel Campionato mondiale
di Formula 1). In entrambi i casi, Hill è ancora l'unica persona ad
aver ottenuto queste vittorie.
|
 |
Il piccolo Damon Hill trascorre una giornata con il papà Graham....
|

|
I due titoli mondiali
Nato nel 1929 ad Hampstead, un sobborgo
di Londra, appassionato di corse e motori entra in Lotus come meccanico.
Inizia la sua carriera di pilota con le vetture di Colin Chapman, ma
poi corre per sette anni alla BRM e torna alla Lotus nel 1967 al fianco
di Jim Clark.
Dopo il primo titolo mondiale del 1962,
ritorna campione del mondo nel 1968, alla guida della Lotus 49. Jim
Clark muore ad inizio stagione sul tracciato di Hockenheim, tocca a
Graham Hill, suo scudiero, prendere in mano le redini della squadra e
concretizzare le potenzialità della monoposto britannica e del DFV
Cosworth. La grande esperienza del pilota britannico ha la meglio su
tutti gli avversari ed a fine anno conquista nuovamente l’ambito titolo.
|
Il Gran Premio degli Stati Uniti 1963 è stato un Gran Premio di Formula 1 disputato il 6 ottobre 1963 sul Circuito di Watkins Glen.
La gara fu vinta da Graham Hill, alla guida di una BRM.
 Gran Premio degli Stati Uniti 1964 Gran Premio degli Stati Uniti 1964fu
la nona gara della stagione 1964 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 4 ottobre sul circuito Watkins Glen International.Il
pilota principale della Cooper-Climax statunitense Phil Hill, che non
aveva partecipatoalla gara precedente (fu sostituito dal pilota di
riserva), ritornò al volante.La corsa vide la vittoria di Graham
Hill su BRM, seguito da John Surtees su Ferrari e da Jo Siffert su
Brabham-BRM.
 Il Gran Premio degli Stati Uniti 1965
fu la nona gara della stagione 1965 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 3 ottobre sul Circuito di Watkins Glen. La corsa vide
la vittoria di Graham Hill su BRM, seguito dai piloti Brabham-Climax
Dan Gurney e Jack Brabham. |
|
|
La vittoria ad Indy
| Nel 1966 ben 225.000 spettatori
accalcano le tribune di Indianapolis, la vittoria di Clark della
precedente edizione ha richiamato tantissimo pubblico che accorre sugli
spalti per vedere se l’asso scozzese riesce a ripetere l’impresa. Graham
Hill è attirato dalla corsa americana e dai premi in denaro, si iscrive
al volante di una Lola-Ford. La corsa è molto movimentata nelle
posizioni di testa, i protagonisti sono tutti piloti inglesi, oltre a
Hill ci sono Clark e Stewarth anche lui al volante di una vettura
realizzata da Eric Broadley. Stewarth, a lungo terzo, ha dei problemi al
suo motore e scende in sesta posizione, ma per la vittoria si verifica
un episodio curioso: sia Hill che Clark si credono vincitori allo
scadere dei 200 giri ed entrambi entrano nella Victory Lane per ritirare
il Borg Warner Trophy. In realtà la vittoria è di Graham Hill, il team
Lotus aveva commesso un errore nel conteggio dei giri e Colin Chapman
ritirò immediatamente il reclamo lasciando alla Lola T90 la prima
vittoria ad Indianapolis. |
|
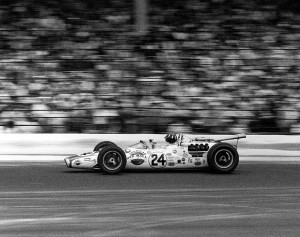
|
Dopo la vittoria nel catino dell’Indiana
la carriera di Graham Hill continua con altri successi, in 17 anni
disputa 176 G.P., il record di presenze fino ad allora, vincendone 14.
E’ suo il primato di vittorie a Montecarlo, cinque in totale, uguagliato
da Senna negli anni 90. Il pilota inglese è stato uno dei principali
attori del circus della F.1 negli anni ’60, e spesso viene ricordato,
oltre che per i suoi famosi baffi anche per il humor tipicamente
inglese. Eclettico, era facile incontrarlo nei box con la moglie Bette
che gli teneva i tempi, o a qualche party tra piloti, soprattutto dove
c’era da divertirsi. Nel 1964, dopo l’incidente tra la sua vettura e la
Ferrari di Lorenzo Bandini nel G.P. del Messico, che consentì a Surtees
di vincere il mondiale, facendolo perdere a Hill, regalò per natale
all’italiano un corso di guida, con un biglietto di prendere almeno la
patente per corrispondenza, un gesto spiritoso e simpatico che dimostra
la signorilità e la goliardia nell’ambiente di allora delle corse, ben
diverso dell’attuale fatto di reclami e spie. |
|
I due anni successivi lo vedono
ancora in lotta per il titolo ma questi ultimi anni in BRM sono segnati da una
grande quantità di problemi meccanici.
Nel 1967 torna alla Lotus e si forma un
super team con lui ed il due volte Campione del Mondo Jimmy
Clark.
Il 1968 è l'anno della tragica morte di Clark ad Hockenheim, Graham Hill
vince i due successivi gran premi
e diventa Campione del Mondo di Formula 1.
Gli anni
successivi non sono felici per Hill e vengono ricordati soprattutto per la sua
ultima vittoria, quella di Monaco nel 1969.
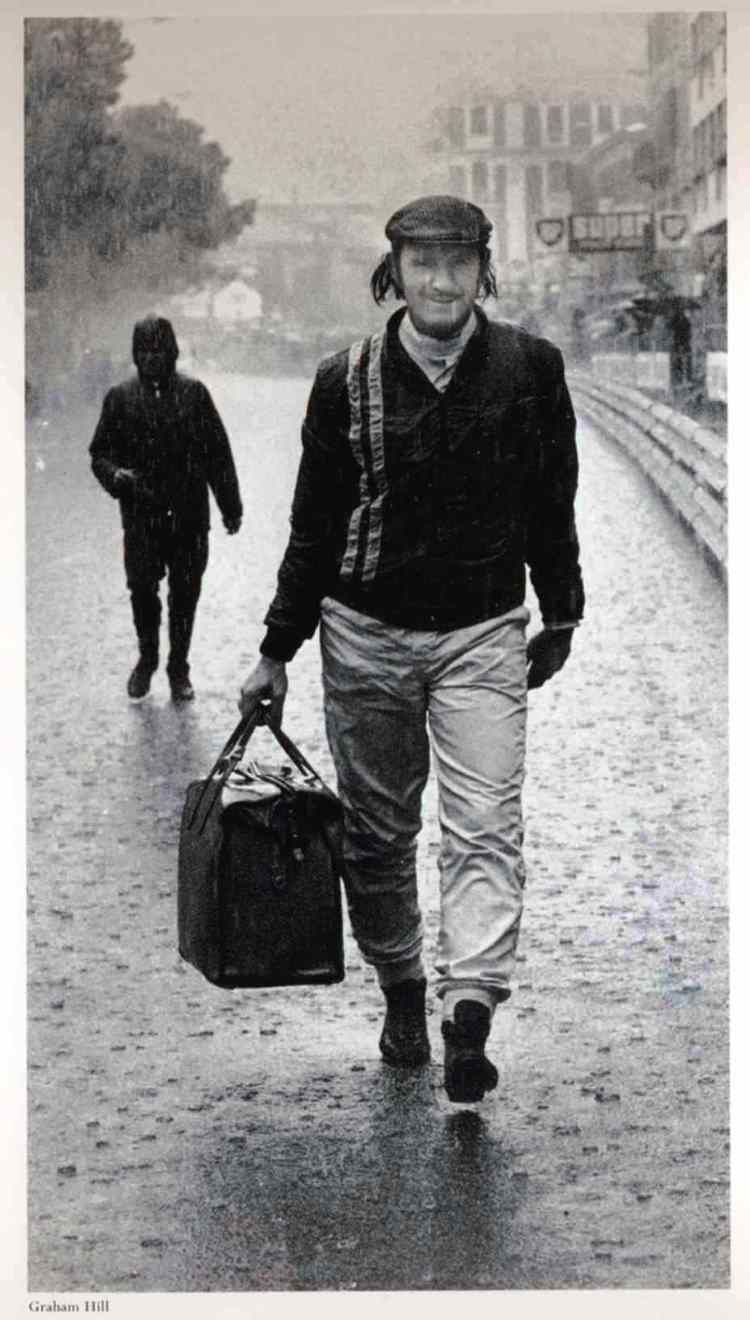 |
Questa è la sua quinta vittoria a Montecarlo, un record che non sarebbe stato sorpassato fino al 1993 quando Ayrton
Senna conquista la sua sesta vittoria sul circuito monegasco.A Watkins Glen rimane coinvolto
in un terribile incidente che lo vede costretto su di una sedia a rotelle.
Dopo
essersi rimesso dalle sue ferite ricomincia a correre ma senza ulteriori
successi. Fonda una sua scuderia, la Embassy, ma non ha successo.
|
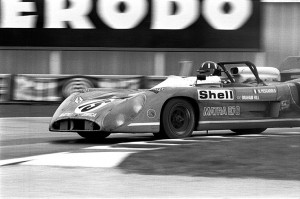 |
La vittoria a Le Mans
Graham Hill è stato anche l’unico pilota
ad aver vinto, oltre Indianapolis e l’alloro mondiale, anche la 24 Ore
di Le Mans, nel 1972 in coppia con Henry Pescarolo alla guida della
Matra MS670. Quell’anno Lagardere, il patron della Matra, chiamò
l’inglese a far coppia con Henry Pescarolo. Per tutti era solo un pilota
a fine carriera, demotivato, che correva solo per soldi, ed invece,
ancora una volta, la grande professionalità di Graham Hill ha avuto la
meglio.
Per
vincere nella maratona francese servono grandi doti, motivazione,
rispetto per la meccanica e la coppia Hill-Pescarolo conquistano
l’ambito trofeo sbaragliando tutti i pronostici che li davano solo per
comprimari. Per ora Graham Hill è stato l’unico a riuscire in questa
impresa, e nessuno sembra in grado di eguagliare questo primato in
un’era dove i piloti sono sempre più specializzati nelle varie
categorie.
|
Il Team Hill

|
Dopo l’avventura con il Team Gold Leaf
Lotus, passò al team privato di Rob Walker, sempre con la Lotus. Nel
1971 e ’72 corse con il Team Brabham per poi gareggiare con un proprio
team e le vetture Lola. Nella stagione 1975 fece debuttare una vettura
di sua costruzione (denominata GH1), anche se derivata da il modello
Lola T370 al Gran Premio del Sud Africa con Rolf Stommelen. Nel
successivo Gran Premio di Spagna corsero François Migault e Rolf
Stommelen. Proprio quando il pilota tedesco era in testa la perdita
dell’alettone provocò la sua uscita di pista con l’uccisione di quattro
spettatori. Nel Gran Premio di Monaco Graham Hill tenterà di
qualificarsi ma senza fortuna.
Sostituito Stommelen con Tony Brise la scuderia riuscì ad ottenere i
suoi primi punti al Gran Premio di Svezia con Brise, sesto. L’incidente
aereo in cui perirà Graham Hill, assieme a Tom Brise, il 29 novembre del
1975 mentre stavano rientrando da una sessione di test al Castellet,
determinerà la chiusura della scuderia. Hill stesso era alla guida del
suo aereo, un Piper Aztec, a causa della nebbia andò ad urtare durante
l’atterraggio contro un albero sulla pista di Elstree. Oltre ai due
piloti morirono il progettista Andy Smallman ed alcuni tecnici e
meccanic
|
Nel 1975, alla bella età di 46 anni, disputa i primi due gran
premi e poi annuncia il ritiro.Affiderà la vettura al suo pupillo,
Tony
Brise, che però morirà con lui quando cade l’aereo che stava pilotando. Era
il 29 novembre 1975 e il mondo non vedrà
più il
famoso casco con le strisce bianche fino a quando, nel 1992, suo figlio Damon
riporta
in Formula 1 questa famosa icona
rendendogli onore vincendo anche lui il
mondiale nell'anno 1996.
|
|

|

|
|
 Andreas Nikolaus Lauda nasce
a Vienna il 22 Febbraio 1949. Andreas Nikolaus Lauda nasce
a Vienna il 22 Febbraio 1949.
La sua è una famiglia molto influente e questo lo agevola quando è
costretto a chiedere in prestito i fondi per correre.
Partecipa alla sua prima gara, una gara in salita, nel 1968 a
bordo di una Cooper arrivando secondo. Da allora in poi, a dispetto
dell’insistenza del padre che lo voleva lontano dalle gare
automobilistiche, continua a competere nella gare in salita e più tardi
in Formula Vee. Comincia a farsi notare in Formula 3 e, nel 1971,
passa in Formula 2 "comprandosi" un posto alla March, in accoppiata con
Ronnie
Peterson (il quale aveva anch’egli pagato per correre) e
assicurandosi un contratto che prevedeva di correre in Formula 1/Formula 2
l’anno seguente. Quando la March
fallisce, riesce a persuadere Louis Stanley della BRM a vendergli un
posto. In quest’avventura colleziona talmente tanti debiti da far
impallidire chiunque.La chiamata di Luca Montezemolo della Ferrari gli
arriva appena prima del suo crollo finanziario, cosa che non lo aveva
neppur minimamente preoccupato anche se, più tardi, confesserà di essere
stato un pazzo. Strappa il suo contratto con la BRM e firma come pilota
Ferrari per due stagioni.

Niki Lauda ferrari 312 B3 1974 modello A
|
 |
Nel 1974, il suo primo anno al cavallino
rampante, Lauda colleziona le prime delle 26 vittorie in Formula 1. Lui ed
il suo compagno di squadra Clay Regazzoni corrono con ottime vetture e
concorrono al titolo di Campione del Mondo. Lauda agguanta il titolo
l’anno successivo con una vettura tecnicamente molto superiore alle
avversarie. Conquista 5 vittorie ed un ampio margine dal secondo classificato. Ha
ribattezzato il 1975 "l’anno incredibile" proprio per la
facilità e la naturalezza con cui vince. Il campionato successivo sembra
destinato a concludersi nello stesso modo. Nel 1976 la sicurezza è ai minimi livelli e, durante il Gran
Premio del Nurburgring - che ancora si correva sul vecchio tracciato da
olt re 12 km - Niki Lauda ebbe un gravissimo incidente dal quale uscì
segnato per sempre. Le conseguenze più gravi le ebbe a causa dei ritardi
dei mezzi di soccorso che, su una pista così lunga, impiegavano
moltissimo tempo ad arrivare. Solo il coraggio di tre piloti, Edwards,
Eartl e, soprattutto, Merzario, lo strapparono alla morte.
Rimane in
coma e per qualche ora la sua vita sembra appesa ad un filo. Comunque
riesce a riprendersi e, mostrando un coraggio difficile da eguagliare,
dopo sei settimane è già al volante della sua Ferrari (solo dopo molti
anni dichiarerà che quel giorno era pietrificato dalla paura). Il ritorno alle gare di Lauda gli frutta, a
Monza, uno
sbalorditivo quarto posto. Si arriva all'ultima gara - il Gran Premio del Giappone -
con Lauda ancora in testa alla classifica. La gara
inizia sotto una pioggia torrenziale e, dopo due giri, Lauda si ritira
dicendo che è da pazzi correre in quelle condizioni. Il titolo lo
vince l'inglese Hunt per solo un punto. re 12 km - Niki Lauda ebbe un gravissimo incidente dal quale uscì
segnato per sempre. Le conseguenze più gravi le ebbe a causa dei ritardi
dei mezzi di soccorso che, su una pista così lunga, impiegavano
moltissimo tempo ad arrivare. Solo il coraggio di tre piloti, Edwards,
Eartl e, soprattutto, Merzario, lo strapparono alla morte.
Rimane in
coma e per qualche ora la sua vita sembra appesa ad un filo. Comunque
riesce a riprendersi e, mostrando un coraggio difficile da eguagliare,
dopo sei settimane è già al volante della sua Ferrari (solo dopo molti
anni dichiarerà che quel giorno era pietrificato dalla paura). Il ritorno alle gare di Lauda gli frutta, a
Monza, uno
sbalorditivo quarto posto. Si arriva all'ultima gara - il Gran Premio del Giappone -
con Lauda ancora in testa alla classifica. La gara
inizia sotto una pioggia torrenziale e, dopo due giri, Lauda si ritira
dicendo che è da pazzi correre in quelle condizioni. Il titolo lo
vince l'inglese Hunt per solo un punto.
Nel
1977 Lauda si avvia a vincerà il suo secondo campionato, ma i
rapporti con la Ferrari si deteriorano tanto da fargli abbandonare la
squadra prima della fine della stagione.
La
separazione non è amichevole e solo dopo molto tempo Lauda ritratterà
molte delle critiche mosse alla squadra. Lauda non si è mai fatto intimorire da
Enzo
Ferrari e non ha gradito la situazione che si è creata e le parole
accese che gli sono state rivolte dal Drake dopo il suo ritiro nella gara
del Giappone.
Nel 1978 corre con la Brabham di Bernie Ecclestone e Gordon
Murray ma non arrivano i successi sperati. Il 1979 è l'anno
peggiore per Niki, la scarsa competitività della Brabham e l'arrivo di un
giovane arrembante, tale Nelson
 Piquet,
lo inducono alla decisione di ritirarsi dalle corse. Piquet,
lo inducono alla decisione di ritirarsi dalle corse.
Per le due stagioni successive
si dedica alla sua compagnia aerea e fa il commentatore per la televisione
tedesca. Niki Lauda rientra in Formula 1 nel 1982 per, da sua stessa
ammissione, problemi finanziari. La compagnia aerea che ha aperto è sull’orlo della bancarotta. Firma con
Ron Dennis e la
McLaren.
Nessuno credeva che Niki potesse di nuovo competere per il titolo ma lui,
una volta di più, mise tutti a tacere vincendo il campionato nel 1984
precedendo il compagno di squadra Alain Prost, per solo mezzo punto!
Il suo successo, oltre che alle sue
indiscusse abilità di pilota, è dovuto anche a due fattori che
vengono
spesso trascurati. Il primo è la sua onestà nei confronti degli
altri, avversari e non, nella misura in cui loro lo sono con lui. Il
secondo è la sua totale dedizione a quello che fa.
Galleria Fotografica

Monte Carlo,1976
|

Nurburgring,1975
|

Monte Carlo, 1972
|

Watkins Glen, 1975
|

Monte Carlo, 1976
|

Zandvoort, 1975
|

Jarama, 1974
|

Nurburgring, 1976
|
 Monte Carlo, 1983
Monte Carlo, 1983
|

Estoril, 1984
|

Monte Carlo, 1978
|

Fuji, 1976
|
Il suo secondo ed ultimo addio alle corse avviene ad Adelaide
nel 1985, anche questo, nel suo stile: veloce e senza fronzoli. La
sua McLaren sta volando sul rettilineo ma, alla staccata, i freni
anteriori non rispondono: la via di fuga ferma la vettura, lui scende e
scompare dietro le barriere senza guardarsi indietro una sola volta.
|
|

|
|


Da oscuro gregario a campione acclamato. È tutta qui, se vogliamo, la
particolarità della carriera di Nigel Mansell, pilota passato alla storia
per la sua grinta, il suo coraggio, il suo non arrendersi mai neppure di
fronte alla sorte troppe volte avversa.
Non era un grande tattico, non aveva la visione di gara di un Lauda o di un
Prost né il perfezionismo di Senna: il suo obbiettivo era l’avversario da
sconfiggere, da demolire anche psicologicamente, a colpi di giri veloci. Se
l’avversario era dietro il suo obbiettivo era fare il vuoto, se era
davanti non si dava pace fino a quando non entrava nel suo mirino. Aveva la
straordinaria capacità di tenere altissimo il ritmo per una corsa intera, senza
le pause che tipicamente un pilota si concede anche nelle corse più combattute e
lo faceva fino alla fine, quando usura dei pneumatici e consumi avrebbero
consigliato maggiore prudenza. Questo suo modo di correre, senza pace, senza
tregua, fece letteralmente impazzire il suo principale avversario, Nelson
Piquet, fino a fare sparire dalle labbra dello “zingaro” il suo mitico sorriso
ironico.

Nell’ambiente della F.1 Mansell è stato, per ragioni uguali ed opposte,
amatissimo dai tifosi e detestato dai critici. La folla ammirava il suo coraggio
e la sua dedizione alla lotta allo stesso modo con cui i critici detestavano gli
errori in cui, di tanto in
tanto, cadeva. Allo stesso modo gli addetti ai lavori difficilmente tollerano chi
non ha fortuna: non di certo per antipatia personale ma, più probabilmente,
perché, chi vive dell’analisi di uno sport, difficilmente è propenso ad
ammettere che qualche cosa di sfuggente, di non controllabile come il caso
possa essere stato determinante in un risultato, preferisce ignorarlo e trovare
una spiegazione “logica” anche là dove non può esserci. Per i tifosi, quindi,
Mansell aveva perso ben tre mondiali solo perchè “sfortunato”, mentre per i
critici era irrimediabilmente “sprecone” ed “inconcludente”..
Quello che in realtà gli addetti ai lavori non hanno mai perdonato a Mansell
era il fatto di essere un “parvenu”, un “intruso”, uno che si era distaccato
dalla mediocrità a cui sembrava condannato ed essere entrato all’improvviso,
senza neppure chiedere permesso, nel giro dei piloti che contano. Quando un
giovane pilota comincia a dimostrare le proprie doti, i “divi” dell’ambiente
tentano in tutti i modi di tenerlo alla larga, assumono un atteggiamento
guardingo ed usano anche la stampa amica per cercare di screditarlo o, comunque,
di guadagnare posizioni “politiche” che permettano di guadagnare tempo. Ma,
psicologicamente, si preparano all’inevitabile scontro. Così è stato, ad
esempio, con Senna e Schumacher.
Ma con Mansell era diverso. Quando comincia a
mettere a soqquadro l’ambiente ha già 33 anni e la stessa età dei campioni più
affermati dell’epoca. In cinque stagioni alla Lotus aveva fatto vedere ben poco,
era solo una figura di secondo piano, il fido scudiero di Elio De Angelis.
Difficile immaginare che, all’improvviso, questo scudiero si mettesse a correre
come un pazzo e a demolire in termini velocistici il suo caposquadra. Nel 1986
rivoluziona l’ambiente della F.1: maltratta il suo compagno e manda all’aria
tutte le previsioni che vedevano in una serrata lotta Prost – Piquet il filo
conduttore della stagione. Solo adottando questa chiave di lettura è possibile
capire il mito del “Leone” mai domo e del suo numero “5 rosso”.
Che in questo strano inglese, classe 1953 di Upton On Severn, protagonista
delle formule minori in Gran Bretagna, ci fosse qualcosa di buono, lo aveva
intuito il solito Colin Chapman, patron della Lotus, che lo mette sotto
contratto a partire dalla stagione 1980. Nella casa inglese rimane cinque anni,
fino al 1984: buone prestazioni in qualificazione, qualche piazzamento e niente
di più; il “buon” comprimario di Elio De Angelis, all’epoca alfiere della Lotus.

Frank Williams simpatizza per lui e lo porta nella sua scuderia nel 1985,
proprio quando comincia l’epopea del turbo Honda. Dopo una stagione di rodaggio
(dove arrivano le prime vittorie), Mansell si scatena, sorprendendo tutti per
grinta e velocità. Infatti nelle stagioni 1986 e 1987 è il grande protagonista:
vince ben 13 gran premi dando spettacolo e facendo disperare il suo compagno di
squadra, Nelson Piquet, che sembrava destinato ad una passeggiata trionfale in
entrambe le stagioni. Ma la sorte, mai dalla sua parte, gli nega la conquista
del titolo mondiale, assumendo sempre la forma di un pneumatico.
In Australia,
ultimo G.P. della stagione 1986, la gomma scoppia mentre gestiva un comodo terzo
posto più che sufficiente alla conquista del titolo che finirà poi, nelle mani di un
incredulo Alain Prost. In Ungheria, nel 1987, una ruota maldestramente avvitata
da un meccanico si stacca mentre era abbondantemente in testa: il colpo del K.O.
al suo compagno di squadra si trasforma in un boomerang e rilancia un ormai
sfiduciato Piquet.
La disperata rincorsa che ne seguirà si concluderà
tristemente a Suzuka dove un terribile incidente gli procura lo schiacciamento di due
vertebre
che gli impedisce di partecipare agli ultimi due gran
premi.
MANSELL SPINGE FINO ALLO SVENIMENTO
Usa 1984: in una domenica rovente (42°) la Lotus di Mansell si
ferma a pochi metri dal traguardo per la rottura del differenziale.
Il
pilota scende e spinge la monoposto fino a che il caldo e la
disidratazione non lo fanno crollare, svenuto, sull'asfalto.

Il 1988 è un vero purgatorio: la Honda non ha perdonato la mancata conquista
del titolo 1986 addebitandola alla lotta troppo concitata tra i due piloti della
scuderia. Così l’astuto Ron Dennis ha gioco facile a strappare ad uno sfortunato
Frank Williams i
motori Honda. Contro le vetture di Senna e Prost nel 1988 nessuno può nulla,
tantomeno Mansell, al volante di una Williams motorizzata Judd (un motore di
F.3000 modificato per l’esigenza) e alle prese con i postumi dell’incidente. La
sola nota positiva è un nuovo contratto con la Ferrari per la stagione
successiva: era stato proprio il grande Enzo (morto nell’agosto di quell’anno) a
volerlo assolutamente in squadra.
 Alla
Ferrari Mansell passa due anni. Nella stagione 1989 guida la casa di
Maranello alla riscossa, infila due vittorie gioiello e compie la grande impresa
della sua carriera: sul circuito dell’Hungaroring, notoriamente famoso per
l’impossibilità a sorpassare, parte dalla tredicesima posizione e vince dopo
aver “infilato” 11 avversari con sorpasso finale, memorabile, a scapito del
grande Senna. Il 1990 è, invece, afflitto da troppi ritiri mentre Prost, suo
compagno in quella stagione, lotta per il titolo. Dopo l’ennesimo abbandono
durante il G.P. di Inghilterra, Mansell annuncia, mestamente, il suo primo
ritiro. Alla
Ferrari Mansell passa due anni. Nella stagione 1989 guida la casa di
Maranello alla riscossa, infila due vittorie gioiello e compie la grande impresa
della sua carriera: sul circuito dell’Hungaroring, notoriamente famoso per
l’impossibilità a sorpassare, parte dalla tredicesima posizione e vince dopo
aver “infilato” 11 avversari con sorpasso finale, memorabile, a scapito del
grande Senna. Il 1990 è, invece, afflitto da troppi ritiri mentre Prost, suo
compagno in quella stagione, lotta per il titolo. Dopo l’ennesimo abbandono
durante il G.P. di Inghilterra, Mansell annuncia, mestamente, il suo primo
ritiro.
Ma per il “Leone” non è ancora tempo di pantofole: Frank Williams lo richiama
in fretta e furia e gli affida una delle sue Williams Renault. Se nel 1991,
superate le difficoltà tecniche iniziali, lotta fino all’ultimo per il titolo
con Senna e si classifica “solo” secondo (anche per colpa del solito pneumatico
avvitato male, questa volta in Portogallo), nel 1992 domina completamente la
stagione: troppo superiore tecnicamente rispetto alla concorrenza la Williams e
troppo motivato il suo pilota. Mansell vince 9 G.P. su 16, si laurea campione
con 5 gare di anticipo lasciando agli altri solo le briciole.
Questa formidabile stagione sarà, purtroppo, la sua ultima intera in F.1. Nel
1993 viene, infatti, appiedato per motivi “politici”: la Renault, impresa
pubblica francese, vuole un pilota francese e lo sceglie in Alain Prost. Mansell
si rifugia negli “States” dove vince il campionato di F.Cart.
Mansell farà qualche altra apparizione in F.1: nel 1994 ancora con la
Williams dopo la morte di Senna, riuscendo perfino a vincere l'ultimo G.P. della
stagione, e nel 1995 per soli due G.P. con la McLaren.
I risultati sono scarsi e, dopo il gran premio di Monaco del 1995, Mansell
annuncerà il suo ritiro, stavolta definitivo. A 42 anni, l’inesorabile passare del tempo
ha ormai consumato gli artigli del “vecchio” Leone....
|
|

|
|
|
|
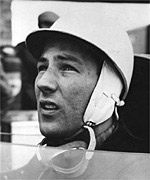 Il 27 maggio 1951 nel Gran
Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del
mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling
Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non
hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17
settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran
Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole
positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il
pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa
delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del
mondo. Il 27 maggio 1951 nel Gran
Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del
mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling
Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non
hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17
settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran
Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole
positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il
pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa
delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del
mondo.
La grande sfortuna di Moss è stata quella di incrociare la
propria carriera con quella del più grande pilota di ogni epoca a
livello di risultati, Juan Manuel Fangio, che dal '55 al '57
lo precedette nella classifica mondiale, mentre nel '58 fu battuto
di un solo punto dal connazionale Mike Hawthorn, pilota della
Ferrari che, pur avendo vinto un solo Gran Premio contro i quattro
di Stirling, si aggiudicò il titolo a causa di un regolamento
discutibile che premiava di più i piazzamenti che le vittorie. Dopo
essersi piazzato terzo nella classifica dei campionati '59 '60 e '61
Moss si stava apprestando a dare l'ennesimo assalto all'iride
per la stagione 1962 quando il lunedì di Pasqua in una gara fuori
campionato a Goodwood ebbe un terribile incidente che pose fine alla
sua carriera.
Tra le tante prestazioni memorabili del londinese va
ricordata quella del 19 gennaio 1958 a Buenos Aires quando con la
piccola Cooper-Climax a motore posteriore battè nettamente le ben
più potenti Ferrari e Maserati che parteciparono a quella gara;
inoltre fu il primo pilota a portare alla vittoria la gloriosa
scuderia della Lotus a Montecarlo nel 1960.
La gara di F1 con meno iscritti di sempre
Anno 1958. La F1 sbarcava in Argentina, circuito di Buenos Aires, per il primo Gran Premio della stagione.
|
|

La Cooper di Moss
|
La gara era in programma il 19 gennaio. Erano passati 4 mesi dall'ultima
gara di F1 a Monza, e durante l'inverno le varie scuderie avevano
sviluppato nuovi modelli o migliorato gli esistenti.
Tuttavia, il regolamento tra le due stagioni era cambiato. Prima del GP
d'Argentina la composizione delle benzine era libera, ma per la stagione
1958 venne reso obbligatorio l'uso di carburanti standard avio, quindi
di derivazione aeronautica.
Vanwall e Brm si trovarono impreparati al cambiamento; di conseguenza
decisero di disertare l'appuntamento oltreoceano per concentrarsi sul GP
successivo. Quello di Monaco, a maggio!
Arrivarono a Buenos Aires solo 10 vetture. Eccole: 3 Ferrari D246, 6
Maserati 250F e una Cooper-Climax T43 a motore posteriore del Rob Walker
Racing Team. Stirling Moss era alla guida dell'unica rappresentante del
Regno Unito, mentre per il Cavallino gareggiarono Musso, Hawthorn e
Collins. Le Maserati, schierate in forma privata a causa del ritiro del
team ufficiale per motivi economici, furono a disposizione di Fangio,
Behra, Godia, Gould, Menditeguy e Schell.

Moss festeggiato al traguardo
|
La gara fu avvicente. Moss la conquistò grazie a una accorta tattica,
mettendo a registro due record per la F1: la prima vittoria per la
Cooper e la prima per una vettura a motore posteriore. L'inglese non si
fermò ai box per cambiare pneumatici, riuscendo a gestire il suo
vantaggio su Luigi Musso. Hawthorn arrivò 3°, mentre Fangio giunse 4°
davanti a tutte le altre Maserati. Collins fu l'unico ritirato per via
della rottura dell'albero di trasmissione.
Moss negli ultimi giri fu costretto a rallentare a causa del consumo
delle gomme. Una sosta ai box, tuttavia, non gli avrebbe fatto
risparmiare tempo in quanto la sua Cooper non disponeva del fissaggio
centrale. Musso, da parte sua, potè solo recriminare sul risultato
finale; lui e il box Ferrari non si erano intesi bene
sull'interpretazione della strategia di Moss, lasciandogli prendere un
vantaggio incolmabile quando invece sarebbe stato meglio spingere
sull'acceleratore.
Era un'epoca romantica per l'automobilismo, e di quella gara rimangono
attuali solo le strategie suicide della Ferrari... Nella gara
successiva, quella di Montecarlo, si ristabilì lo scorrere naturale
degli eventi, con più di 30 iscritti (tra cui Bernie Ecclestone) e una
straordinaria varietà di team e modelli. |
Moss negli ultimi giri fu costretto a rallentare a causa del consumo
delle gomme. Una sosta ai box, tuttavia, non gli avrebbe fatto
risparmiare tempo in quanto la sua Cooper non disponeva del fissaggio
centrale. Musso, da parte sua, potè solo recriminare sul risultato
finale; lui e il box Ferrari non si erano intesi bene
sull'interpretazione della strategia di Moss, lasciandogli prendere un
vantaggio incolmabile quando invece sarebbe stato meglio spingere
sull'acceleratore.
Era un'epoca romantica per l'automobilismo, e di quella gara rimangono
attuali solo le strategie suicide della Ferrari... Nella gara
successiva, quella di Montecarlo, si ristabilì lo scorrere naturale
degli eventi, con più di 30 iscritti (tra cui Bernie Ecclestone) e una
straordinaria varietà di team e modelli.
|
|
|

|
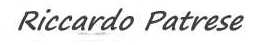
|
|
 La vettura bianco-blu guidava in quel
pomeriggio di primavera sereno e festoso il Gran Premio di San Marino.
Dietro di lei, come una minaccia, c'era una Ferrari. Non una Ferrari
qualunque, ma "la" Ferrari di quegli anni, la numero 27, che aveva perso
il suo eroe l'anno prima, ma che grazie al suo indimenticato alfiere era
entrata nel mito. Dunque la vettura bianco-blu precedeva la numero 27 e
Imola, che l'anno prima aveva assistito al duello fratricida tra i due
ferraristi e li aveva persi entrambi pochi Gran Premi dopo, stava col
fiato sospeso. Aspettando quella vittoria, che, sul Santerno, avrebbe
"vendicato" il ricordo di Gilles Villeneuve. E chissà cosa sono il
destino, l'ansia di rivincita o il dolore. La vettura bianco-blu guidava in quel
pomeriggio di primavera sereno e festoso il Gran Premio di San Marino.
Dietro di lei, come una minaccia, c'era una Ferrari. Non una Ferrari
qualunque, ma "la" Ferrari di quegli anni, la numero 27, che aveva perso
il suo eroe l'anno prima, ma che grazie al suo indimenticato alfiere era
entrata nel mito. Dunque la vettura bianco-blu precedeva la numero 27 e
Imola, che l'anno prima aveva assistito al duello fratricida tra i due
ferraristi e li aveva persi entrambi pochi Gran Premi dopo, stava col
fiato sospeso. Aspettando quella vittoria, che, sul Santerno, avrebbe
"vendicato" il ricordo di Gilles Villeneuve. E chissà cosa sono il
destino, l'ansia di rivincita o il dolore.
La vettura bianco blu alle Acque Minerali uscì
di pista in una fumata di polvere. Dalle tribune le bandiere rosse che animano i circuiti
di tutto il mondo, ma che solo a Imola e a Monza sanno essere crudeli e
commoventi allo stesso tempo, si alzarono gioiosamente al cielo
accompagnate dal boato del pubblico. Patrick Tambay stava onorando la
memoria di Gilles Villeneuve. Su un muretto delle Acque Minerali Riccardo
Patrese stava assaporando, tra i fischi e lo sventolìo di bandiere rosse,
quanto è amaro essere piloti italiani su circuiti ferraristi. Quando penso
alla carriera di Riccardo Patrese il ricordo vola sempre a quella giornata
di Imola, perché anch'io ho fatto un salto di gioia vedendolo uscire di
pista. Perché invece di pensare al trionfo di un pilota italiano esigevo
la memoria di un pilota canadese volato via. E' stato "il senso di colpa"
di quel pomeriggio romagnolo a render caro alla mia memoria Riccardo
Patrese, uno dei migliori e più sottovalutati piloti italiani degli ultimi
anni, il decano di tutti i piloti della Formula 1. Le sue 256 presenze
sono ancora oggi un record lontano da ogni possibilità di essere battuto.
Nella sua lunghissima carriera Rick ha corso
per le squadre di serie B e per i top team, distinguendosi sempre per
tenacia, velocità e sfortuna. Ha conosciuto la delusione delle promesse
non mantenute e l'euforia della vittoria, la crudeltà dei colleghi e il
rispetto e la stima dei top manager. Non ci sono imprese epiche né grande
fortuna nel passato del ragazzo di Padova. All'inizio della carriera
correva per squadre disastrate che ne rendevano difficile la visibilità,
ma è riuscito, nonostante tutto, ad affacciarsi alla pole position con la
Arrows dei primissimi anni '80. Non ha mai goduto di buona stampa: il suo
carattere chiuso, la timidezza e la sfortuna, davvero tanta, tenace e
incredibile, gli facevano preferire altri colleghi. E a metà degli anni
'80 il pubblico e i media italiani gli preferivano Michele Alboreto, tanto
popolare e sopravvalutato perché correva per la Ferrari infelice del
dopo-Villeneuve. E poi, quando al termine della carriera, è approdato in
un top-team e ha potuto esprimere se stesso e il proprio talento, era in
squadra con Nigel Mansell, l'unico pilota che abbia saputo stringere, per
qualche arcana ragione, un rapporto di amore e odio tanto intenso con
Frank Williams.
Ma a leggere bene gli anni di Riccardo Patrese
si trova tanta storia della Formula 1 moderna. E ci sono tre
momenti
indimenticabili, tutti, è nello stile del vecchio Rick, negativi
per lui.
Sono Monza '78, Imola '83 ed Estoril '92. A Monza Riccardo fu
vittima
della peggiore vigliaccata che i piloti di Formula 1 e la loro
associazione abbiano mai commesso nei confronti di un
collega.Ricordo la confusione e l'incidente che coinvolse un numero
incredibile di
vetture.Il giorno dopo Ronnie Peterson, uno dei piloti più
apprezzati di quegli anni, morì all'ospedale Niguarda per le
conseguenze
di quell'incidente e nel dolore di quella morte il suo Paese, la
Svezia,
rinunciò alla Formula 1. Riccardo fu accusato dai colleghi di aver
innescato l'incidente con una manovra azzardata e fu considerato
per gli
anni successivi "il colpevole" della morte di Ronnie Peterson.
L'associazione Piloti gli impedì di prendere parte al Gran Premio
successivo. Patrese aveva allora 24 anni ed era uno dei piloti più
giovani
della Formula 1. Chissà quanta determinazione, quanta calma e
quanta
conoscenza di sé, in lui,
 per non ribellarsi pubblicamente e
violentemente, per non denunciare costantemente l'impudenza e la crudeltà
di quella esclusione e il trattamento da paria a cui fu sottoposto per
anni, prima che Bernie Ecclestone lo chiamasse alla Brabham, facendone un
top-driver. Alcuni anni dopo fu poi stabilito che non aveva alcuna
responsabilità nella collisione fatale di Monza. Non risulta che alcuno dei colleghi, che
tanto male cercarono di fare alla sua immagine e alla sua carriera, si sia
scusato con lui. Tra loro, e questo mi dispiace sempre molto, c'era anche
Niki Lauda. Di Imola '83 si è già detto: se c'è un momento nero nella
storia del tifo ferrarista di questi anni, io lo identifico in quel
Riccardo Patrese fermo alle Acque Minerali tra bandiere rosse e pubblico
festante, tra fischi e scherno. Ti abbiamo mai chiesto scusa, per quel
gesto, Rick? Avrei voluto che la Formula 1, dopo quel giorno, fosse più
gentile di te. Dopo i successi con la Brabham (Rick ha vinto il GP di
Monaco 1982 e il GP del Sudafrica per il team di Bernie Ecclestone), sono
arrivati gli anni bui in Alfa Romeo e di nuovo in Brabham, culminati nella
morte di Elio De Angelis, nel 1986, ma caratterizzati sempre dai buoni
rapporti con i compagni di squadra, dallo stesso Elio a Eddie Cheever. E
poi è arrivata la Williams. per non ribellarsi pubblicamente e
violentemente, per non denunciare costantemente l'impudenza e la crudeltà
di quella esclusione e il trattamento da paria a cui fu sottoposto per
anni, prima che Bernie Ecclestone lo chiamasse alla Brabham, facendone un
top-driver. Alcuni anni dopo fu poi stabilito che non aveva alcuna
responsabilità nella collisione fatale di Monza. Non risulta che alcuno dei colleghi, che
tanto male cercarono di fare alla sua immagine e alla sua carriera, si sia
scusato con lui. Tra loro, e questo mi dispiace sempre molto, c'era anche
Niki Lauda. Di Imola '83 si è già detto: se c'è un momento nero nella
storia del tifo ferrarista di questi anni, io lo identifico in quel
Riccardo Patrese fermo alle Acque Minerali tra bandiere rosse e pubblico
festante, tra fischi e scherno. Ti abbiamo mai chiesto scusa, per quel
gesto, Rick? Avrei voluto che la Formula 1, dopo quel giorno, fosse più
gentile di te. Dopo i successi con la Brabham (Rick ha vinto il GP di
Monaco 1982 e il GP del Sudafrica per il team di Bernie Ecclestone), sono
arrivati gli anni bui in Alfa Romeo e di nuovo in Brabham, culminati nella
morte di Elio De Angelis, nel 1986, ma caratterizzati sempre dai buoni
rapporti con i compagni di squadra, dallo stesso Elio a Eddie Cheever. E
poi è arrivata la Williams.
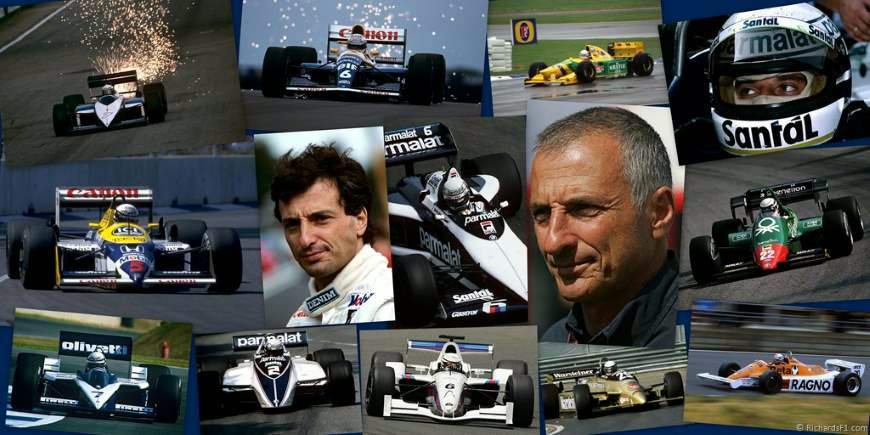 |
 Ricordo l'estate del 1987 in cui Frank Williams
si divertiva a dribblare i giornalisti italiani, che intuivano l'ingaggio
di Rick, e si lasciava scappare, di tanto in tanto, mezze parole per far
crescere le aspettative. La Williams stava concludendo l'era
Piquet-Mansell e dal 1988 avrebbe ceduto il primato a un'altra mitica
coppia, quella di Alain Prost e Ayrton Senna Da Silva sulla McLaren. Era
una delle squadre più importanti e più stimate della Formula 1, ma dal
1988 non sarebbe stata la più competitiva. Riccardo fece il suo dovere con
onestà, arrivando a vincere alcune gare. Nel 1990 arrivò a prendersi la
più bella rivincita della sua carriera, vincendo, in un tripudio di folla
finalmente rispettosa e contenta, il Gran Premio di San Marino. Era l'anno
del duello Prost su Ferrari-Senna su McLaren, ma il ragazzo di Padova
aveva conquistato il rispetto e l'affetto dell'Italia, diventandone il suo
più popolare rappresentante in Formula 1. Nella sua felicità Rick fu come
sempre misurato e sorridente. Ricordo l'estate del 1987 in cui Frank Williams
si divertiva a dribblare i giornalisti italiani, che intuivano l'ingaggio
di Rick, e si lasciava scappare, di tanto in tanto, mezze parole per far
crescere le aspettative. La Williams stava concludendo l'era
Piquet-Mansell e dal 1988 avrebbe ceduto il primato a un'altra mitica
coppia, quella di Alain Prost e Ayrton Senna Da Silva sulla McLaren. Era
una delle squadre più importanti e più stimate della Formula 1, ma dal
1988 non sarebbe stata la più competitiva. Riccardo fece il suo dovere con
onestà, arrivando a vincere alcune gare. Nel 1990 arrivò a prendersi la
più bella rivincita della sua carriera, vincendo, in un tripudio di folla
finalmente rispettosa e contenta, il Gran Premio di San Marino. Era l'anno
del duello Prost su Ferrari-Senna su McLaren, ma il ragazzo di Padova
aveva conquistato il rispetto e l'affetto dell'Italia, diventandone il suo
più popolare rappresentante in Formula 1. Nella sua felicità Rick fu come
sempre misurato e sorridente.
Nel 1992 ci fu lo spettacolare incidente
dell'Estoril causato da Gerhard
Berger, che al fianco di Ayrton Senna, in McLaren, si distinse in varie
scorrettezze gratuite. Poco prima dell'ingresso della corsia d'ingresso ai
box l'austriaco strinse contro la Williams di Rick. Il contatto fu
inevitabile e la vettura dell'italiano decollò esibendosi in varie
carambole, prima di andare a cadere a pochi centimetri dal muretto dei
box. Come si suol dire, si sfiorò la tragedia. Ma Rick, ragazzo educato e
tranquillo, non si esibì in nessuna sceneggiata né pretese la squalifica
di Gerhard. Un altro stile, il suo.
Non si può dire che la sua carriera abbia
subito il declino. Rick ha lasciato al momento giusto. Approdato
alla
Benetton alla vigilia dell'era Schumacher, a quasi 40 anni,
affettuosamente chiamato "il nonno", stimato, rispettato e ancora
nel block-notes dei top-manager più importanti, ha preferito lasciare il
Circus
con i suoi record e la sua lunghissima storia di pilota italiano e
per
questo non troppo fortunato. Del resto il mito non si allea mai
con la
fortuna.
|
|

|
|
|
 Gli
piaceva osservare i pesciolini del suo acquario.Quel piccolo mondo fatto solo di
colori e nessun suono, lo affascinava e lo rilassava.Non diventò mai campione
del mondo, per sfortuna o, forse, per una misteriosa congiuntura del destino. Gli
piaceva osservare i pesciolini del suo acquario.Quel piccolo mondo fatto solo di
colori e nessun suono, lo affascinava e lo rilassava.Non diventò mai campione
del mondo, per sfortuna o, forse, per una misteriosa congiuntura del destino.
Nato il 14 febbraio 1944 a Orebro, Svezia, cominciò come tanti, con i kart.In
una corsa aveva il numero 41, l'italiano Sala il numero 1.Il numero 41 era un
trampoliere nel nido, un gomitolo quasi, perchè non sapeva dove mettere le sue
lunghe gambe.Il numero 1, uomo di Lilliput, era invece deciso e aggressivo.Vinse
Peterson.Gli addetti ai lavori si chiedevano come facesse ad andare così
veloce.Sui kart imparò l'arte del controsterzo e, controsterzando, arrivò in
F.3 e vinse nel 1969 il G.P. di Monaco che è l'anticamera della F.1.Ancora
una volta tutti si chiedevano come facesse ad essere così veloce.Il Montjuich,
in Spagna, era un circuito per i curvatori di ventura che sapevano andare oltre
il limite.Su un tratto in discesa, con curve e controcurva, lui sapeva
infliggere decimi di secondo ogni giro ai suoi grandi rivali, Stewart e
Fittipaldi. Quando alla Lotus lo costrinsero a fare in numero due di Andretti,
lui accettò ma quando, durante le prove ufficiali di un gran premio, gli
montarono delle gomme vistosamente inadatte, lui si lanciò in pista e segnò il
record.Appena fermo ai box, ancora in macchina, alzò il dito medio verso Colin
Chapman che l'aveva umiliato.Un giornalista faceva notare davanti alla
televisione, il modo in cui vinse il gran premio d'Italia 1976.Lauda guidava la
sua Ferrari respirando piano e sanguinando sotto il casco(era la sua prima corsa
dopo il rogo del Nuerburgring);Hunt si piantava nella sabbia nel tentativo di
rimontare;Regazzoni inseguiva invano il sogno di vincere per la terza volta
sulla pista a lui più cara;l'asfalto era viscido ma Peterson sembrava libero da
ogni problema di aderenza e costruiva la sua vittoria vanificando la resistenza
degli avversari. Quando alla Lotus lo costrinsero a fare in numero due di Andretti,
lui accettò ma quando, durante le prove ufficiali di un gran premio, gli
montarono delle gomme vistosamente inadatte, lui si lanciò in pista e segnò il
record.Appena fermo ai box, ancora in macchina, alzò il dito medio verso Colin
Chapman che l'aveva umiliato.Un giornalista faceva notare davanti alla
televisione, il modo in cui vinse il gran premio d'Italia 1976.Lauda guidava la
sua Ferrari respirando piano e sanguinando sotto il casco(era la sua prima corsa
dopo il rogo del Nuerburgring);Hunt si piantava nella sabbia nel tentativo di
rimontare;Regazzoni inseguiva invano il sogno di vincere per la terza volta
sulla pista a lui più cara;l'asfalto era viscido ma Peterson sembrava libero da
ogni problema di aderenza e costruiva la sua vittoria vanificando la resistenza
degli avversari.
Debutta a Monaco il 10 maggio 1970, nel 1971 è vice campione del mondo e sfiora
la vittoria, per un centesimo di secondo, nel gran premio d'Italia, il più
veloce della storia, 246 Km/h.Nel 1972 vince, con la Ferrari, la 1000 km di
Buenos Aires e, finalmente, nel 1973 la prima vittoria in F.1, in Francia l'1
luglio, alla fine del mondiale fu, di nuovo, vice campione.Seguiranno altre
nove
vittorie, in mezzo, piazzamenti, ritiri e incidenti."Crashed", così
è scritto nelle classifiche."Crashed" al Cristal
Palace,"Crashed" al Maillory park dove la sua March F.2 decollò su un
terrapieno proprio in faccia a un pubblico ipnotizzato dalla sorpresa e dallo
spavento."Crashed" a Silverstone.Tuttavia il suo albo d'oro non
registra i suoi "Crashed" interiori, quando dovette scontrarsi non con
terrapieni nè con guard rail ma con l'incomprensione e l'inadeguatezza
meccanica che fece nascere lo slogan:il pilota giusto sulla macchina
sbagliata.Pareva che tutta la vita di Peterson fosse dominata dall'attesa
perchè, con gli anni, la sua storia era diventata sempre più incomprensibile,
dato che i successi che le sue doti invocavano, non arrivavano.Anche Ferrari,
dopo avergli affidato una sua vettura sport, non volle saperne di dargli una
F.1. E
Ronnie si portava dietro tutto quanto con leggerezza anche se il suo sguardo era
sempre più malinconico e rassegnato.Arrivò a quel gran premio d'Italia, il 10
settembre 1978, sempre più solo con se stesso.Chapman gli aveva fatto
un'altro sgarbo affidandogli una Lotus vecchia di un anno per paura che desse
fastidio a Andretti, il campione predestinato.Babro, la moglie, era lontana con
la figlia Nina e anche il suo orso portafortuna, che teneva sempre
nell'abitacolo, quel giorno non c'era.Fu un gran premio di trecento metri. E
Ronnie si portava dietro tutto quanto con leggerezza anche se il suo sguardo era
sempre più malinconico e rassegnato.Arrivò a quel gran premio d'Italia, il 10
settembre 1978, sempre più solo con se stesso.Chapman gli aveva fatto
un'altro sgarbo affidandogli una Lotus vecchia di un anno per paura che desse
fastidio a Andretti, il campione predestinato.Babro, la moglie, era lontana con
la figlia Nina e anche il suo orso portafortuna, che teneva sempre
nell'abitacolo, quel giorno non c'era.Fu un gran premio di trecento metri.
Si
partiva da una strada larga che stringeva all'avvicinarsi della prima
variante.Ronnie s'infilò nell'imbuto con macchine
davanti,dietro, a destra e a
sinistra.Accadde qualcosa e fu ancora "Crashed".Dal groviglio
spuntarono le fiamme ma lo tirarono fuori in tempo, la sua macchina era ridotta
a brandelli.Finalmente lo portarono via in barella e Ronnie alzò un'ultima
volta la testa per guardarsi la gamba fratturata in sette punti.All'ospedale gli
riscontrarono ustioni e altre fratture, lo operarono subito e l'intervento durò
sette ore.Alle 4.30 del mattino sopravvenne una grave crisi respiratoria e
renale.Alle 7 non c'è più speranza e alle 10.10 Ronnie Peterson era ormai un
ricordo.Con glaciale freddezza Colin Chapman commentò:
"Succede".Mario Andretti, il compagno di squadra, entrò nel cortile
dell'ospedale, gli dettero la notizia e non scese neppure dall'auto.Sui giornali
tanti articoli contro le corse con foto di Peterson in prima pagina.In quel
mare di parole inutili e ipocrite Ronnie pare affondare nel suo acquario dove il
riflesso del suo viso si mescola ai pesciolini rosso e oro.Un mondo piccolo,
fatto solo di colori e nessun suono.
|
|

|

|
A metà degli anni '80 in Formula 1 c'erano due
modi di essere brasiliani. Uno era quello mistico, tormentato e nostalgico
di Ayrton Senna e l'altro era quello solare, irriverente e scherzoso,
spruzzato dalla saudade, di Nelson Piquet.
A metà degli anni '80 Nelson Piquet, che aveva
già vinto due dei suoi tre titoli mondiali (il terzo sarebbe arrivato nel
1987 con la Williams),
 era
il pilota più amato del
Circus, beniamino dei tifosi di tutto il mondo, più volte
trionfatore di
Monza, ogni volta accolto con un entusiasmo e accompagnato sempre
da donne bellissime. Lo chiamavano lo "zingaro" della
Formula 1 perché abitava in una bella barca nel porto di
Montecarlo, così
da essere sempre pronto a nuove avventure nei porti
mediterranei.Si
spostava con un aereo che si era regalato dopo la conquista del
secondo
titolo mondiale e che aveva imparato a guidare nell'inverno del
1983 dalle
parti di Reggio Emilia, facendo impazzire le teen-agers della
zona.Sosteneva di essere pigro, di amare la compagna del momento e i
figli
lontani e di essere gelosissimo della sua vita privata. Era un
uomo,
Nelson, come non ce ne sono stati più in Formula 1 e di cui si fa
bene ad
avere sempre nostalgia. era
il pilota più amato del
Circus, beniamino dei tifosi di tutto il mondo, più volte
trionfatore di
Monza, ogni volta accolto con un entusiasmo e accompagnato sempre
da donne bellissime. Lo chiamavano lo "zingaro" della
Formula 1 perché abitava in una bella barca nel porto di
Montecarlo, così
da essere sempre pronto a nuove avventure nei porti
mediterranei.Si
spostava con un aereo che si era regalato dopo la conquista del
secondo
titolo mondiale e che aveva imparato a guidare nell'inverno del
1983 dalle
parti di Reggio Emilia, facendo impazzire le teen-agers della
zona.Sosteneva di essere pigro, di amare la compagna del momento e i
figli
lontani e di essere gelosissimo della sua vita privata. Era un
uomo,
Nelson, come non ce ne sono stati più in Formula 1 e di cui si fa
bene ad
avere sempre nostalgia.
Aveva la fama di sciupafemmine (tra i suoi
flirt, mai confermati né smentiti, figura anche la principessa Stephanie
di Monaco), di indolente e di bontempone (memorabili, negli anni della
Williams, gli scherzi in Messico a un Nigel Mansell affetto dalla
"maledizione di Montezuma"). Eppure quando questo brasiliano fascinoso e
sorridente, amante della battuta salace, pronto alla polemica più cattiva,
saliva sulla sua vettura, incantava le folle per maestria, intelligenza e
astuzia.  Sulla griglia di partenza era
l'unico pilota di vertice che scherzava con i giornalisti sull'avvenenza
delle donne presenti o che mandava a quel paese con una battuta pepata un
intervistatore per la stupidità delle sue domande e poi, in gara,
velocissimo, intelligente e mai in difficoltà psicologiche, si imponeva
sui rivali. Nelson sembrava un gatto che gioca con il topo. Fu così nel
1981, con un Carlos Reutemann indebolito dalle rivalità interne della
Williams, nel 1983, con un Alain Prost allora impetuoso e alla ricerca del
primo titolo, nel 1987, con un Nigel Mansell come sempre sprecone e
inconcludente. Piquet non ha mai dominato un Campionato mondiale, tutti i
suoi titoli li ha vinti all'ultima gara, dimostrando una notevole tenuta
psicologica. Durante la stagione i suoi rivali si sfogavano, stravincevano
e dominavano, poi, nel corso dell'estate Nelson, che aveva già accumulato
una serie di buoni piazzamenti, segnava i punti a suo favore con vittorie
belle e difficilmente sofferte fino a presentarsi all'ultima gara pronto
per la sfida decisiva. E non l'ha quasi mai persa: l'unica volta che è
successo, nel 1986, è stato perché il suo team, la solita Williams
sprecona, non ha saputo, oh novità, gestire le rivalità interne. Sulla griglia di partenza era
l'unico pilota di vertice che scherzava con i giornalisti sull'avvenenza
delle donne presenti o che mandava a quel paese con una battuta pepata un
intervistatore per la stupidità delle sue domande e poi, in gara,
velocissimo, intelligente e mai in difficoltà psicologiche, si imponeva
sui rivali. Nelson sembrava un gatto che gioca con il topo. Fu così nel
1981, con un Carlos Reutemann indebolito dalle rivalità interne della
Williams, nel 1983, con un Alain Prost allora impetuoso e alla ricerca del
primo titolo, nel 1987, con un Nigel Mansell come sempre sprecone e
inconcludente. Piquet non ha mai dominato un Campionato mondiale, tutti i
suoi titoli li ha vinti all'ultima gara, dimostrando una notevole tenuta
psicologica. Durante la stagione i suoi rivali si sfogavano, stravincevano
e dominavano, poi, nel corso dell'estate Nelson, che aveva già accumulato
una serie di buoni piazzamenti, segnava i punti a suo favore con vittorie
belle e difficilmente sofferte fino a presentarsi all'ultima gara pronto
per la sfida decisiva. E non l'ha quasi mai persa: l'unica volta che è
successo, nel 1986, è stato perché il suo team, la solita Williams
sprecona, non ha saputo, oh novità, gestire le rivalità interne.
Veloce, astuto e intelligente,
queste le sue principali qualità, affinate, nei primi anni di Formula 1,
accanto a Niki Lauda. Anche negli anni dei grandi trionfi Nelson Piquet
ammetteva senza reticenze gli insegnamenti dell'austriaco: "Lui faceva il
suo lavoro, ma io ho avuto la capacità di osservare e di imparare" diceva
sottolineando il suo ruolo attivo. Una differenza con il grande Niki?
Secondo alcuni Piquet era più veloce, secondo Nelson Niki pensava molto più di lui
ai soldi, secondo Niki Nelson era incosciente perché non pensava alla
sicurezza, tema sul quale invece lui, dopo l'incidente del Nuerburgring,
era diventato molto sensibile. Il primo rivale del pilota brasiliano è
stato Alain Prost.  Le sane battaglie tra i due sono
sempre state corrette e oneste, mai una polemica di troppo, neanche
quando, nell'estate del 1983, Alain spedì Nelson sulla sabbia a Zandvoort,
in una manovra azzardata che non avrebbe più ripetuto alcuni anni dopo. Un
incidente di gara, lo definì Nelson, che allora sembrò dove dire addio al
titolo per quel ritiro. Che tempi diversi, però! Il direttore sportivo
della Renault corse alla Brabham per scusarsi dell'errore di Prost e lo
stesso Alain, che fu costretto al ritiro per le conseguenze di
quell'incidente, corsero a scusarsi con il collega. Poi, è cronaca, il
titolo andò a Piquet, in un indimenticabile Gran Premio del Sudafrica.
Subito dopo apparve la stella di Ayrton Senna Da Silva, il giovane
brasiliano predestinato alla vittoria di cui Nelson iniziò a sentire
presto la rivalità in patria. Le punzecchiature e le battute cattive su
Ayrton non si contano. La più terribile, a parte quella sulla presunta
omosessualità di Ayrton, che gli costò il perpetuo rancore del
compatriota, è quella detta subito dopo il passaggio dalla Williams alla
Lotus: "Vado a mettere a posto la macchina che Senna non ha saputo mai
sistemare". Poi la Lotus ha continuato il suo declino mentre Ayrton Senna,
negli stessi anni si aggiudicava due titoli mondiali con la McLaren. Dopo
l'incidente di Imola Nelson è stato ammirevole nella sua coerenza: non
avendo mai amato Ayrton in vita, non è andato, al contrario di molti, al
suo funerale "perché non è opportuno". E in quella mancanza di opportunità
ha avuto rispetto per la prima volta, del talento del rivale. Le sane battaglie tra i due sono
sempre state corrette e oneste, mai una polemica di troppo, neanche
quando, nell'estate del 1983, Alain spedì Nelson sulla sabbia a Zandvoort,
in una manovra azzardata che non avrebbe più ripetuto alcuni anni dopo. Un
incidente di gara, lo definì Nelson, che allora sembrò dove dire addio al
titolo per quel ritiro. Che tempi diversi, però! Il direttore sportivo
della Renault corse alla Brabham per scusarsi dell'errore di Prost e lo
stesso Alain, che fu costretto al ritiro per le conseguenze di
quell'incidente, corsero a scusarsi con il collega. Poi, è cronaca, il
titolo andò a Piquet, in un indimenticabile Gran Premio del Sudafrica.
Subito dopo apparve la stella di Ayrton Senna Da Silva, il giovane
brasiliano predestinato alla vittoria di cui Nelson iniziò a sentire
presto la rivalità in patria. Le punzecchiature e le battute cattive su
Ayrton non si contano. La più terribile, a parte quella sulla presunta
omosessualità di Ayrton, che gli costò il perpetuo rancore del
compatriota, è quella detta subito dopo il passaggio dalla Williams alla
Lotus: "Vado a mettere a posto la macchina che Senna non ha saputo mai
sistemare". Poi la Lotus ha continuato il suo declino mentre Ayrton Senna,
negli stessi anni si aggiudicava due titoli mondiali con la McLaren. Dopo
l'incidente di Imola Nelson è stato ammirevole nella sua coerenza: non
avendo mai amato Ayrton in vita, non è andato, al contrario di molti, al
suo funerale "perché non è opportuno". E in quella mancanza di opportunità
ha avuto rispetto per la prima volta, del talento del rivale.
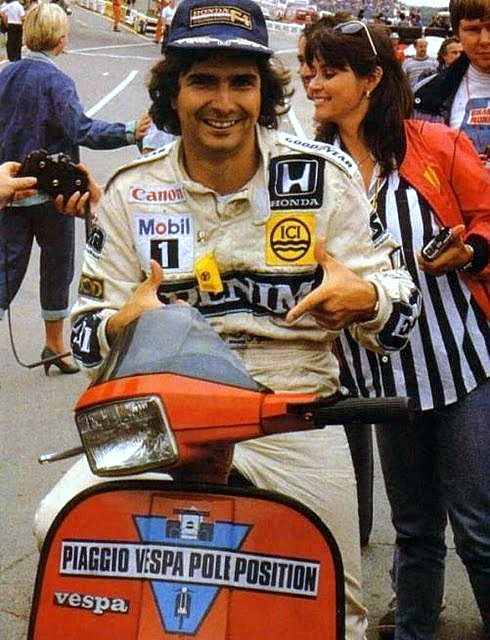 |
|
Canada 1984: singolare scenetta sul
podio dove il vincitore Nelson Piquet sollevò il piede
destro nudo,
fortemente arrossato per le ustioni causate da un nuovo
radiatore dell'olio posto all'interno del musetto della sua Brabham,
non adeguatamente isolato dalla pedaliera.
|
|
L'ultima vera rivalità in Formula 1 è stata
quella che lo ha separato da Nigel Mansell. Negli anni trascorsi alla
Williams il carattere allegro e scherzoso di Nelson divenne più spigoloso
e duro. La difficoltà dei rapporti interni, caratteristica del team
inglese e accentuata in quel periodo dal drammatico incidente che
costrinse Frank Williams su una sedia a rotelle, il timore di veder
favorito il compagno di squadra, da lui considerato meno intelligente, e,
soprattutto, il "tradimento"
 del suo contratto di prima guida da parte
della Williams, innervosirono profondamente Piquet. La perdita del titolo
mondiale 1986, buttato al vento dalla Williams in un rocambolesco Gran
Premio d'Australia, che vide il ritiro di entrambe le vetture e vincitore
del Campionato, a sorpresa, Alain Prost, fu la goccia che fece traboccare
il vaso: il brasiliano decise che non appena fosse stato possibile avrebbe
abbandonato la squadra, lasciando Mansell e Williams al loro irrisolto rapporto. Nel 1987 Nelson
ebbe uno spaventoso incidente a Imola, alla curva del Tamburello, fatale
per il tifo brasiliano. La sagoma della sua vettura rimase per qualche
giorno impressa sul muretto della Tamburello, mentre l'Italia intera
seguiva affettuosamente le vicende del suo campione non ferrarista più
amato. Per precauzione Nelson, che non aveva riportato gravi ferite, fu
tenuto in ospedale e saltò il Gran Premio. Poi, ammise alcuni mesi dopo a
Suzuka, il fantasma di Imola rovinò le sue notti e gli fece cambiare stile
di vita. Nel 1987 un Nelson Piquet ritrovato, ormai conscio della squadra
per la quale correva, si divertì davvero come un gatto astuto con un
topolino fragile e pasticcione. Vinse il Campionato con sole tre vittorie
contro le sei del rivale, ma con un numero di piazzamenti maggiore e una
gestione della stagione più intelligente. Quando a Suzuka Mansell, già in
pole-position, ebbe il pauroso incidente in prova che gli costò il
Mondiale, Nelson non riuscì a nascondere un ghigno un po' diabolico per la
stupidità dell'inglese. E in un liberatorio incontro con i giornalisti si
sfogò finalmente, raccontando delle paure di Imola e difendendo con foga
il suo titolo mondiale. Perché il Campionato lo si vince non nell'ultima
gara, ma durante l'intera stagione, sapendo rinunciare al "piede" quando
serve la "ragione". E lo si perde andandosi a stampare nelle protezoni di
Suzuka quando si hanno in mano Campionato Mondiale e pole-position perché
non si sa usare la "ragione". Dopo Suzuka Nelson del suo contratto di prima guida da parte
della Williams, innervosirono profondamente Piquet. La perdita del titolo
mondiale 1986, buttato al vento dalla Williams in un rocambolesco Gran
Premio d'Australia, che vide il ritiro di entrambe le vetture e vincitore
del Campionato, a sorpresa, Alain Prost, fu la goccia che fece traboccare
il vaso: il brasiliano decise che non appena fosse stato possibile avrebbe
abbandonato la squadra, lasciando Mansell e Williams al loro irrisolto rapporto. Nel 1987 Nelson
ebbe uno spaventoso incidente a Imola, alla curva del Tamburello, fatale
per il tifo brasiliano. La sagoma della sua vettura rimase per qualche
giorno impressa sul muretto della Tamburello, mentre l'Italia intera
seguiva affettuosamente le vicende del suo campione non ferrarista più
amato. Per precauzione Nelson, che non aveva riportato gravi ferite, fu
tenuto in ospedale e saltò il Gran Premio. Poi, ammise alcuni mesi dopo a
Suzuka, il fantasma di Imola rovinò le sue notti e gli fece cambiare stile
di vita. Nel 1987 un Nelson Piquet ritrovato, ormai conscio della squadra
per la quale correva, si divertì davvero come un gatto astuto con un
topolino fragile e pasticcione. Vinse il Campionato con sole tre vittorie
contro le sei del rivale, ma con un numero di piazzamenti maggiore e una
gestione della stagione più intelligente. Quando a Suzuka Mansell, già in
pole-position, ebbe il pauroso incidente in prova che gli costò il
Mondiale, Nelson non riuscì a nascondere un ghigno un po' diabolico per la
stupidità dell'inglese. E in un liberatorio incontro con i giornalisti si
sfogò finalmente, raccontando delle paure di Imola e difendendo con foga
il suo titolo mondiale. Perché il Campionato lo si vince non nell'ultima
gara, ma durante l'intera stagione, sapendo rinunciare al "piede" quando
serve la "ragione". E lo si perde andandosi a stampare nelle protezoni di
Suzuka quando si hanno in mano Campionato Mondiale e pole-position perché
non si sa usare la "ragione". Dopo Suzuka Nelson
 ritrovò il buonumore, il sorriso e l'irriverente voglia
di tirare scherzi. Ha chiuso la carriera alla Benetton, dove avrebbe
dovuto "svezzare" un giovanotto che non ha avuto la sua umiltà
nell'imparare da un maestro, non è illuminato dalla sua allegria ed era
già allora vittima del complesso di superiorità che gli sarebbe costato
poi un paio di titoli mondiali. Michael Schumacher, insomma. E' stato
l'ultimo pilota amatissimo e popolarissimo durante la sua carriera. Perché
questo brasiliano dall'italiano cantilenante sia stato in Italia a volte
più amato dei piloti della Ferrari, perché la stampa inglese non si sia
mai scatenata contro di lui negli anni della feroce rivalità con Mansell,
perché fosse difficile trovare qualcuno che lo detestasse, anche negli
anni dei trionfi, quando era più facile odiarlo, è difficile da spiegare.
Era un uomo, come è già stato detto, come non ce ne sono più in Formula 1
e di cui è bello sentire sempre nostalgia. Ciao Nelson, e che la vita
continui a sorriderti, nel tuo Brasile ritrovato, come in quei fantastici
anni '80 in cui eri il volto sorridente e luminoso della Formula 1. ritrovò il buonumore, il sorriso e l'irriverente voglia
di tirare scherzi. Ha chiuso la carriera alla Benetton, dove avrebbe
dovuto "svezzare" un giovanotto che non ha avuto la sua umiltà
nell'imparare da un maestro, non è illuminato dalla sua allegria ed era
già allora vittima del complesso di superiorità che gli sarebbe costato
poi un paio di titoli mondiali. Michael Schumacher, insomma. E' stato
l'ultimo pilota amatissimo e popolarissimo durante la sua carriera. Perché
questo brasiliano dall'italiano cantilenante sia stato in Italia a volte
più amato dei piloti della Ferrari, perché la stampa inglese non si sia
mai scatenata contro di lui negli anni della feroce rivalità con Mansell,
perché fosse difficile trovare qualcuno che lo detestasse, anche negli
anni dei trionfi, quando era più facile odiarlo, è difficile da spiegare.
Era un uomo, come è già stato detto, come non ce ne sono più in Formula 1
e di cui è bello sentire sempre nostalgia. Ciao Nelson, e che la vita
continui a sorriderti, nel tuo Brasile ritrovato, come in quei fantastici
anni '80 in cui eri il volto sorridente e luminoso della Formula 1.
|
 |
|
|
 voleva diventare un giocatore di calcio invece, ha vinto quattro volte
campionato del mondo di formula 1 ed è stato il pilota con più vittorie in
carriera, 51, fino a quando Michael Schumacher, non gli ha tolto il
primato nel 2001.Questi due dati bastano per inserirlo, senza dubbio,
fra i piloti più grandi di tutti i tempi. voleva diventare un giocatore di calcio invece, ha vinto quattro volte
campionato del mondo di formula 1 ed è stato il pilota con più vittorie in
carriera, 51, fino a quando Michael Schumacher, non gli ha tolto il
primato nel 2001.Questi due dati bastano per inserirlo, senza dubbio,
fra i piloti più grandi di tutti i tempi.
 Alcuni
lo criticavano per il suo modo da "calcolatore" di guidare ma
non è sempre stato così.Nel corso della carriera, il suo stile di
guida è cambiato.Dopo aver dominato in formula due, la McLaren gli
offrì una vettura e debuttò in Argentina nel 1980.La scuderia
inglese era, però, in piena crisi tecnica e gestionale quindi Alain non poté
ottenere quei risultati che molti si aspettavano.A fine stagione decise di
lasciare la squadra. Alcuni
lo criticavano per il suo modo da "calcolatore" di guidare ma
non è sempre stato così.Nel corso della carriera, il suo stile di
guida è cambiato.Dopo aver dominato in formula due, la McLaren gli
offrì una vettura e debuttò in Argentina nel 1980.La scuderia
inglese era, però, in piena crisi tecnica e gestionale quindi Alain non poté
ottenere quei risultati che molti si aspettavano.A fine stagione decise di
lasciare la squadra.
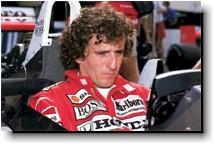 Nel 1981 firmò per la Renault.La scuderia transalpina
aveva l'ambizione di conquistare il primo mondiale con un motore turbo e
con una squadra tutta francese, l'altro pilota era, infatti, René
Arnoux.Quell'anno rischiò di vincere il titolo ma, la poca
affidabilità della vettura ed i dissidi col compagno di squadra, gli
impedirono di raggiungere l'obbiettivo.Accadde la stessa cosa nel 1982 e
nel 1983.Alain lasciò quindi la Renault e tornò alla McLaren che
non era quella del debutto ma aveva un nuovo proprietario, Ron Dennis,
che l'aveva rifondata e resa competitiva.Il suo compagno fu, nel 1984 e
1985, Niki Lauda.Il "ragioniere" diede una svolta alla
carriera di Prost perché, da lui, imparò come si gestisce una gara e,
soprattutto, un campionato.Quell'anno, malgrado sette vittorie
contro quattro dell'austriaco, "riuscì" a perdere il
titolo per solo mezzo punto!! Imparò la lezione e, nel 1985,
vinse il primo titolo bissato l'anno successivo grazie ai piazzamenti ed
alla capacità di gestire la corsa. Nel 1981 firmò per la Renault.La scuderia transalpina
aveva l'ambizione di conquistare il primo mondiale con un motore turbo e
con una squadra tutta francese, l'altro pilota era, infatti, René
Arnoux.Quell'anno rischiò di vincere il titolo ma, la poca
affidabilità della vettura ed i dissidi col compagno di squadra, gli
impedirono di raggiungere l'obbiettivo.Accadde la stessa cosa nel 1982 e
nel 1983.Alain lasciò quindi la Renault e tornò alla McLaren che
non era quella del debutto ma aveva un nuovo proprietario, Ron Dennis,
che l'aveva rifondata e resa competitiva.Il suo compagno fu, nel 1984 e
1985, Niki Lauda.Il "ragioniere" diede una svolta alla
carriera di Prost perché, da lui, imparò come si gestisce una gara e,
soprattutto, un campionato.Quell'anno, malgrado sette vittorie
contro quattro dell'austriaco, "riuscì" a perdere il
titolo per solo mezzo punto!! Imparò la lezione e, nel 1985,
vinse il primo titolo bissato l'anno successivo grazie ai piazzamenti ed
alla capacità di gestire la corsa.
 |
 Nel 1988 e 1989 ebbe come compagno Ayrton Senna, l'astro
nascente della F.1.Fu l'inizio della più grande rivalità mai vista nel
mondo dello sport.L'antipatia era vicendevole.Prost sapeva che Senna era
più forte di lui e Senna sapeva che, per battere Prost, non bastava
essere più veloce di lui.Alain, infatti, grazie alla
"protezione" dell'allora presidente della F.I.A., Balestre,
riuscì a togliere al brasiliano un titolo vinto sul campo.Durante il G.P.
del Giappone 1989, decisivo per il titolo, Senna tenta di superare Prost e
il francese lo butta fuori.Senna riprende la corsa e vince ma, la F.I.A.,
squalifica il brasiliano per "taglio di chicane".Da quel momento
è guerra totale e, l'anno dopo, Senna butterà fuori pista Prost, nel
frattempo passato alla Ferrari, sempre nel G.P. del Giappone,
togliendo al francese la possibilità di lottare per il titolo nell'ultima
gara.Nel 1991 Prost corre ancora con la Ferrari ma la stagione è
fallimentare.Le continue dichiarazioni contro la scuderia e l'incapacità
del francese di sistemare la vettura, fanno si che il rapporto con la
scuderia di Maranello termini due gare prima della fine della stagione.Nel 1992, Alain Prost,
non corre, torna nel 1993 col team Williams e vince il suo quarto
titolo.Alla fine della stagione si ritirerà definitivamente perchè
riteneva che le vetture fossero troppo pericolose.I fatti del 1994
gli diedero, purtroppo, ragione.Nel 1997 rileva il team Ligier e lo
ribattezza Prost grand prix. Nel 1988 e 1989 ebbe come compagno Ayrton Senna, l'astro
nascente della F.1.Fu l'inizio della più grande rivalità mai vista nel
mondo dello sport.L'antipatia era vicendevole.Prost sapeva che Senna era
più forte di lui e Senna sapeva che, per battere Prost, non bastava
essere più veloce di lui.Alain, infatti, grazie alla
"protezione" dell'allora presidente della F.I.A., Balestre,
riuscì a togliere al brasiliano un titolo vinto sul campo.Durante il G.P.
del Giappone 1989, decisivo per il titolo, Senna tenta di superare Prost e
il francese lo butta fuori.Senna riprende la corsa e vince ma, la F.I.A.,
squalifica il brasiliano per "taglio di chicane".Da quel momento
è guerra totale e, l'anno dopo, Senna butterà fuori pista Prost, nel
frattempo passato alla Ferrari, sempre nel G.P. del Giappone,
togliendo al francese la possibilità di lottare per il titolo nell'ultima
gara.Nel 1991 Prost corre ancora con la Ferrari ma la stagione è
fallimentare.Le continue dichiarazioni contro la scuderia e l'incapacità
del francese di sistemare la vettura, fanno si che il rapporto con la
scuderia di Maranello termini due gare prima della fine della stagione.Nel 1992, Alain Prost,
non corre, torna nel 1993 col team Williams e vince il suo quarto
titolo.Alla fine della stagione si ritirerà definitivamente perchè
riteneva che le vetture fossero troppo pericolose.I fatti del 1994
gli diedero, purtroppo, ragione.Nel 1997 rileva il team Ligier e lo
ribattezza Prost grand prix.
|
|

|
 Nasce in Germania nel 1942 da genitori a Nasce in Germania nel 1942 da genitori a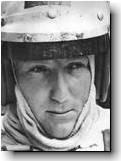 ustriaci e tedeschi che morirono durante
un bombardamento nel 1943.Visse a Graz, in Austria, con i nonni.La
passione per le corse, iniziò nel 1962. Gareggiò con una non
competitiva Formula Junior Cooper nel 1963 e fu molto sorpreso
quando la Ford gli propose di guidare una Brabham - Cosworth F.2
nel 1964.Si fece notare in due gare, a Mallory Park, dove
giunse secondo, e a Crystal Palace, dove vinse.Per questi
risultati, la Cooper gli chiese di affiancare Bruce McLaren nel
campionato di F.1 del 1965. ustriaci e tedeschi che morirono durante
un bombardamento nel 1943.Visse a Graz, in Austria, con i nonni.La
passione per le corse, iniziò nel 1962. Gareggiò con una non
competitiva Formula Junior Cooper nel 1963 e fu molto sorpreso
quando la Ford gli propose di guidare una Brabham - Cosworth F.2
nel 1964.Si fece notare in due gare, a Mallory Park, dove
giunse secondo, e a Crystal Palace, dove vinse.Per questi
risultati, la Cooper gli chiese di affiancare Bruce McLaren nel
campionato di F.1 del 1965.
 Le Cooper non erano competitive
quell'anno e gli consentirono solo un quarto e un sesto posto nei G.P. di Germania
e U.S.A..Lo stile di Rindt era particolare, apparentemente
remissivo ma, in realtà, veloce e redditizio.Corse la 1000 Km del
Nuerburgring con una Porsche in coppia con Bonnier e finì terzo,
vince la 24 ore di Le Mans, corre nel campionato NART con una Ferrari
insieme a Masten Gregory, infine con la Ford.Continua anche a correre in
F.2 ed ottiene ottimi risultati tanto da diventare un eroe nazionale. Le Cooper non erano competitive
quell'anno e gli consentirono solo un quarto e un sesto posto nei G.P. di Germania
e U.S.A..Lo stile di Rindt era particolare, apparentemente
remissivo ma, in realtà, veloce e redditizio.Corse la 1000 Km del
Nuerburgring con una Porsche in coppia con Bonnier e finì terzo,
vince la 24 ore di Le Mans, corre nel campionato NART con una Ferrari
insieme a Masten Gregory, infine con la Ford.Continua anche a correre in
F.2 ed ottiene ottimi risultati tanto da diventare un eroe nazionale.
Le stagioni in F.1 con la Cooper furono deludenti a causa della scarsa
competitività della vettura.Le soddisfazioni arrivano dalla F.2.nel 1967
vinse nove gare.Ebbe anche un pauroso incidente nel tentativo di
qualificare una Eagle ad Indianapolis.
 Nel 1968, Jochen, divenne il numero due
alla Brabham Repco V-8, ormai giunta alla fine della sua la vita competitiva.Sembrava
che Rindt, sbagliasse sempre vettura e molti si chiedevano se mai avrebbe
vinto un G.P..Fra questi c'era Denis Jenkinson, giornalista celebre, che dichiarò
che, se Rindt avesse vinto un Gran Premio, si sarebbe tagliato la sua
celebre barba.Jenkinson avrebbe dovuto onorare presto il suo impegno. Nel 1968, Jochen, divenne il numero due
alla Brabham Repco V-8, ormai giunta alla fine della sua la vita competitiva.Sembrava
che Rindt, sbagliasse sempre vettura e molti si chiedevano se mai avrebbe
vinto un G.P..Fra questi c'era Denis Jenkinson, giornalista celebre, che dichiarò
che, se Rindt avesse vinto un Gran Premio, si sarebbe tagliato la sua
celebre barba.Jenkinson avrebbe dovuto onorare presto il suo impegno.
Alla fine dell'anno Rindt firma col team Lotus e,come compagno, ha
Graham Hill. Il suo primo anno fu segnato per un brutto incidente durante
il G.P. di Spagna.Ne uscì con una mascella rotta e una commozione
celebrale.Fortunatamente si ristabilisce presto, ma risente di qualche
problema alla vista e all'equilibrio per qualche tempo.A Watkins Glen Rindt
vince il suo primo G.P. e Jenkinson, si taglia la barba!!. La felicità
venne guastata dal grave incidente occorso a G. Hill che si frattura le
gambe.

Jochen Rindt con la moglie Nina a Monza
|
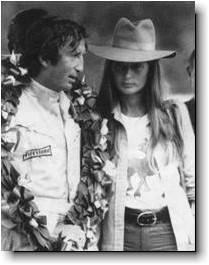 Nel 1970
è il pilota di punta della Lotus che progetta la rivoluzionaria e, in
seguito, leggendaria "72".Non viene però utilizzata
nelle prime gare ma anche il modello 49c, risulta competitivo e consente a
Rindt di conquistare una vittoria a Monaco dopo una rimonta leggendaria
ai danni del "vecchio" Brabham.Una gara fantastica con sorpasso
all'ultimo giro.Il nuovo modello debutta in Olanda e consente a Rindt di
vincere altre quattro gare e di ipotecare il titolo mondiale.Durante
il G.P. d'Olanda, muore il suo Amico Courage e molti sono convinti
che si ritirerà a fine stagione.Arriva al G.P. d'Italia con un
consistente vantaggio in classifica e voleva chiudere il campionato
proprio in questa gara.Durante le qualificazioni del Sabato, la
Lotus 72 impazzisce alla fine del lungo rettilineo prima della
parabolica.La vettura si disintegra contro il guard-rail e Jochen muore
sul colpo. Nel 1970
è il pilota di punta della Lotus che progetta la rivoluzionaria e, in
seguito, leggendaria "72".Non viene però utilizzata
nelle prime gare ma anche il modello 49c, risulta competitivo e consente a
Rindt di conquistare una vittoria a Monaco dopo una rimonta leggendaria
ai danni del "vecchio" Brabham.Una gara fantastica con sorpasso
all'ultimo giro.Il nuovo modello debutta in Olanda e consente a Rindt di
vincere altre quattro gare e di ipotecare il titolo mondiale.Durante
il G.P. d'Olanda, muore il suo Amico Courage e molti sono convinti
che si ritirerà a fine stagione.Arriva al G.P. d'Italia con un
consistente vantaggio in classifica e voleva chiudere il campionato
proprio in questa gara.Durante le qualificazioni del Sabato, la
Lotus 72 impazzisce alla fine del lungo rettilineo prima della
parabolica.La vettura si disintegra contro il guard-rail e Jochen muore
sul colpo.
La perdita di Jochen, alla vigilia della conquista del titolo,
sconvolse il mondo delle corse.Jacky Ickx aveva ancora la
possibilità di superare i punti totali di Rindt ma la vittoria di Emerson Fittipaldi,
su Lotus 72, al G.P. di U.S.A., assicurò il titolo allo sfortunato pilota
austriaco.Karl Jochen Rindt diventa campione mondiale postumo.
|
|

|
Il ritorno in Formula 1.
Il 29 luglio 2009, in seguito all'infortunio di Massa
durante le qualificazioni del Gran Premio d'Ungheria, la Ferrari
annunciò il ritorno alle corse in Formula 1 di Schumacher. Sarebbe stato
il tedesco a correre per le restanti gare della stagione 2009, a
partire dal Gran Premio d'Europa a Valencia, al fianco di Räikkönen.
L'11 agosto, tuttavia, Schumacher (dopo alcuni test effettuati in pista)
comunicò di dover rinunciare a disputare le restanti gare della
stagione con il team di Maranello a causa di alcuni problemi al collo
risalenti
ad un incidente in moto avvenuto sei mesi prima.
A fine stagione si susseguirono una serie di rumors circa un incontro tra lo stesso Schumacher e
Ross Brawn (proprietario della Brawn GP, team
neo-campione del mondo) che avevano vissuto insieme le esperienze in
Benetton e Ferrari nel quale si parlò di un possibile ritorno del sette
volte campione del mondo, al volante della Mercedes.
Il 29 dicembre 2009 il clamoroso annuncio.
La decisione di tornare si rivela infelice e senza soddisfazioni,
perdendo il confronto col compagno di squadra Nico Rosberg e
conquistando solo un podio.
Alla fine del 2012 viene "costretto" al ritiro definitivo per far posto
a Lewis Hamilton.
A fine carriera i record da
registrare sono tanti.
7 titoli mondiali, 5 consecutivi, 91 vittorie, 68 pole,
77 giri veloci, 155 podii, 1488 i punti totali,
148
punti in un'unica stagione, 22 le
triplette (pole, miglior giro e vittoria), 13 vittorie in una
stagione, 17 podii in un
campionato.
Tra i record più invidiati anche quello dei guadagni. Il ferrarista è
stato in testa alla classifica dei 'paperoni' dello sport con 100
milioni di euro all'anno. Cifre di fronte alle quale impallidiscono
perfino le stelle del calcio.
In diciotto anni di carriera Michael Schumacher ha
dimostrato di essere all'altezza dei più grandi piloti del passato, i
suoi record saranno l'obbiettivo delle generazioni future di piloti.
Come tutti i
grandi campioni aveva i suoi difetti ma indubbiamente è stato il pilota che meglio ha
saputo interpretare la formula 1 moderna fatta di elettronica e strategie
di gara.Alla fine della carriera gli rimarra comunque la nostalgia di non
aver potuto misurarsi fino in fondo con lil grande Senna ma, in ogni caso, è
stato l'emblema
del cambiamento che la formula 1 ha avuto in quegli anni.
|
|

|
|

partecipò, tra il 1965 e il 1973, a 99 Gran Premi di Formula 1, partì 17
volte in pole position, vinse 27 gare e divenne tre volte Campione del
Mondo: nel 1969 su MatraFord, nel 1971 e nel 1973 su
Tyrrell-Ford.
 Nato nel 1939 in Scozia, a Durnbuck, fece il benzinaio
nel garage di suo padre, e divenne tecnico specializzato in motori
frequentando corsi serali. Vinse quattro campionati di tiro al piattello.
Nel 1961 partecipò alla sua prima gara con una vettura sportiva Marcos.
Nel 1962 si ritirò dal tiro al piattello, nel 1963, uscito di casa alla
chetichella, corse con lo pseudonimo "A. N. Other” per la scuderia
scozzese Ecurie-Ecosse. Nato nel 1939 in Scozia, a Durnbuck, fece il benzinaio
nel garage di suo padre, e divenne tecnico specializzato in motori
frequentando corsi serali. Vinse quattro campionati di tiro al piattello.
Nel 1961 partecipò alla sua prima gara con una vettura sportiva Marcos.
Nel 1962 si ritirò dal tiro al piattello, nel 1963, uscito di casa alla
chetichella, corse con lo pseudonimo "A. N. Other” per la scuderia
scozzese Ecurie-Ecosse.
Nella maggior parte dei casi vinceva. Quando Ken
Tyrrell gli offrì un posto in Formula 3, rifiutò un contratto quinquennale
di 3.000 sterline, stipulando, con una stretta di mano, un contratto
annuale. Nel 1964 vinse 12 gare su 53. Nel 1965, passato con la BRM in
Formula 1, vinse il suo primo Gran Premio, a Monza.
|
 |
 |
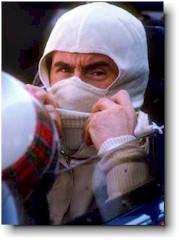 |
|
Nel 1966 a Spa un
acquazzone lo spazzò via dalla pista. Rimase incastrato nel cockpit della
BRM: i serbatoi scoppiarono. Graham hill, anche lui sul bordo della pista,
lo liberò da quella situazione.La frattura alla
clavicola guarì più rapidamente dei ricordi. Il risultato fu uno Stewart
più maturo che, divenuto ancora più veloce grazie all’autocritica,
intraprese una crociata per una maggiore sicurezza nello sport
automobilistico.
Per Stewart l’amico Jochen Rindt non solo era
l’avversario più duro, ma anche un compagno di lotta per la sicurezza.
Stewart dichiarò al Nurhurgring: "Cos’è cambiato qui dai tempi di
Caracciola? Niente, solo gli alberi sono diventati più fitti. Spariamo gli
uomini sulla luna e li riportiamo a casa sani e salvi. Perché i piloti
devono morire subito?”.
Subito dopo l’incidente mortale di Rindt, nel
1970 a Monza, Jackie corse il suo giro di prova più veloce: “Ken Tyrrell
mi disse: escine subito, ed aveva ragione. Al rientro da quel giro,
qualcuno mi diede una bottiglia di Coca Cola, la scagliai contro un muro e
mi fu chiaro come tutto quanto non avesse alcun senso... Stewart fu il
primo pilota che si fece commercializzare dall’agenzia di professionisti
McCormack. Si ritirò nel 1973. Tornò in Formula 1 nel 1997 con una propria
scuderia
|
|
|

|

|
 |
|
Gilles Villeneuve nasce in Quebec il 18 gennaio 1950. Cresce tra gare
di Formula Atlantic e di motoslitta. Lui stesso accredita parte del suo
successo a queste gare: "Ogni inverno potevi contare tranquillamente
su tre o quattro ribaltamenti - e sto parlando di correre sul ghiaccio a
circa 160 kmh. Le gare su queste slitte volanti mi hanno dato una
grandissima esperienza nel controllo della vettura. E la visibilità era
terribile! A meno che tu non fossi primo, non riuscivi a vedere nulla a
causa di tutta la neve che sollevava chi ti precedeva. E’ stata
un’ottima esperienza per velocizzare i miei tempi di reazione; inoltre
nelle gare sotto la pioggia riesco a guidare in maniera abbastanza
tranquilla". Nel 1976 domina il campionato di Formula Atlantic con un
team canadese così povero che è costretto a seguire la gara di Mosport
da semplice spettatore. Ma le sue impressionanti prestazioni gli
forniscono una certa fama ed un posto alla McLaren. La sua prima gara in
Formula 1 (che coincide con il debutto del motore Renault turbo) è a
Silverstone nel 1977 come compagno di James Hunt e Jochen Mass.
La sua prestazione in prova è imoressionante e si qualifica decimo con
una vettura vecchia di due anni.
La cosa non sfuggì ad Enzo Ferrari che, dopo l'abbandono di Lauda,
lo chiama per per correre le ultime due gare della stagione.
Enzo
Ferrari disse che quando incontrò per la prima volta il piccolo
canadese, questi gli ricordò immediatamente il grande Nuvolari.
L’ovvio interesse di Ferrari per Villeneuve fa si che Gilles inizi la
 sua corta ma mirabolante carriera in Ferrari. Nella gara di Mosport deve
lasciare la corsa a causa di una perdita di olio. La gara successiva, al
Fuji, lo vede nuovamente fuori, ma questa volta in modo più drammatico, a
causa dell’investimento di alcuni spettatori.
sua corta ma mirabolante carriera in Ferrari. Nella gara di Mosport deve
lasciare la corsa a causa di una perdita di olio. La gara successiva, al
Fuji, lo vede nuovamente fuori, ma questa volta in modo più drammatico, a
causa dell’investimento di alcuni spettatori.
Nonostante questi insuccessi, dichiara che "Se qualcuno mi dicesse
che ho tre desideri, il primo sarebbe quello di poter correre, il secondo
di essere in Formula 1 ed il terzo di guidare per la Ferrari...." La
prima delle sei vittorie di Villeneuve arriva l’anno successivo, ed in
modo molto combattuto, in Canada.
A proposito di vittorie, tutti dicono che ha vinto solo sei Gran Premi.
Occorre però ricordare che 1979 arriva secondo nel Campionato del Mondo
dietro al suo compagno di squadra Jody Scheckter, per il quale oggi c’è
meno considerazione di quanta se ne abbia per Gilles. Aiutò Jody a
conquistare il titolo con la promessa che l'anno successivo sarebbe
stato lui a vincere.La qualità delle
macchine guidate da Villeneuve, però, è sempre stata scadente. Il suo
modo di guidare non teneva in nessun conto la conservazione della vettura,
altro particolare che ha contribuito alla scarsità di vittorie. Era difficile vedere una gara
nella quale non faceva letteralmente decollare la sua Ferrari. Ma la gara
che porta Gilles nella leggenda, è il Gran Premio di Francia del 1979 a
Digione, la Renault e Jean-Pierre
Jabouille segnano la prima vittoria con una moderna macchina turbo. A Rene
Arnoux basta non fare errori per poter arrivare al secondo
posto e fare una doppietta Renault.
 Ma
Villeneuve si fa valere ingaggiando
un duello a colpi di pneumatici, derappate e sgommate con Arnoux che non
è facile da dimenticare. La folle insistenza di Villeneuve, che la sua
meno potente Ferrari vuole a tutti i costi battere la più veloce Renault
di Arnoux, viene ricompensata e finisce la gara davanti al francese. Si può
sicuramente dire che questa fu la battaglia per la seconda posizione più
eccitante nella storia della Formula 1. Come certi altri grandi piloti, e
citiamo solo due dei più grandi, Clark
e Senna,
Villeneuve aveva due personalità completamente opposte. Lauda
scrisse di lui "E’ stato il più pazzo diavolo che io abbia mai
incontrato in Formula 1... la cosa strana è che, sceso dalla vettura,
aveva un carattere amabile e sensibile; ma quando si infilava il casco
diventava tutt’altra persona.". E' stato un temerario di enormi proporzioni. Tuttavia sulla pista era scrupolosamente corretto e
non faceva mai nulla per mettere in pericolo la sicurezza di qualcun
altro. Questa combinazione di caratteristiche lo fanno diventare
estremamente popolare e benvoluto non solo dai fans ma anche dai suoi
avversari. Rimane tuttora uno dei piloti più amati in Canada, in Italia e
nel resto del mondo della Formula 1. La rottura dell’amicizia con il suo
migliore amico può aver contribuito alla sua tragica e prematura
scomparsa. Nel giro finale del Gran Premio di Imola del 1982, che domina
fin dal principio, rallenta sapendo di avere ormai la gara in pugno. Ma
viene inaspettatamente sorpassato a tradimento dal suo compagno di squadra
Pironi
il quale gli ruba letteralmente la vittoria. Villeneuve è
furioso nonostante il suo carattere pacato. Con la ferita che brucia
ancora si presenta, due settimane più tardi, al Gran Premio di Zolder. Ma
Villeneuve si fa valere ingaggiando
un duello a colpi di pneumatici, derappate e sgommate con Arnoux che non
è facile da dimenticare. La folle insistenza di Villeneuve, che la sua
meno potente Ferrari vuole a tutti i costi battere la più veloce Renault
di Arnoux, viene ricompensata e finisce la gara davanti al francese. Si può
sicuramente dire che questa fu la battaglia per la seconda posizione più
eccitante nella storia della Formula 1. Come certi altri grandi piloti, e
citiamo solo due dei più grandi, Clark
e Senna,
Villeneuve aveva due personalità completamente opposte. Lauda
scrisse di lui "E’ stato il più pazzo diavolo che io abbia mai
incontrato in Formula 1... la cosa strana è che, sceso dalla vettura,
aveva un carattere amabile e sensibile; ma quando si infilava il casco
diventava tutt’altra persona.". E' stato un temerario di enormi proporzioni. Tuttavia sulla pista era scrupolosamente corretto e
non faceva mai nulla per mettere in pericolo la sicurezza di qualcun
altro. Questa combinazione di caratteristiche lo fanno diventare
estremamente popolare e benvoluto non solo dai fans ma anche dai suoi
avversari. Rimane tuttora uno dei piloti più amati in Canada, in Italia e
nel resto del mondo della Formula 1. La rottura dell’amicizia con il suo
migliore amico può aver contribuito alla sua tragica e prematura
scomparsa. Nel giro finale del Gran Premio di Imola del 1982, che domina
fin dal principio, rallenta sapendo di avere ormai la gara in pugno. Ma
viene inaspettatamente sorpassato a tradimento dal suo compagno di squadra
Pironi
il quale gli ruba letteralmente la vittoria. Villeneuve è
furioso nonostante il suo carattere pacato. Con la ferita che brucia
ancora si presenta, due settimane più tardi, al Gran Premio di Zolder.
|
 |
Jacques segue l'intervista che viene fatta al padre Gilles Villeneuve
Durante le qualifiche del sabato, mentre fa il giro veloce,
arriva dietro la più lenta March pilotata da Mass. Gilles
tenta il tutto per tutto sperando she Mass si sposti ma non sarà
così. L'impatto fra le due ruote, fà letteralmente decollare la Ferrari
che si disintegra, scagliando il pilota canadese contro le reti di
protezione. La sfortuna vuole che il pilota Ferrari vada a
colpire il palo tra una rete e l’altra. Villeneuve viene soccorso subito
ma le sue ferite risultano mortali. Muore nell’ospedale locale la sera
stessa. La sua morte ha lasciato una profondissima tristezza che aleggia
tuttora nel mondo delle corse. Anche Arnoux, il suo avversario nello
scontro epico di Digione ed in molte altre occasioni, ha confessato di
aver pianto il giorno in cui Gilles è morto.
Quell'anno suo figlio Jacques aveva undici anni e, nel 1997
coglierà quella vittoria che solo il destino negò al padre.
Oltre al
duello di Digione, di Gilles si ricorderà per sempre, il giro su tre
ruote a Zandvoort, le vittorie mitiche del 1981 con la
prima Ferrari con motore turbo, a Monaco ed in Spagna dove tiene
testa per tutta la gara a cinque vetture, più veloci della sua, che lo
seguono in fila indiana. Queste e tante altre imprese hanno dato vita a
quella che era chiamata "febbre Villeneuve". Nessuno
riuscirà più a dare simili emozioni. |
 |
|
 |
Gilles Villeneuve stato il pilota
più
popolare che la Ferrari non abbia mai avuto rischiando di offuscarne
il mito.Il suo unico scopo era di andare
il più veloce possibile col mezzo a disposizione e, spesso, anche più del possibile.Questo
mandava in visibilio le folle e si era meritato
il soprannome di
"Aviatore", soprannome confermato anche dal suo ultimo
tragico e spettacolare volo.
|
JAMES HUNT

Il pilota inglese famoso non solo per le sue doti di guida nel circus
iridato…ma anche per il suo modo di vivere fuori dalle piste…attorniato
da belle ragazze, ma purtroppo anche da alcool e troppo fumo,
specialmente dopo il suo ritiro dalle corse.
|

Suzy Miller, la moglie di Hunt
|
|
Il Gran Premio del Giappone 1976
è stata la sedicesima, e ultima, prova della stagione 1976 del
Campionato mondiale di Formula 1. Si è corsa domenica 24 ottobre
1976 sul Circuito del Fuji. La gara è stata vinta dallo
statunitense Mario Andretti su Lotus-Ford Cosworth; per il vincitore
si trattò del secondo successo nel mondiale. Ha preceduto sul
traguardo il francese Patrick Depailler su Tyrrell-Ford Cosworth
e il britannico James Hunt su McLaren-Ford Cosworth.
Grazie al terzo posto James Hunt si aggiudicò il suo primo, e
unico, campionato del mondo piloti di F1 con un solo punto di scarto su
Niki Lauda, che si ritirò dalla gara per le cattive condizioni
atmosferiche, che avevano messo inizialmente in dubbio la stessa tenuta
della gara.
|
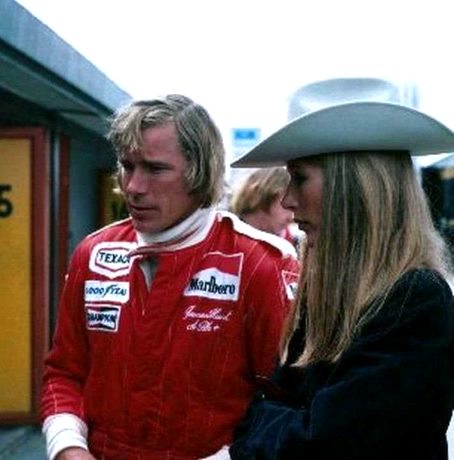 |
 |
| James Hunt - Nina Rindt 1976 |
James Hunt GP Monaco 1976 |
|
James non è rimasto molto
nel circus della F1 ma ha lasciato un solco indelebile nel cuore dei
tifosi. Campione del mondo nel 1976,
anno del terribile incidente di
Lauda in Germania, James ha mosso i primi passi in F1 alla guida della
Hesket…Hesket che porterà
alla vittoria (la sua prima) nel 1975 in
Olanda. James si ritirò dopo Monaco 1979 mentre guidava per il team
Wolf, ma seguì sempre
la f1 come commentatore per la Tv inglese BBC,
fedele spalla del grande Murray Walker dal 1980. Dopo Montecarlo James
disse:
“Lascio ora e definitivamente perché – nel mondo della F1 –
l’uomo non conta più!”
Fu trovato morto a soli 45 anni per arresto
cardiaco nella sua casa il 15 giugno 1993. |
|
|
FORMULA 1
Albo d'Oro Campionato Mondiale Piloti
|
ANNO
|
VINCITORE
|
PILOTA
|
PAESE
|
ALBO D'ORO
|
|
CAMPIONATO MONDIALE COSTRUTTORI
Il titolo è stato messo in palio dal 1958 |
MOTORE |
PILOTI |
|
1950
|
Giuseppe Farina
|

|

|

|
|
|
|
|
|
1951
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|

|
|
|
|
|
|
1952
|
Alberto Ascari
|

|

|

|
|
|
|
|
|
1953
|
Alberto Ascari
|

|

|
 
|
|
|
|
|
|
1954
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|
 
|
|
|
|
|
|
1955
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|
  
|
|
|
|
|
|
1956
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|
   
|
|
|
|
|
|
1957
|
Juan Manuel Fangio
|

|

|
    
|
|
|
|
|
|
1958
|
Mike Hawthorn
|

|

|

|
|
 Vanwall Vanwall
VW5 |
Vanwall |
Stirling Moss
Tony Brooks |
|
1959
|
Jack Brabham
|

|

|

|
|
 Cooper Cooper
T43 |
Climax |
Jack Brabham
Stirling Moss
Bruce McLaren |
|
|
|
|
1960
|
Jack Brabham
|

|

|
 
|
CAMPIONATO MONDIALE COSTRUTTORI
 Cooper
T43
|
MOTORI
Climax
|
|
1961
|
Phil Hill
|

|

|

|
 Ferrari Ferrari
158 F1 |
Ferrari |
|
1962
|
Graham Hill
|

|

|

|
 BRM BRM
P57 |
BRM |
|
1963
|
Jim Clark
|

|

|

|
 Lotus Lotus
25 |
Climax |
|
1964
|
John Surtees
|

|

|

|
 Ferrari Ferrari
158 F1 |
Ferrari |
|
1965
|
Jim Clark
|

|

|
 
|
 Lotus Lotus
33 |
Climax |
|
1966
|
Jack Brabham
|

|

|
  
|
 Brabham Brabham
BT20 |
Repco |
|
1967
|
Denny Hulme
|

|

|

|
 Brabham Brabham
BT24 |
Repco |
|
1968
|
Graham Hill
|

|

|
 
|
 Lotus Lotus
49B |
Ford |
|
1969
|
Jackie Stewart
|

|

|

|
 Matra Matra
MS84 |
|
|
|
1970
|
Jochen Rindt
|

|

|

|
CAMPIONATO MONDIALE COSTRUTTORI
 Lotus
72C
|
MOTORI
Ford |
|
1971
|
Jackie Stewart
|

|

|
 
|
 Tyrrell Tyrrell
003
7 |
Ford |
|
1972
|
Emerson Fittipaldi
|

|

|

|
 Lotus Lotus
72D |
Ford |
|
1973
|
Jackie Stewart
|

|

|
  
|
 Lotus Lotus
72E |
Ford |
|
1974
|
Emerson Fittipaldi
|

|

|
 
|
 McLaren McLaren
M23 |
Ford |
|
1975
|
Niki Lauda
|

|

|

|
 Ferrari Ferrari
312 T |
Ferrari |
|
1976
|
James Hunt
|

|

|

|
 Ferrari Ferrari
312 T2 |
Ferrari |
|
1977
|
Niki Lauda
|

|

|
 
|
 Ferrari Ferrari
312 T2 |
Ferrari |
|
1978
|
Mario Andretti
|

|

|

|
 Lotus Lotus
79 |
Ford |
|
1979
|
Jody Scheckter
|

|

|

|
 Ferrari Ferrari
312 T4 |
Ferrari |
|
|
|
|
1980
|
Alan Jones
|

|

|

|
CAMPIONATO MONDIALE COSTRUTTORI
 Williams
FW07B
|
MOTORI
Ford
|
|
1981
|
Nelson Piquet
|

|

|

|
 Williams Williams
FW07C |
Ford |
|
1982
|
Keke Rosberg
|

|

|

|
 Ferrari Ferrari
126 C2 |
Ferrari |
|
1983
|
Nelson Piquet
|

|

|
 
|
 Ferrari Ferrari
126 C3 |
Ferrari |
|
1984
|
Niki Lauda
|

|

|
  
|
 McLaren McLaren
MP4/2 |
TAG Porsche |
|
1985
|
Alain Prost
|

|

|

|
 McLaren McLaren
MP4/2B |
TAG Porsche |
|
1986
|
Alain Prost
|

|

|
 
|
 Williams Williams
FW11 |
Honda |
|
1987
|
Nelson Piquet
|

|

|
  
|
 Williams Williams
FW11B |
Honda |
|
1988
|
Ayrton Senna
|

|

|

|
 McLaren McLaren
MP4/4 |
Honda |
|
1989
|
Alain Prost
|

|

|
  
|
 McLaren McLaren
MP4/5 |
Honda |
|
|
|
|
1990
|
Ayrton Senna
|

|

|
 
|
CAMPIONATO MONDIALE COSTRUTTORI
 McLaren
MP4/5B
|
MOTORI
Honda
|
|
1991
|
Ayrton Senna
|

|

|
  
|
 McLaren McLaren
MP4/6 |
Honda |
|
1992
|
Nigel Mansell
|

|

|

|
 Williams Williams
FW14B |
Renault |
|
1993
|
Alain Prost
|

|

|
   
|
 Williams Williams
FW15C |
Renault |
|
1994
|
Michael Schumacher
|

|

|

|
 Williams Williams
FW16 |
Renault |
|
1995
|
Michael Schumacher
|

|

|
 
|
 Benetton Benetton
B195 |
Renault |
|
1996
|
Damon Hill
|

|

|

|
 Williams Williams
FW18 |
Renault |
|
1997
|
Jacques Villeneuve
|

|

|

|
 Williams Williams
FW19 |
Renault |
|
1998
|
Mika Hakkinen
|

|

|

|
 McLaren McLaren
MP4/13 |
Mercedes |
|
1999
|
Mika Hakkinen
|

|

|
 
|
 Ferrari Ferrari
F399 |
Ferrari |
|
|
Sito Blog personale - Riproduzione vietata

|






















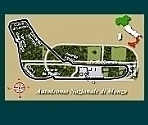
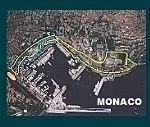

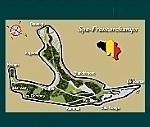



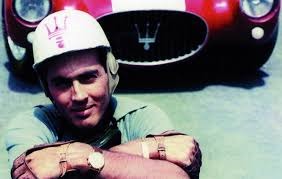





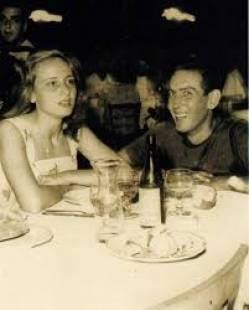
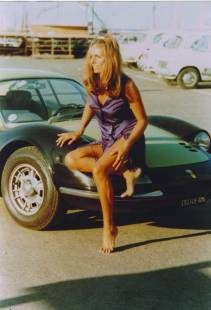









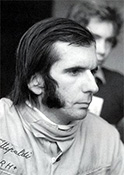





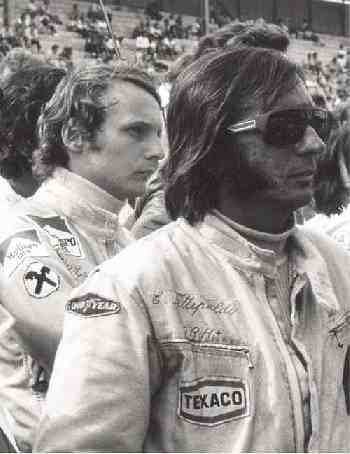
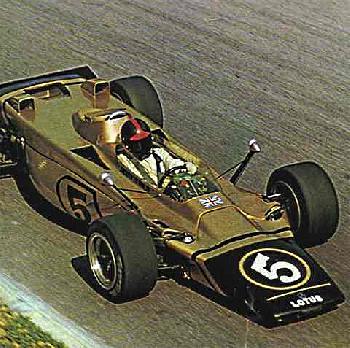




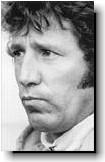 Decidono quindi di andarsene e passano diversi anni in un campo di profughi in
Toscana. Nel 1954 l’interesse di Mario alle gare di velocità lo porta a Monza
dove vede il grande Ascari competere nel Gran Premio d’Italia. L’anno successivo
emigra insieme con la famiglia negli Stati Uniti e trovano casa a Nazareth in
Pennsylvania.
Decidono quindi di andarsene e passano diversi anni in un campo di profughi in
Toscana. Nel 1954 l’interesse di Mario alle gare di velocità lo porta a Monza
dove vede il grande Ascari competere nel Gran Premio d’Italia. L’anno successivo
emigra insieme con la famiglia negli Stati Uniti e trovano casa a Nazareth in
Pennsylvania.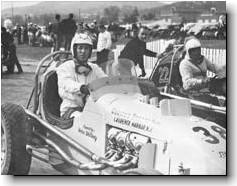
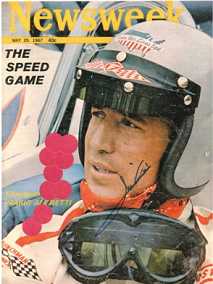





 Si sarebbe potuto scommettere che, entro il
1976, Andretti sarebbe stato destinato a fare grandi cose in Formula 1 e,
considerando l’estrema velocità di questo pilota, sarebbe diventato il cavallino
rampante di Maranello. Tuttavia questa previsione non si sarebbe mai avverata.
Lascia la Ferrari al termine della stagione del 1972 e per due anni corre con
l’ormai dimenticata scuderia Parnelli fino al suo scioglimento nel 1976 (salta
la stagione 1973 per concentrarsi sul campionato USAC). In quell’anno ritorna
alla Lotus che gli offre un’ulteriore possibilità in Formula 1. L’accordo tra
Andretti e Colin Chapman è un dono del cielo per entrambi, per Andretti che si
ritrova con la famosa Lotus 79 "effetto suolo" che gli consentirà di vincere il
Campionato del 1978, e per Chapman che ha bisogno di un pilota di esperienza e
con grinta per studiare e sfruttare a fondo la vettura.
Si sarebbe potuto scommettere che, entro il
1976, Andretti sarebbe stato destinato a fare grandi cose in Formula 1 e,
considerando l’estrema velocità di questo pilota, sarebbe diventato il cavallino
rampante di Maranello. Tuttavia questa previsione non si sarebbe mai avverata.
Lascia la Ferrari al termine della stagione del 1972 e per due anni corre con
l’ormai dimenticata scuderia Parnelli fino al suo scioglimento nel 1976 (salta
la stagione 1973 per concentrarsi sul campionato USAC). In quell’anno ritorna
alla Lotus che gli offre un’ulteriore possibilità in Formula 1. L’accordo tra
Andretti e Colin Chapman è un dono del cielo per entrambi, per Andretti che si
ritrova con la famosa Lotus 79 "effetto suolo" che gli consentirà di vincere il
Campionato del 1978, e per Chapman che ha bisogno di un pilota di esperienza e
con grinta per studiare e sfruttare a fondo la vettura.

 Guidare vetture da corsa a prestazioni
elevate richiede uno sforzo fisico e psicologico non indifferente.
Guidare vetture da corsa a prestazioni
elevate richiede uno sforzo fisico e psicologico non indifferente.


 da sinistra Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Mike Hawthorn e Luigi Villoresi
da sinistra Giuseppe Farina, Alberto Ascari, Mike Hawthorn e Luigi Villoresi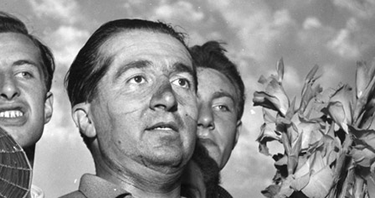
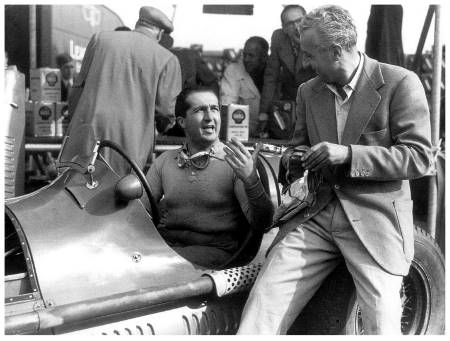




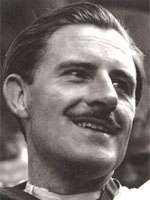





 Gran Premio degli Stati Uniti 1964fu
la nona gara della stagione 1964 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 4 ottobre sul circuito Watkins Glen International.Il
pilota principale della Cooper-Climax statunitense Phil Hill, che non
aveva partecipatoalla gara precedente (fu sostituito dal pilota di
riserva), ritornò al volante.La corsa vide la vittoria di Graham
Hill su BRM, seguito da John Surtees su Ferrari e da Jo Siffert su
Brabham-BRM.
Gran Premio degli Stati Uniti 1964fu
la nona gara della stagione 1964 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 4 ottobre sul circuito Watkins Glen International.Il
pilota principale della Cooper-Climax statunitense Phil Hill, che non
aveva partecipatoalla gara precedente (fu sostituito dal pilota di
riserva), ritornò al volante.La corsa vide la vittoria di Graham
Hill su BRM, seguito da John Surtees su Ferrari e da Jo Siffert su
Brabham-BRM. Il Gran Premio degli Stati Uniti 1965
fu la nona gara della stagione 1965 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 3 ottobre sul Circuito di Watkins Glen. La corsa vide
la vittoria di Graham Hill su BRM, seguito dai piloti Brabham-Climax
Dan Gurney e Jack Brabham.
Il Gran Premio degli Stati Uniti 1965
fu la nona gara della stagione 1965 del Campionato mondiale di Formula
1, disputata il 3 ottobre sul Circuito di Watkins Glen. La corsa vide
la vittoria di Graham Hill su BRM, seguito dai piloti Brabham-Climax
Dan Gurney e Jack Brabham.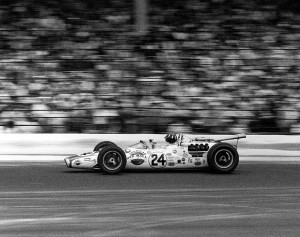
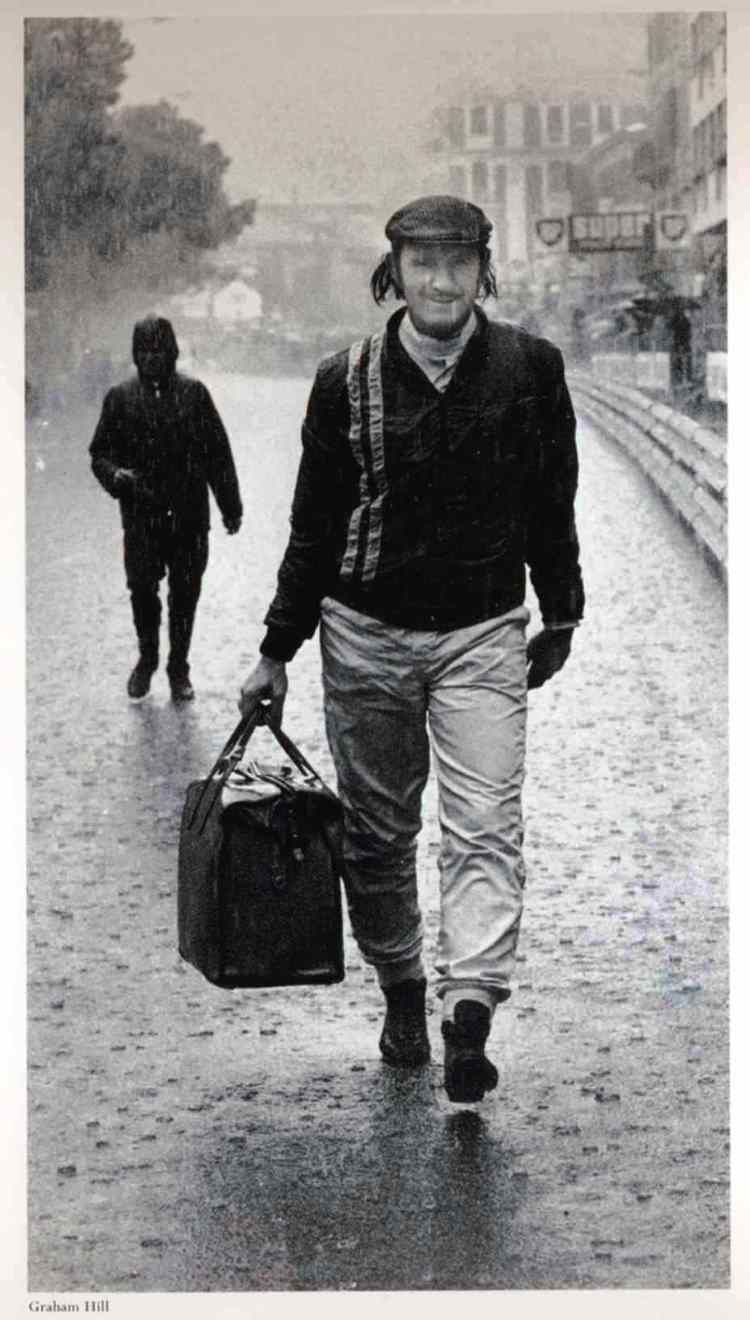
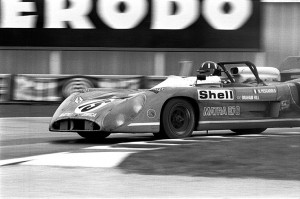


 Andreas Nikolaus Lauda nasce
a Vienna il 22 Febbraio 1949.
Andreas Nikolaus Lauda nasce
a Vienna il 22 Febbraio 1949.


 Piquet,
lo inducono alla decisione di ritirarsi dalle corse.
Piquet,
lo inducono alla decisione di ritirarsi dalle corse.







 Monte Carlo, 1983
Monte Carlo, 1983








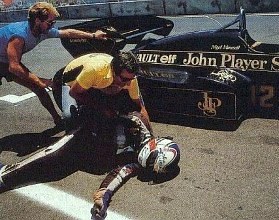








 Alla
Ferrari Mansell passa due anni. Nella stagione 1989 guida la casa di
Maranello alla riscossa, infila due vittorie gioiello e compie la grande impresa
della sua carriera: sul circuito dell’Hungaroring, notoriamente famoso per
l’impossibilità a sorpassare, parte dalla tredicesima posizione e vince dopo
aver “infilato” 11 avversari con sorpasso finale, memorabile, a scapito del
grande Senna. Il 1990 è, invece, afflitto da troppi ritiri mentre Prost, suo
compagno in quella stagione, lotta per il titolo. Dopo l’ennesimo abbandono
durante il G.P. di Inghilterra, Mansell annuncia, mestamente, il suo primo
ritiro.
Alla
Ferrari Mansell passa due anni. Nella stagione 1989 guida la casa di
Maranello alla riscossa, infila due vittorie gioiello e compie la grande impresa
della sua carriera: sul circuito dell’Hungaroring, notoriamente famoso per
l’impossibilità a sorpassare, parte dalla tredicesima posizione e vince dopo
aver “infilato” 11 avversari con sorpasso finale, memorabile, a scapito del
grande Senna. Il 1990 è, invece, afflitto da troppi ritiri mentre Prost, suo
compagno in quella stagione, lotta per il titolo. Dopo l’ennesimo abbandono
durante il G.P. di Inghilterra, Mansell annuncia, mestamente, il suo primo
ritiro.

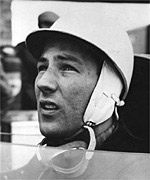 Il 27 maggio 1951 nel Gran
Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del
mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling
Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non
hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17
settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran
Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole
positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il
pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa
delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del
mondo.
Il 27 maggio 1951 nel Gran
Premio della Svizzera sul circuito di Bremgarten, prima prova del
mondiale di quell'anno, debuttava a soli 22 anni Stirling
Moss, il più grande pilota di tutti i tempi tra quelli che non
hanno mai vinto un titolo mondiale di Formula 1. Nato il 17
settembre 1929 a Londra, Moss in dieci anni ha corso 66 Gran
Premi vincendone 16 (percentuale molto alta) e stabilendo 16 pole
positions e 20 giri più veloci in gara; malgrado queste cifre il
pilota inglese è stato soprannominato "l'eterno secondo" a causa
delle sue quattro piazze d'onore consecutive nel campionato del
mondo.










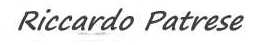
 La vettura bianco-blu guidava in quel
pomeriggio di primavera sereno e festoso il Gran Premio di San Marino.
Dietro di lei, come una minaccia, c'era una Ferrari. Non una Ferrari
qualunque, ma "la" Ferrari di quegli anni, la numero 27, che aveva perso
il suo eroe l'anno prima, ma che grazie al suo indimenticato alfiere era
entrata nel mito. Dunque la vettura bianco-blu precedeva la numero 27 e
Imola, che l'anno prima aveva assistito al duello fratricida tra i due
ferraristi e li aveva persi entrambi pochi Gran Premi dopo, stava col
fiato sospeso. Aspettando quella vittoria, che, sul Santerno, avrebbe
"vendicato" il ricordo di Gilles Villeneuve. E chissà cosa sono il
destino, l'ansia di rivincita o il dolore.
La vettura bianco-blu guidava in quel
pomeriggio di primavera sereno e festoso il Gran Premio di San Marino.
Dietro di lei, come una minaccia, c'era una Ferrari. Non una Ferrari
qualunque, ma "la" Ferrari di quegli anni, la numero 27, che aveva perso
il suo eroe l'anno prima, ma che grazie al suo indimenticato alfiere era
entrata nel mito. Dunque la vettura bianco-blu precedeva la numero 27 e
Imola, che l'anno prima aveva assistito al duello fratricida tra i due
ferraristi e li aveva persi entrambi pochi Gran Premi dopo, stava col
fiato sospeso. Aspettando quella vittoria, che, sul Santerno, avrebbe
"vendicato" il ricordo di Gilles Villeneuve. E chissà cosa sono il
destino, l'ansia di rivincita o il dolore.
 per non ribellarsi pubblicamente e
violentemente, per non denunciare costantemente l'impudenza e la crudeltà
di quella esclusione e il trattamento da paria a cui fu sottoposto per
anni, prima che Bernie Ecclestone lo chiamasse alla Brabham, facendone un
top-driver. Alcuni anni dopo fu poi stabilito che non aveva alcuna
responsabilità nella collisione fatale di Monza. Non risulta che alcuno dei colleghi, che
tanto male cercarono di fare alla sua immagine e alla sua carriera, si sia
scusato con lui. Tra loro, e questo mi dispiace sempre molto, c'era anche
Niki Lauda. Di Imola '83 si è già detto: se c'è un momento nero nella
storia del tifo ferrarista di questi anni, io lo identifico in quel
Riccardo Patrese fermo alle Acque Minerali tra bandiere rosse e pubblico
festante, tra fischi e scherno. Ti abbiamo mai chiesto scusa, per quel
gesto, Rick? Avrei voluto che la Formula 1, dopo quel giorno, fosse più
gentile di te. Dopo i successi con la Brabham (Rick ha vinto il GP di
Monaco 1982 e il GP del Sudafrica per il team di Bernie Ecclestone), sono
arrivati gli anni bui in Alfa Romeo e di nuovo in Brabham, culminati nella
morte di Elio De Angelis, nel 1986, ma caratterizzati sempre dai buoni
rapporti con i compagni di squadra, dallo stesso Elio a Eddie Cheever. E
poi è arrivata la Williams.
per non ribellarsi pubblicamente e
violentemente, per non denunciare costantemente l'impudenza e la crudeltà
di quella esclusione e il trattamento da paria a cui fu sottoposto per
anni, prima che Bernie Ecclestone lo chiamasse alla Brabham, facendone un
top-driver. Alcuni anni dopo fu poi stabilito che non aveva alcuna
responsabilità nella collisione fatale di Monza. Non risulta che alcuno dei colleghi, che
tanto male cercarono di fare alla sua immagine e alla sua carriera, si sia
scusato con lui. Tra loro, e questo mi dispiace sempre molto, c'era anche
Niki Lauda. Di Imola '83 si è già detto: se c'è un momento nero nella
storia del tifo ferrarista di questi anni, io lo identifico in quel
Riccardo Patrese fermo alle Acque Minerali tra bandiere rosse e pubblico
festante, tra fischi e scherno. Ti abbiamo mai chiesto scusa, per quel
gesto, Rick? Avrei voluto che la Formula 1, dopo quel giorno, fosse più
gentile di te. Dopo i successi con la Brabham (Rick ha vinto il GP di
Monaco 1982 e il GP del Sudafrica per il team di Bernie Ecclestone), sono
arrivati gli anni bui in Alfa Romeo e di nuovo in Brabham, culminati nella
morte di Elio De Angelis, nel 1986, ma caratterizzati sempre dai buoni
rapporti con i compagni di squadra, dallo stesso Elio a Eddie Cheever. E
poi è arrivata la Williams.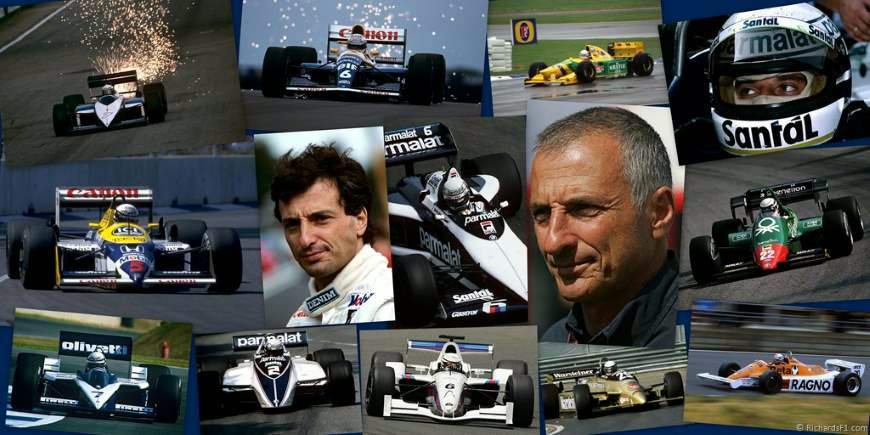
 Ricordo l'estate del 1987 in cui Frank Williams
si divertiva a dribblare i giornalisti italiani, che intuivano l'ingaggio
di Rick, e si lasciava scappare, di tanto in tanto, mezze parole per far
crescere le aspettative. La Williams stava concludendo l'era
Piquet-Mansell e dal 1988 avrebbe ceduto il primato a un'altra mitica
coppia, quella di Alain Prost e Ayrton Senna Da Silva sulla McLaren. Era
una delle squadre più importanti e più stimate della Formula 1, ma dal
1988 non sarebbe stata la più competitiva. Riccardo fece il suo dovere con
onestà, arrivando a vincere alcune gare. Nel 1990 arrivò a prendersi la
più bella rivincita della sua carriera, vincendo, in un tripudio di folla
finalmente rispettosa e contenta, il Gran Premio di San Marino. Era l'anno
del duello Prost su Ferrari-Senna su McLaren, ma il ragazzo di Padova
aveva conquistato il rispetto e l'affetto dell'Italia, diventandone il suo
più popolare rappresentante in Formula 1. Nella sua felicità Rick fu come
sempre misurato e sorridente.
Ricordo l'estate del 1987 in cui Frank Williams
si divertiva a dribblare i giornalisti italiani, che intuivano l'ingaggio
di Rick, e si lasciava scappare, di tanto in tanto, mezze parole per far
crescere le aspettative. La Williams stava concludendo l'era
Piquet-Mansell e dal 1988 avrebbe ceduto il primato a un'altra mitica
coppia, quella di Alain Prost e Ayrton Senna Da Silva sulla McLaren. Era
una delle squadre più importanti e più stimate della Formula 1, ma dal
1988 non sarebbe stata la più competitiva. Riccardo fece il suo dovere con
onestà, arrivando a vincere alcune gare. Nel 1990 arrivò a prendersi la
più bella rivincita della sua carriera, vincendo, in un tripudio di folla
finalmente rispettosa e contenta, il Gran Premio di San Marino. Era l'anno
del duello Prost su Ferrari-Senna su McLaren, ma il ragazzo di Padova
aveva conquistato il rispetto e l'affetto dell'Italia, diventandone il suo
più popolare rappresentante in Formula 1. Nella sua felicità Rick fu come
sempre misurato e sorridente.
 Gli
piaceva osservare i pesciolini del suo acquario.Quel piccolo mondo fatto solo di
colori e nessun suono, lo affascinava e lo rilassava.Non diventò mai campione
del mondo, per sfortuna o, forse, per una misteriosa congiuntura del destino.
Gli
piaceva osservare i pesciolini del suo acquario.Quel piccolo mondo fatto solo di
colori e nessun suono, lo affascinava e lo rilassava.Non diventò mai campione
del mondo, per sfortuna o, forse, per una misteriosa congiuntura del destino. Quando alla Lotus lo costrinsero a fare in numero due di Andretti,
lui accettò ma quando, durante le prove ufficiali di un gran premio, gli
montarono delle gomme vistosamente inadatte, lui si lanciò in pista e segnò il
record.Appena fermo ai box, ancora in macchina, alzò il dito medio verso Colin
Chapman che l'aveva umiliato.Un giornalista faceva notare davanti alla
televisione, il modo in cui vinse il gran premio d'Italia 1976.Lauda guidava la
sua Ferrari respirando piano e sanguinando sotto il casco(era la sua prima corsa
dopo il rogo del Nuerburgring);Hunt si piantava nella sabbia nel tentativo di
rimontare;Regazzoni inseguiva invano il sogno di vincere per la terza volta
sulla pista a lui più cara;l'asfalto era viscido ma Peterson sembrava libero da
ogni problema di aderenza e costruiva la sua vittoria vanificando la resistenza
degli avversari.
Quando alla Lotus lo costrinsero a fare in numero due di Andretti,
lui accettò ma quando, durante le prove ufficiali di un gran premio, gli
montarono delle gomme vistosamente inadatte, lui si lanciò in pista e segnò il
record.Appena fermo ai box, ancora in macchina, alzò il dito medio verso Colin
Chapman che l'aveva umiliato.Un giornalista faceva notare davanti alla
televisione, il modo in cui vinse il gran premio d'Italia 1976.Lauda guidava la
sua Ferrari respirando piano e sanguinando sotto il casco(era la sua prima corsa
dopo il rogo del Nuerburgring);Hunt si piantava nella sabbia nel tentativo di
rimontare;Regazzoni inseguiva invano il sogno di vincere per la terza volta
sulla pista a lui più cara;l'asfalto era viscido ma Peterson sembrava libero da
ogni problema di aderenza e costruiva la sua vittoria vanificando la resistenza
degli avversari.





 E
Ronnie si portava dietro tutto quanto con leggerezza anche se il suo sguardo era
sempre più malinconico e rassegnato.Arrivò a quel gran premio d'Italia, il 10
settembre 1978, sempre più solo con se stesso.Chapman gli aveva fatto
un'altro sgarbo affidandogli una Lotus vecchia di un anno per paura che desse
fastidio a Andretti, il campione predestinato.Babro, la moglie, era lontana con
la figlia Nina e anche il suo orso portafortuna, che teneva sempre
nell'abitacolo, quel giorno non c'era.Fu un gran premio di trecento metri.
E
Ronnie si portava dietro tutto quanto con leggerezza anche se il suo sguardo era
sempre più malinconico e rassegnato.Arrivò a quel gran premio d'Italia, il 10
settembre 1978, sempre più solo con se stesso.Chapman gli aveva fatto
un'altro sgarbo affidandogli una Lotus vecchia di un anno per paura che desse
fastidio a Andretti, il campione predestinato.Babro, la moglie, era lontana con
la figlia Nina e anche il suo orso portafortuna, che teneva sempre
nell'abitacolo, quel giorno non c'era.Fu un gran premio di trecento metri.
 era
il pilota più amato del
Circus, beniamino dei tifosi di tutto il mondo, più volte
trionfatore di
Monza, ogni volta accolto con un entusiasmo e accompagnato sempre
da donne bellissime. Lo chiamavano lo "zingaro" della
Formula 1 perché abitava in una bella barca nel porto di
Montecarlo, così
da essere sempre pronto a nuove avventure nei porti
mediterranei.Si
spostava con un aereo che si era regalato dopo la conquista del
secondo
titolo mondiale e che aveva imparato a guidare nell'inverno del
1983 dalle
parti di Reggio Emilia, facendo impazzire le teen-agers della
zona.Sosteneva di essere pigro, di amare la compagna del momento e i
figli
lontani e di essere gelosissimo della sua vita privata. Era un
uomo,
Nelson, come non ce ne sono stati più in Formula 1 e di cui si fa
bene ad
avere sempre nostalgia.
era
il pilota più amato del
Circus, beniamino dei tifosi di tutto il mondo, più volte
trionfatore di
Monza, ogni volta accolto con un entusiasmo e accompagnato sempre
da donne bellissime. Lo chiamavano lo "zingaro" della
Formula 1 perché abitava in una bella barca nel porto di
Montecarlo, così
da essere sempre pronto a nuove avventure nei porti
mediterranei.Si
spostava con un aereo che si era regalato dopo la conquista del
secondo
titolo mondiale e che aveva imparato a guidare nell'inverno del
1983 dalle
parti di Reggio Emilia, facendo impazzire le teen-agers della
zona.Sosteneva di essere pigro, di amare la compagna del momento e i
figli
lontani e di essere gelosissimo della sua vita privata. Era un
uomo,
Nelson, come non ce ne sono stati più in Formula 1 e di cui si fa
bene ad
avere sempre nostalgia. Sulla griglia di partenza era
l'unico pilota di vertice che scherzava con i giornalisti sull'avvenenza
delle donne presenti o che mandava a quel paese con una battuta pepata un
intervistatore per la stupidità delle sue domande e poi, in gara,
velocissimo, intelligente e mai in difficoltà psicologiche, si imponeva
sui rivali. Nelson sembrava un gatto che gioca con il topo. Fu così nel
1981, con un Carlos Reutemann indebolito dalle rivalità interne della
Williams, nel 1983, con un Alain Prost allora impetuoso e alla ricerca del
primo titolo, nel 1987, con un Nigel Mansell come sempre sprecone e
inconcludente. Piquet non ha mai dominato un Campionato mondiale, tutti i
suoi titoli li ha vinti all'ultima gara, dimostrando una notevole tenuta
psicologica. Durante la stagione i suoi rivali si sfogavano, stravincevano
e dominavano, poi, nel corso dell'estate Nelson, che aveva già accumulato
una serie di buoni piazzamenti, segnava i punti a suo favore con vittorie
belle e difficilmente sofferte fino a presentarsi all'ultima gara pronto
per la sfida decisiva. E non l'ha quasi mai persa: l'unica volta che è
successo, nel 1986, è stato perché il suo team, la solita Williams
sprecona, non ha saputo, oh novità, gestire le rivalità interne.
Sulla griglia di partenza era
l'unico pilota di vertice che scherzava con i giornalisti sull'avvenenza
delle donne presenti o che mandava a quel paese con una battuta pepata un
intervistatore per la stupidità delle sue domande e poi, in gara,
velocissimo, intelligente e mai in difficoltà psicologiche, si imponeva
sui rivali. Nelson sembrava un gatto che gioca con il topo. Fu così nel
1981, con un Carlos Reutemann indebolito dalle rivalità interne della
Williams, nel 1983, con un Alain Prost allora impetuoso e alla ricerca del
primo titolo, nel 1987, con un Nigel Mansell come sempre sprecone e
inconcludente. Piquet non ha mai dominato un Campionato mondiale, tutti i
suoi titoli li ha vinti all'ultima gara, dimostrando una notevole tenuta
psicologica. Durante la stagione i suoi rivali si sfogavano, stravincevano
e dominavano, poi, nel corso dell'estate Nelson, che aveva già accumulato
una serie di buoni piazzamenti, segnava i punti a suo favore con vittorie
belle e difficilmente sofferte fino a presentarsi all'ultima gara pronto
per la sfida decisiva. E non l'ha quasi mai persa: l'unica volta che è
successo, nel 1986, è stato perché il suo team, la solita Williams
sprecona, non ha saputo, oh novità, gestire le rivalità interne. Le sane battaglie tra i due sono
sempre state corrette e oneste, mai una polemica di troppo, neanche
quando, nell'estate del 1983, Alain spedì Nelson sulla sabbia a Zandvoort,
in una manovra azzardata che non avrebbe più ripetuto alcuni anni dopo. Un
incidente di gara, lo definì Nelson, che allora sembrò dove dire addio al
titolo per quel ritiro. Che tempi diversi, però! Il direttore sportivo
della Renault corse alla Brabham per scusarsi dell'errore di Prost e lo
stesso Alain, che fu costretto al ritiro per le conseguenze di
quell'incidente, corsero a scusarsi con il collega. Poi, è cronaca, il
titolo andò a Piquet, in un indimenticabile Gran Premio del Sudafrica.
Subito dopo apparve la stella di Ayrton Senna Da Silva, il giovane
brasiliano predestinato alla vittoria di cui Nelson iniziò a sentire
presto la rivalità in patria. Le punzecchiature e le battute cattive su
Ayrton non si contano. La più terribile, a parte quella sulla presunta
omosessualità di Ayrton, che gli costò il perpetuo rancore del
compatriota, è quella detta subito dopo il passaggio dalla Williams alla
Lotus: "Vado a mettere a posto la macchina che Senna non ha saputo mai
sistemare". Poi la Lotus ha continuato il suo declino mentre Ayrton Senna,
negli stessi anni si aggiudicava due titoli mondiali con la McLaren. Dopo
l'incidente di Imola Nelson è stato ammirevole nella sua coerenza: non
avendo mai amato Ayrton in vita, non è andato, al contrario di molti, al
suo funerale "perché non è opportuno". E in quella mancanza di opportunità
ha avuto rispetto per la prima volta, del talento del rivale.
Le sane battaglie tra i due sono
sempre state corrette e oneste, mai una polemica di troppo, neanche
quando, nell'estate del 1983, Alain spedì Nelson sulla sabbia a Zandvoort,
in una manovra azzardata che non avrebbe più ripetuto alcuni anni dopo. Un
incidente di gara, lo definì Nelson, che allora sembrò dove dire addio al
titolo per quel ritiro. Che tempi diversi, però! Il direttore sportivo
della Renault corse alla Brabham per scusarsi dell'errore di Prost e lo
stesso Alain, che fu costretto al ritiro per le conseguenze di
quell'incidente, corsero a scusarsi con il collega. Poi, è cronaca, il
titolo andò a Piquet, in un indimenticabile Gran Premio del Sudafrica.
Subito dopo apparve la stella di Ayrton Senna Da Silva, il giovane
brasiliano predestinato alla vittoria di cui Nelson iniziò a sentire
presto la rivalità in patria. Le punzecchiature e le battute cattive su
Ayrton non si contano. La più terribile, a parte quella sulla presunta
omosessualità di Ayrton, che gli costò il perpetuo rancore del
compatriota, è quella detta subito dopo il passaggio dalla Williams alla
Lotus: "Vado a mettere a posto la macchina che Senna non ha saputo mai
sistemare". Poi la Lotus ha continuato il suo declino mentre Ayrton Senna,
negli stessi anni si aggiudicava due titoli mondiali con la McLaren. Dopo
l'incidente di Imola Nelson è stato ammirevole nella sua coerenza: non
avendo mai amato Ayrton in vita, non è andato, al contrario di molti, al
suo funerale "perché non è opportuno". E in quella mancanza di opportunità
ha avuto rispetto per la prima volta, del talento del rivale.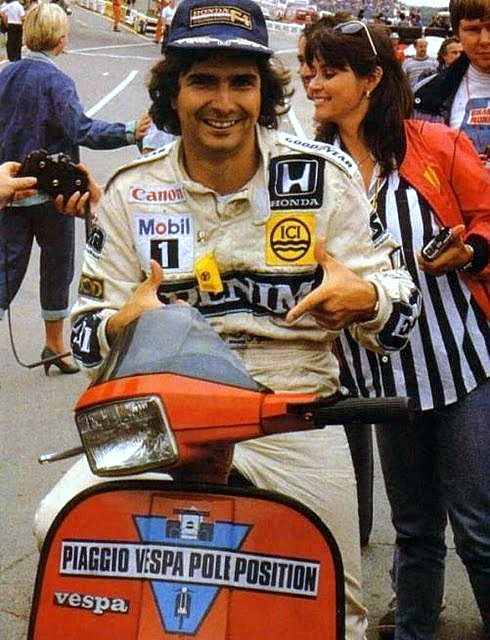



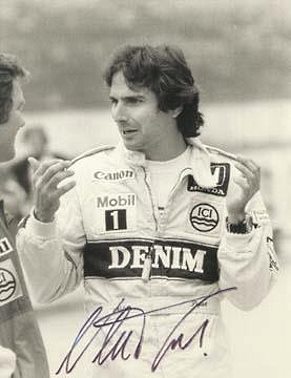
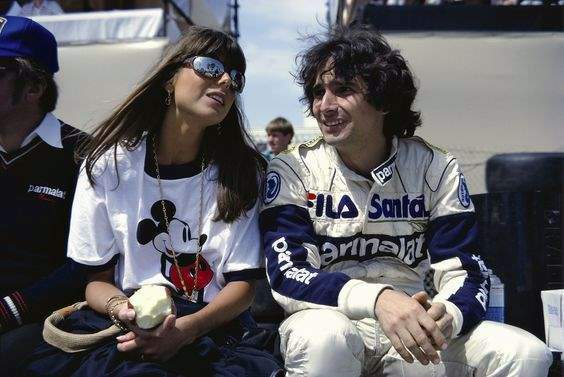






 del suo contratto di prima guida da parte
della Williams, innervosirono profondamente Piquet. La perdita del titolo
mondiale 1986, buttato al vento dalla Williams in un rocambolesco Gran
Premio d'Australia, che vide il ritiro di entrambe le vetture e vincitore
del Campionato, a sorpresa, Alain Prost, fu la goccia che fece traboccare
il vaso: il brasiliano decise che non appena fosse stato possibile avrebbe
abbandonato la squadra, lasciando Mansell e Williams al loro irrisolto rapporto. Nel 1987 Nelson
ebbe uno spaventoso incidente a Imola, alla curva del Tamburello, fatale
per il tifo brasiliano. La sagoma della sua vettura rimase per qualche
giorno impressa sul muretto della Tamburello, mentre l'Italia intera
seguiva affettuosamente le vicende del suo campione non ferrarista più
amato. Per precauzione Nelson, che non aveva riportato gravi ferite, fu
tenuto in ospedale e saltò il Gran Premio. Poi, ammise alcuni mesi dopo a
Suzuka, il fantasma di Imola rovinò le sue notti e gli fece cambiare stile
di vita. Nel 1987 un Nelson Piquet ritrovato, ormai conscio della squadra
per la quale correva, si divertì davvero come un gatto astuto con un
topolino fragile e pasticcione. Vinse il Campionato con sole tre vittorie
contro le sei del rivale, ma con un numero di piazzamenti maggiore e una
gestione della stagione più intelligente. Quando a Suzuka Mansell, già in
pole-position, ebbe il pauroso incidente in prova che gli costò il
Mondiale, Nelson non riuscì a nascondere un ghigno un po' diabolico per la
stupidità dell'inglese. E in un liberatorio incontro con i giornalisti si
sfogò finalmente, raccontando delle paure di Imola e difendendo con foga
il suo titolo mondiale. Perché il Campionato lo si vince non nell'ultima
gara, ma durante l'intera stagione, sapendo rinunciare al "piede" quando
serve la "ragione". E lo si perde andandosi a stampare nelle protezoni di
Suzuka quando si hanno in mano Campionato Mondiale e pole-position perché
non si sa usare la "ragione". Dopo Suzuka Nelson
del suo contratto di prima guida da parte
della Williams, innervosirono profondamente Piquet. La perdita del titolo
mondiale 1986, buttato al vento dalla Williams in un rocambolesco Gran
Premio d'Australia, che vide il ritiro di entrambe le vetture e vincitore
del Campionato, a sorpresa, Alain Prost, fu la goccia che fece traboccare
il vaso: il brasiliano decise che non appena fosse stato possibile avrebbe
abbandonato la squadra, lasciando Mansell e Williams al loro irrisolto rapporto. Nel 1987 Nelson
ebbe uno spaventoso incidente a Imola, alla curva del Tamburello, fatale
per il tifo brasiliano. La sagoma della sua vettura rimase per qualche
giorno impressa sul muretto della Tamburello, mentre l'Italia intera
seguiva affettuosamente le vicende del suo campione non ferrarista più
amato. Per precauzione Nelson, che non aveva riportato gravi ferite, fu
tenuto in ospedale e saltò il Gran Premio. Poi, ammise alcuni mesi dopo a
Suzuka, il fantasma di Imola rovinò le sue notti e gli fece cambiare stile
di vita. Nel 1987 un Nelson Piquet ritrovato, ormai conscio della squadra
per la quale correva, si divertì davvero come un gatto astuto con un
topolino fragile e pasticcione. Vinse il Campionato con sole tre vittorie
contro le sei del rivale, ma con un numero di piazzamenti maggiore e una
gestione della stagione più intelligente. Quando a Suzuka Mansell, già in
pole-position, ebbe il pauroso incidente in prova che gli costò il
Mondiale, Nelson non riuscì a nascondere un ghigno un po' diabolico per la
stupidità dell'inglese. E in un liberatorio incontro con i giornalisti si
sfogò finalmente, raccontando delle paure di Imola e difendendo con foga
il suo titolo mondiale. Perché il Campionato lo si vince non nell'ultima
gara, ma durante l'intera stagione, sapendo rinunciare al "piede" quando
serve la "ragione". E lo si perde andandosi a stampare nelle protezoni di
Suzuka quando si hanno in mano Campionato Mondiale e pole-position perché
non si sa usare la "ragione". Dopo Suzuka Nelson
 ritrovò il buonumore, il sorriso e l'irriverente voglia
di tirare scherzi. Ha chiuso la carriera alla Benetton, dove avrebbe
dovuto "svezzare" un giovanotto che non ha avuto la sua umiltà
nell'imparare da un maestro, non è illuminato dalla sua allegria ed era
già allora vittima del complesso di superiorità che gli sarebbe costato
poi un paio di titoli mondiali. Michael Schumacher, insomma. E' stato
l'ultimo pilota amatissimo e popolarissimo durante la sua carriera. Perché
questo brasiliano dall'italiano cantilenante sia stato in Italia a volte
più amato dei piloti della Ferrari, perché la stampa inglese non si sia
mai scatenata contro di lui negli anni della feroce rivalità con Mansell,
perché fosse difficile trovare qualcuno che lo detestasse, anche negli
anni dei trionfi, quando era più facile odiarlo, è difficile da spiegare.
Era un uomo, come è già stato detto, come non ce ne sono più in Formula 1
e di cui è bello sentire sempre nostalgia. Ciao Nelson, e che la vita
continui a sorriderti, nel tuo Brasile ritrovato, come in quei fantastici
anni '80 in cui eri il volto sorridente e luminoso della Formula 1.
ritrovò il buonumore, il sorriso e l'irriverente voglia
di tirare scherzi. Ha chiuso la carriera alla Benetton, dove avrebbe
dovuto "svezzare" un giovanotto che non ha avuto la sua umiltà
nell'imparare da un maestro, non è illuminato dalla sua allegria ed era
già allora vittima del complesso di superiorità che gli sarebbe costato
poi un paio di titoli mondiali. Michael Schumacher, insomma. E' stato
l'ultimo pilota amatissimo e popolarissimo durante la sua carriera. Perché
questo brasiliano dall'italiano cantilenante sia stato in Italia a volte
più amato dei piloti della Ferrari, perché la stampa inglese non si sia
mai scatenata contro di lui negli anni della feroce rivalità con Mansell,
perché fosse difficile trovare qualcuno che lo detestasse, anche negli
anni dei trionfi, quando era più facile odiarlo, è difficile da spiegare.
Era un uomo, come è già stato detto, come non ce ne sono più in Formula 1
e di cui è bello sentire sempre nostalgia. Ciao Nelson, e che la vita
continui a sorriderti, nel tuo Brasile ritrovato, come in quei fantastici
anni '80 in cui eri il volto sorridente e luminoso della Formula 1. Alcuni
lo criticavano per il suo modo da "calcolatore" di guidare ma
non è sempre stato così.Nel corso della carriera, il suo stile di
guida è cambiato.Dopo aver dominato in formula due, la McLaren gli
offrì una vettura e debuttò in Argentina nel 1980.La scuderia
inglese era, però, in piena crisi tecnica e gestionale quindi Alain non poté
ottenere quei risultati che molti si aspettavano.A fine stagione decise di
lasciare la squadra.
Alcuni
lo criticavano per il suo modo da "calcolatore" di guidare ma
non è sempre stato così.Nel corso della carriera, il suo stile di
guida è cambiato.Dopo aver dominato in formula due, la McLaren gli
offrì una vettura e debuttò in Argentina nel 1980.La scuderia
inglese era, però, in piena crisi tecnica e gestionale quindi Alain non poté
ottenere quei risultati che molti si aspettavano.A fine stagione decise di
lasciare la squadra.
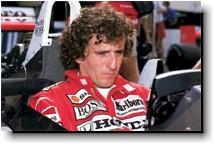 Nel 1981 firmò per la Renault.La scuderia transalpina
aveva l'ambizione di conquistare il primo mondiale con un motore turbo e
con una squadra tutta francese, l'altro pilota era, infatti, René
Arnoux.Quell'anno rischiò di vincere il titolo ma, la poca
affidabilità della vettura ed i dissidi col compagno di squadra, gli
impedirono di raggiungere l'obbiettivo.Accadde la stessa cosa nel 1982 e
nel 1983.Alain lasciò quindi la Renault e tornò alla McLaren che
non era quella del debutto ma aveva un nuovo proprietario, Ron Dennis,
che l'aveva rifondata e resa competitiva.Il suo compagno fu, nel 1984 e
1985, Niki Lauda.Il "ragioniere" diede una svolta alla
carriera di Prost perché, da lui, imparò come si gestisce una gara e,
soprattutto, un campionato.Quell'anno, malgrado sette vittorie
contro quattro dell'austriaco, "riuscì" a perdere il
titolo per solo mezzo punto!! Imparò la lezione e, nel 1985,
vinse il primo titolo bissato l'anno successivo grazie ai piazzamenti ed
alla capacità di gestire la corsa.
Nel 1981 firmò per la Renault.La scuderia transalpina
aveva l'ambizione di conquistare il primo mondiale con un motore turbo e
con una squadra tutta francese, l'altro pilota era, infatti, René
Arnoux.Quell'anno rischiò di vincere il titolo ma, la poca
affidabilità della vettura ed i dissidi col compagno di squadra, gli
impedirono di raggiungere l'obbiettivo.Accadde la stessa cosa nel 1982 e
nel 1983.Alain lasciò quindi la Renault e tornò alla McLaren che
non era quella del debutto ma aveva un nuovo proprietario, Ron Dennis,
che l'aveva rifondata e resa competitiva.Il suo compagno fu, nel 1984 e
1985, Niki Lauda.Il "ragioniere" diede una svolta alla
carriera di Prost perché, da lui, imparò come si gestisce una gara e,
soprattutto, un campionato.Quell'anno, malgrado sette vittorie
contro quattro dell'austriaco, "riuscì" a perdere il
titolo per solo mezzo punto!! Imparò la lezione e, nel 1985,
vinse il primo titolo bissato l'anno successivo grazie ai piazzamenti ed
alla capacità di gestire la corsa.










 Nel 1988 e 1989 ebbe come compagno Ayrton Senna, l'astro
nascente della F.1.Fu l'inizio della più grande rivalità mai vista nel
mondo dello sport.L'antipatia era vicendevole.Prost sapeva che Senna era
più forte di lui e Senna sapeva che, per battere Prost, non bastava
essere più veloce di lui.Alain, infatti, grazie alla
"protezione" dell'allora presidente della F.I.A., Balestre,
riuscì a togliere al brasiliano un titolo vinto sul campo.Durante il G.P.
del Giappone 1989, decisivo per il titolo, Senna tenta di superare Prost e
il francese lo butta fuori.Senna riprende la corsa e vince ma, la F.I.A.,
squalifica il brasiliano per "taglio di chicane".Da quel momento
è guerra totale e, l'anno dopo, Senna butterà fuori pista Prost, nel
frattempo passato alla Ferrari, sempre nel G.P. del Giappone,
togliendo al francese la possibilità di lottare per il titolo nell'ultima
gara.Nel 1991 Prost corre ancora con la Ferrari ma la stagione è
fallimentare.Le continue dichiarazioni contro la scuderia e l'incapacità
del francese di sistemare la vettura, fanno si che il rapporto con la
scuderia di Maranello termini due gare prima della fine della stagione.Nel 1992, Alain Prost,
non corre, torna nel 1993 col team Williams e vince il suo quarto
titolo.Alla fine della stagione si ritirerà definitivamente perchè
riteneva che le vetture fossero troppo pericolose.I fatti del 1994
gli diedero, purtroppo, ragione.Nel 1997 rileva il team Ligier e lo
ribattezza Prost grand prix.
Nel 1988 e 1989 ebbe come compagno Ayrton Senna, l'astro
nascente della F.1.Fu l'inizio della più grande rivalità mai vista nel
mondo dello sport.L'antipatia era vicendevole.Prost sapeva che Senna era
più forte di lui e Senna sapeva che, per battere Prost, non bastava
essere più veloce di lui.Alain, infatti, grazie alla
"protezione" dell'allora presidente della F.I.A., Balestre,
riuscì a togliere al brasiliano un titolo vinto sul campo.Durante il G.P.
del Giappone 1989, decisivo per il titolo, Senna tenta di superare Prost e
il francese lo butta fuori.Senna riprende la corsa e vince ma, la F.I.A.,
squalifica il brasiliano per "taglio di chicane".Da quel momento
è guerra totale e, l'anno dopo, Senna butterà fuori pista Prost, nel
frattempo passato alla Ferrari, sempre nel G.P. del Giappone,
togliendo al francese la possibilità di lottare per il titolo nell'ultima
gara.Nel 1991 Prost corre ancora con la Ferrari ma la stagione è
fallimentare.Le continue dichiarazioni contro la scuderia e l'incapacità
del francese di sistemare la vettura, fanno si che il rapporto con la
scuderia di Maranello termini due gare prima della fine della stagione.Nel 1992, Alain Prost,
non corre, torna nel 1993 col team Williams e vince il suo quarto
titolo.Alla fine della stagione si ritirerà definitivamente perchè
riteneva che le vetture fossero troppo pericolose.I fatti del 1994
gli diedero, purtroppo, ragione.Nel 1997 rileva il team Ligier e lo
ribattezza Prost grand prix.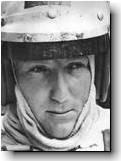 ustriaci e tedeschi che morirono durante
un bombardamento nel 1943.Visse a Graz, in Austria, con i nonni.La
passione per le corse, iniziò nel 1962. Gareggiò con una non
competitiva Formula Junior Cooper nel 1963 e fu molto sorpreso
quando la Ford gli propose di guidare una Brabham - Cosworth F.2
nel 1964.Si fece notare in due gare, a Mallory Park, dove
giunse secondo, e a Crystal Palace, dove vinse.Per questi
risultati, la Cooper gli chiese di affiancare Bruce McLaren nel
campionato di F.1 del 1965.
ustriaci e tedeschi che morirono durante
un bombardamento nel 1943.Visse a Graz, in Austria, con i nonni.La
passione per le corse, iniziò nel 1962. Gareggiò con una non
competitiva Formula Junior Cooper nel 1963 e fu molto sorpreso
quando la Ford gli propose di guidare una Brabham - Cosworth F.2
nel 1964.Si fece notare in due gare, a Mallory Park, dove
giunse secondo, e a Crystal Palace, dove vinse.Per questi
risultati, la Cooper gli chiese di affiancare Bruce McLaren nel
campionato di F.1 del 1965.
 Le Cooper non erano competitive
quell'anno e gli consentirono solo un quarto e un sesto posto nei G.P. di Germania
e U.S.A..Lo stile di Rindt era particolare, apparentemente
remissivo ma, in realtà, veloce e redditizio.Corse la 1000 Km del
Nuerburgring con una Porsche in coppia con Bonnier e finì terzo,
vince la 24 ore di Le Mans, corre nel campionato NART con una Ferrari
insieme a Masten Gregory, infine con la Ford.Continua anche a correre in
F.2 ed ottiene ottimi risultati tanto da diventare un eroe nazionale.
Le Cooper non erano competitive
quell'anno e gli consentirono solo un quarto e un sesto posto nei G.P. di Germania
e U.S.A..Lo stile di Rindt era particolare, apparentemente
remissivo ma, in realtà, veloce e redditizio.Corse la 1000 Km del
Nuerburgring con una Porsche in coppia con Bonnier e finì terzo,
vince la 24 ore di Le Mans, corre nel campionato NART con una Ferrari
insieme a Masten Gregory, infine con la Ford.Continua anche a correre in
F.2 ed ottiene ottimi risultati tanto da diventare un eroe nazionale. Nel 1968, Jochen, divenne il numero due
alla Brabham Repco V-8, ormai giunta alla fine della sua la vita competitiva.Sembrava
che Rindt, sbagliasse sempre vettura e molti si chiedevano se mai avrebbe
vinto un G.P..Fra questi c'era Denis Jenkinson, giornalista celebre, che dichiarò
che, se Rindt avesse vinto un Gran Premio, si sarebbe tagliato la sua
celebre barba.Jenkinson avrebbe dovuto onorare presto il suo impegno.
Nel 1968, Jochen, divenne il numero due
alla Brabham Repco V-8, ormai giunta alla fine della sua la vita competitiva.Sembrava
che Rindt, sbagliasse sempre vettura e molti si chiedevano se mai avrebbe
vinto un G.P..Fra questi c'era Denis Jenkinson, giornalista celebre, che dichiarò
che, se Rindt avesse vinto un Gran Premio, si sarebbe tagliato la sua
celebre barba.Jenkinson avrebbe dovuto onorare presto il suo impegno.
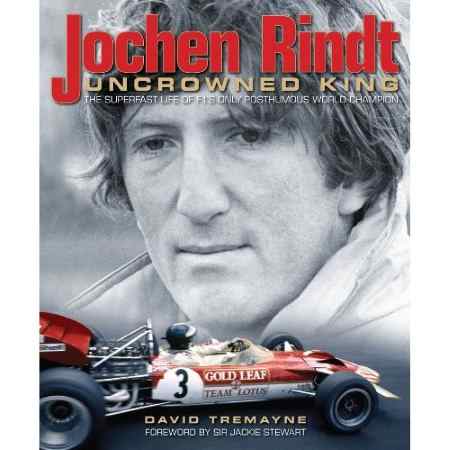

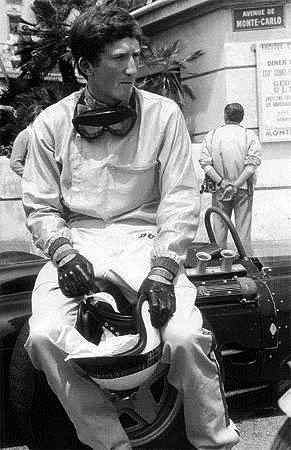
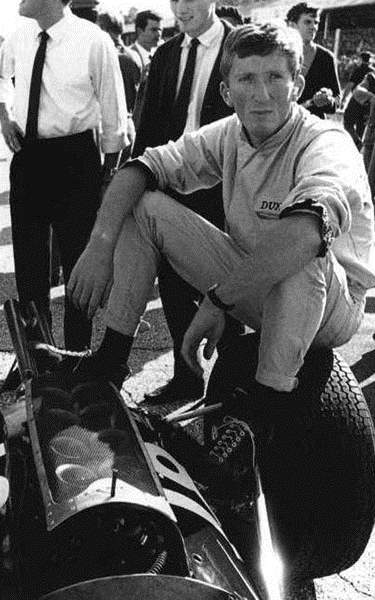



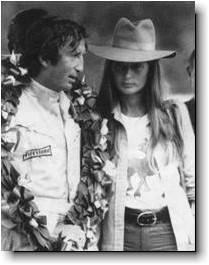 Nel 1970
è il pilota di punta della Lotus che progetta la rivoluzionaria e, in
seguito, leggendaria "72".Non viene però utilizzata
nelle prime gare ma anche il modello 49c, risulta competitivo e consente a
Rindt di conquistare una vittoria a Monaco dopo una rimonta leggendaria
ai danni del "vecchio" Brabham.Una gara fantastica con sorpasso
all'ultimo giro.Il nuovo modello debutta in Olanda e consente a Rindt di
vincere altre quattro gare e di ipotecare il titolo mondiale.Durante
il G.P. d'Olanda, muore il suo Amico Courage e molti sono convinti
che si ritirerà a fine stagione.Arriva al G.P. d'Italia con un
consistente vantaggio in classifica e voleva chiudere il campionato
proprio in questa gara.Durante le qualificazioni del Sabato, la
Lotus 72 impazzisce alla fine del lungo rettilineo prima della
parabolica.La vettura si disintegra contro il guard-rail e Jochen muore
sul colpo.
Nel 1970
è il pilota di punta della Lotus che progetta la rivoluzionaria e, in
seguito, leggendaria "72".Non viene però utilizzata
nelle prime gare ma anche il modello 49c, risulta competitivo e consente a
Rindt di conquistare una vittoria a Monaco dopo una rimonta leggendaria
ai danni del "vecchio" Brabham.Una gara fantastica con sorpasso
all'ultimo giro.Il nuovo modello debutta in Olanda e consente a Rindt di
vincere altre quattro gare e di ipotecare il titolo mondiale.Durante
il G.P. d'Olanda, muore il suo Amico Courage e molti sono convinti
che si ritirerà a fine stagione.Arriva al G.P. d'Italia con un
consistente vantaggio in classifica e voleva chiudere il campionato
proprio in questa gara.Durante le qualificazioni del Sabato, la
Lotus 72 impazzisce alla fine del lungo rettilineo prima della
parabolica.La vettura si disintegra contro il guard-rail e Jochen muore
sul colpo. 










 Nato nel 1939 in Scozia, a Durnbuck, fece il benzinaio
nel garage di suo padre, e divenne tecnico specializzato in motori
frequentando corsi serali. Vinse quattro campionati di tiro al piattello.
Nel 1961 partecipò alla sua prima gara con una vettura sportiva Marcos.
Nel 1962 si ritirò dal tiro al piattello, nel 1963, uscito di casa alla
chetichella, corse con lo pseudonimo "A. N. Other” per la scuderia
scozzese Ecurie-Ecosse.
Nato nel 1939 in Scozia, a Durnbuck, fece il benzinaio
nel garage di suo padre, e divenne tecnico specializzato in motori
frequentando corsi serali. Vinse quattro campionati di tiro al piattello.
Nel 1961 partecipò alla sua prima gara con una vettura sportiva Marcos.
Nel 1962 si ritirò dal tiro al piattello, nel 1963, uscito di casa alla
chetichella, corse con lo pseudonimo "A. N. Other” per la scuderia
scozzese Ecurie-Ecosse. 





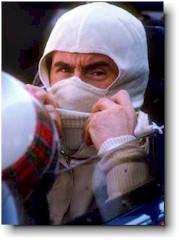



 Ma
Villeneuve si fa valere ingaggiando
un duello a colpi di pneumatici, derappate e sgommate con Arnoux che non
è facile da dimenticare. La folle insistenza di Villeneuve, che la sua
meno potente Ferrari vuole a tutti i costi battere la più veloce Renault
di Arnoux, viene ricompensata e finisce la gara davanti al francese. Si può
sicuramente dire che questa fu la battaglia per la seconda posizione più
eccitante
Ma
Villeneuve si fa valere ingaggiando
un duello a colpi di pneumatici, derappate e sgommate con Arnoux che non
è facile da dimenticare. La folle insistenza di Villeneuve, che la sua
meno potente Ferrari vuole a tutti i costi battere la più veloce Renault
di Arnoux, viene ricompensata e finisce la gara davanti al francese. Si può
sicuramente dire che questa fu la battaglia per la seconda posizione più
eccitante